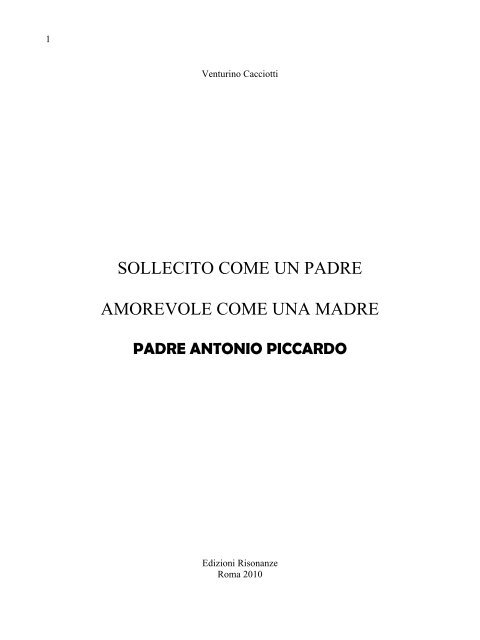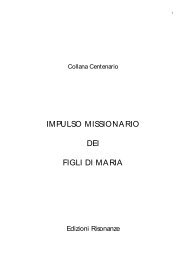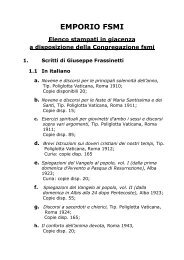sollecito come un padre amorevole come una madre - Figli di Santa ...
sollecito come un padre amorevole come una madre - Figli di Santa ...
sollecito come un padre amorevole come una madre - Figli di Santa ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1<br />
Venturino Cacciotti<br />
SOLLECITO COME UN PADRE<br />
AMOREVOLE COME UNA MADRE<br />
PADRE ANTONIO PICCARDO<br />
E<strong>di</strong>zioni Risonanze<br />
Roma 2010
2<br />
Finito <strong>di</strong> stampare il 3 novembre 2010<br />
Anniversario della morte <strong>di</strong> P. Antonio Piccardo<br />
Tipografia Multiprint Roma<br />
Supplemento al n. 3/2010 <strong>di</strong> Risonanze
3<br />
INTRODUZIONE<br />
Lo stu<strong>di</strong>o delle nostre origini serve a mettere in luce quella esperienza dello Spirito che la<br />
Chiesa ha riconosciuto <strong>come</strong> reale, vera e legittima. È <strong>un</strong> percorso che ridà forza alla<br />
Congregazione, ricompattandola attorno ad <strong>un</strong> fulcro per apprezzare il presente e orientarsi nel<br />
prossimo futuro. Scoprire o intuire il fulcro significa avere materiale da rileggere e ricomprendere<br />
alla luce dei segni dei tempi.<br />
L’avventura originale dei fondatori, vissuta in forza del carisma loro donato, è <strong>un</strong>a<br />
particolare «esperienza dello Spirito destinata a trasmettersi ai propri <strong>di</strong>scepoli per essere da questi<br />
vissuta, custo<strong>di</strong>ta, approfon<strong>di</strong>ta e costantemente sviluppata in sintonia con il Corpo <strong>di</strong> Cristo in<br />
perenne crescita» 1 .<br />
Questa rivisitazione della nostra storia vista <strong>come</strong> in <strong>un</strong> prisma attraverso la luce che<br />
promana dalla figura <strong>di</strong> Padre Antonio Piccardo ha l’intento <strong>di</strong> aiutare a definire meglio la propria<br />
identità.<br />
Padre Piccardo è il primo dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria; egli ha iniziato con la Pia Casa ed ha concluso<br />
con la Congregazione. La prima e la seconda sono entità <strong>di</strong>verse, ma risalta chiaro che si tratta <strong>di</strong><br />
due realtà tra loro perfettamente incastonate.<br />
Padre Piccardo viene alla ribalta verso gli anni settanta del secolo XIX, tempo agitato e<br />
simultaneamente fecondo; si può rimirare <strong>come</strong> <strong>un</strong> uomo scelto da Dio, che è <strong>di</strong>venuto segno<br />
profetico nella Chiesa particolare <strong>di</strong> Genova con la “Pia Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata<br />
per l’avviamento dei giovinetti poveri allo stato ecclesiastico”. Egli, fedele alla sua mozione<br />
interiore, è stato anche strumento della Chiesa <strong>un</strong>iversale con la costituzione della “Congregazione<br />
dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata”.<br />
Padre Antonio Piccardo era <strong>un</strong> uomo dall’aspetto amabile e dal tratto signorile, recava con<br />
sé <strong>un</strong> bel patrimonio <strong>di</strong> beni elargiti da Dio alla sua famiglia ma ancor piú <strong>un</strong> patrimonio <strong>di</strong><br />
ricchezze spirituali e morali: <strong>un</strong> intelletto sagace addestrato ai buoni stu<strong>di</strong> nel liceo, all’<strong>un</strong>iversità e<br />
nella scuola <strong>di</strong> filosofia e teologia del seminario.<br />
Aveva <strong>un</strong> animo retto e buono, <strong>un</strong>o spirito equilibrato e <strong>un</strong>’assennatezza naturale, <strong>un</strong>’anima<br />
sacerdotale ardente <strong>di</strong> zelo per fare a qual<strong>un</strong>que modo il bene, e poi <strong>un</strong> grande e fervido desiderio <strong>di</strong><br />
lavorare per <strong>un</strong> compito altissimo: favorire, sviluppare, accompagnare le vocazioni e quei giovani<br />
che <strong>di</strong>mostravano <strong>di</strong> esserne inclini, che il Signore affidava alle sue cure 2 .<br />
Sono state scritte tre brevi biografie su Padre Piccardo 3 , ma molto materiale deve essere<br />
ancora esaminato, il presente scritto per quanto modesto è <strong>un</strong>a piccola pietra nella costruzione della<br />
conoscenza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a vita che possiede aspetti eccezionali.<br />
Ho detto solo qualche cosa ma se questo elaborato riesce ad entusiasmare e suscitare<br />
interesse per la figura del Padre Piccardo e per lo stu<strong>di</strong>o delle origini dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria mi sentirei<br />
sufficientemente gratificato.<br />
P. Cacciotti Venturino<br />
1 Mutae relationes, n° 11.<br />
2 Queste note sono rielaborate dagli app<strong>un</strong>ti <strong>di</strong> P. Giacomo Chiesa. P. Giacomo Chiesa è stato al<strong>un</strong>no della Pia Casa<br />
sotto la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> Padre Piccardo, è stato or<strong>di</strong>nato sacerdote nel 1897; lavora pastoralmente per <strong>un</strong> periodo in <strong>di</strong>ocesi,<br />
dopo la morte della mamma, entra nei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria e professa il 15 giugno del 1906.<br />
3 BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003; AA.VV., Il nostro Primo<br />
Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004; P. PAPI, P. Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma, 1994.
4<br />
I PRIMI ANNI<br />
L’infanzia e la giovinezza<br />
Nella piccola famiglia Piccardo <strong>di</strong> Voltri il 14 <strong>di</strong>cembre 1844 fu <strong>un</strong> giorno <strong>di</strong> luce e <strong>di</strong> gioia.<br />
Il signor Pasquale può congratularsi con sua moglie Maria Viacara per la nascita del suo<br />
primogenito.<br />
Egli era sindaco del paese, la sua famiglia era <strong>di</strong>stinta e agiata, anche se non si fregiava dello<br />
stemma nobiliare, <strong>un</strong> figlio maschio <strong>di</strong>ventava <strong>un</strong>a garanzia per la futura soli<strong>di</strong>tà della famiglia.<br />
È da ritenere certa ed evidente l’appartenenza <strong>di</strong> Pasquale Piccardo a <strong>un</strong> ambiente<br />
contrassegnato dal prestigio sociale e politico; lui era il sindaco <strong>di</strong> Voltri e suo cognato fu per<br />
cinque legislature deputato al parlamento nazionale.<br />
La sua era com<strong>un</strong>que anche <strong>un</strong>a famiglia timorata <strong>di</strong> Dio: non solo la mamma Maria aveva<br />
<strong>un</strong>a grande fede, ma anche Pasquale aveva il titolo e il ruolo <strong>di</strong> amministratore del Santuario della<br />
Madonna dell’Acquasanta.<br />
Il nuovo nato fu chiamato Antonio e il 17 <strong>di</strong>cembre lo portarono al fonte battesimale nella<br />
chiesa <strong>di</strong> San Ambrogio e il parroco Don Giuseppe Battilana lo rese figlio <strong>di</strong> Dio.<br />
Bisogna ammettere che non abbiamo molte informazioni sull’infanzia e sull’adolescenza <strong>di</strong><br />
Padre Piccardo. In tal caso sorge la tentazione <strong>di</strong> colmare le lac<strong>un</strong>e dell’informazione e <strong>di</strong> riempire i<br />
vuoti ricorrendo ai luoghi com<strong>un</strong>i dell’agiografia. Cercheremo <strong>di</strong> evitare il tranello.<br />
«L’aura mariana della famiglia e la fede del popolo in mezzo al quale il piccolo Antonio<br />
passò la sua fanciullezza e adolescenza testimoniano la tenerissima devozione alla Madonna a cui<br />
veniva educato» 4 . Possiamo rilevare che il giovinetto aveva <strong>di</strong>eci anni quando il Papa Pio IX<br />
proclamò il dogma dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria e quattor<strong>di</strong>ci quando la<br />
Madonna apparve a Lourdes.<br />
«L’arcivescovo <strong>di</strong> Genova Mons. Andrea Charvaz chiese al prevosto <strong>di</strong> Sant’Ambrogio in<br />
Voltri <strong>di</strong> celebrare per tutto il paese <strong>un</strong>a festa per l’avvenuta proclamazione del dogma<br />
dell’Immacolata da parte del Papa, e gli assegnò la data del 10 luglio 1855. I voltresi, gente pratica<br />
e da sempre abituata a strappare le sue ricchezze con estrema fatica al mare insi<strong>di</strong>oso e alla terra<br />
collinare, accolsero con molto entusiasmo la proposta dell’arcivescovo e andarono a gara per<br />
onorare Maria con tali festeggiamenti, che lasciarono tutti grandemente meravigliati» 5 .<br />
Nell’archivio parrocchiale si trova la cronaca della festa e tra l’altro si legge: «Si chiuse<br />
finalmente la f<strong>un</strong>zione con la processione solenne che mai in Voltri fu vista piú numerosa e devota,<br />
col canto dell’Ambrosiano e la bene<strong>di</strong>zione col Venerabile. Mai si vide maggior affetto ed<br />
entusiasmo nel celebrare le glorie <strong>di</strong> Maria.<br />
L’allegrezza, la pace e l’<strong>un</strong>ione si vedevano sul volto <strong>di</strong> tutti, e nelle sere <strong>di</strong> detti giorni,<br />
generale fu l’illuminazione delle case dei privati. Inoltre per le strade eranvi archi trionfali<br />
4 BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 8.<br />
5 AA. VV., Immacolata, E<strong>di</strong>zioni d’arte Marconi, n° 90, Genova 1992, 6-7.
5<br />
solennemente addobbati, e con lampadari, con cere, con grotte e navigli, tutto illuminato a giorno,<br />
mirabili a vedersi» 6 .<br />
In questa cronaca non si incontra il nome <strong>di</strong> Antonio Piccardo, ma non si può dubitare che<br />
<strong>un</strong> fanciullo <strong>di</strong> <strong>un</strong><strong>di</strong>ci anni non si lasciasse coinvolgere dal magico fascino <strong>di</strong> <strong>un</strong>a popolazione in<br />
fibrillazione, considerando che il sindaco, <strong>di</strong> cui era figlio, aveva <strong>un</strong> ruolo non secondario. Se <strong>un</strong>a<br />
<strong>di</strong>mensione interessante si vuole evidenziare, questa è rappresentata dall’effetto percepito nel suo<br />
interiore; ma questo ci apparirà chiaro dallo sviluppo della sua vita. Mentre la sua esultanza<br />
interiore per questi avvenimenti è <strong>un</strong>a non improbabile supposizione, che la sua vita fu<br />
contrassegnata dalla presenza <strong>di</strong> Maria Immacolata, <strong>di</strong> cui fu <strong>un</strong> eletto figlio, è <strong>un</strong>’incontestabile<br />
certezza.<br />
Antonio ha goduto del beneficio della migliore educazione scolastica frequentando a Voltri<br />
le elementari con ottimi risultati e gli stu<strong>di</strong> ginnasiali e liceali al Collegio Nazionale <strong>di</strong> Genova,<br />
considerato <strong>come</strong> il collegio dei signori. «Vi si impartiva <strong>un</strong>a seria <strong>di</strong>sciplina con <strong>un</strong>o stile anche <strong>un</strong><br />
po’ militare e si coltivava il sapere con somma <strong>di</strong>ligenza» 7 . La testimonianza del suo con<strong>di</strong>scepolo<br />
Fer<strong>di</strong>nando Resasco ci suggerisce alc<strong>un</strong>e linee molto lusinghiere del profilo dello studente Piccardo:<br />
<strong>di</strong> mo<strong>di</strong> cortesi, simpatico ai professori e alla scolaresca, indefessamente stu<strong>di</strong>oso. «Sapevamo che<br />
aveva idee <strong>di</strong>verse dalle nostre e che l’attraevano al sacerdozio, ma non ne faceva sfoggio» 8 .<br />
Sempre lo stesso Resasco riferisce: «Piccardo all’occorrenza sapeva essere energico e lo<br />
<strong>di</strong>mostrò specialmente accorrendo in <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> <strong>un</strong> con<strong>di</strong>scepolo maltrattato da <strong>un</strong> pessimo soggetto.<br />
In quella occasione non si riconosceva piú, e alla meraviglia <strong>di</strong> chi aveva assistito alla scena<br />
rispose: Non ho fatto che il mio dovere <strong>di</strong> cristiano» 9 .<br />
Il suo naturale era contrassegnato dalla semplicità, dall’impegno nei propri doveri senza<br />
esaltazione <strong>di</strong> sé, o atteggiamenti <strong>di</strong> ostentazione.<br />
«Un intelletto sagace, addestrato ai buoni stu<strong>di</strong> … <strong>un</strong> animo retto e buono, tale da attirarsi<br />
<strong>un</strong>a irresistibile simpatia e <strong>un</strong>a spontanea benevolenza per chi<strong>un</strong>que avesse a che fare con lui; <strong>un</strong>o<br />
spirito equilibrato e <strong>un</strong>’assennatezza naturale … <strong>un</strong> amore sensibilissimo a tutto ciò che possa<br />
in<strong>di</strong>care sofferenza o <strong>di</strong>sagio segnatamente nei piccoli e nei poveri» 10 . Si può affermare che questa<br />
sua attitu<strong>di</strong>ne alla serietà, al lavoro e alla felice <strong>di</strong>sposizione alla virtú è attestata dai numerosi<br />
quaderni <strong>di</strong> scuola pieni <strong>di</strong> app<strong>un</strong>ti, note, riass<strong>un</strong>ti, <strong>di</strong> questo periodo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>. Da essi si può dedurre<br />
l’impegno dello studente scevro <strong>di</strong> ogni velleità, confermato anche dai risultati eccellenti conseguiti<br />
<strong>di</strong> cui fanno testo i <strong>di</strong>plomi conservati in Archivio.<br />
La scelta vocazionale<br />
Lo studente Antonio Piccardo era molto legato alla sua scuola e ai suoi coetanei, ma a due<br />
compagni, che <strong>un</strong>a sera lo avevano invitato al Teatro Carlo Felice per la prima <strong>di</strong> “Un ballo in<br />
6<br />
Archivio della Parrocchia <strong>di</strong> S. Ambrogio, Voltri, luglio 1855.<br />
7<br />
BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 9.<br />
8<br />
Ibid., pag. 10.<br />
9<br />
Ibid., pag. 10.<br />
10<br />
G. CHIESA, Il suo ritorno alla casa <strong>madre</strong>, in AA.VV., Il nostro Primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze,<br />
Roma, 2004, 132.
6<br />
maschera” <strong>di</strong> Giuseppe Ver<strong>di</strong>, declinando l’invito rispose con questa sintomatica frase: “I miei<br />
ideali non son affatto per il teatro; altra è la mia vocazione”.<br />
«Quando il giovinetto sentiva sbocciare i primi segni della vocazione ecclesiastica, non<br />
aveva che <strong>un</strong><strong>di</strong>ci anni, lo zio Padre Benedetto scriveva dall’America alla <strong>madre</strong> <strong>di</strong> porre la<br />
vocazione del figlio sotto la protezione della Vergine Immacolata» 11 . «A conferma dell’avvenuto<br />
affidamento <strong>di</strong> sé a Maria - afferma Mons. Giacomo Ghio - fu conquistato al sacerdozio dalla<br />
Vergine alla quale aveva consacrata la sua vita» 12 .<br />
Conseguita la licenza liceale, all’età <strong>di</strong> vent’anni, si iscrisse all’Università nella facoltà <strong>di</strong><br />
Diritto Canonico e cominciò contemporaneamente a frequentare il Corso teologico nel Seminario<br />
arcivescovile, accogliendo con animo grato la grazia <strong>di</strong> essere stato scelto per lo stato sacerdotale.<br />
«Ebbe tra i docenti il dottissimo Mons. Salvatore Magnasco, che lo avviò, oltre che<br />
all’arricchimento culturale, anche ad <strong>un</strong>a progressiva ascensione dello spirito.<br />
L’allievo non tardò a farsi apprezzare, specialmente nella Teologia Dogmatica, tanto che i<br />
professori e i con<strong>di</strong>scepoli ebbero <strong>di</strong> lui la massima stima» 13 , <strong>come</strong> testimoniò lo stesso Mons.<br />
Magnasco.<br />
Fu or<strong>di</strong>nato sacerdote il sei giugno 1868 da Monsignor Andrea Charvaz nella cattedrale <strong>di</strong><br />
San Lorenzo in Genova. Si recò poi a Roma per ricevere la bene<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> Papa Pio IX, ma la prima<br />
Messa la celebrò nel suo Santuario: la Madonna dell’Acquasanta.<br />
«Il Venerabile Giuseppe Frassinetti, chiamava Maria “Stella del mio sacerdozio”. Anche per<br />
Padre Antonio Piccardo Maria è stata la stella che guidò i passi del suo ministero sacerdotale tra i<br />
giovani, in<strong>di</strong>rizzandoli verso nobili e santi ideali <strong>come</strong> sacerdoti <strong>di</strong> Dio o <strong>come</strong> onorati citta<strong>di</strong>ni» 14 .<br />
11<br />
RAZZORE D., Don Piccardo e il Santuario dell’Acquasanta, in AA. VV., Il nostro Primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni<br />
Risonanze, Roma, 2004, 109.<br />
12<br />
GHIO G., Nel ricordo della sua morte, in Aa.Vv., Il nostro Primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma,<br />
2004, 73.<br />
13<br />
PAPI P., P. Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma, 1994, 13.<br />
14<br />
BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 13.
7<br />
NELLA CASA DEI FIGLI DI MARIA<br />
Inspiegabilmente ma provvidenzialmente scelto da Dio, ha seguito la mozione interiore ed è<br />
<strong>di</strong>venuto <strong>un</strong>a bene<strong>di</strong>zione per la Diocesi <strong>di</strong> Genova con la <strong>di</strong>rezione e lo sviluppo della “Casa dei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata per l’avviamento dei giovinetti poveri allo stato ecclesiastico”. Il<br />
giovane sacerdote Antonio Piccardo, uomo dall’aspetto amabile e da <strong>un</strong> forte desiderio <strong>di</strong> bene, che<br />
gli ardeva dentro appena ventiquattrenne ha saputo ann<strong>un</strong>ziare il valore del Regno <strong>di</strong> Dio tra gli<br />
uomini<br />
Era <strong>di</strong> famiglia benestante, ma proprio la sua famiglia lo aveva aiutato a far emergere il<br />
patrimonio <strong>di</strong> ricchezze spirituali e morali del suo animo.<br />
Anni <strong>di</strong>fficili, quelli in cui ha iniziato il suo tirocinio pastorale, per i fermenti politico-sociali<br />
che fervevano da ogni dove, per la lotta piú o meno camuffata alla Chiesa e in particolare al Papa,<br />
per <strong>un</strong> senso <strong>di</strong> secolarismo religioso, che <strong>un</strong>ito all’in<strong>di</strong>fferenza e al sospetto rendevano estranea la<br />
fede alla vita, <strong>di</strong>fficile infine per la carenza, quasi tragica <strong>di</strong> vocazioni sacerdotali e religiose.<br />
Frassinetti con l’aiuto dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria viventi in com<strong>un</strong>e dette <strong>un</strong>a risposta operativa alla<br />
grave crisi vocazionale nella Archi<strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> Genova 15 . L’Istituzione suscitava attese da parte <strong>di</strong><br />
molti. Le cose andarono cosí: frequentava la chiesa <strong>di</strong> S. Sabina <strong>un</strong> giovane dalla evidente<br />
inquietu<strong>di</strong>ne vocazionale ma senza i mezzi economici per accedere al seminario; il parroco, il dotto<br />
e santo don Giuseppe Frassinetti, il fratello don Raffaelle, se ne accorgono e ne parlano a Pietro<br />
Olivari, <strong>un</strong> vero uomo <strong>di</strong> Dio, <strong>un</strong>o dei tre consacrati 16 nella Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, con<br />
saggio realismo e altrettanta fiducia nella Provvidenza apre la strada <strong>di</strong>cendo: “lo prenderemo con<br />
noi e lo manterremo con i nostri risparmi”. I giovani che si presentarono <strong>di</strong>vennero presto<br />
quattro, sei, otto … la canonica si fa piccola e si guarda alla casa degli Artigianelli dove l’Olivari<br />
prestava il suo lavoro <strong>di</strong> tipografo, e da qui in Via Lata.<br />
Il Frassinetti impegnato nella gestione della parrocchia e onerato da altre incombenze ad<br />
essa connesse, non era in grado <strong>di</strong> seguire in modo sistematico questo drappello; cercò in vari mo<strong>di</strong><br />
aiuto, il chierico Semino gli parlò del Diacono Piccardo.<br />
Il Piccardo, or<strong>di</strong>nato sacerdote, si accinse a quest’opera, aderendo alla proposta che gli era<br />
pervenuta da parte del Priore Giuseppe Frassinetti, attraverso il suo con<strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> seminario<br />
Giovanni Battista Semino.<br />
Accettare la proposta (niente <strong>di</strong> ufficiale e <strong>di</strong> calcolato) <strong>di</strong> prendersi cura <strong>di</strong> questi giovani<br />
poveri, che aspiravano al sacerdozio, era precludersi le vie che si aprivano davanti a coloro che,<br />
15<br />
Il Frassinetti aveva raccolto e comparato i dati riguardanti la sproporzione tra i sacerdoti morti e le nuove or<strong>di</strong>nazioni<br />
l<strong>un</strong>go gli anni 1856 – 1865:<br />
Anni Or<strong>di</strong>nati Morti Anni Or<strong>di</strong>nati Morti<br />
1856 17 20 1861 6 19<br />
1857 13 31 1862 7 19<br />
1858 7 25 1863 6 15<br />
1859 6 36 1864 11 23<br />
1860 4 24 1865 8 35<br />
16<br />
Pietro Olivari (17/9/1831 – 27/1/1890), tipografo, con il Pedemonte, impiegato <strong>di</strong> Banca e il Ghiglione, cuoco: veri<br />
religiosi al secolo secondo lo spirito del Frassinetti, formano la prima com<strong>un</strong>ità nella canonica <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina.<br />
L’Olivari si può considerare <strong>un</strong>o dei fondatori dell’Opera dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata.
8<br />
stu<strong>di</strong>ando <strong>come</strong> interni nel Seminario e con buoni risultati, avevano pur sempre l’aura del successo,<br />
anche <strong>un</strong> po’ carrieristico, <strong>di</strong> <strong>un</strong> riconoscimento sociale e <strong>di</strong> <strong>un</strong>a buona sistemazione.<br />
Che cosa ha spinto il giovane sacerdote ad accettare, quasi con imme<strong>di</strong>atezza, la proposta?<br />
C’era forse l’idea <strong>di</strong> iniziare <strong>un</strong>’opera propria, che avrebbe potuto suscitare intorno alla sua<br />
persona ammirazione e lui stesso vivere <strong>un</strong>’avventura ine<strong>di</strong>ta?<br />
Ricercava forse <strong>un</strong>a via per <strong>un</strong>’auto-gestione <strong>di</strong> <strong>un</strong>’opera senza intralci ma in solitaria e<br />
nell’in<strong>di</strong>pendenza?<br />
Chi conosce gli sviluppi dell’opera non può sottoscrivere ness<strong>un</strong>a delle due ipotesi, perché il<br />
giovane sacerdote si rimise subito alla decisione del Vescovo, da cui doveva ricevere l’incarico e a<br />
cui dare ragione dell’espletamento del suo compito. Una vicinanza <strong>di</strong> carattere spirituale possiamo<br />
intravvedere: egli era particolarmente devoto alla Madonna e l’istituzione era de<strong>di</strong>cata a Maria<br />
Immacolata.<br />
Sono avare le fonti da cui desumere i sentimenti e i moti interiori <strong>di</strong> Padre Piccardo: ogni<br />
risposta ha certamente <strong>un</strong>a parte ipotetica. Tutto sommato, forse è meglio lasciare a questa scelta la<br />
sua zona <strong>di</strong> mistero, nel senso piú vero del termine: azione <strong>di</strong>vina dello Spirito manifestata nella<br />
realtà umana.<br />
Egli si trovò a vivere fin dal primo giorno in <strong>un</strong>a com<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria: adulti e giovani<br />
che si erano consacrati me<strong>di</strong>ante il voto <strong>di</strong> castità alla Vergine Immacolata, che avevano <strong>un</strong>a regola<br />
e seguivano in particolari momenti riti e incontri riservati.<br />
Il nuovo arrivato manifestò tutta la sua umile sapienza nell’adeguarsi alla com<strong>un</strong>ità che<br />
incontrava, anziché nel conformare tutto a se stesso, alla sua visione e alle sue mete. Fu cosí, <strong>come</strong><br />
ci <strong>di</strong>cono i documenti d’archivio, che il 27 <strong>di</strong>cembre del 1868 «fu accettato in questa Pia Unione il<br />
molto Reverendo Don Piccardo, che da poco aveva preso l’ere<strong>di</strong>tà spirituale del Frassinetti,<br />
assumendo la <strong>di</strong>rezione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria viventi in com<strong>un</strong>e» 17 .<br />
La canonica <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina, prima e storica <strong>di</strong>mora dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, non era piú<br />
appetibile, non solo perché angusta, ma anche perché, dopo la morte del Frassinetti, non era<br />
permesso varcarne la soglia.<br />
I <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria con il gruppo degli aspiranti vivevano nella soffitta dell’Istituto degli<br />
Artigianelli che Don Montebr<strong>un</strong>o aveva concesso in comodato.<br />
Spazio ce n’era, ma la sistemazione in quella zona “romita” della casa era poco pratica e<br />
decorosa.<br />
Da Don Piccardo questo compito non era reputato temporaneo, in vista <strong>di</strong> altre mete piú<br />
prestigiose, ma egli si era impersonato in esso e ci si era messo dentro anima e corpo. I problemi,<br />
anche quelli <strong>di</strong> carattere materiale, esigevano <strong>un</strong>a soluzione congrua.<br />
Era necessaria <strong>un</strong>a sede semplice, anche semplicissima, ma adatta allo scopo. Fu cosí che,<br />
con l’aumentare degli al<strong>un</strong>ni, la “piccola carovana” trasmigrò in Via Lata 18 e il 18 ottobre del 1869<br />
17 Il Documento, pag. 29, pro manuscripto. Archivio FSMI, Roma.<br />
18 Le tappe verso la terra promessa: da <strong>Santa</strong> Sabina a via Ginevrina ed a Roma: <strong>un</strong>a vera itineranza.<br />
gennaio 1866 presso la canonica <strong>di</strong> S.Sabina.<br />
17/03/1866 – 10/07/1867 presso gli “Artigianelli” con Pietro Olivari.<br />
08/07/1867 – 18/10 1869 in via Lata con l’Olivari e don Piccardo.<br />
18/10/1869 – ottobre 1870 in via Milius con don Piccardo e l’Olivari.<br />
ottobre 1870 – febbraio 1872 in via delle Cappuccine.
9<br />
in via Milyus, in <strong>un</strong> appartamento piú grande. Lí Mons. Salvatore Magnasco il 25 novembre<br />
intronizzò il Santissimo Sacramento nella cappella ricavata in quei locali.<br />
Per Don Piccardo, però, era <strong>un</strong> problema importante il poter sistemare la com<strong>un</strong>ità in <strong>un</strong>a<br />
sede piú conveniente e prese in affitto <strong>un</strong> grande appartamento piú comodo e con <strong>un</strong> po’ <strong>di</strong> giar<strong>di</strong>no<br />
presso l’antico monastero delle Cappuccine, dove oggi sorge <strong>un</strong> braccio dell’Ospedale Galliera. In<br />
questa nuova casa la com<strong>un</strong>ità restò solo due anni perché egli voleva <strong>un</strong>a residenza propria e<br />
definitiva.<br />
La com<strong>un</strong>ità dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria poté finalmente avere <strong>un</strong>a stabile <strong>di</strong>mora il primo febbraio<br />
1872. Fu allora che per opera e il contributo anche dell’Olivari si fece acquisto della casa che,<br />
restaurata ed ampliata e vorremmo <strong>di</strong>re quasi interamente rifatta, è tuttora sede dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria.<br />
Il suo intento era quello <strong>di</strong> dare <strong>un</strong>a sistemazione tale che favorisse <strong>un</strong> regolare svolgimento<br />
della vita della com<strong>un</strong>ità, e fosse <strong>un</strong>a pietra fondante per il futuro dell’opera.<br />
Fu questo <strong>un</strong> gran passo; già si avevano piú <strong>di</strong> quaranta al<strong>un</strong>ni e la nuova abitazione<br />
rispondeva ai requisiti richiesti.<br />
Con occhio esperto in<strong>di</strong>viduò la zona e la casa, ma i padroni non la cedevano “per carità e<br />
amor <strong>di</strong> Dio”, c’era <strong>un</strong> prezzo anche molto sostenuto da pagare; ma la “carità e l’amor <strong>di</strong> Dio” si<br />
manifestarono per altra via, la via della Provvidenza; d’altronde la fede nella Provvidenza era cosí<br />
forte, che nonostante la mancanza <strong>di</strong> cespiti, anche nei momenti piú critici, non mancarono mai gli<br />
aiuti per andare avanti.<br />
La zona <strong>di</strong> Carignano era veramente splen<strong>di</strong>da e ridente, anche se aveva <strong>un</strong> aspetto<br />
campestre. Pochi erano i palazzi antichi con alc<strong>un</strong>e palazzine piú modeste ad uso <strong>di</strong> villeggiatura.<br />
«A picco sul mare sorgeva l’antica chiesa <strong>di</strong> San Giacomo là dove ora è il poggio “Giovane Italia”,<br />
chiesa squallida e romita, <strong>un</strong> tempo ufficiata dai monaci agostiniani e solo piú tar<strong>di</strong> eretta in<br />
parrocchia. Due sole viuzze silenziose e deserte confluivano a breve <strong>di</strong>stanza dal sagrato della<br />
chiesa ombreggiato <strong>di</strong> alberi secolari, convergenti <strong>un</strong>a da via Rivoli e l’altra da via Galeazzo Alessi.<br />
Sul colle <strong>di</strong> Carignano la sontuosa Basilica dell’Ass<strong>un</strong>ta faceva contrasto con i <strong>di</strong>ntorni villerecci …<br />
Su <strong>un</strong>a delle viuzze che conducevano a San Giacomo c’era via Ginevra che, nel secondo tratto, era<br />
chiamata via Ginevrina; qui sorgeva <strong>un</strong>a modesta palazzina <strong>un</strong> tempo forse non spregevole, <strong>come</strong><br />
risulta dalle sale che allora costituivano il pianterreno, decorate da lesene e cornici <strong>di</strong> pietra<br />
verniciata a nero» 19 .<br />
II P. Antonio Piccardo con Don G. B. Semino ed i signori Giuseppe Canale, Antonio Guano<br />
e Pietro Olivari fece il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta il primo febbraio 1872 con il proprietario marchese<br />
Lorenzo Centurione fu Carlo dello stabile “palazzo” con casa colonica e villetta attigua. Alla data<br />
dell’acquisto la palazzina era <strong>di</strong>visa in parecchi piccoli appartamenti; dopo gli adattamenti piú<br />
urgenti e in<strong>di</strong>spensabili vi furono trasferiti gli al<strong>un</strong>ni. Tutto era ancora <strong>un</strong> po’ ristretto, ma<br />
finalmente i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria potevano <strong>di</strong>re: siamo in casa nostra.<br />
Con il trasferimento dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria in questa nuova sede, l’istituzione poteva <strong>di</strong>rsi uscita<br />
dall’infanzia.<br />
febbraio 1872 in via Ginevrina (Jacopo Ruffini, l’attuale Istituto Piccardo)<br />
19 BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 16-17.
10<br />
Nel 1873 gli al<strong>un</strong>ni erano abbastanza numerosi, <strong>un</strong> po’ <strong>di</strong> tutte le classi, dalle ginnasiali alla<br />
teologia; le ginnasiali si facevano alla meglio in casa, essendo pochi gli al<strong>un</strong>ni ed improvvisati i<br />
maestri, in compenso esisteva <strong>un</strong> grande impegno negli <strong>un</strong>i e negli altri. Per la filosofia e la teologia<br />
i giovani frequentavano <strong>come</strong> esterni il Seminario.<br />
Aveva forse il Piccardo preparato la sua sistemazione? Il racconto della sua vita non ci<br />
<strong>di</strong>pinge <strong>un</strong> uomo né seduto, né auto-centrato.<br />
Questo passo dava il senso <strong>di</strong> “qualcosa” in cui c’era la mano del Signore.<br />
Sul portone <strong>di</strong> ingresso <strong>di</strong> via Ginevrina stava la scritta che esiste tuttora: “Auspiciis firmata<br />
novis” sormontata dal monogramma del nome <strong>di</strong> Gesú collocato ai tempi <strong>di</strong> San Bernar<strong>di</strong>no da<br />
Siena. Quale miglior auspicio o meglio quale miglior profezia?
11<br />
UOMO DAI RAPPORTI FORTI<br />
Padre Piccardo proveniva da <strong>un</strong>a famiglia <strong>un</strong>ita, che, secondo i parametri o<strong>di</strong>erni, bastava a<br />
se stessa: affetti, coesione, risorse, considerazione erano le note che la caratterizzavano. Eppure egli<br />
sperimentò <strong>un</strong> allargamento del cuore nell’entrare nel piccolo mondo dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria. La sua<br />
nuova famiglia erano quei giovani che volevano <strong>di</strong>ventare sacerdoti, ma non ne avevano i mezzi;<br />
nonostante la sua nobile origine, la ieraticità, l’autorevolezza seppe farsi piccolo con i piccoli e<br />
povero con i poveri.<br />
Questo suo atteggiamento era certamente dettato dalla fede: egli non si percepiva <strong>come</strong><br />
protagonista ma <strong>come</strong> semplice strumento nelle mani <strong>di</strong> Dio; tuttavia sembra abbastanza provato<br />
che la sua ricchezza <strong>di</strong> umanità lo facesse sentire vicino a chi si accostava a lui con schiettezza e<br />
semplicità.<br />
Le relazioni umane si concretizzano nei sentimenti che, <strong>come</strong> in <strong>un</strong> caleidoscopio<br />
interagiscono tra loro e arrivano a quelle <strong>di</strong>mensioni interiori che attraversano il vivere umano,<br />
creando <strong>un</strong> insieme variegato <strong>di</strong> luci e ombre, <strong>di</strong> felicità e insicurezza.<br />
Una delle aspirazioni basilari del cuore umano è <strong>di</strong> essere abitato dal sentimento<br />
dell’amicizia, manifestazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a natura elevata e fonte <strong>di</strong> gioia.<br />
L’amicizia è <strong>un</strong>’esperienza umana con molti gra<strong>di</strong> e sfumature: possono infiltrarsi elementi<br />
emotivi, razionali e perfino narcisistici, ma può essere anche <strong>di</strong> lega pura, <strong>di</strong> oro a <strong>di</strong>ciotto carati e<br />
anche se con qualche imperfezione, <strong>come</strong> ogni realtà terrena, riflesso <strong>di</strong> <strong>un</strong>’immagine e <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
riflesso ultraterreno.<br />
Per Padre Piccardo l’amicizia aveva <strong>un</strong> valore pregiato e rimase in lui salda malgrado il<br />
passare degli anni.<br />
Con i suoi compagni <strong>di</strong> liceo mantenne sempre vivi contatti. Con Urbano Rattazzi «strinse<br />
<strong>un</strong>’amicizia che doveva perdurare tutta la vita, fino ad aver confortato religiosamente gli ultimi<br />
istanti del suo con<strong>di</strong>scepolo, che era salito al grado <strong>di</strong> ministro della Casa Reale … Altro suo<br />
con<strong>di</strong>scepolo fu il marchesino Cattaneo. Anche <strong>di</strong> lui il Piccardo fu molto amico, <strong>come</strong> lo fu pure <strong>di</strong><br />
altri con<strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong> piú modeste fort<strong>un</strong>e e che, occorrendo, soccorse» 20 .<br />
Questo suo naturale atteggiarsi lo rendeva capace <strong>di</strong> parlare da uomo a uomo, perché partiva<br />
dalla spontaneità dell’animo, <strong>come</strong> anche si constata in <strong>un</strong>a lettera <strong>di</strong> <strong>un</strong> certo Ernesto Sinanga, <strong>di</strong><br />
cui riportiamo <strong>un</strong> brano.<br />
«Quello che mi piace nella sua risposta è quel tenore <strong>di</strong> calma, <strong>di</strong> serenità d’animo, <strong>di</strong><br />
tolleranza veramente cristiana … Questo atteggiamento da parte sua, del resto, me lo aspettavo, ben<br />
conoscendo il suo cuore retto e la sua mente illuminata» 21 .<br />
L’attenzione all’altro si coglie anche nelle lettere confidenziali, nelle quali <strong>di</strong>mostra<br />
affettuoso interessamento alla vita quoti<strong>di</strong>ana dell’interlocutore, a cui chiede notizie <strong>di</strong> persone<br />
conosciute e si informa della salute e cose varie.<br />
20 BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 10.<br />
21 Archivio FSMI, Roma.
12<br />
Non sono molte tali lettere e non perché tante siano state smarrite, quanto perché, nonostante<br />
che avesse in grande stima l’amicizia, e <strong>di</strong> amici ne avesse veramente tanti, era molto <strong>di</strong>screto nelle<br />
frequentazioni amicali.<br />
Nel suo ministero Padre Piccardo è entrato in relazione con anime gran<strong>di</strong> con cui ha<br />
con<strong>di</strong>viso l’affinità spirituale, la coincidenza nel pensare e nel sentire e la vicinanza umana. Sono<br />
questi i fondamenti dell’amicizia, dono prezioso che la vita elargisce e che lo ha accompagnato tutta<br />
la vita.<br />
Si tratta <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>i personaggi illustri in vita e <strong>di</strong> altri senza grande rilievo quando erano vivi<br />
ma che sono stati onorati dopo morte con gli onori degli altari. Elenchiamo brevemente: San<br />
Giovanni Bosco, che incontrò varie volte e con il quale con<strong>di</strong>vise preoccupazioni e aspettative, il<br />
Beato Michele Rua, il Beato Giacomo Alberione, San Luigi Orione, il car<strong>di</strong>nale Svampa.<br />
Padre Piccardo venne accolto a Roma da Mons Francesco Faberi e da lui ritenuto l’uomo<br />
giusto, provvidenziale, ed epigraficamente lo ritrasse cosí: “quello è <strong>un</strong> sacerdote genovese che vale<br />
tanto oro quanto pesa”.<br />
Mons. Faberi (07/01/1869 – 04/01/1931) viene nominato il 19 ottobre 1903 Direttore delle<br />
opere spirituali a Sant’Apollinare quin<strong>di</strong> Prefetto degli ecclesiastici studenti esterni in Roma e nel<br />
successivo 20 ottobre 1904 Segretario del Vicariato sempre dal Car<strong>di</strong>nale Respighi, ufficio che<br />
ricoprirà sino alla nomina <strong>di</strong> canonico <strong>di</strong> S. Pietro l’8 marzo 1915.<br />
Come scrive Padre Antonio Giuseppe Piccardo: il Faberi fu per i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria il Delegato<br />
del Vicariato, il Consigliere illuminato, il <strong>padre</strong> autorevole, l’eccitatore <strong>di</strong> energie. Nei primi passi<br />
dell’Istituto egli fu, si può ben <strong>di</strong>re, <strong>come</strong> <strong>un</strong> <strong>padre</strong> che per benigna <strong>amorevole</strong>zza del Santo Padre<br />
Pio X poté accelerare il suo definitivo costituirsi. Soleva ripetere con tenerezza:”Nolite timere,<br />
pusillus grex…”. La Congregazione fin dall’inizio e pur dopo aver lasciato il Vicariato fu sempre<br />
ininterrottamente <strong>un</strong>o degli oggetti più cari al suo cuore.<br />
Egli ebbe, e ne fu ricambiato, venerazione e stima per Padre Piccardo in misura tutta<br />
speciale cosí scriveva in occasione della sua morte: “Sono davvero commosso per il dolore che ha<br />
cagionato ai suoi confratelli ed a me per la gratitu<strong>di</strong>ne che sento verso <strong>di</strong> lui che mi ha dato <strong>un</strong>a<br />
cosí tenera prova <strong>di</strong> affetto volendomi considerare primo fra gli amici cui legava <strong>un</strong> suo ricordo. Di<br />
tutto il bene fatto <strong>come</strong> <strong>di</strong> quello che abbiamo sofferto insieme sento il dovere <strong>di</strong> ringraziare il<br />
Signore.”<br />
Dove l’<strong>un</strong>ione degli animi ha toccato <strong>un</strong> suo apice è nella relazione con Monsignor Giacomo<br />
Ghio: l’amicizia era <strong>un</strong>a forza per fomentare rapporti <strong>di</strong> reciprocità e fiducia, per l’apertura <strong>di</strong> sé<br />
all’altro, per la partecipazione alle gioie e sofferenze, ai successi e fallimenti.<br />
Monsignor Giacomo Ghio era <strong>un</strong> animo avvezzo alla delicatezza dell’amicizia e della<br />
fraternità. Egli era legato da <strong>un</strong> affetto filiale e profondo con il Prevosto della Basilica <strong>di</strong> San<br />
Lorenzo Mons. Alimonda. Il Ghio parlando <strong>di</strong> lui afferma: “Huic ego homini tantum debeo,<br />
quantum homo homini vix debere fas est”. L’Alimonda fu eletto vescovo <strong>di</strong> Savona ed «egli sentí<br />
vivamente la lontananza dell’Alimonda … ma Id<strong>di</strong>o, nel mentre lo privava <strong>di</strong> colui che era stato il<br />
sostegno della sua fanciullezza, gli faceva acquistare <strong>un</strong> altro <strong>padre</strong> nella persona del Rev. Antonio<br />
Piccardo, il continuatore del Frassinetti, il quale gli aprí le porte della Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria in
13<br />
Carignano e lo circondò <strong>di</strong> affetto e <strong>di</strong> premure. L’istituzione cominciava allora a dare i primi frutti,<br />
ed egli vi trovò <strong>un</strong>a nuova famiglia, dei Superiori premurosi e dei compagni affezionati» 22 .<br />
Terminato il servizio militare nell’ottobre del 1882 fu accolto «<strong>di</strong> nuovo nella Casa dei <strong>Figli</strong><br />
<strong>di</strong> Maria per attendere al compimento degli stu<strong>di</strong> teologici … Il Superiore, don Piccardo, ben presto<br />
lo nominò prefetto affidandogli la sorveglianza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a camerata» 23 . «La prima messa la celebrò<br />
nella Cappella dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria tra la gioia intima dei Superiori e dei compagni» 24 .<br />
Tra amici non ci si vergogna <strong>di</strong> chiedere e <strong>di</strong> offrire anche ciò che è necessario alla<br />
sopravvivenza e che normalmente si suppone in possesso <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong>o. Quando fu destinato vice<br />
parroco a San Cipriano <strong>di</strong> Val Polcevera, non sfuggí all’occhio vigile <strong>di</strong> Padre Piccardo, che il<br />
nuovo vice-parroco, pur avendo <strong>un</strong>a sede, <strong>di</strong> fatto “non aveva pietra dove posare il capo”; e allora il<br />
suo superiore-amico gli mandò al seguito <strong>un</strong> carro con i mobili che sarebbero serviti per<br />
“alloggiarsi” piú decentemente 25 .<br />
Padre Giovanni Vaccari in <strong>un</strong> <strong>di</strong>scorso commemorativo, in occasione del cinquantesimo<br />
della Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata apre <strong>un</strong>o spiraglio da cui si intravvede<br />
quale fraterna relazione piena <strong>di</strong> fiducia esisteva tra Padre Piccardo e Mons. Ghio: «È qui doveroso<br />
aggi<strong>un</strong>gere <strong>un</strong> nuovo nome a quelli dei consiglieri <strong>di</strong> Don Piccardo, ossia quello <strong>di</strong> Don Giacomo<br />
Ghio, Arciprete <strong>di</strong> Sori, presso cui il Direttore, dopo aver lasciato il Seminario, alternava la sua<br />
residenza con quella dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria a Genova: presso Don Ghio a Sori, Don Piccardo accoglieva<br />
quanti dovevano riferire o illuminarlo sulle questioni che erano collegate colla erezione della<br />
Congregazione» 26 .<br />
Mons. Ghio avrebbe voluto seguire il suo <strong>di</strong>rettore tra i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria e vivere e con<strong>di</strong>videre<br />
con lui opere e ideali che risaltavano com<strong>un</strong>i a tutti e due. Il perché non si sia <strong>un</strong>ito a lui è<br />
raccontato in alc<strong>un</strong>i cenni biografici.<br />
«Era questi Mons. Vincenzo Persoglio, parroco <strong>di</strong> S. Torpete, che gli era stato assegnato per<br />
confessore dall’Alimonda, fin dall’età <strong>di</strong> quattor<strong>di</strong>ci anni, e che poi continuò a confessarlo anche da<br />
sacerdote e da parroco. Egli, che conosceva bene tutti segreti del suo cuore gli chiese:<br />
-Perché vuoi farti religioso?<br />
-Per fare santo me e santificare gli altri - egli rispose.<br />
-Ebbene, quando è cosí – ripigliò Mons. Persoglio - potete farlo piú e meglio restando al<br />
servizio della Diocesi.<br />
Ma egli insisteva e allora Mons. Persoglio <strong>di</strong>sse:<br />
-Credetelo a me: <strong>un</strong> buon sacerdote può fare maggior bene che <strong>un</strong> religioso» 27 .<br />
Il sacerdote Giacomo Ghio fu nominato e consacrato vescovo <strong>di</strong> Urbino, «e <strong>di</strong> lui va oggi<br />
giustamente orgoglioso il venerando Padre Piccardo, che nel suo primo collegio gli fu Direttore e<br />
<strong>padre</strong>, e con lui esultano i maestri e i compagni sacerdoti già al<strong>un</strong>ni dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, che nella<br />
elezione <strong>di</strong> Mons. Ghio … sentono onorata tutta la famiglia, che oggi si stringe in lietissima festa<br />
22<br />
GHIO G., Mons. Giacomo Ghio, Scuola Tipografica Derelitti, Genova 1937, 30.<br />
23<br />
Ibid., 32.<br />
24<br />
Ibid., 33.<br />
25<br />
Ibid., 36.<br />
26<br />
Archivio FSMI, Roma, Nella luce del Motu Proprio <strong>di</strong> Pio X. 21 giugno 1904.<br />
27<br />
GHIO G., Mons. Giacomo Ghio, Scuola Tipografica Derelitti, Genova 1937, 31.
14<br />
intorno al suo primo vescovo, <strong>come</strong> in festa si vedrebbe <strong>un</strong>a famiglia alla glorificazione <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
figlio» 28 . Le loro vie si <strong>di</strong>varicarono ma i loro animi rimasero <strong>un</strong>iti.<br />
Il rapporto che <strong>un</strong>iva Pio X e Padre Piccardo era <strong>di</strong> antica data: si erano conosciuti a<br />
Genova, quando ancora Giuseppe Sarto non era insignito della <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> Vescovo <strong>di</strong> Roma, si può<br />
<strong>di</strong>re che la loro amicizia era cresciuta lentamente <strong>come</strong> lentamente si era generata e reciprocamente<br />
offerta. Essa era fondata su sentimenti <strong>di</strong> mutua stima spirituale e <strong>di</strong> profondo rispetto religioso. Ma<br />
<strong>di</strong> questo si parlerà piú avanti.<br />
28 L. BOGGIANO, Mons. Ghio e la Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, pro manuscripto, Archivio Parrocchiale <strong>di</strong> Bosio (Alessandria)
15<br />
P. PICCARDO, UOMO DI PREGHIERA<br />
P. Carlo Olivari con <strong>un</strong>a felice pennellata tratteggia il desiderio fervido che muoveva P.<br />
Piccardo nel suo agire, il suo zelo nel fare i bene, la decisione interiore che non si sgomenta <strong>di</strong><br />
fronte ai gran<strong>di</strong> pesi che gravano sulle sue spalle: «Non fu vita <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o la sua; fu vita d’azione» 29 .<br />
Facilmente questa lapidaria descrizione trova il consenso dei piú, perché è <strong>un</strong>a mentalità dominante<br />
quella che afferma che ciò che conta è l’azione, il lavoro per cambiare le strutture <strong>di</strong> ingiustizia e <strong>di</strong><br />
iniquità sia nella società che nella Chiesa.<br />
Nel linguaggio corrente, al primato dell’azione si contrappone la contemplazione; eppure<br />
contemplazione e azione si compenetrano profondamente tra loro. Alla concentrazione interiore non<br />
fa contrasto l’azione ma la <strong>di</strong>strazione, che è <strong>un</strong>a azione deviata a causa del fine sbagliato oppure<br />
perché <strong>di</strong>fforme da <strong>un</strong>a misura equilibrata. P. Piccardo era <strong>un</strong>a persona attiva, che affrontava ogni<br />
sacrificio, che si immergeva nei problemi, si lasciava coinvolgere dall’operosità pur <strong>di</strong> fare <strong>un</strong> po’<br />
<strong>di</strong> bene.<br />
Secondo <strong>un</strong> certo modo <strong>di</strong> sentire, la preghiera, fardello <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zione e consolante inutilità si<br />
può consentire a persone ormai inattive e senza influsso. Non era cosí per Padre Piccardo: la sua<br />
vita infaticabile e spesso con piú <strong>di</strong>more, che richiamano <strong>un</strong> continuo peregrinare, era interiormente<br />
caratterizzata da <strong>un</strong>a tranquilla stanzialità e in<strong>di</strong>rizzata perciò ad <strong>un</strong>a riflessione e contemplazione<br />
serena degli avvenimenti della Chiesa, della Congregazione e della sua vita, nella continua<br />
conquista della pacificazione interiore.<br />
La sua preghiera continua, che sviluppava sui grani del rosario 30 , richiama il carisma mistico<br />
del Frassinetti, autentico uomo <strong>di</strong> preghiera. È <strong>come</strong> se Padre Piccardo avesse ass<strong>un</strong>to su <strong>di</strong> sé il<br />
ministero della preghiera; era fonte <strong>di</strong> ammirazione vederlo pregare, quasi entrare in quel luogo<br />
segreto del cuore nel quale si trovava <strong>di</strong> fronte a Dio, anzi notare che app<strong>un</strong>to lí, lui <strong>di</strong>morava<br />
abitualmente.<br />
La sua vita era animata da <strong>un</strong>a soda spiritualità e dallo spirito <strong>di</strong> <strong>un</strong>a genuina pietà; da qui<br />
prendeva le mosse la preghiera e la vita <strong>di</strong> devozione che inculcava ai suoi al<strong>un</strong>ni.<br />
«In lui vi era spirito <strong>di</strong> preghiera che gli faceva considerare ogni cosa in quella visione<br />
soprannaturale che è propria dei santi, per cui non era ritardato dai beni, né abbattuto dai mali del<br />
tempo: spirito <strong>di</strong> preghiera che si manifestava in tanti mo<strong>di</strong>, che si traduceva nel suo contegno<br />
esterno, che irra<strong>di</strong>ava dal suo volto» 31 .<br />
Risulta dalle testimonianze che lui, nella maturità spirituale, aveva scelto <strong>come</strong> modello la<br />
preghiera fidente e la fede robusta che vedeva trasparire nella persona del Papa Pio X; egli era saldo<br />
tra i vorticosi sconvolgimenti della società: lo possiamo immaginare situato al centro <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
carosello, che, nonostante le pressioni <strong>di</strong> depistaggio, non perde l’orientamento e non viene falsata<br />
la bussola del desiderio sempre orientata al nord o meglio allo zenit.<br />
La gratitu<strong>di</strong>ne verso Dio sorgeva spontanea nelle parole e nel cuore <strong>di</strong> Padre Piccardo. «Se è<br />
d’obbligo <strong>di</strong> tutti ringraziare il Signore per i tanti benefici che ci comparte, quanto a noi piú<br />
29<br />
OLIVARI C., P. Piccardo e i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, Ed. Risonanze, Roma<br />
2004, 89.<br />
30<br />
P. PAPI, P. Antonio Piccardo, Roma 1994, 32.<br />
31<br />
G. GHIO, Nel ricordo della sua morte, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, Ed. Risonanze, Roma 2004,74.
16<br />
incombe questo dolcissimo dovere. A noi che da Lui piú <strong>di</strong> tanti altri abbiamo sperimentato favori e<br />
grazie!» 32<br />
«In tutte le Case abbia luogo <strong>un</strong>a particolare f<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> ringraziamento» 33<br />
La preghiera <strong>di</strong> ringraziamento è continuamente presente nelle sue esortazioni. È vero: essa<br />
si rivolge al passato per i doni ricevuti, per la generosità elargita dall’alto, è retrospettiva e nasce<br />
dalla memoria e fa sorgere riconoscenza, ma apre anche al futuro e alla speranza.<br />
«Rivolgiamoci al Signore, alla nostra celeste Patrona Maria Santissima Immacolata, al<br />
nostro Protettore San Giuseppe, affinché bene<strong>di</strong>cano le nostre intenzioni e tutte le <strong>di</strong>rigano al fine<br />
supremo ed <strong>un</strong>ico della gloria <strong>di</strong> Dio e della salute delle anime» 34 . La preghiera <strong>di</strong> azione <strong>di</strong> grazie<br />
si configura <strong>come</strong> la <strong>di</strong>mensione tipica del vivere cristianamente e religiosamente il presente.<br />
Padre Piccardo educava alla preghiera; egli era tramite della trasmissione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a densità<br />
spirituale <strong>di</strong> cui il suo animo rigurgitava, e non poteva non com<strong>un</strong>icare. Nella Pia Casa «sono<br />
fiorenti tre devozioni, tre forze vive dalle quali quei cari figlioli si sentono presi e innamorati: la<br />
devozione alla Santissima Eucarestia, la devozione alla Madonna Immacolata e <strong>un</strong> grande amore al<br />
Papa. Quanta luce, quanta forza scende ai loro giovani cuori <strong>di</strong>nanzi al quel grazioso altare della<br />
linda Cappella, sotto lo sguardo materno e la bene<strong>di</strong>zione della Madonna sorridente dall’alto della<br />
sua nicchia» 35 .<br />
«Ma da quanta preghiera era sostenuto! Egli scrisse: - Pregai, pregai <strong>di</strong> cuore, raccomandai<br />
tutti i membri della nostra Congregazione, tutti gli al<strong>un</strong>ni <strong>di</strong> tutte le Case, tutti i nostri collaboratori.<br />
Ma in modo speciale raccomandai la Congregazione … pregai molto piú per me» 36 .<br />
Con la preghiera <strong>di</strong> domanda l’orante sublima il suo bisogno e lo trasforma in desiderio, crea<br />
attesa affidandosi all’Altro. Essa <strong>di</strong>venta vivida e pressante nei momenti <strong>di</strong> incertezza e <strong>di</strong><br />
sofferenza.<br />
In molte circostanze <strong>di</strong> cambiamenti profon<strong>di</strong> e in particolare nell’ultima l<strong>un</strong>ga prova, con<br />
l’aiuto della preghiera è riuscito a comporre la sua nuova situazione con la fede, sicuro che le<br />
tenebre non sono l’assenza ma solo il nascon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> Dio. Padre Piccardo non ha avuto nemmeno<br />
bisogno <strong>di</strong> <strong>un</strong>’azione <strong>di</strong> ritrovamento del centro, perché <strong>di</strong> fatto nel centro è rimasto sempre situato,<br />
attaccato com’era all’essenziale della vita.<br />
«Quante procelle non urtarono contro la sua navicella nel corso della sua l<strong>un</strong>ga navigazione,<br />
fino a minacciare il naufragio! La sua fede, la sua preghiera, la fortezza sempre lo salvarono» 37 .<br />
La sofferenza non è <strong>un</strong> tormento in<strong>di</strong>viduale, mitigato ogni tanto da consolazioni, talvolta<br />
solo metaforiche, ma segno <strong>di</strong> vita e garanzia che l’opera <strong>di</strong> cui il “sofferente” è protagonista,<br />
poggia su <strong>un</strong>a realtà gran<strong>di</strong>osa <strong>come</strong> è quella della Croce. La preghiera <strong>di</strong> Padre Piccardo trovava la<br />
32<br />
Circolari dei Padre Generali, Circolare n. 5, Archivio FSMI, Roma.<br />
33<br />
Circolari dei Padre Generali, Circolare n. 8, Archivio FSMI, Roma.<br />
34<br />
Circolari dei Padre Generali, Circolare n. 2, Archivio FSMI, Roma.<br />
35<br />
CHIESA G., Il ritorno alla casa <strong>madre</strong>, , in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, Ed. Risonanze, Roma 2004,<br />
142.<br />
36<br />
PISONI T., Lettere ai confratelli, pro manuscripto, Roma 2009, 21.<br />
37<br />
GHIO G., L’uomo forte, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, Ed. Risonanze, Roma 2004, 10-101.
17<br />
sua collocazione nell’<strong>un</strong>ione con la preghiera silenziosa <strong>di</strong> Gesú sulla montagna e nella notte buia<br />
dell’Orto del Getsemani, portando su <strong>di</strong> sé non solo il suo ma anche il peso <strong>di</strong> tutti i confratelli.<br />
Il quattro giugno 1910 Sua Santità Pio X, ci racconta lo stesso Padre Piccardo, «nella sua<br />
speciale benevolenza, che si degna <strong>di</strong> concederci, aderendo al voto della Congregazione Plenaria<br />
dei Religiosi, tenutasi in Vaticano il tre giugno, festa del Sacratissimo Cuore <strong>di</strong> Gesú, concedeva il<br />
Decreto <strong>di</strong> approvazione definitiva del nostro Istituto e l’approvazione ad sexennium delle nostre<br />
Costituzioni» 38 . Quel giorno o meglio la solennità del Sacro Cuore è considerata da Padre Piccardo<br />
“memoriale” per tutta la Congregazione. Nei suoi scritti, in molti tratti, il Cuore <strong>di</strong> Gesú è il<br />
meeting-point, l’angolo <strong>di</strong> preghiera, cioè quel luogo segreto in cui la vita sacerdotale e religiosa<br />
trova la opport<strong>un</strong>a collocazione.<br />
«In tutta la Congregazione si faccia <strong>un</strong>a f<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> ringraziamento col canto del Te Deum.<br />
Raccomando poi che sia sempre conservata viva la memoria dei giorni tre e quattro giugno <strong>come</strong> <strong>di</strong><br />
date particolarmente memorabili nella storia della Congregazione» 39 .<br />
«Dalla devozione del Cuore <strong>di</strong> Gesú dobbiamo aspettarci ogni bene per ciasched<strong>un</strong>o <strong>di</strong> noi,<br />
per le nostre Case e per tutta la Congregazione … Fratelli, ho richiamato alla memoria mia e alla<br />
vostra queste promesse, per eccitarvi sempre piú nella devozione al Sacro Cuore, fonte <strong>di</strong> grazie e <strong>di</strong><br />
ogni bene<strong>di</strong>zione» 40 .<br />
La preghiera e la celebrazione della festa del Sacro Cuore aiutano ad aprire la mente<br />
all’orizzonte della preghiera <strong>di</strong> Gesú per <strong>di</strong>ventare simili al suo cuore pieno <strong>di</strong> mitezza e <strong>di</strong><br />
misericor<strong>di</strong>a.<br />
38 PICCARDO A., Circolari dei Padre Generali, Circolare n. 3, 21 giugno 1910, Archivio FSMI, Roma.<br />
39 PICCARDO A., Circolari dei Padre Generali, Circolare n. 3, 21 giugno 1910, Archivio FSMI, Roma.<br />
40 PICCARDO A., Circolari dei Padre Generali, Circolare n. 4, 21 giugno 1911, Archivio FSMI, Roma.
18<br />
CON I SUOI COMPAGNI<br />
Nella Pia Casa si viveva <strong>un</strong>’atmosfera <strong>di</strong> famiglia, Padre Piccardo e i suoi collaboratori<br />
erano “<strong>un</strong>um corpus”: era questo <strong>un</strong>o stile <strong>di</strong> vita non precisamente <strong>un</strong>a struttura giuri<strong>di</strong>ca. Questo<br />
senso <strong>di</strong> <strong>un</strong>ità è <strong>un</strong>a realtà che rimane anche se dal gruppo si stacca <strong>un</strong>a figura in particolare, <strong>un</strong> po’<br />
<strong>come</strong> la testa dal corpo.<br />
La capacità e l’anima <strong>un</strong>itiva era favorita dalla spontanea generosità, accresciuta dalla<br />
nobiltà dello scopo e dalla verde speranza <strong>di</strong> <strong>un</strong>o sviluppo che si prospettava.<br />
La spinta <strong>di</strong> gruppo, anche se si trattava <strong>di</strong> <strong>un</strong>’energia che innescava altre energie, non è la<br />
spiegazione in sé sufficiente, perché essa è generalmente fondata sull’entusiasmo, che è <strong>di</strong> sua<br />
natura non razionale e temporaneo. Un’altra è la ragione della propria adesione al gruppo e della<br />
fedeltà al suo ass<strong>un</strong>to, ed essa ha la ra<strong>di</strong>ce in quella scelta personale che si chiama vocazione.<br />
I <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria viventi in com<strong>un</strong>e si erano praticamente fusi con la “Pia Casa per<br />
l’avviamento dei ragazzi poveri agli stu<strong>di</strong> ecclesiastici”, ed erano rimasti a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> questa<br />
opera che si delineava ar<strong>di</strong>ta sotto l’aspetto ideale e ancor piú sotto quello economico.<br />
Ad essi si affiancavano altri, che o provenivano dalle fila dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria o erano stati<br />
collaboratori e ammiratori del Frassinetti. Si dovette provvedere, <strong>come</strong> era ben giusto, alla scuola <strong>di</strong><br />
quei giovinetti e non mancarono sacerdoti che ne <strong>di</strong>vennero i maestri; quando e per quanto fu<br />
possibile essi risedettero nella Casa <strong>di</strong> Carignano per con<strong>di</strong>videre non solo la scienza ma anche la<br />
vita e lo spirito.<br />
Soprattutto all’inizio, chi entrava nella Pia Casa doveva già appartenere alla Pia Unione dei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata. Se questo principio era valido per gli al<strong>un</strong>ni altrettanto lo era per i<br />
maestri e gli adulti, <strong>di</strong> cui facevano parte anche i primi <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria viventi in com<strong>un</strong>e.<br />
I riti <strong>di</strong> ammissione al noviziato e alla Pia Unione, che supponevano il voto <strong>di</strong> castità e la<br />
promessa <strong>di</strong> povertà e <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza, erano il vincolo <strong>di</strong> reciproca appartenenza; questi voti<br />
avevano <strong>un</strong> valore puramente privato, <strong>come</strong> <strong>un</strong> reciproca garanzia “ad uso interno” della com<strong>un</strong>e<br />
scelta <strong>di</strong> vita.<br />
Non si può ancora parlare <strong>di</strong> com<strong>un</strong>ità, soprattutto se con tale locuzione si intende <strong>un</strong>a<br />
struttura <strong>di</strong> carattere formale, tuttavia essi formavano <strong>un</strong> “corpus” originale.<br />
I can<strong>di</strong>dati al sacerdozio, provenienti, all’inizio dalla Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, per<br />
prepararsi all’Or<strong>di</strong>nazione vivevano ora sotto <strong>un</strong> solo tetto. Si può <strong>di</strong>re che si realizzava cosí la<br />
prospettiva del Frassinetti, che aveva tutta l’aria della profezia. Ci racconta “Il documento”:<br />
«Nell’estate o nell’aut<strong>un</strong>no 1865 il buon Priore, <strong>di</strong>verse volte, intrattenne la pia <strong>un</strong>ione <strong>di</strong>scorrendo<br />
del progetto <strong>di</strong> impiantare la Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, facendo l’invito a chi volesse entrarvi, <strong>di</strong>cendo<br />
all’incirca cosí: -Voi che siete dei bravi giovani, che avete maturo giu<strong>di</strong>zio non abbraccerete il<br />
progetto <strong>di</strong> entrare in <strong>un</strong>a Casa per vivere <strong>un</strong>iti in santa carità, con maggior perfezione facendo vita<br />
com<strong>un</strong>e e, se Dio vi chiamasse, facendovi preti?» 41<br />
La Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria era la Casa <strong>di</strong> Padre Piccardo; «in essa egli era <strong>come</strong> <strong>un</strong> piccolo<br />
re, e re assoluto, perché tutto <strong>di</strong>pendeva da lui e tutto a lui si riferiva; ma era <strong>un</strong> regno paterno il<br />
41 Lettera <strong>di</strong> Don Bernardo Rosina a Padre Piccardo, martedí santo 1891.
19<br />
suo; i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria l’ebbero sempre <strong>come</strong> <strong>padre</strong>. Il suo sembiante <strong>di</strong>gnitoso e ad <strong>un</strong> tempo amabile<br />
incuteva rispetto, ma non scemava l’amore» 42 .<br />
Quando il novello sacerdote Antonio Piccardo nel luglio del 1868 fece l’ingresso nella Casa<br />
dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria si incontrò con Pietro Olivari. Fin dal 30 maggio 1866 egli aveva la <strong>di</strong>rezione<br />
della Pia Casa, e alternando il lavoro <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore della Tipografia della Gioventú con questo suo<br />
ufficio, aiutato dagli altri <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria viventi in com<strong>un</strong>e, riusciva, sotto la guida del Priore, a<br />
essere <strong>di</strong> buon aiuto al piccolo drappello <strong>di</strong> giovani.<br />
Dopo l’improvvisa morte del Frassinetti, rimase in dubbio se continuare ad occuparsi <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>’opera che, a lui secolare, pareva sproporzionata alle sue forze.<br />
«In questa perplessità fu incoraggiato a proseguire l’opera da Don Raffaele Frassinetti, dal<br />
Rev.mo Canonico Salvatore Magnasco, ora nostro amatissimo Arcivescovo, dal chierico Semino e<br />
da altri, ed egli docilissimo sempre a fare la volontà <strong>di</strong> Dio non oppose resistenza a quelle<br />
esortazioni, e in <strong>un</strong>’ad<strong>un</strong>anza tenutasi all’uopo, fu acclamato Superiore della piccola com<strong>un</strong>ità» 43<br />
Nel Documento leggiamo: «Si venne poi a sapere che l’Olivari aveva accettato la proposta 44 .<br />
Questo dovea essere <strong>di</strong> incoraggiamento e <strong>di</strong> buon esempio … la Divina Provvidenza aveva dato<br />
alla santa opera <strong>un</strong> tal <strong>padre</strong>, quale fu il Priore Frassinetti, da non sgomentarsi, né nella sua<br />
incubazione, per cosí <strong>di</strong>re, né nella sua infanzia. Egli poi nella persona del signor Olivari sembra<br />
abbia dato alla Casa, <strong>come</strong> è a <strong>di</strong>re, <strong>un</strong>a provvida <strong>madre</strong>» 45 .<br />
Il novello sacerdote Don Antonio Piccardo e il Signor Pietro Olivari si trovarono ad operare<br />
fianco a fianco. Fu l’incontro <strong>di</strong> due anime elette, protese alla realizzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> compito, che<br />
avevano ere<strong>di</strong>tato, e che amavano e <strong>di</strong> cui forse ancora non avevano misurato la portata.<br />
«Quando (Don Piccardo) v’entrò da prima avrebbe voluto che l’Olivari serbasse la sua<br />
qualità <strong>di</strong> Superiore, e nel refettorio tenesse il primo posto; ma è superfluo il <strong>di</strong>re che questi, cosí<br />
umile e riverente ai sacerdoti, non volle per nulla aderire alle cortesi proposte del nuovo<br />
Direttore» 46 .<br />
La loro collaborazione fu ininterrotta, gomito a gomito, non solo sul piano organizzativo e<br />
finanziario ma anche educativo: Pietro «per quel suo fine <strong>di</strong>scernimento dava talvolta giu<strong>di</strong>zio ben<br />
sicuro intorno a qualche al<strong>un</strong>no» 47 .<br />
La Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria Immacolata era casa sua; e tutti lo consideravano <strong>come</strong> <strong>padre</strong>.<br />
«Ecco perché la morte <strong>di</strong> lui ebbe tanto rimpianto tra i giovani <strong>di</strong> quel benemerito sodalizio, che ha<br />
dato già alla Chiesa genovese <strong>un</strong> eletto numero <strong>di</strong> sacerdoti, non pochi dei quali, vennero ieri a<br />
Genova, da parrocchie lontane, ove furono destinati, per associarsi ai compagni, agli amici, nel<br />
rendere <strong>un</strong>a testimonianza d’affetto al loro amico, al loro benefattore» 48 .<br />
42<br />
OLIVARI C., P. Piccardo e i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze,<br />
Roma 2004, 87.<br />
43<br />
Pietro Olivari, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004, 28.<br />
44<br />
La proposta della vita com<strong>un</strong>e<br />
45<br />
Il Documento, Archivio FSMI, Roma.<br />
46<br />
Pietro Olivari, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004, 26-27.<br />
47 Ibid, 28.<br />
48 Ibid., (Il Citta<strong>di</strong>no 30 gennaio 1891), 77.
20<br />
Egli era profondamente affezionato alla Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, aveva dato tutto se stesso<br />
per ventiquattro anni eppure «temea, chi il crederebbe? d’essere indegno <strong>di</strong> abitarvi, e pareagli<br />
d’impe<strong>di</strong>rne il buon andamento, onde avea in animo <strong>di</strong> pigliare altro soggiorno; e nella sua<br />
infermità manifestò al Canonico Semino il desiderio <strong>di</strong> farsi trasportare all’Ospedale, per non essere<br />
<strong>di</strong> sí grave <strong>di</strong>sagio ai <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, e a quelli che gli prestavan servigio; e <strong>di</strong>cea cosí davvero, che il<br />
Canonico dovette imporgli <strong>di</strong> non rinnovare piú mai cotale domanda» 49 .<br />
Non posse<strong>di</strong>amo documenti che ci permettono <strong>di</strong> esplorare quale rapporto <strong>di</strong> amicizia e <strong>di</strong><br />
collaborazione corresse tra lui e Padre Piccardo, forse a questa mancanza può supplire la lettera con<br />
la quale Padre Piccardo <strong>di</strong>ede l’ann<strong>un</strong>zio della morte: «Sí, la sventura ha colpito la nostra Casa:<br />
abbiam perduto in lui <strong>un</strong> fratello, <strong>un</strong> <strong>padre</strong>, <strong>un</strong> conforto, <strong>un</strong> sostegno, <strong>un</strong> esemplare <strong>di</strong> ogni piú<br />
eletta virtú» 50 .<br />
***<br />
Giovanni Battista Semino, ci raccontano le cronache, non era ancora seminarista quando<br />
cominciò ad aiutare Pietro Olivari dando lezione ai primi ragazzi che erano entrati nella Pia Casa;<br />
accolto poi in Seminario poté de<strong>di</strong>care minor tempo a questa opera buona ma passava tutto il tempo<br />
delle vacanze estive con loro. Fu me<strong>di</strong>atore tra il Frassinetti e il Diacono Antonio Piccardo nella<br />
ricerca <strong>di</strong> chi si prendesse a carico la <strong>di</strong>rezione della nuova opera e rimase, da sacerdote, sebbene<br />
canonico a <strong>Santa</strong> Maria Ass<strong>un</strong>ta in Carignano nella Casa con il suo compagno e amico don<br />
Piccardo, con<strong>di</strong>videndone tutte le vicende, le traversie e i successi.<br />
***<br />
Dalla canonica <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina Don Raffaele Frassinetti si mise in umile pellegrinaggio con<br />
la piccola carovana <strong>di</strong> Pietro Olivari, la sentiva <strong>come</strong> il dono, quasi la reliquia che il fratello<br />
Giuseppe aveva lasciato <strong>come</strong> ricordo. Fu accanto a Padre Piccardo; dotato, <strong>come</strong> era <strong>di</strong> facilità <strong>di</strong><br />
approccio con i giovani, profuse le sue doti a favore <strong>di</strong> quei ragazzi che, sotto la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong><br />
Piccardo, progre<strong>di</strong>vano nella pietà e nella scienza. Il Padre Piccardo pianse la sua morte, avvenuta il<br />
26 gennaio 1891: la Casa aveva perso <strong>un</strong> membro prezioso.<br />
***<br />
Padre Piccardo aveva avuto <strong>come</strong> allievo a San Giuliano <strong>di</strong> Albaro <strong>un</strong> giovanetto timido e<br />
buono e <strong>di</strong> bell’ingegno, con il candore dell’innocenza e l’amabilissima ingenuità: Giovanni<br />
Battista Mantero. Lui aveva trovato «nel giovane sacerdote Piccardo <strong>un</strong> vero <strong>padre</strong>; e questi a sua<br />
volta con quell’occhio sagace che intuiva le qualità e l’indole dei suoi figlioli, non tardò ad<br />
accorgersi che il Signore gli aveva inviato <strong>un</strong> tesoro» 51 .<br />
Or<strong>di</strong>nato sacerdote nel 1881, Padre Piccardo lo volle con sé. Oltre all’insegnamento della<br />
matematica e delle scienze, egli applicava il suo genio musicale alla preparazione <strong>di</strong> «quelle<br />
stupende Accademie letterario-musicali, che da semplici e timi<strong>di</strong> saggi com’erano dapprima,<br />
assursero spesso, piú tar<strong>di</strong>, all’altezza <strong>di</strong> vere e solenni feste d’arte» 52 . Queste accademie erano<br />
parte integrante del sistema educativo <strong>di</strong> Padre Piccardo. Egli cercò <strong>di</strong> essere all’altezza della<br />
49 Ibid., 28.<br />
50 Ibid., 59.<br />
51 CHIESA G., Il sacerdote Giovan Battista Mantero, Tip. G. Mescarello, Genova 1923, 12.<br />
52 Ibid., 9.
21<br />
fiducia che in lui riponeva il suo amato Direttore. Visse sempre nella Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria in<br />
Carignano perché si sentiva <strong>un</strong>o <strong>di</strong> loro e il loro spirito era il suo stile <strong>di</strong> vita.<br />
***<br />
Entrò nella Casa ancora adolescente P. Luigi Profumo, e «il Padre Piccardo ne andava<br />
orgoglioso, e lo considerava <strong>come</strong> <strong>un</strong>a perla della sua Casa, anzi in tutte le occasioni in cui si<br />
trattasse <strong>di</strong> comporre degli omaggi da rendere a qualche persona ragguardevole … era sempre Luigi<br />
il prescelto da lui» 53 .<br />
«Non sappiamo preciso <strong>come</strong> egli avvertisse la voce della vocazione, sappiamo però che in<br />
questo momento tanto decisivo per lui, non gli mancò l’appoggio <strong>di</strong> <strong>un</strong> gran servo <strong>di</strong> Dio, il celebre<br />
e tanto venerato Padre Antonio Piccardo, allora Direttore dell’Istituto dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria: quanto ci<br />
basta per accertarci che era <strong>un</strong>a vera chiamata del Signore» 54<br />
Divenne sacerdote nel 1882 e dopo aver frequentato la facoltà <strong>di</strong> lettere e filosofia alla Regia<br />
Università, fu maestro <strong>di</strong> retorica. L’Arcivescovo Magnasco tanto insistette, che Padre Piccardo<br />
acconsentí <strong>di</strong> inviarlo <strong>come</strong> docente <strong>di</strong> retorica al Seminario <strong>di</strong> Chiavari. Entrò nella Compagnia <strong>di</strong><br />
Gesú, ma da Gesuita non lasciò mai <strong>di</strong> sentirsi parte dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. Maria Immacolata; tra l’altro da<br />
Anagni, dove era <strong>di</strong> sede, non mancò <strong>di</strong> recarsi a Roma per essere vicino al suo Direttore negli<br />
ultimi giorni <strong>di</strong> vita.<br />
***<br />
Con lui entrò nella Compagnia <strong>di</strong> Gesú anche P. Alessandro Monti, che per molti anni fu<br />
maestro nella Pia Casa, dove anche abitava.<br />
Altri meriterebbero menzione <strong>come</strong> don Boraggini, Mons. Ghio, Don Gesino, ma dobbiamo<br />
riconoscere che la documentazione è troppo scarsa per poter dare notizie atten<strong>di</strong>bili, ma la loro<br />
presenza e la loro collaborazione è rimasta scritta nel libro della vita.<br />
***<br />
Gli è rimasto accanto fino alla morte il Padre Carlo Olivari. Egli «lasciata la famiglia, fu<br />
accolto nella Casa alla quale Don Antonio Piccardo aveva dato il suo or<strong>di</strong>namento geniale e<br />
paterno. In essa anche quelli che possedevano beni <strong>di</strong> fort<strong>un</strong>a e notevoli talenti <strong>di</strong> intelligenza non<br />
isdegnavano i lavori piú umili e faticosi col risultato che, con vera <strong>un</strong>ione <strong>di</strong> spiriti e con profonda<br />
gioia dell’animo, tutti venivano a trovarsi in casa propria» 55 .<br />
Lui stesso cosí si racconta: «Eravamo sullo scorcio del 1872, quando lo vi<strong>di</strong> la prima volta.<br />
Egli era in tutto il fiore dei suoi vent’otto anni: giovinetto io sui quin<strong>di</strong>ci mi presentavo a lui a<br />
chiedergli <strong>di</strong> essere accolto tra i suoi. Orfano e povero, piccolo e sparuto da non affidare troppo <strong>di</strong><br />
reggere a l<strong>un</strong>go agli stu<strong>di</strong>, potevo ben io aspettarmi per lo meno <strong>un</strong> cortese <strong>di</strong>niego. Eppure quel<br />
sorriso <strong>amorevole</strong> che gli era abituale temperò tosto in me quella timidezza che il suo nobile e<br />
<strong>di</strong>gnitoso contegno m'ispirava. “Ma tu sei già troppo vecchio, mi <strong>di</strong>sse celiando, per cominciare lo<br />
stu<strong>di</strong>o del latino”.<br />
53<br />
FEDI G., Cenni biografici <strong>di</strong> P. Luigi Profumo, Tip. G. Antonioli, Gazzano 1951, 9-10.<br />
54<br />
Ibid., 6-7.<br />
55<br />
GAZZALI A., P. Prof. Carlo Olivari, Tip. Moscarello, Genova 1940, 7.
22<br />
Ed io a lui, preso coraggio “Lo so: e se non comincio mai ?” M'accorsi che non avevo<br />
chiesto invano. Quel primo incontro fu il primo anello <strong>di</strong> <strong>un</strong>a catena in lui <strong>di</strong> benefizi e <strong>di</strong> riguar<strong>di</strong>,<br />
in me <strong>di</strong> gratitu<strong>di</strong>ne e d'affetto che doveva tenerci avvinti per cinquantatre anni, e che solo la morte<br />
avrebbe spezzati» 56 .<br />
***<br />
C’erano al<strong>un</strong>ni che avevano seguito il maestro ed erano rimasti con lui per con<strong>di</strong>videre la<br />
stessa vita e la stessa passione. Con lui erano <strong>un</strong> vero “corpus” e con lui alc<strong>un</strong>i con<strong>di</strong>videvano anche<br />
le nascoste aspirazioni per il futuro dell’Opera. Altri vissero con lui, <strong>come</strong> per esempio Padre<br />
Antonio Minetti, Padre Tommaso Gaggero, Padre Antonio Giuseppe Piccardo, e lo seguirono nella<br />
realizzazione del progetto della Congregazione religiosa.<br />
Non gli è mai venuta meno la fiducia e la certezza nei confronti <strong>di</strong> chi gli era vicino; essa era<br />
basata non su <strong>un</strong>a supponente fiducia nella sua persona e nelle sue capacità, ma aveva <strong>come</strong><br />
supporto la sua inclinazione all’ottimismo per l’uomo e il suo affidamento in Dio, a cui rimaneva<br />
<strong>un</strong>ito con la preghiera «e passava e ripassava, pregando, i grani del rosario che non abbandonava<br />
mai» 57 .<br />
56<br />
OLIVARI C., P. Piccardo e i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, in AA.VV., Il nostro Primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze,<br />
Roma 2004, 85-86.<br />
57<br />
P. PAPI, P. Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma, 1994, 52.
23<br />
RETTORE DEI SEMINARI<br />
A Genova esistevano ab immemorabili due seminari: il minore detto del Chiappetto e il<br />
Maggiore. Erano situati in due e<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>pendenti ed anche abbastanza <strong>di</strong>stanti tra <strong>di</strong> loro. Nel<br />
seminario, incominciando dal minore negli anni 1830-1870 avevano accesso i figli dei notabili <strong>di</strong><br />
Genova, i nuovi borghesi e in generale coloro che avevano <strong>un</strong>a posizione <strong>di</strong> rilievo nella società.<br />
Con i cambiamenti sociali che si erano operati, i venti rivoluzionari, il fervore per la ri<strong>un</strong>ificazione<br />
dell’Italia, la mentalità subiva flessioni e tendenze <strong>di</strong> mutamento <strong>di</strong> varia natura: il seminario stava<br />
<strong>di</strong>ventando accessibile a <strong>un</strong> numero maggiore <strong>di</strong> classi sociali.<br />
Proprio a Genova la presenza della Pia Casa per l’avviamento dei giovinetti poveri allo stato<br />
ecclesiastico, iniziata dal Frassinetti e <strong>di</strong> cui il Piccardo era <strong>di</strong>rettore, aveva risvegliato <strong>un</strong> vivo<br />
interesse per le nuove leve ecclesiastiche.<br />
Quando Mons. Reggio, nominato arcivescovo <strong>di</strong> Genova, pose mano alla ristrutturazione<br />
della Diocesi, <strong>di</strong>resse la sua attenzione a quello che egli considerava il cuore della sua Chiesa: il<br />
seminario. «Con la formazione culturale e intellettuale del seminario, Mons. Reggio prende a cuore<br />
e non meno, la formazione spirituale e pastorale. Per questo chiama al compito <strong>di</strong> rettore del<br />
seminario il Padre Antonio Piccardo, superiore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria e sacerdote assai stimato<br />
dall’arcivescovo per il suo spirito <strong>di</strong> pietà e <strong>di</strong> fraternità. Chiama poi <strong>come</strong> <strong>di</strong>rettore spirituale il<br />
Padre Luigi Persoglio … Queste due nomine, per la verità non comprese da alc<strong>un</strong>i sacerdoti, sono i<br />
primi segni <strong>di</strong> <strong>un</strong>a nuova ondata spirituale» 58 .<br />
«Il Padre Tommaso Olcese, <strong>di</strong> prima mano, poiché era stato segretario <strong>di</strong> Mons. Reggio,<br />
cosí evidenziava l’opera <strong>di</strong> Padre Piccardo <strong>come</strong> rettore del seminario arcivescovile <strong>di</strong> Genova<br />
(1895-1902): che la chiamata del Piccardo a Rettore del Seminario fosse <strong>un</strong>a mossa politica <strong>di</strong><br />
Mons. Reggio per <strong>di</strong>minuire la vitalità e l’importanza dell’Opera dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria lo sentii <strong>di</strong>re da<br />
molti, ma quando piú tar<strong>di</strong> andai Segretario con Mons. Reggio egli mi <strong>di</strong>chiarò in modo chiaro e<br />
categorico, <strong>come</strong> mai parlava, che il suo pensiero nei riguar<strong>di</strong> dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria era il seguente: Io<br />
chiamai, egli mi <strong>di</strong>sse, con parole che mi pare ricordare quasi esattamente, Don Piccardo a Rettore<br />
del Seminario perché mi piace lo spirito che è nei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria e perché egli lo coltivi e lo faccia<br />
fiorire anche in Seminario; e gli ho dato anche or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> chiamare ai posti <strong>di</strong> insegnamento e <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rezione che si fossero resi vacanti del personale che sia stato educato nei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria cioè dei<br />
suoi al<strong>un</strong>ni» 59 .<br />
La scelta era contrastata da <strong>un</strong>a parte del clero, che mal sopportava l’esistenza del<br />
“seminario” dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, che considerava <strong>un</strong> doppione, ma <strong>un</strong> biografo <strong>di</strong> Reggio scrive: «La<br />
scelta del Rev.mo Padre Piccardo a Rettore dei due seminari <strong>di</strong>ocesani fu oltremodo indovinata, per<br />
mezzo suo Mons. Reggio promosse nel pio Istituto quello spirito <strong>di</strong> soave fraternità, quel carattere<br />
<strong>di</strong> vita familiare, quella santa confidenza tra seminaristi e superiori, propria dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria<br />
Immacolata» 60 .<br />
La nomina fu pubblicata da “Il Citta<strong>di</strong>no” il 25 luglio, Padre Piccardo si recò a prendere<br />
possesso del piccolo seminario del Chiappeto il 17 agosto, «inoltre Mons. Reggio, gli <strong>di</strong>ede altra<br />
58 D. TETTAMANZI, Tommaso Reggio, Piemme, Casale Monferrato 2000, 140.<br />
59 FAIN BINDA L., Lettera <strong>di</strong> famiglia n° 33 del 1-12-2003.<br />
60 FALDI E., Tommaso Reggio arcivescovo <strong>di</strong> Genova, Stringa E<strong>di</strong>tore, Genova 1969, 136.
24<br />
prova <strong>di</strong> stima e <strong>di</strong> benevolenza, inviandolo a Milano <strong>come</strong> suo rappresentante al Congresso<br />
Cattolico ri<strong>un</strong>ito in quella città il 1° settembre e giorno seguente» 61 .<br />
«La nomina del Padre Piccardo risultò provvidenziale perché nella seconda metà del 1895<br />
venne alla luce <strong>un</strong> improvviso quanto increscioso incidente dovuto ad <strong>un</strong> rischio errato che privò il<br />
Seminario <strong>di</strong> tutte le sue ren<strong>di</strong>te» 62 . Scrive Padre Giacomo Chiesa: «Dovendo (P. Piccardo) essere<br />
informato dello stato economico-finanziario del Seminario, ne chiese <strong>un</strong>a relazione all’economo,<br />
che era il Rev. Emilio Paro<strong>di</strong>. Questi colto <strong>di</strong> sorpresa … pregò <strong>di</strong> voler attendere ancora <strong>un</strong> po’…<br />
Intanto il 2 gennaio (1896) l’economo scomparve, né si vide piú al suo ufficio in seminario … I<br />
fornitori esigevano <strong>di</strong> essere sod<strong>di</strong>sfatti … con l’aiuto <strong>di</strong> Dio e la sagacia del Piccardo i fornitori<br />
furono accontentati con fortissimi acconti, e in brevissimo tempo tutto fu salvato … La Provvidenza<br />
si serví del Padre Piccardo, il quale per la sua bontà, la sua saggezza e signorilità de’ suoi mo<strong>di</strong><br />
godeva molta stima in Genova, e seppe trovare aiuti generosi» 63 .<br />
«Nel luglio 1895 - scrisse Don Piccardo a P. Zucchetti in data 8 gennaio 1912 - io ricevevo<br />
da Mons. Reggio, Arcivescovo <strong>di</strong> Genova, la nomina a Rettore del Seminario e la tenni fino al<br />
luglio 1902. Prima <strong>di</strong> accettare volli essere sicuro che egli mi concedesse <strong>un</strong> Direttore Spirituale per<br />
i chierici (da notare che non vi era stato mai prima <strong>di</strong> allora la carica <strong>di</strong> Direttore Spirituale). Mi<br />
trovai <strong>un</strong> giorno nella libreria “Lanate” in Piazza San Lorenzo con P. Persoglio e gli <strong>di</strong>ssi: - In<br />
questo momento io vedo innanzi a me il Direttore Spirituale per i seminaristi. - Restò sorpreso il<br />
buon <strong>padre</strong> e mi <strong>di</strong>sse: - Sarà <strong>di</strong>fficile che io possa accettare -. Gli risposi: - Lasci fare a me che ho<br />
già avuto l’assenso dall’Arcivescovo, ora scriverò al Provinciale a Torino -. Scrissi subito ed<br />
ottenni la desiderata licenza. Era fondamentale la presenza del Direttore spirituale e con la<br />
collaborazione cor<strong>di</strong>ale ed illuminata <strong>di</strong> P. Persoglio, Don Piccardo, poté corrispondere ben<br />
degnamente alla missione a cui la Provvidenza lo aveva chiamato» 64 .<br />
Nel 1900 con l’avvento del nuovo secolo e la proclamazione del Giubileo, P. Piccardo<br />
«organizzò pellegrinaggi per i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria e i seminaristi, spronandoli a recarsi a Roma e, dove<br />
non arrivava la borsa dei suoi giovani al<strong>un</strong>ni, arrivò la sua paterna generosità» 65 . Si impegnò perché<br />
nel cortile del seminario campeggiasse in alto la statua del Divin Redentore; la festa fu solenne e<br />
lasciò nell’animo <strong>di</strong> chi ebbe la fort<strong>un</strong>a <strong>di</strong> assistervi <strong>un</strong> indelebile ricordo.<br />
Padre Piccardo ha voluto che fosse redatta la cronaca del seminario; essa è <strong>un</strong>a ricca fonte <strong>di</strong><br />
notizie della quoti<strong>di</strong>anità della vita, delle iniziative, dell’impostazione generale e degli eventi piú<br />
eccezionali. Colpisce <strong>un</strong> particolare: non c’era avvenimento lieto o triste della vita della Chiesa<br />
locale in cui non ci fosse la presenza o almeno la rappresentanza dei seminaristi; la morte dei<br />
sacerdoti è ricordata con grande rispetto e partecipazione, il Vescovo viene citato con filiale<br />
riverenza e parlando del Rettore si nota <strong>un</strong> sottofondo <strong>di</strong> <strong>amorevole</strong> rispetto 66 .<br />
“Il Citta<strong>di</strong>no” pubblicando la notizia aveva aggi<strong>un</strong>to che l’Istituzione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria «che<br />
formò sempre la pre<strong>di</strong>letta cura dell’ operosissimo Piccardo, ed ebbe sotto <strong>di</strong> lui sí grande<br />
61<br />
BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 45.<br />
62<br />
Ibid., 45.<br />
63<br />
Lettera <strong>di</strong> P. Giacomo Chiesa alla Madre Generale delle Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Marta del 23-12-1951, Archivio Generale<br />
Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Marta, Roma.<br />
64<br />
BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 47.<br />
65 Ibid., 48.<br />
66 Archivio del Seminario Maggiore, Genova.
25<br />
incremento, continuerà ad essere sotto la sua <strong>di</strong>rezione e riterrà l’alta sorveglianza delle tre case dei<br />
suoi <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria» 67 .<br />
Non tutte le voci com<strong>un</strong>que erano concor<strong>di</strong>: in particolare si <strong>di</strong>stingue <strong>un</strong>a lettera del<br />
Canonico Arciprete Enrico Bonino in<strong>di</strong>rizzata alla Sacra Congregazione degli Stu<strong>di</strong> in Vaticano in<br />
cui lamenta la sua mancata nomina a Prefetto degli Stu<strong>di</strong> e sottolinea la sua <strong>di</strong>stanza dal modo <strong>di</strong><br />
gestire il Seminario: eccesso <strong>di</strong> vacanze, personale non adatto, privilegi ecc. A questa si può<br />
contrapporre <strong>un</strong>a semplice lettera che nel 1904 (due anni erano passati da quando non era piú<br />
Rettore ed era a Roma) scrivono i seminaristi al loro vecchio Rettore: «All’amato Direttore Padre<br />
Antonio Piccardo nel giorno solenne <strong>di</strong> Pasqua mandano <strong>un</strong> augurio gli al<strong>un</strong>ni lontani. Le feste,<br />
mentre sono destinate a sollevare lo spirito a Dio, anche questo ottengono tra noi sulla terra:<br />
rendono piú sal<strong>di</strong> gli affetti domestici e stringono sempre <strong>di</strong> piú i vincoli <strong>di</strong> amore e <strong>di</strong><br />
riconoscenza. Potevamo lasciar passare <strong>un</strong>a simile occasione per attestare l’amore che nutriamo<br />
verso il nostro amato Direttore?» 68 .<br />
Duecento furono i sacerdoti presenti ai festeggiamenti del suo ottantesimo compleanno, e<br />
ciò faceva ripetere il ritornello: “O quanto lo amavano e quanti lo amavano”.<br />
Giuseppe Pierucci in <strong>un</strong>a elegia a lui de<strong>di</strong>cata cosí conclude:<br />
'' Ei fu Seminatore d' amore e <strong>di</strong> bontà.<br />
Donò gli averi ai poveri,<br />
ché a lui fu inesausto forziere l’Evangel cristiano,<br />
fonte <strong>di</strong> carità.<br />
Dai mattutini albori, fin oltre la sera calante,<br />
arò perseverando e seminò con fede:<br />
Onde a la Religione sacrò sacerdoti trecento<br />
e offrí a l'Italia <strong>madre</strong> nobili citta<strong>di</strong>ni.<br />
Lo Spirto a Dio: a la Terra la spoglia;<br />
agli umani venturi<br />
l'esempio e la memoria, fin che la vita duri”.<br />
Amen 69 .<br />
67<br />
Diario <strong>di</strong> don Tommaso Gaggero, quaderno XXX, Archivio FSMI, Roma.<br />
68<br />
Archivio FSMI, Roma.<br />
69<br />
PIERUCCI G., Elegia,in AA. VV., Il nostro Primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma, 2004, 104.
26<br />
PADRE PICCARDO EDUCATORE<br />
«L’Arcivescovo Mons. Tommaso Reggio chiamò a <strong>di</strong>rigere i Seminari Vescovili Padre<br />
Piccardo, Direttore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, a meglio cementare l’<strong>un</strong>ione del Clero e curarne con<br />
in<strong>di</strong>rizzo <strong>un</strong>iforme la formazione. E cosí <strong>un</strong> <strong>un</strong>ico Superiore <strong>di</strong>rigeva i due Istituti.<br />
Il nuovo Rettore, con l’approvazione dell’Arcivescovo, uomo <strong>di</strong> belle iniziative e <strong>di</strong> larghe<br />
vedute, volle che in Seminario ci fosse <strong>un</strong> trattamento <strong>un</strong>ico per tutti i seminaristi e si adoperò che<br />
tra seminaristi e Superiori si stabilisse quella confidenza familiare che era propria dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
Maria» 70 .<br />
Cementare l’<strong>un</strong>ione del Clero: <strong>un</strong> numero considerevole <strong>di</strong> giovani sacerdoti erano stati<br />
formati presso i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, avevano quin<strong>di</strong> <strong>come</strong> figura <strong>di</strong> riferimento P. Antonio Piccardo; ma<br />
bisogna ben supporre che la gestione della Diocesi era in mano ad <strong>un</strong>’altra parte del Clero ed ecco<br />
allora il compito <strong>di</strong> creare <strong>un</strong>ità e accordo affidato al Padre Piccardo.<br />
Stabilire <strong>un</strong>o stile familiare, <strong>un</strong>a parità tra i seminaristi e <strong>un</strong> rapporto <strong>di</strong> fiducia con i<br />
Superiori.<br />
Si può ben comprendere da questo che il Piccardo era <strong>un</strong> uomo <strong>di</strong> grande spessore a cui è<br />
affidato il compito <strong>di</strong> coesione tra i membri del clero e a cui è riconosciuto il merito <strong>di</strong> <strong>un</strong> metodo<br />
pedagogico efficace ed adatto ai tempi.<br />
Nell’archivio della Casa <strong>di</strong> Genova si conservano alc<strong>un</strong>i suoi quaderni <strong>di</strong> app<strong>un</strong>ti del tempo<br />
del liceo, in <strong>un</strong>o <strong>di</strong> essi troviamo questa frase: “Il bene si compie soltanto amando”. Un motto?<br />
Uno slogan? Un programma?<br />
Egli non ha lasciato scritti o trattati <strong>di</strong> carattere pedagogico o antropologico in modo da<br />
poterne analizzare con comodo profitto il pensiero, dobbiamo perciò volgere la nostra attenzione<br />
alle vicende della sua vita e da queste ricavare <strong>un</strong> testo che narri la vitalità e la serietà della sua<br />
opera educativa e il significato vocazionale <strong>di</strong> cui era intrisa. E questo perché ci troviamo <strong>di</strong> fronte<br />
non a <strong>un</strong> teorico ma ad <strong>un</strong> uomo concreto, realista, dotato <strong>di</strong> <strong>un</strong>o sguardo adeguato alle varie<br />
situazioni e persone. Chiaramente lo riconosce anche il Padre Minetti quando, per inciso, gli scrive:<br />
«Potrei darle relazione piú dettagliata, ma parlando con lei, che i giovani fa presto a conoscerli,<br />
crederei fatica inutile, mentre Puppo già lo conosce meglio <strong>di</strong> me» 71 .<br />
Sapeva bene cosa voleva raggi<strong>un</strong>gere e faceva <strong>di</strong> tutto per ottenere il fine, ma pretendeva<br />
poco in modo che non lo si smarrisse.<br />
Chi era l’educatore Antonio Piccardo.<br />
Il <strong>di</strong>acono Antonio Piccardo era seminarista interno e prefetto della camerata dei piccoli,<br />
quando il Semino, a nome <strong>di</strong> Pietro Olivari e del Frassinetti, gli fece la proposta <strong>di</strong> assumere la<br />
<strong>di</strong>rezione della “Pia Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata per l’avviamento dei giovinetti<br />
poveri agli stu<strong>di</strong> ecclesiastici”, si ebbe questa reazione: «Piacque tanto la cosa al Piccardo, ma il<br />
non essere ancora sacerdote, il vedersi cosí giovane ed inesperto lo faceva titubante, tuttavia aveva<br />
in massima accettato parendogli che il Signore gli aprisse il campo per fare <strong>un</strong> poco <strong>di</strong> bene. Si<br />
70 Archivio delle Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Marta, Roma.<br />
71 Lettera del 25-8-1903, Archivio FSMI, Roma.
27<br />
riserbò però <strong>di</strong> parlare della cosa» 72 . Mettiamo in rilievo: si sentiva giovane ed inesperto,<br />
desideroso <strong>di</strong> fare <strong>un</strong> po’ del bene.<br />
Mons. Giacomo Ghio nel cercare <strong>un</strong>a caratteristica che in qualche modo fissasse la sua<br />
personalità, lo definisce «uomo forte nel senso piú bello e cristianamente puro della parola» 73 e<br />
spiega che è <strong>un</strong>a forza d’animo fatta <strong>di</strong> preghiera e <strong>di</strong> <strong>un</strong>ione con Dio, <strong>di</strong> dolcezza e <strong>di</strong> umiltà.<br />
A lui si associa Mons. Girolamo Car<strong>di</strong>nale: «La virtú caratteristica del nostro venerato<br />
Superiore era la bontà. Si riconoscevano e si apprezzavano le altre doti, <strong>di</strong> cui il Signore lo aveva<br />
arricchito: l’intelligenza, la prudenza, il raro buon senso, l’attività, lo zelo, la fermezza e, quando<br />
occorreva, l’energia; ma c’era <strong>un</strong>a che quasi le assorbiva tutte, dando a tutte <strong>un</strong> colore e <strong>un</strong> sapore<br />
speciale, la bontà» 74 .<br />
La personalità dell’educatore, i principi a cui egli si ispira, la lotta con i propri <strong>di</strong>fetti che<br />
forgia la sua persona, il dominio del proprio carattere ed anche il tratto educato offerto e ricevuto<br />
non sono delle variabili nel modo <strong>di</strong> educare ma elementi portanti che definiscono il metodo<br />
educativo. Padre Piccardo seppe ben valorizzare l’educazione ricevuta e ne seppe proiettare la luce<br />
e il calore attorno a sé.<br />
Piuttosto ottimista, preferiva rilevare le buone qualità del giovane; rimproverava, castigava<br />
se era il caso, ma il giovane sapeva <strong>di</strong> godere la stima del suo superiore.<br />
La figura <strong>di</strong> Padre Piccardo educatore<br />
Una forma <strong>di</strong> educazione per avere connotazioni <strong>di</strong> autenticità deve mettere in luce la sua<br />
indole <strong>di</strong>namica in reciprocità sia da parte dell’educatore che dell’educando, senza il cui libero<br />
concorso e consenso non ci sarebbe educazione. Spesso per descrivere <strong>un</strong> metodo educativo e<br />
quin<strong>di</strong> <strong>un</strong> educatore, si mettono in risalto i fini, i valori, gli ideali che vengono proposti o che si<br />
tenta <strong>di</strong> trasmettere. In realtà l’intervento educativo deve essere <strong>un</strong> atto <strong>di</strong> cooperazione e <strong>di</strong><br />
partecipazione da parte dell’educatore e dell’educando, il cui fondamento è <strong>un</strong>a reciproca fiducia:<br />
nell’educando <strong>di</strong> stima per l’educatore, nell’educatore <strong>di</strong> ottimismo per lo sviluppo futuro<br />
dell’educando. È dentro questa cornice che si può affermare che Padre Piccardo era <strong>un</strong> vero<br />
educatore, attento ad ogni singolo ragazzo e <strong>di</strong> esso non si proponeva <strong>di</strong> farne <strong>un</strong>a persona ideale<br />
ma <strong>un</strong>o che mettesse a frutto al massimo le sue possibilità, partendo da quella vocazionale.<br />
L’ardore apostolico, il credere alla propria missione era la forza che forniva legna al fuoco<br />
della perseveranza e suscitava fiducia e pazienza <strong>di</strong> fronte alla sor<strong>di</strong>tà della materia da modellare. Si<br />
sa dalla pedagogia che i valori non entrano nella persona o nella vita a colpi <strong>di</strong> semplici esortazioni,<br />
ma solo con <strong>un</strong>a paziente e indovinata opera informativa e formativa.<br />
Il suo sistema educativo<br />
72 Archivio Fsmi, Roma<br />
73 GHIO G., L’uomo forte, in AA. VV., Il nostro Primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma, 2004, 100.<br />
74 CARDINALE G., La sua bontà, in AA. VV., Il nostro Primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma, 2004, 103.
28<br />
Era sorto a Genova l’Istituto degli Artigianelli, fondato da Don Francesco Montebr<strong>un</strong>o 75 .<br />
Era apprezzata l’opera per il suo impegno sociale e per il sistema educativo, in <strong>un</strong> certo modo<br />
innovativo rispetto al modo <strong>di</strong> educare allora messo in atto. Se l’educazione legata all’osservanza<br />
della legge e al rispetto dei <strong>di</strong>vieti era il principio pedagogico applicato negli istituti <strong>di</strong> educazione<br />
statale, Don Montebr<strong>un</strong>o si ispirava ad <strong>un</strong> principio che veniva sintetizzato nella formula “Substine<br />
et abstine”, principio da lui addolcito e sublimato dal soffio dello spirito cristiano. Il giovane<br />
doveva avere o acquisire <strong>un</strong> carattere capace <strong>di</strong> “sopportare” e <strong>un</strong>a padronanza <strong>di</strong> sé che lo portasse<br />
ad accontentarsi del puro necessario senza la minima superfluità, cioè ad astenersi. Padre Piccardo<br />
era stato educato in <strong>un</strong> collegio statale ed aveva sotto gli occhi il metodo <strong>di</strong> Don Montebr<strong>un</strong>o, ma<br />
egli scelse <strong>un</strong>’altra via.<br />
L’intento primario fu quello <strong>di</strong> rendere l’istituzione <strong>un</strong>a famiglia, <strong>un</strong>a casa pervasa da<br />
sentimenti e rapporti domestici, <strong>un</strong> ambiente intimo e simpatico.<br />
Scriveva San Giovanni Bosco in <strong>un</strong>a lettera alla Congregazione Salesiana: “Bisogna che voi<br />
non <strong>di</strong>mentichiate che rappresentate i genitori <strong>di</strong> questa cara gioventù … Se perciò sarete veri<br />
padri dei vostri allievi, bisogna che voi ne abbiate anche il cuore”.<br />
Non è facile <strong>di</strong>re se Don Bosco l’abbia mutuato dai <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria o viceversa o hanno avuto<br />
la stessa intuizione in modo in<strong>di</strong>pendente, si può com<strong>un</strong>que affermare che “la Pia Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
Maria” era in senso pieno <strong>un</strong>a vera casa, <strong>un</strong>a casa con <strong>un</strong> <strong>padre</strong> sapiente ed avvincente.<br />
L’intento <strong>di</strong> questo in<strong>di</strong>rizzo (<strong>come</strong> ricaviamo da alc<strong>un</strong>e testimonianze) era non<br />
l’appren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>di</strong>sciplina meccanica, che poi si abbandona nella vita attiva, specialmente<br />
sacerdotale, ma <strong>un</strong>a <strong>di</strong>sciplina che è abito al bene, abnegazione, sacrificio o amore.<br />
Il programma che connotava gli al<strong>un</strong>ni si può cosí sintetizzare: stu<strong>di</strong>are, pregare e stare<br />
allegri, perché le persone sante sono sempre allegre e felici, <strong>come</strong> <strong>di</strong>ceva il Frassinetti, cioè: servite<br />
Domino in laetitia.<br />
«Voleva che tutti fraternamente si amassero, ma non poteva soffrire né amicizie particolari,<br />
né antipatie. Voleva i suoi giovani pronti e volenterosi, anche nei piú umili uffizi, ancorché si<br />
<strong>di</strong>stinguessero per ingegno o altre qualità: potente mezzo <strong>di</strong> educazione per la pratica della vita.<br />
Voleva che nella Casa si tenessero in gran conto gli stu<strong>di</strong>, alimentava quella fierezza che incitava<br />
gli animi giovanili ad osare quanto consentivano le forze. Sapeva infondere in essi lo spirito <strong>di</strong><br />
corpo per quella vita <strong>di</strong> famiglia che negli eventi prosperi ed avversi accom<strong>un</strong>ava tutti i membri<br />
nelle gioie e nei dolori» 76 .<br />
E molte testimonianze sono piene <strong>di</strong> gratitu<strong>di</strong>ne per la formazione ricevuta e per l’amore <strong>di</strong><br />
cui erano stati circondati negli anni della via verso il sacerdozio 77 . Una per tutte da <strong>un</strong> sacerdote exal<strong>un</strong>no<br />
del Seminario:<br />
“Rev.mo Padre, oggi adempio il mio voto, che fu <strong>un</strong> tempo <strong>un</strong>a promessa: offrire e de<strong>di</strong>care<br />
al Reveren<strong>di</strong>ssimo Padre Antonio Piccardo la mia prima Messa in musica. Lo faccio con tutta la<br />
75 Nella soffitta <strong>di</strong> questo Istituto era stata ospitata a “Pia Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria per l’avviamento dei giovinetti poveri<br />
allo stato ecclesiastico” Don Montebr<strong>un</strong>o era <strong>di</strong>ventato <strong>un</strong> aiutante del Padre Piccardo e lo troviamo nelle assemblee<br />
preparatorie della Congregazione.<br />
76 Q. PRONI, Patres nostri, in Settantacinquesimo, Roma 1941, 26.<br />
77 Si rimanda alla lettura della pubblicazione: AA.VV., Il nostro Primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma<br />
2004
29<br />
giocon<strong>di</strong>tà del mio animo, sperando che questo tenue omaggio <strong>di</strong> figlio sarà gra<strong>di</strong>to al suo cuore <strong>di</strong><br />
Padre. Mi inchino alla Paternità Vostra Reveren<strong>di</strong>ssima e con tutto l’affetto le bacio la mano.<br />
Devotissimo servo Don Stefano Ferro” 78 .<br />
Il ministero dell’educazione gli era entrato nel sangue, egli non si ispirava al modello<br />
dell’osservanza com<strong>un</strong>e.<br />
«Voleva che i suoi giovani fossero allegri …, <strong>di</strong> quando in quando li premiava con<br />
passeggiate straor<strong>di</strong>narie, a cui, finché poté, volle sempre prendere parte. E nei <strong>di</strong>vertimenti<br />
collegiali, sapeva cosí bene contemperare l’indulgenza con la severità, che il favore ottenuto<br />
risultava a mille doppi piú caro» 79 .<br />
L’atteggiamento dell’educatore che p<strong>un</strong>isce solo e non premia mai è fonte <strong>di</strong> pericolo e <strong>di</strong><br />
impenetrabilità, perché cristallizza in <strong>un</strong> solo verso la com<strong>un</strong>icazione e la risposta dell’educando.<br />
Non cosí era Padre Piccardo: sapeva adattare la legge alla situazione senza infrangere la vali<strong>di</strong>tà e la<br />
sostanza della stessa. Accettare il bene presente anche se lac<strong>un</strong>oso con sguardo l<strong>un</strong>gimirante in vista<br />
del meglio o della piena osservanza della legge è frutto <strong>di</strong> sapienza, è intelligenza e senso del reale.<br />
Ciò non implica il fatto <strong>di</strong> non proporre gran<strong>di</strong> ideali, <strong>di</strong> non spingere i giovani a sognare; dalla<br />
lettura della cronaca <strong>di</strong> casa risulta che non c’era acci<strong>di</strong>a in quella com<strong>un</strong>ità; i ragazzi non erano<br />
annoiati e <strong>di</strong>samorati, perché <strong>un</strong> fuoco, pur nascosto dalla normalità del quoti<strong>di</strong>ano, era<br />
continuamente attizzato dagli educatori per risvegliare i sogni e la passione dei gran<strong>di</strong> ideali.<br />
C’è <strong>un</strong> <strong>di</strong>alogo personale con i ragazzi, che è chiaro in<strong>di</strong>ce che essi sono l’oggetto principale<br />
delle sue attenzioni e che ha a cuore il loro progresso e la loro crescita.<br />
Dal Diario <strong>di</strong> Padre Piccardo:<br />
“Dalla ricreazione mi accorsi che … parlando con <strong>un</strong> suo compagno, prendeva quasi in<br />
scherzo la riprensione avuta il 28 sera: segno che le promesse fatte ieri, neanche stavolta erano<br />
sincere. Chiamatolo lo rimproverai; era <strong>un</strong>a buona occasione dalla mia porta doveva subito<br />
recarsi in cappella, si confessò e dopo la confessione pareva pentito”.<br />
“Stasera venne a me il … Sul principio pareva quasi venuto con <strong>un</strong> fare sprezzante …<br />
facendogli riflettere varie cose … confessò il suo naturale aver bisogno <strong>di</strong> guida”.<br />
“Chiamo … che da qualche tempo pare non abbia grande amore alla pietà. Confessa <strong>di</strong><br />
sentirsi molto freddo, <strong>di</strong> non essersi ben accinto a fare il bene: promette farlo”.<br />
“Viene … confessando <strong>un</strong> po’ <strong>di</strong> malinconia”.<br />
“8 <strong>di</strong>cembre 1873. Festa dell’Immacolata: al mattino si invitò il Priore <strong>di</strong> San Giacomo per<br />
la Messa della com<strong>un</strong>ione: prima della com<strong>un</strong>ione <strong>un</strong> breve <strong>di</strong>scorso, poi celebrai l’altra Messa <strong>di</strong><br />
ringraziamento.<br />
Questa è la festa che bisogna celebrare con piú solennità: a pranzo due pietanze, frutta,<br />
vino, dolce.<br />
Scrive poi a Tommaso Gaggero: “Ti autorizzo a fare quelle operazioncelle <strong>di</strong> cui mi parli.<br />
Quanto al resto non ti affliggere del passato. Per carità, non aggi<strong>un</strong>gere male a male”.<br />
78 Archivio FSMI, Roma.<br />
79 OLIVARI C., Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, Tip. Poliglotta, Città del Vaticano 1929,
30<br />
Da questa descrizione, dalle deduzioni che se ne possono trarre e soprattutto dal risalto dato<br />
allo stile o spirito <strong>di</strong> famiglia, ci si aspetterebbe <strong>un</strong>a com<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> eguali o com<strong>un</strong>que abbastanza<br />
livellata. Padre Piccardo invece non ha annullato le <strong>di</strong>stanze, non ha eliminato le <strong>di</strong>fferenze perché<br />
lui si sentiva portatore <strong>di</strong> <strong>un</strong>a responsabilità educativa e questo, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> tutte le apparenze instaura<br />
la com<strong>un</strong>icazione e il <strong>di</strong>alogo ed elimina l’illusione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a falsa confidenza che è invece segno <strong>di</strong><br />
immaturità nell’educatore.<br />
Si legge <strong>di</strong> lui: «Il suo sembiante incuteva rispetto, ma non scemava l’amore. Anche la sua<br />
ombra, si <strong>di</strong>rebbe, era temuta; eppure era <strong>un</strong>a festa quando scendeva nella ricreazione. E amava che<br />
i suoi giovani fossero allegri, perché fossero buoni» 80 .<br />
Un ex-al<strong>un</strong>no compose <strong>un</strong>a poesia in occasione della traslazione della salma <strong>di</strong> Padre<br />
Piccardo dal Cimitero citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Staglieno alla cappella dell’Istituto <strong>di</strong> via Jacopo Ruffini.<br />
O caro Padre mio, vi parlo schietto<br />
oggi il vostro carissimo ritorno<br />
io lo volea cantar con <strong>un</strong> sonetto,<br />
ma pensa, pensa non conclusi <strong>un</strong> corno.<br />
Dire che questa casa e questo tetto<br />
son vostri per <strong>di</strong>ritto e per soggiorno<br />
dove accoglieste me anche, poveretto<br />
parmi questo <strong>un</strong> elogio <strong>di</strong>sadorno.<br />
Ma <strong>di</strong>rò, Padre, se vestito ancora<br />
della creta morta, nel mondo rio,<br />
tanto faceste per questa <strong>di</strong>mora<br />
che non farete adesso, o Buono, o Pio,<br />
mentre regnate e regnerete ancora<br />
coi santi in ciel, con Maria, con Dio? 81 .<br />
80 Ibid.<br />
81 PIERUCCI G., Elegia, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, Ed. Risonanze, Roma 2004, 104.
31<br />
SEGUIRE L’ISPIRAZIONE E, TRA LE OPPOSIZIONI,<br />
RIMANERE FEDELE ALLA CHIESA<br />
Padre Piccardo sentiva profondamente la sua appartenenza alla Chiesa, ne era suo membro e<br />
ne desiderava ardentemente lo sviluppo e la sognava piena <strong>di</strong> fascino.<br />
La Chiesa <strong>di</strong> Dio che è in Genova gli era cara: in essa egli era nato alla fede, aveva<br />
conosciuto ed amato ciò che dava senso alla sua vita, in essa lui era sacerdote.<br />
Egli <strong>come</strong> <strong>padre</strong>, guida e animatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria si è trovato ad affrontare situazioni<br />
totalmente nuove e dall’esito impreve<strong>di</strong>bile. Non ha trovato l’appoggio del Pastore della Chiesa con<br />
il quale non c’era concordanza <strong>di</strong> idee circa il destino dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria. Ha dovuto camminare da<br />
solo, soprattutto nei momenti piú critici e cercare nella sofferenza dell’anima luce per <strong>di</strong>scernere la<br />
volontà <strong>di</strong> Dio. Ha voluto essere figlio obbe<strong>di</strong>ente ma non <strong>di</strong>sattendere la mozione interiore.<br />
Si è recato a Roma per avere quei lumi che gli permettessero <strong>di</strong> non correre invano in <strong>un</strong>a<br />
vana illusione, che avrebbe potuto confondere con la volontà <strong>di</strong> Dio. Si incamminò verso Roma ma<br />
<strong>come</strong> <strong>un</strong> pellegrino con il cappuccio calato sulla fronte senza sbattere la porta <strong>di</strong>etro <strong>di</strong> sé, pregando<br />
e non male<strong>di</strong>cendo l’Arcivescovo, che non lo comprendeva.<br />
Viene spontaneo domandarsi: perché queste <strong>di</strong>fficoltà e incomprensioni? Certamente la<br />
limitatezza umana ha dato il suo contributo ma in <strong>un</strong>a prospettiva <strong>di</strong> Provvidenza si può <strong>di</strong>re che gli<br />
ostacoli servono per creare nell’uomo, che si accinge ad <strong>un</strong>’opera cosí originale, <strong>come</strong> è quella <strong>di</strong><br />
essere latore <strong>di</strong> <strong>un</strong> nuovo carisma alla Chiesa, <strong>un</strong>a densità spirituale. Questa vita interiore intensa <strong>di</strong><br />
chi inizia è fonte <strong>di</strong> fecon<strong>di</strong>tà perché trasmette il carisma iniziale e lo ravviva in ogni vocazione che<br />
viene ad infoltire le fila della nuova famiglia.<br />
Osservando anche superficialmente gli avvenimenti si nota <strong>come</strong> la “Pia Opera dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
Maria”, parte viva e feconda della Chiesa genovese suscitava nell’ambito clericale <strong>un</strong> variegato<br />
atteggiamento che andava dalla approvazione piena <strong>di</strong> simpatia alla opposizione piú o meno<br />
sfumata.<br />
C’era <strong>un</strong>a forma <strong>di</strong> contrasto strisciante ma anche <strong>un</strong>a contrapposizione manifesta; essa si<br />
coglie in vari elementi <strong>come</strong> per esempio l’inchiesta fatta dalla Commissione del Seminario per gli<br />
esterni, sulla compatibilità dell’istituzione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria con il Seminario 82 , la lettera (riservata)<br />
dell’Arciprete Canonico Enrico Bonino al Car<strong>di</strong>nale Prefetto della Congregazione degli Stu<strong>di</strong> del<br />
Vaticano del 24 novembre 1900, l’insofferenza dell’Arcivescovo Mons. Pulciano che si ricava da<br />
vari app<strong>un</strong>ti, il cui originale è nell’Archivio del Seminario <strong>di</strong> Genova.<br />
82 L’inchiesta è sui generis perché non pone quesiti ma dà affermazioni. Si chiede <strong>di</strong> pron<strong>un</strong>ciarsi:<br />
1. Si teme <strong>un</strong> dualismo nel clero. Perciò si cerca <strong>di</strong> dare <strong>un</strong> in<strong>di</strong>rizzo <strong>un</strong>ico al clero sia per le conferenze spirituali, sia<br />
per il canto liturgico, sia per le cerimonie etc.<br />
2. La Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria può fare <strong>un</strong>a scelta dei migliori nell’ammettere i giovani, quin<strong>di</strong> gli al<strong>un</strong>ni del Seminario<br />
ne hanno scapito e gelosia, non potendo il Seminario fare questa scelta dovendo accogliere tutti quelli che può i<br />
quali abbiano le qualità sufficienti etc.<br />
3. La Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria secondo la sua prima istituzione aveva per iscopo il solo avviamento dei giovinetti agli<br />
stu<strong>di</strong> ecclesiastici<br />
4. La Casa non <strong>di</strong>pende <strong>di</strong>rettamente dall’Or<strong>di</strong>nario: è amministrata da sacerdoti e da secolari e quin<strong>di</strong> si teme, avendo<br />
<strong>un</strong> carattere laicale, che possa facilmente degenerare etc.<br />
Non sappiamo che estensione avesse la rilevazione, in nostro possesso ci sono alc<strong>un</strong>e risposte tra cui quella <strong>di</strong> Mons.<br />
Persoglio.
32<br />
C’è <strong>un</strong>a accettazione viva, cor<strong>di</strong>ale e sincera da parte dei sacerdoti ex allievi, <strong>di</strong> ecclesiastici<br />
ragguardevoli e vescovi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ocesi limitrofe.<br />
C’è anche <strong>un</strong> riconoscimento con<strong>di</strong>zionato, o meglio <strong>di</strong>re <strong>un</strong>a opposizione ovattata, volta a<br />
far sí che “La Pia Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria” <strong>di</strong>ventasse <strong>un</strong>a semplice espressione del Seminario, fino<br />
a stemperarsi e perdere l’originario suo fine gi<strong>un</strong>gendo ad <strong>un</strong>a <strong>di</strong>sgregazione per appiattimento con<br />
l’inevitabile assorbimento da parte del Seminario.<br />
In che situazione spirituale si trovava Don Piccardo che voleva fare solo <strong>un</strong> po’ <strong>di</strong> bene? In<br />
lui il desiderio dell’incontro tra la sua novità e l’accettazione delle decisioni della Chiesa giocava <strong>un</strong><br />
ruolo fondamentale. Questa sofferta incomprensione, questa mancanza <strong>di</strong> incontro generava quella<br />
sofferenza a cui richiama il Vangelo: «Se il chicco <strong>di</strong> grano caduto in terra non muore …» (Gv 12,<br />
24). Tale sofferenza nella linea della croce, lo apre ad <strong>un</strong>a piena <strong>di</strong>mensione pasquale.<br />
Non era nello stile né nei desideri <strong>di</strong> Padre Piccardo essere “segno <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zione”;<br />
l’<strong>un</strong>ità e l’armonia erano i parametri con i quali si può misurare la sua personalità, ma aveva dentro<br />
<strong>un</strong> appello irrin<strong>un</strong>ciabile a cui doveva essere fedele.<br />
La forza dell’agire, della convinzione e della santa testardaggine <strong>di</strong> Padre Piccardo e<br />
l’accoglienza <strong>di</strong> Pio X, fa sí che la cronaca minore <strong>di</strong> <strong>un</strong>a associazione qualsiasi sia trasformata in<br />
<strong>un</strong>a nuova luce nell’impegno ecclesiale e scriva pagine ine<strong>di</strong>te e non “dejá vue” nella sequela <strong>di</strong><br />
Cristo.<br />
Forse qualc<strong>un</strong>o potrebbe pensare che, Padre Piccardo, ostacolato su molti fronti,<br />
male<strong>di</strong>cesse chi nella <strong>di</strong>ocesi, pur con motivazioni <strong>di</strong> bene, lo metteva in ristrettezze, invece no,<br />
cercò <strong>un</strong>a nuova via per amare piú genuinamente la Chiesa; e colui che in quel Corpo ha la missione<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>scernere lo Spirito, ha riconosciuto lo slancio spirituale che recava con sé e il risveglio che<br />
sarebbe avvenuto dal <strong>di</strong> dentro della Chiesa stessa.<br />
Se c’era <strong>un</strong> prezzo da pagare, Padre Piccardo era <strong>di</strong>sposto a pagarlo e <strong>di</strong> fatto lui e primi<br />
compagni non si sono tirati in<strong>di</strong>etro. Il loro tesoro interiore non era <strong>un</strong> possesso privato da<br />
consumarsi in <strong>un</strong>a cerchia selezionata ma aveva la connotazione dell’ecclesialità. È il<br />
riconoscimento <strong>di</strong> questa nota determinante, <strong>di</strong> cui lui era portatore e non padrone, che lo ha<br />
motivato ad affrontare l’avventura della Congregazione.<br />
C’è <strong>un</strong> legame impalpabile ma innegabile tra il misconoscimento <strong>di</strong> <strong>un</strong> carisma fino, magari,<br />
a considerarlo <strong>un</strong> inganno o <strong>un</strong>a autoesaltazione da parte del fondatore e i suoi primi compagni e la<br />
sua successiva valorizzazione e talvolta esaltazione. Gli esempi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà con i Vescovi ed anche<br />
con la Sede Apostolica sono innumerevoli 83 .<br />
Padre Piccardo, in <strong>un</strong> cammino interiore per conoscere la volontà <strong>di</strong> Dio su <strong>di</strong> sé e sui <strong>Figli</strong><br />
<strong>di</strong> Maria, soffre per le opposizioni da parte dell’Or<strong>di</strong>nario e le <strong>di</strong>fficoltà e le <strong>di</strong>ffidenze serpeggianti<br />
tra il Clero altolocato della città.<br />
Scrive Padre Minetti nel suo <strong>di</strong>ario:<br />
«16 Settembre 1902. “Oggi giorno <strong>di</strong> dolore. Il Signor Direttore si presentò all’Arcivescovo<br />
per sentire il suo parere intorno alle Regole … Il principio dell’Arcivescovo è <strong>di</strong> trarre tutto a sé”.<br />
83 Cfr. J. M. LOZANO, El f<strong>un</strong>dator y su famiglia religiosa. Inspiración y carisma, Publicationes Claretianas, Madrid<br />
1978, passim.
33<br />
4 Ottobre 1902. “Oggi giorno <strong>di</strong> letizia per essere arrivata da Roma <strong>un</strong>a lettera del Signor<br />
Direttore che dà <strong>un</strong> po’ <strong>di</strong> speranza pro nostra Congregatione facienda”.<br />
6 Novembre 1902. «I destinati per Roma andarono dall’Arcivescovo per congedarsi e<br />
prendere la pastorale bene<strong>di</strong>zione e tutti allegri e contenti si presentarono a lui, ed egli ci ricevette<br />
con volto accigliato e ci <strong>di</strong>sse: Presto, presto che ci ho della gente.<br />
Eccellenza, <strong>di</strong>sse il Direttore, prima <strong>di</strong> partire per Roma siamo venuti ad ossequiarla e<br />
pregarla della sua pastorale bene<strong>di</strong>zione.<br />
L’Arcivescovo con accento <strong>di</strong>sgustoso ci <strong>di</strong>sse: Io vi do la bene<strong>di</strong>zione <strong>come</strong> la darei al<br />
popolo e non annetto a tale bene<strong>di</strong>zione ness<strong>un</strong>’altra cosa.<br />
Il Direttore: È la bene<strong>di</strong>zione del Signore in qual<strong>un</strong>que modo sia apporta sempre bene.<br />
Ripeté che egli non intendeva dare alla sua bene<strong>di</strong>zione ness<strong>un</strong> altro significato perché noi ci<br />
siamo intesi con Roma e prima dovevamo intendere lui.<br />
Io, Eccellenza, sono venuto, <strong>di</strong>sse il Direttore, e poi sa <strong>come</strong> sono andate le cose.<br />
Lei, Don Piccardo, ha trattato male e glielo <strong>di</strong>co in l<strong>un</strong>go e in largo e dovevate prima<br />
parlare con me. Ricordatevi quello che avete promesso quando vi siete or<strong>di</strong>nati, avete promesso<br />
obbe<strong>di</strong>enza e riverenza.<br />
Io aggi<strong>un</strong>si: Se io avessi saputo che desiderava parlarmi, sarei venuto ben volentieri, ma il<br />
nostro Direttore fece lui.<br />
Si, rispose, ma dovevate tener conto dei vostri Superiori.<br />
E il Direttore: Ma anche a Roma sono nostri Superiori.<br />
Fu per noi <strong>un</strong> fulmine a ciel sereno. Pazienza, tutto per amor <strong>di</strong> Dio!<br />
Venne ad accompagnarci nell’uscita il Canonico De Amicis e, contata la cosa, ci <strong>di</strong>sse: Ci<br />
vuole pazienza, voi eravate in regola, ci vuole pazienza» 84<br />
Ness<strong>un</strong>o dà a se stesso né la vita religiosa, né la regola, né la denominazione: tutto viene<br />
sempre ricevuto da <strong>un</strong> altro, da <strong>un</strong>o che ha il dono della paternità.<br />
Il Padre Piccardo vive dell’idea <strong>di</strong> consacrazione religiosa sotto la denominazione <strong>di</strong> <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Maria Immacolata, idea mutuata dalla vita, dalla tensione spirituale e dalla volontà inespressa<br />
del Frassinetti, tuttavia l’investitura la riceve dal Vescovo <strong>di</strong> Roma con la me<strong>di</strong>azione del Car<strong>di</strong>nale<br />
Vicario Pietro Respighi: egli pone il sigillo alla loro aspirazione e conferma la regola.<br />
È questa la ricompensa della fedeltà nella sofferta ricerca della volontà <strong>di</strong> Dio sull’opera che<br />
portava avanti e sulla sua stessa vita.<br />
Di ritorno dal suo secondo viaggio a Roma, alla com<strong>un</strong>ità della Casa ri<strong>un</strong>ita, Padre Piccardo<br />
espose la proposta che il Car<strong>di</strong>nale Vicario gli aveva fatto a nome <strong>di</strong> Sua Santità Leone XIII, ed<br />
aggi<strong>un</strong>se: “Ma lí non si guadagna”. Tutti in coro risposero: “A Roma non si <strong>di</strong>ce mai <strong>di</strong> no!”.<br />
84 Archivio Fsmi, Roma.
34<br />
Il <strong>di</strong>re “tout court” che il Frassinetti è il Fondatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata (il<br />
che è vero), è <strong>un</strong>a scorciatoia. Tra la “Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria” e la “Congregazione dei <strong>Figli</strong><br />
<strong>di</strong> Maria” non c’è solo progressione ma anche <strong>di</strong>scontinuità; <strong>di</strong>scontinuità nelle forme concrete <strong>di</strong><br />
realizzazione, che si manifesta nell’aspetto giuri<strong>di</strong>co e nelle regole.<br />
Il carisma è <strong>un</strong> “in<strong>di</strong>cibile”, qualche autore lo definisce <strong>un</strong>a “follia” rispetto alla fatalità della<br />
storia; calare la realtà “carisma” che è soprannaturale e quin<strong>di</strong> non dominabile dall’uomo, in <strong>un</strong>a<br />
istituzione significa sia mortificarla, sia dargli continuità; è la chiesa che istituzionalizza il carisma,<br />
e la Chiesa è anch’essa <strong>un</strong> mistero.<br />
Se si vuole definire <strong>un</strong> carisma si riesce al massimo a produrre <strong>un</strong> balbettio, eppure anche<br />
questo farfugliamento è in<strong>di</strong>spensabile, perché è proprio cosí che, in <strong>un</strong> certo modo, esso può<br />
esistere nella storia.<br />
Il ruolo <strong>di</strong> Padre Piccardo <strong>come</strong> ispiratore carismatico e non solo continuatore<br />
dell’ispirazione frassinettiana è <strong>un</strong> capitolo suggestivo ed esaltante.<br />
La fedeltà nella sofferenza e la sofferenza nella fedeltà fa germogliare i fiori.
35<br />
PADRE PICCARDO FONDATORE?<br />
Padre Piccardo era il postulatore della causa <strong>di</strong> beatificazione del Priore Giuseppe<br />
Frassinetti; racconta Padre Tommaso Bertolotto: «Nel 1921 il processo or<strong>di</strong>nario a Genova era<br />
terminato e negli ultimi giorni <strong>di</strong> aprile <strong>di</strong> quello stesso anno, accompagnato dal vice postulatore,<br />
don Giuseppe Capurro, volle egli stesso essere il portatore degli atti del processo a Roma e<br />
presentarli alla Sacra Congregazione dei Riti. In quel momento sembrò che egli facesse la consegna<br />
<strong>di</strong> tutto se stesso all’autorità apostolica» 85<br />
I volumi degli atti portano nel frontespizio il titolo: Canonizationis Servi Dei Pauli Mariae<br />
Josephi Frassinetti, sacerdotis saecularis Parochi-Prioris Paroeciae S. Sabinae, F<strong>un</strong>datoris<br />
Congregationis Filiorum S. Mariae Immaculatae.<br />
Risulta senza ambiguità <strong>di</strong> termini che nel fondatore Piccardo si sia consolidata la certezza<br />
<strong>di</strong> essere erede e figlio <strong>di</strong> chi ha ideato e ha accompagnato i primi passi della creatura che, affidata<br />
alle sue cure, ha esplicitato, grazie alla sua “fedeltà formativa” tutte le possibilità e i germogli in<br />
essa riposti. Egli ne è <strong>di</strong>ventato, <strong>come</strong> lo definisce l’epitaffio posto sulla sua tomba, “parens alter”,<br />
solidale con il “primus pater”.<br />
Nella lettera redatta dal Car<strong>di</strong>nale Pietro Respighi, depositata presso la Congregazione per<br />
gli Istituti <strong>di</strong> vita religiosa e le Società <strong>di</strong> vita apostolica, che tiene luogo <strong>di</strong> “Decretum lau<strong>di</strong>s”, ad<br />
<strong>un</strong> tratto si <strong>di</strong>ce: “…ottenere la fedele osservanza degli obblighi ass<strong>un</strong>ti da Padre Piccardo…e<br />
provvedere al bene e alla stabilità della Congregazione fondata da esso”.<br />
Si tratta allora <strong>di</strong> due fondazioni?<br />
Si può <strong>di</strong>re che Padre Piccardo ha aperto la chiusa e l’acqua della fonte è defluita nella<br />
storia; ha conservato la fedeltà all’ere<strong>di</strong>tà affidatagli in <strong>un</strong> rinnovamento <strong>di</strong>namico, misurandosi con<br />
le instabili circostanze del tempo. Si deve affermare che non sono due fondazioni ma due fondatori,<br />
o meglio due uomini in com<strong>un</strong>ione e in solidale collaborazione per la stessa fondazione.<br />
Il riconoscimento da parte della Chiesa del titolo <strong>di</strong> “fondatore” sia al Frassinetti sia al<br />
Piccardo sopprime ogni perplessità, infatti la Chiesa sancisce e riconosce il carisma <strong>di</strong> fondatore,<br />
riconoscendo l’istituto stesso, perché fondamentale è che l’autorità gerarchica sia la depositaria del<br />
carisma che è sempre a beneficio <strong>di</strong> tutto il popolo <strong>di</strong> Dio.<br />
Il Frassinetti è circondato dai <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria viventi in com<strong>un</strong>e, essi formano quasi la sua<br />
aureola. È a essi che egli ha partecipato e com<strong>un</strong>icato lo stesso spirito che albergava in lui<br />
chiamandoli all’amore per il bene e alla santità, arricchendoli <strong>di</strong> <strong>un</strong>a particolare intimità e <strong>un</strong>endoli<br />
alla sua stessa missione, che crea <strong>come</strong> <strong>un</strong> rapporto <strong>di</strong> paternità: da <strong>padre</strong> a figlio. In essi egli,<br />
sebbene preso e <strong>di</strong>stratto da <strong>un</strong>a quoti<strong>di</strong>anità parrocchiale e apostolica, ha vissuto quello stesso<br />
spirito.<br />
Padre Piccardo aggi<strong>un</strong>tosi <strong>un</strong> po’ piú tar<strong>di</strong>, era parte <strong>di</strong> questa com<strong>un</strong>ità, anzi ne è <strong>di</strong>ventato<br />
la parte piú eletta.<br />
Sorge a questo p<strong>un</strong>to <strong>un</strong>a domanda: perché tanta <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> anni dalla fondazione della Pia<br />
Casa alla fondazione della Congregazione? Le istituzioni, <strong>come</strong> gli in<strong>di</strong>vidui hanno leggi che<br />
85 BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 112.
36<br />
presiedono al loro sviluppo e regolano la loro attività con <strong>un</strong> decorso lento ma sicuro e nello stesso<br />
tempo non soggetto a schemi preventivi. Sarebbe pericoloso affrettare le soste che la natura e in<br />
questo caso la Provvidenza, ha segnato.<br />
Per approfon<strong>di</strong>re il tema siamo costretti ad entrare nell’intimo dell’animo del giovane<br />
sacerdote, <strong>di</strong> fresco or<strong>di</strong>nato, Antonio Piccardo per carpirgli il segreto che gli ha fatto intuire la<br />
collocazione <strong>di</strong> quella piccola com<strong>un</strong>ità, che il Frassinetti simbolicamente gli consegnava, nella vita<br />
e nel cuore della Chiesa, percepire la forza profetica in essa germinalmente deposta al fine <strong>di</strong><br />
risvegliare e richiamare il cammino verso il Regno.<br />
È questa <strong>un</strong>’operazione necessaria, anche se ha dentro il pericolo <strong>di</strong> far cantare <strong>un</strong>a canzone<br />
antica con ritmi nuovi o leggerla con <strong>un</strong>a chiave musicale <strong>di</strong>versa.<br />
Padre Piccardo era l’uomo dell’essenziale, anche nelle parole; non troviamo in ness<strong>un</strong><br />
documento ness<strong>un</strong>a “<strong>di</strong>chiarazione d’intenti”, né piste programmatiche, dobbiamo allora capirlo<br />
attraverso il suo operato, gli avvenimenti, la maturazione e la macerazione dell’idea e cosí scoprire<br />
il desiderio della sua anima nell’accogliere questo compito.<br />
L’attività, l’impegno e l’impulso che Padre Piccardo ha dato, fin da subito, all’opera, sono<br />
segni <strong>di</strong> <strong>un</strong>a presa <strong>di</strong> coscienza <strong>di</strong> leadership e non solo leadership organizzativa ma carismatica.<br />
Tale impulso <strong>come</strong> <strong>un</strong>a scossa sotterranea, percorreva tutta la casa e coinvolgeva i<br />
collaboratori e i professori, in particolare Pietro Olivari e Raffaele Frassinetti. Cioè la leadrship era<br />
trasmessa anche ad altri che, in sintonia con lui, mettevano le fondamenta <strong>di</strong> <strong>un</strong>’opera che avrebbe<br />
avuto il sigillo pontificio.<br />
Che significato contiene quel “Appena fui or<strong>di</strong>nato sacerdote s’impossessò del mio cuore<br />
<strong>un</strong>a brama forte <strong>di</strong> giovare, per quanto potessi nella mia nullità, confidando <strong>un</strong>icamente nel <strong>di</strong>vino<br />
aiuto, al giovane clero, e mi pareva che molto si sarebbe potuto fare a suo pro”?<br />
Quale è stata simile “brama forte che si è impossessata del cuore” <strong>di</strong> Padre Piccardo da<br />
indurlo a lasciare gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, la sua sicura carriera ecclesiastica, la vita confortevole,<br />
connaturale alla sua famiglia, per de<strong>di</strong>carsi tutto e fin dall’inizio del suo sacerdozio al problema<br />
della carenza <strong>di</strong> vocazioni? Si intuisce <strong>un</strong>a chiamata ad uscire dall’accampamento, ad allargare i<br />
paletti della tenda e andare oltre il già collaudato.<br />
Lo scenario <strong>di</strong> fondo ci mostra nell’<strong>un</strong>o e nell’altro caso <strong>un</strong>a scelta <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>calità, <strong>un</strong><br />
atteggiamento totalizzante.<br />
Se dobbiamo entrare nell’animo <strong>di</strong> <strong>un</strong> fondatore, non è sufficiente capire che cosa aveva<br />
intenzione <strong>di</strong> fare, iniziando <strong>un</strong>a determinata opera; questo è solo il primo passo della<br />
comprensione, è la soglia <strong>di</strong> quel misterioso vento che alimentava la sua vita. L’indagine si deve<br />
spingere anche alla fonte o al fuoco interiore che lo muoveva in quella <strong>di</strong>rezione ossia al fulcro, alla<br />
caratteristica fondamentale della sua persona che è stata poi riversata sull’istituzione. È necessario<br />
intravedere tramite quale esperienza egli sia venuto a contatto con lo Spirito e quali esperienze<br />
spirituali siano state determinanti.<br />
Ma è possibile cogliere l’illuminazione interiore o la chiamata <strong>di</strong>vina che ha mosso i nostri<br />
fondatori a impegnare la loro vita in questa opera che va sotto il nome <strong>di</strong> <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria<br />
Immacolata?
37<br />
Si possono cogliere alc<strong>un</strong>i sprazzi o bagliori della bellezza della chiamata, in base alle<br />
confidenze che essi stessi hanno fatto. Il loro pu<strong>di</strong>co silenzio può essere rotto. Per il Frassinetti,<br />
recependo passi dei suoi scritti, in particolare la Lettera al canonico Guerra, le Brevi riflessioni ai<br />
sacerdoti fratelli e Riflessioni proposte agli Ecclesiastici. Nel Piccardo si coglie <strong>un</strong>icamente dal suo<br />
agire, dalla sua opera costante e coerente.<br />
Nell’esaminare l’andamento quoti<strong>di</strong>ano della Pia Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata<br />
per l’avviamento dei giovani poveri agli stu<strong>di</strong> ecclesiastici, risaltano gesti ed avvenimenti in<br />
qualche modo rivelatori <strong>di</strong> <strong>un</strong>a “ulteriorità”.<br />
«Padre Piccardo, vitalmente <strong>un</strong>ito al Frassinetti potrebbe far sua la confessione <strong>di</strong><br />
Sant’Alessio dei Servi <strong>di</strong> Maria: “Mai fu intenzione mia e dei miei compagni fondare <strong>un</strong> nuovo<br />
or<strong>di</strong>ne, né che dall’<strong>un</strong>ione mia e dei miei compagni germogliasse <strong>un</strong>a Congregazione. Tutto questo<br />
è da attribuirsi perciò soltanto a Nostra Signora» 86 .<br />
Il suo operare ci fa pensare che la conduzione della Casa da parte <strong>di</strong> Padre Piccardo non era<br />
simile al cabotaggio che naviga costa costa finché non gi<strong>un</strong>ge ad <strong>un</strong> qualche approdo, ma <strong>un</strong><br />
tendere le vele al vento e cercare il mare aperto.<br />
Elenchiamo alc<strong>un</strong>i fatti senza particolari analisi contestuali.<br />
L’Arcivescovo Magnasco il 22 gennaio 1873 raccomandava l’opera ai possibili benefattori<br />
con <strong>un</strong>a lettera ufficiale: “Quest’opera posta sotto la protezione e l’alta <strong>di</strong>rezione dell’Arcivescovo<br />
<strong>di</strong> Genova dal suo regolamento, concorre a sod<strong>di</strong>sfare <strong>un</strong>o dei piú urgenti bisogni della città e della<br />
<strong>di</strong>ocesi, che è quello <strong>di</strong> accrescere il numero degli aspiranti allo stato ecclesiastico e cosí supplire<br />
alla continua deficienza del Clero. Quin<strong>di</strong> caldamente si raccomanda la carità dei benefattori.<br />
† Salvatore Arcivescovo”.<br />
L’opera era posta sotto l’alta <strong>di</strong>rezione dell’Arcivescovo, eppure i contratti <strong>di</strong> affitto e <strong>di</strong><br />
acquisto degli stabili per questa attività, <strong>come</strong> pure l’acquisto <strong>di</strong> villa Adorno <strong>di</strong> Rivarolo e la<br />
costruzione del Collegio San Giuseppe <strong>di</strong> Pra figurano tutti sotto il nome <strong>di</strong> Antonio Piccardo.<br />
Nel 1885 viene alla luce <strong>un</strong> progetto <strong>di</strong> regolamento per creare <strong>un</strong>a Congregazione. Ne è<br />
autore don Alessandro Monti, che era membro e professore nella Pia Casa.<br />
Dal Regolamento <strong>di</strong> don Piccardo: Nella casa possono essere accolti anche adulti -secondo<br />
lo spirito <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, che desiderano essere confratelli "al secolo" ma anche vivere in<br />
com<strong>un</strong>ità".<br />
Il 23 novembre 1887 Don Minetti scrive nel suo <strong>di</strong>ario (in <strong>un</strong> italiano <strong>un</strong> po’<br />
sgrammaticato): “Stasera parlai col Signor Direttore, <strong>di</strong> erigere questa casa – dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria - a<br />
formale Congregazione. Tutto insieme gli è piaciuto e pare che sarebbe <strong>di</strong>sposto o meglio<br />
desideroso”.<br />
7 febbraio 1889. Monsignor Emiliano Manacorda vescovo <strong>di</strong> Fossano consegna al Padre<br />
Piccardo il testo delle Costituzioni per l’erigenda Congregazione, che egli aveva elaborato.<br />
12 agosto 1891. Il Direttore Don Piccardo ri<strong>un</strong>í tutti i sacerdoti, che lavoravano nella Pia<br />
Casa. Erano presenti: Don Minetti, Don Olivari, Don Mantero, Don Monti, Don Montebr<strong>un</strong>o. Non<br />
86 Legenda de origine, n° 24, Fonti storico – spirituali dei Servi <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria, Bergamo 1998, 220.
38<br />
era presente, ma giustificato Don Gaggero. Si parlò delle regole della fondazione della<br />
Congregazione e dei passi successivi per arrivarvi.<br />
26 novembre 1892. Il Direttore Don Antonio Piccardo parla con il nuovo Arcivescovo<br />
Mons. Tommaso Reggio dell’erigenda Congregazione. Si mostra favorevole ma propone <strong>un</strong>a<br />
Congregazione <strong>di</strong> Oblati.<br />
19 luglio 1895. Don Antonio Piccardo viene nominato Rettore dei Seminari arcivescovili,<br />
conservando la Direzione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria.<br />
20 luglio 1895. Visita del Direttore a Monsignor Emiliano Manacorda che consiglia <strong>di</strong><br />
intensificare i lavori in vista della Congregazione.<br />
10 maggio 1899. Scrive Don Minetti nel suo <strong>di</strong>ario: “Il <strong>di</strong>rettore ha detto non piú tar<strong>di</strong> delle<br />
future vacanze si farà la Congregazione”.<br />
3 agosto, 18 agosto, 11 settembre 1899. Incontri ufficiali dei membri della Pia Casa. Erano<br />
presenti: Don Antonio Piccardo, Don Gaggero, Don Olivari, Don Minetti, Don Mantero, Don<br />
Boraggini e Don Antonio Giuseppe Piccardo.<br />
Tema della ri<strong>un</strong>ione:<br />
1) Opport<strong>un</strong>ità e utilità <strong>di</strong> ri<strong>un</strong>irsi in Congregazione<br />
2) Giu<strong>di</strong>zio sulle Regole<br />
3) Opport<strong>un</strong>ità dei voti religiosi.<br />
E qui ora si dovrebbe ripercorrere nell’analisi e nei racconti fedeli il cammino intellettuale,<br />
spirituale ed ecclesiale compiuto da Padre Piccardo, in modo quasi da trovarsi <strong>di</strong> fronte alle stesse<br />
sue scelte, orientamenti, decisioni: anche se questo percorso ci rivelerebbe soltanto la<br />
manifestazione esterna, storica della motivazione <strong>di</strong> fondare la Congregazione e non il suo legame<br />
<strong>di</strong>retto con lo Spirito, cioè il suo carisma, sarebbe tuttavia molto prezioso per la nostra presa <strong>di</strong><br />
coscienza.<br />
Il problema vocazionale e l’attenzione ai giovani possiamo considerarlo la via <strong>di</strong> sbocco<br />
della primitiva idea <strong>di</strong> fondazione <strong>di</strong> Padre Piccardo. Il de<strong>di</strong>carsi “tutto” ad esso, gettarsi a capofitto<br />
in questa opera, <strong>di</strong> cui la Pia Casa e i collegi <strong>di</strong> Pra e Rivarolo erano i primi segni, è stato per lui<br />
<strong>come</strong> <strong>un</strong>a nascita, la vera vocazione della sua vita.<br />
Fondatore non significa necessariamente “iniziatore” o “inventore”, <strong>come</strong> la storia delle<br />
Congregazione nei secoli ampiamente ci <strong>di</strong>mostra.<br />
È <strong>come</strong> se il Frassinetti avesse consegnato al Piccardo <strong>un</strong> progetto in cui erano visibili solo<br />
alc<strong>un</strong>e linee ed egli, guardandolo in filigrana, ne avesse capito la struttura e costruito l’e<strong>di</strong>ficio.<br />
Se il Frassinetti è l’iniziatore, Padre Piccardo ne è il promotore e continuatore e ad ambedue<br />
si ad<strong>di</strong>ce, su basi <strong>di</strong>verse, il titolo <strong>di</strong> fondatore.<br />
Capire e conoscere chi era il Frassinetti, chi era il Piccardo, che cosa hanno scritto, quale era<br />
il loro pensiero teologico, quale “gesta” hanno compiuto, scoprire la loro personalità poliedrica è<br />
bello, giusto e doveroso, ma c’è <strong>un</strong> solo modo per capire a fondo la loro vita e il loro carisma:<br />
amarli.
39<br />
LO SGUARDO PUNTATO VERSO TERRE LONTANE E VERSO NUOVI ORIZZONTI<br />
Nella Pia Casa era acuta la sensibilità missionaria. Pietro Olivari era il responsabile<br />
tipografico degli Annali della <strong>Santa</strong> Infanzia e promotore dell’Opera della Propagazione della Fede.<br />
Tutti gli al<strong>un</strong>ni della Casa era iscritti a detta Opera e ne leggevano gli “Annali”.<br />
«Nelle quoti<strong>di</strong>ane orazioni recitate in com<strong>un</strong>e in cappella, vi era anche <strong>un</strong>'invocazione<br />
particolare e <strong>un</strong>a preghiera a S. Francesco Saverio, al santo missionario, al santo dallo zelo<br />
apostolico e dalla fortezza dell'eroe <strong>di</strong> Cristo. E il santo fu propizio alle loro invocazioni ed essi<br />
promisero: saremo missionari» 87 . Padre Piccardo aveva a cuore la vocazione missionaria, egli<br />
guardava con desiderio verso le terre lontane, affinché il Regno del Signore allargasse i suoi<br />
confini. «E sono <strong>un</strong>a ventina i generosi che sparsi in Australia, in Cina, nel Brasile, nel Messico,<br />
negli Stati Uniti lavorano nel campo del Signore» 88 .<br />
Il primo al<strong>un</strong>no entrato dai <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, Nicolò Ferretti, fu il battipista e andò negli Stati<br />
Uniti. L’animo degli al<strong>un</strong>ni si infiammò alla lettura <strong>di</strong> <strong>un</strong>a lettera accorata <strong>di</strong> <strong>un</strong> Vescovo dell’Asia,<br />
«essa fu la scintilla che animò a rompere ogni indugio. Si <strong>di</strong>scusse, si sentí la voce <strong>di</strong> Dio ed il<br />
chierico Gilar<strong>di</strong>, passando sopra ogni umano riguardo, fu il primo a decidersi e con la bene<strong>di</strong>zione<br />
del <strong>di</strong>rettore Don Piccardo si offrí alle Missioni Estere <strong>di</strong> Milano. Or<strong>di</strong>nato sacerdote, partí nel 1881<br />
per la Cina dove lavorò intensamente nell’Ho-nam per 27 anni. Per la strada aperta da lui si<br />
avviarono altri <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria e furono: Gustavo Maria, apostolo per 42 anni in Birmania, Ferretti (il<br />
primo ragazzo accolto dal Frassinetti) in Nord America, Luigi Paro<strong>di</strong>, passato ai Gesuiti, fu<br />
missionario alle Montagne Rocciose, Domenico Poggi in Brasile, P. Lorenzo Torrazza, Giuseppe<br />
Schenone con i signori della Missione, P. Schiaffino e P. E. Vigo, Gesuiti in Cina, Nicola Grondona<br />
in Messico <strong>come</strong> Salesiano. Inoltre il P. Tragella <strong>di</strong>venne l’anima della <strong>di</strong>vulgazione e propaganda<br />
missionaria e Don Attilio Garrè che in seguito fondò in S. Ilario (Genova) il Collegio per le<br />
Missioni.<br />
A questi seguirono altri e Don Piccardo li seguí sempre tutti con <strong>un</strong> grande amore,<br />
mantenendo con essi affettuosa corrispondenza. Quando alc<strong>un</strong>i <strong>di</strong> loro rimpatriavano li invitava alla<br />
Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, cosa che essi gra<strong>di</strong>vano molto. II Piccardo seppe anche essere generoso con<br />
i suoi ex al<strong>un</strong>ni <strong>di</strong>venuti missionari» 89 .<br />
Fitta era la corrispondenza dei missionari, piena <strong>di</strong> notizie e <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> esse, nel desiderio<br />
<strong>di</strong> essere aggiornati sulla vita della Casa, che ricordano con nostalgia. A mo’ <strong>di</strong> esempio si riportano<br />
alc<strong>un</strong>i stralci <strong>di</strong> lettere, conservate in Archivio.<br />
«Mi tenni in dovere <strong>di</strong> scriverle la presente onde mostrare ancora <strong>un</strong>a volta il mio affetto e la<br />
mia stima verso la Ven. nostra Casa, cui mi sento debitore della mia educazione religiosa e con cui<br />
voglio tenermi congi<strong>un</strong>to in <strong>un</strong>ione <strong>di</strong> sentimenti e <strong>di</strong> preghiera … io mi trovo tuttora, in quanto<br />
Procuratore e Superiore <strong>di</strong> questa vasta Residenza <strong>di</strong> King-Kia-Kong, dove sono tutte le istituzioni<br />
del Vicariato … Da parte mia cerco <strong>di</strong> fare quanto meglio posso affine <strong>di</strong> mandare avanti la barca<br />
… Umilissimo e devotissimo figlio<br />
Antonio Gilar<strong>di</strong> 09 ottobre 1910» 90 .<br />
87<br />
Anime generose, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004, 113.<br />
88<br />
Ibid., 113.<br />
89<br />
BERTOLOTTO T., P. Piccardo – Vita, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004, 29-30.<br />
90 Archivio FSMI, Roma.
40<br />
«Anche questo suo figlio lontano le si avvicina attraverso i mari per queste feste <strong>di</strong> famiglia<br />
… Il Santo <strong>di</strong> cui porta il nome le ottenga la longevità a bene della novella Congregazione e <strong>di</strong> tanta<br />
gioventù, che e<strong>di</strong>ficata da lei si avvia sollecita per le vie della virtú e del sapere.<br />
In questi giorni solenni ricor<strong>di</strong> all’altare <strong>un</strong> suo figlio lontano <strong>di</strong> corpo ma vicino, molto<br />
vicino <strong>di</strong> cuore a quanto ricorda e respira l’atmosfera del venerato Frassinetti …<br />
Onorato sac. Piffero La Plata 25 novembre 1914» 91 .<br />
Padre Piccardo desiderava che il <strong>di</strong>namismo operoso della Chiesa potesse essere esteso<br />
anche ai popoli che non hanno ricevuto il Vangelo e agli italiani emigrati, senza sostegno spirituale.<br />
Non era questo <strong>un</strong> orientamento o <strong>un</strong> attivismo spontaneo ma <strong>un</strong> effetto dell’educazione, sorretta<br />
dall’attenzione e dall’ardore che egli, coa<strong>di</strong>uvato da Pietro Olivari, sentiva per il cammino del<br />
Vangelo e la <strong>di</strong>ffusione della fede.<br />
L’Istituto per le Missioni Estere era stato iniziato da don Pier Francesco Casaretto, con il<br />
beneplacito della <strong>Santa</strong> Sede, nel settembre del 1847 a San Giuliano d’Albaro, proprio nel Convento<br />
in cui Padre Piccardo creerà nel 1870 il Collegio San Giuseppe. Alle Missioni Estere egli ha<br />
in<strong>di</strong>rizzato i sacerdoti novelli e i seminaristi ormai prossimi all’or<strong>di</strong>nazione, che sentivano la spinta<br />
missionaria. Nel 1890 incontriamo <strong>come</strong> <strong>padre</strong> spirituale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria don Francesco Borghero<br />
della società delle Missioni Africane, <strong>di</strong> ritorno dal Dahomey.<br />
Nel 1903 era sorta la Congregazione Diocesana Romana e fra gli al<strong>un</strong>ni c’era chi si<br />
interrogava se aderire o meno a questa nuova istituzione ecclesiale. Don Domenico Poggi,<br />
missionario in Brasile, ruppe ogni indugio e tornò da tanto lontano per essere “<strong>Figli</strong>o <strong>di</strong> Maria”. Il 2<br />
ottobre 1904 fece i primi voti insieme agli altri otto membri.<br />
Aveva in serbo <strong>un</strong> sogno segreto: portare i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria in Brasile. Padre Piccardo, cuore<br />
missionario, lo desiderava <strong>come</strong> lui, ma vedeva che i tempi non erano maturi e le circostanze non lo<br />
consentivano. Don Poggi non rinnovò i voti religiosi e ritornò in Brasile, ma rimase “<strong>Figli</strong>o <strong>di</strong><br />
Maria missionario”. Quando si decise <strong>di</strong> aprire <strong>un</strong>’opera in Argentina, lui senza esitare si <strong>un</strong>í a<br />
Padre Tommaso Bertolotto per portare fino “ai confini del mondo” quell’ardore che aveva visto<br />
infiammare la vita <strong>di</strong> Padre Piccardo.<br />
L’ardore missionario <strong>di</strong> Padre Piccardo non si <strong>di</strong>rigeva “hic et n<strong>un</strong>c” verso quelle nazioni<br />
lontane nella quali era necessario pre<strong>di</strong>care il Vangelo ed impiantare la Chiesa, era tuttavia animato<br />
dal desiderio <strong>di</strong> <strong>un</strong>a viva e nuova cristianità, e ciò costituiva <strong>un</strong>a geniale intesa con il programma <strong>di</strong><br />
Pio X: “Instaurare omnia in Christo”.<br />
Era questo il contesto favorevole che lo proiettava verso nuovi orizzonti. La Casa <strong>di</strong><br />
Carignano non bastava per realizzare il <strong>di</strong>segno carismatico che aveva nel cuore. Il “pianeta”<br />
giovani era piú vasto <strong>di</strong> quelli che si presentavano per prepararsi al sacerdozio. Nel 1870 aprí <strong>un</strong><br />
piccolo collegio per ragazzi ad Albaro nel Convento dei Padri Benedettini, perché servisse <strong>di</strong><br />
preparazione all’acquisto <strong>di</strong> <strong>un</strong>a consapevolezza vocazionale.<br />
La vita fu <strong>di</strong> breve durata, perché due anni dopo, riapertosi il Convento e restituita la Chiesa<br />
ai Padri Benedettini, don Piccardo trasferì gli al<strong>un</strong>ni nella sua villa <strong>di</strong> Serrea <strong>di</strong> Voltri. Con<br />
sollecitu<strong>di</strong>ne pro<strong>di</strong>giosa, grazie al lascito “Sciallero”, costruì in Pra <strong>un</strong> collegio – preseminario.<br />
91 Archivio FSMI, Roma.
41<br />
Nel 1893 fondò il Collegio Sacra Famiglia a Rivarolo, creando <strong>un</strong> istituto per quei giovani<br />
che non si sentivano inclinati allo stato ecclesiastico, per dar loro <strong>un</strong>a educazione cristiana e <strong>un</strong>a<br />
cultura tale da aprire loro <strong>un</strong> avvenire nella vita civile.<br />
Non aveva ancora inaugurato l’Istituto Ecclesiastico Maria Immacolata in via del<br />
Mascherone (novembre 1903), che già il 24 luglio precedente prendeva possesso della Casa <strong>di</strong><br />
Lugnano in Teverina per a<strong>di</strong>birla ad aspirandato della costituenda Congregazione.<br />
Furono imponenti le opere con le quali realizzò il suo <strong>di</strong>segno: acquisto, rifacimento e<br />
ingran<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> immobili a Genova, a Pra, a Rivarolo, a Roma, a Lugnano in Teverina e a Siena.<br />
Nel 1910 era in cantiere l’apertura <strong>di</strong> <strong>un</strong>a scuola <strong>di</strong> istruzione civile a Busalla, opera che poi<br />
non ebbe la sua realizzazione. Certamente Padre Piccardo aveva in prospettiva altre opere, che<br />
avrebbero cominciato a prendere corpo, appena fosse passato il flagello della guerra. La Visita<br />
Apostolica, ponendo la Congregazione fuori del Diritto com<strong>un</strong>e e delle Costituzioni, raggelò ogni<br />
fuoco <strong>di</strong> futuro slancio apostolico e bloccò ogni progetto.<br />
Di fronte a queste gran<strong>di</strong> realizzazioni, non dobbiamo pensare che gli riuscisse tutto facile e<br />
che tutti lo accogliessero a braccia aperte. Egli dovette affrontare <strong>di</strong>fficoltà e superare ostacoli<br />
molto gravi, soprattutto per la realizzazione <strong>di</strong> quello che piú forte dentro gli bruciava: la<br />
Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata. Ebbe bene<strong>di</strong>zioni e appoggi vali<strong>di</strong>ssimi da Pio<br />
X e da altri benefattori, ma dovette far ricorso alla prudente e paziente intelligenza, alla preghiera e<br />
al <strong>di</strong>scernimento.<br />
Nel Capitolo Generale del 1928, tre anni dopo la morte <strong>di</strong> Padre Piccardo, fu approvata<br />
l’apertura alle missioni estere. Fu questa <strong>un</strong>a specificazione ma non <strong>un</strong>a novità: Padre Piccardo<br />
guardava lontano; e se non si era mosso era perché non voleva “andare” oppure “mandare” e basta<br />
ma perché voleva farlo con <strong>un</strong> <strong>di</strong>segno preciso da realizzare, <strong>di</strong>segno che ricopiasse le linee<br />
carismatiche.<br />
Egli lavorò con i giovani in genere e con quelli in “sortem Domini vocati”, si de<strong>di</strong>cò a<br />
scoprire, approfon<strong>di</strong>re ed inculcare la bellezza della vita religiosa, si impegnò a mettere in luce la<br />
vita e le opere del Frassinetti <strong>come</strong> traccia per seguire Cristo e questo suo pro<strong>di</strong>garsi nel campo <strong>di</strong><br />
Dio non segna solo <strong>un</strong>a sua intenzionalità apostolica ma anche <strong>un</strong>a modalità, che fa riferimento a<br />
elementi, meto<strong>di</strong>, mezzi, linguaggi e scelte concrete in questo ambito, che, sebbene precari, sono<br />
scia luminosa che in<strong>di</strong>cano la strada.
42<br />
IL CAMMINO DELLA REGOLA<br />
Mons. Emiliano Manacorda, vescovo <strong>di</strong> Fossano, arrivò il 7 febbraio del 1889 a Genova -<br />
Carignano e depose nelle mani <strong>di</strong> Padre Piccardo <strong>un</strong> plico contenente le Costituzioni per la erigenda<br />
Congregazione. Si erano già incontrati il 13 gennaio dello stesso anno, quando Monsignor Vescovo<br />
aveva benedetta la Cappella del Collegio San Giuseppe <strong>di</strong> Pra. Le sue visite alla Casa dei figli <strong>di</strong><br />
Maria erano frequenti, talvolta trascorreva in essa alc<strong>un</strong>i giorni <strong>di</strong> riposo.<br />
Manacorda era tra i vescovi piú ascoltati e preparati <strong>di</strong> tutta la regione ecclesiastica<br />
subalpina ed era anche autore <strong>di</strong> due importanti testi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto canonico ed ecclesiastico.<br />
Il 20 luglio del 1895 (il giorno dopo la nomina <strong>di</strong> Padre Piccardo a Rettore dei Seminari <strong>di</strong><br />
Genova) durante <strong>un</strong>o dei suoi amichevoli incontri con lui consigliò <strong>di</strong> intensificare i lavori in vista<br />
della Congregazione ed aggi<strong>un</strong>se che non sarebbe piú venuto a trovare i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria finché il<br />
progetto non fosse realizzato. Lo stesso Vescovo «scrive al Direttore, il 2 agosto 1899, che bisogna<br />
assolutamente dell’Istituto dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria farne “<strong>un</strong> ente religioso formale” lasciando le sole<br />
scuole elementari e ginnasiali» 92<br />
La stesura era avvenuta sulla base degli app<strong>un</strong>ti fornitegli da Padre Piccardo e Padre Minetti,<br />
sospinti dall’idea <strong>di</strong> <strong>un</strong>a definitiva sistemazione giuri<strong>di</strong>ca. La sua era <strong>un</strong>a buona Regola, <strong>un</strong>a pietra<br />
miliare in cui non c’era in<strong>di</strong>cata solo la <strong>di</strong>stanza ma era descritta la via ed ad<strong>di</strong>tata la <strong>di</strong>rezione.<br />
Questa Regola nella sua forma <strong>di</strong>alogica, prima <strong>di</strong> essere <strong>un</strong> co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> comportamento, era la<br />
narrazione dell’esperienza <strong>di</strong> vita dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria: anche se in <strong>un</strong> genere letterario scarno ed<br />
essenziale si raccontavano la vita e le gesta <strong>di</strong> Padre Piccardo e dei suoi.<br />
Una cosa non quadrava al sentire <strong>di</strong> Padre Piccardo: si insinuava l’idea <strong>di</strong> <strong>un</strong> cordone<br />
ombelicale, che creava <strong>di</strong>pendenza dal Vescovo e dalla Diocesi <strong>di</strong> Genova, richiamata nel testo,<br />
sotto varie forme, ben trentatre volte. Nel suo spirito pratico, intuiva forse continui conflitti <strong>di</strong> ruolo<br />
o presenza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a continua materia del contendere? O forse il suo sguardo era proiettato piú lontano<br />
oltre <strong>un</strong> certo provincialismo che i confini <strong>di</strong>ocesani rendevano abbastanza angusto? Forse l’<strong>un</strong>o e<br />
l’altro.<br />
Altre aporie si possono ancora rilevare: non si considerava la possibile adesione <strong>di</strong> nuovi<br />
sacerdoti, oltre quelli che lavoravano con e per i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, i can<strong>di</strong>dati preconizzati dovevano<br />
essere giovani dai 16 anni in su, l’entrata in noviziato ed i voti dovevano avere il parere favorevole<br />
del Vescovo ed i sacerdoti potevano essere dalla Curia destinati ad altri compiti, non collegati con<br />
l’organizzazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria. Inoltre si stabiliva che ogni membro doveva devolvere tutto il<br />
suo patrimonio in favore della Congregazione, che peraltro non era legittimata ad avere personalità<br />
giuri<strong>di</strong>ca.<br />
Il Concilio Lateranense IV del 1215 e poi quello <strong>di</strong> Lione del 1274 avevano stabilito che<br />
ness<strong>un</strong>o poteva vivere in gruppo con <strong>un</strong> abito religioso senza scegliere <strong>un</strong>a delle Regole approvate<br />
dalla Chiesa, tra cui la Regola <strong>di</strong> San Benedetto e quella <strong>di</strong> Sant’Agostino. Con il sorgere delle<br />
Congregazioni moderne, queste decisioni avevano perso <strong>un</strong> po’ <strong>di</strong> forza e le Congregazioni sorte al<br />
tempo e dopo la Riforma coniarono <strong>un</strong> nuovo stile <strong>di</strong> vita religiosa e per conseguenza <strong>un</strong> nuovo<br />
filone per quanto riguarda la Regola. Poteva essere agevole per Padre Antonio Piccardo, data la<br />
necessità <strong>di</strong> risolvere rapidamente l’intrigata “questione genovese”, ispirarsi a regole preesistenti, ad<br />
istituti religiosi già consolidati, ma no!, c’era <strong>un</strong> altro afflato interiore.<br />
92 Diario <strong>di</strong> Don Tommaso Gaggero, quaderno XXIX, Archivio FSMI, Roma.
43<br />
I <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria <strong>di</strong> fatto vivevano già sotto <strong>un</strong>a regola, che poteva <strong>di</strong>rsi sperimentata e vissuta<br />
da <strong>un</strong> quarantennio, perciò non erano semplicemente <strong>di</strong> prima fondazione. I regolamenti esistenti,<br />
anche se <strong>di</strong>versamente chiamati, erano cinque. Sebbene essi non siano stati scritti dalla mano del<br />
Frassinetti, eccetto la Regola della Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata e la Regola dei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria viventi in com<strong>un</strong>e, si può <strong>di</strong>re che essi sono espressione fedele della sua volontà,<br />
contengono il suo spirito, cioè la maniera <strong>di</strong> praticare le virtú, <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere e <strong>di</strong> fare il bene tra il<br />
popolo cristiano e tra i piú giovani.<br />
Padre Piccardo percepiva i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria <strong>come</strong> <strong>un</strong> organismo in crescita, <strong>come</strong> <strong>un</strong> corpo che<br />
vuole e sa prendere forma. Si tratta <strong>di</strong> <strong>un</strong>a evoluzione che porta alla scoperta <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>mensioni,<br />
che sono a loro volta stimolo <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento e <strong>di</strong> nuova ricerca. I cinque regolamenti<br />
summenzionati non erano adeguati alla nuova situazione. La tra<strong>di</strong>zione che durava ormai da<br />
quarant’anni, l’ispirazione e il richiamo al Frassinetti, maestro e p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> tutti i<br />
membri, aveva fatto fiorire nella mente e nel cuore <strong>di</strong> Padre Piccardo <strong>un</strong>a Regola semplice ed<br />
efficace, che si imponeva per la sua adesione alla realtà e il suo afflato profetico per l’avvenire.<br />
Il passaggio dalla Pia Opera alla Congregazione supponeva <strong>un</strong>a trasformazione e <strong>un</strong>a<br />
soli<strong>di</strong>ficazione: c’è <strong>un</strong> nuovo “dove” e <strong>un</strong> “quando” spirituale in cui sorge questa nuova forma<br />
ecclesiale. Nel periodo precedente alla Congregazione, la de<strong>di</strong>cazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria me<strong>di</strong>ante il<br />
voto <strong>di</strong> castità era considerata <strong>un</strong>a cosa privata, che riguardava cioè solo il singolo aderente; con<br />
l’accettazione della Congregazione, incominciando da quella <strong>di</strong>ocesana romana da parte del<br />
Car<strong>di</strong>nale Pietro Respighi, c’è il riconoscimento dell’autorità: non si tratta piú <strong>di</strong> cosa privata ma <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a cellula viva e necessaria dell’organismo della Chiesa <strong>un</strong>iversale. La consacrazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
Maria <strong>di</strong>venta <strong>un</strong>’offerta solenne, <strong>un</strong>a consacrazione sia del luogo, cioè dell’Istituto Maria<br />
Immacolata, sia delle persone, che a modo proprio, partecipano dell’offerta sacrificale del<br />
Salvatore.<br />
La Regola presentata all’atto della costituzione della Congregazione <strong>di</strong>ocesana era stata<br />
stesa da Padre Carlo Olivari, sulla falsariga <strong>di</strong> tutti i testi precedenti. Padre Piccardo cosí ricorda<br />
l’iter: «Le prime costituzioni praticate dalla Congregazione furono scritte nell’anno 1902-1903 e l’8<br />
<strong>di</strong>cembre 1903 furono approvate ad experimentum per tre anni dal Car<strong>di</strong>nal Respighi Vicario<br />
Generale <strong>di</strong> Sua Santità. Terminati i tre anni si ottenne in due volte dal Santo Padre Pio X la proroga<br />
delle stesse Costituzioni per altri tre anni i quali vanno a terminare l’8 <strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> quest’anno 1909.<br />
Ora si presentano alla Sacra Congregazione dei Religiosi le Costituzioni le quali vennero rivedute e<br />
per quanto fu possibile riformate secondo le Norme della <strong>Santa</strong> Sede.<br />
P. Antonio Piccardo Superiore Generale<br />
Roma, dalla Casa Generalizia, il 26 novembre 1909» 93 .<br />
Già «a partire dalla seconda metà del secolo XIX le Costituzioni dovettero essere per lo piú<br />
composte secondo <strong>un</strong> preciso metodo detto “norme”, elaborato dal Dicastero dei vescovi e regolari<br />
e poi pubblicato nel 1901. Avvenne cosí che quasi tutti gli istituti sorti nel menzionato secolo fino ai<br />
tempi moderni ebbero <strong>un</strong> testo pressoché uguale e per la <strong>di</strong>stribuzione della materia e per le varie<br />
<strong>di</strong>sposizioni. Inoltre la fedeltà alle “norme” che proibivano espressamente che nelle Costituzioni vi<br />
fossero citazioni della Scrittura, dei concili, dei santi padri ed esortazioni ascetiche e spirituali, fece<br />
delle Costituzioni <strong>un</strong> co<strong>di</strong>ce giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong>sciplinare; quin<strong>di</strong> arido, privo <strong>di</strong> quell’afflato <strong>di</strong> cui erano<br />
93 Archivio FSMI, Roma
44<br />
generalmente pervase piú o meno le Regole e le Costituzioni antiche» 94 . Fu approvato qualche anno<br />
dopo il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico ed anche le Costituzioni dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria si adeguarono ad <strong>un</strong><br />
modello com<strong>un</strong>e in cui l’eccesso dei canoni del Co<strong>di</strong>ce citati quasi integralmente, fece sfumare<br />
l’impulso spirituale e apostolico. Esse furono approvate definitivamente il 6 giugno del 1931, cioè<br />
sei anni dopo la morte <strong>di</strong> Padre Piccardo.<br />
Fu il Concilio Vaticano II, che volle che le leggi generali degli istituti abbracciassero gli<br />
elementi evangelici e teologici della vita religiosa e dell’<strong>un</strong>ione <strong>di</strong> questa con la Chiesa ed anche le<br />
norme giuri<strong>di</strong>che necessarie per definire chiaramente il carattere, i fini e i mezzi dell’Istituto 95 .<br />
Vuoi nelle Costituzioni presentate al Car<strong>di</strong>nale Vicario nel 1903, <strong>come</strong> anche nei testi<br />
precedenti e successivi, sempre risalta l’aspetto carismatico sia nella linea apostolica che nella linea<br />
mariana.<br />
Il fine apostolico è presente anche nel gruppo dei primi <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria viventi in com<strong>un</strong>e, ma<br />
data la conformazione della Unione, è <strong>un</strong> po’ generico. L’impegno per l’appoggio al gruppetto <strong>di</strong><br />
ragazzi ri<strong>un</strong>itisi per realizzare la vocazione al sacerdozio configura e determina meglio l’attenzione<br />
apostolica. La Regola della Pia Unione esorta a fare «tutto quel bene che essi possono» 96 e<br />
chiarisce: «attenderanno a promuovere la salvezza e la santificazione delle anime altrui, questo zelo<br />
riguarderà specialmente la gioventú, porzione della società la piú debole e la piú insi<strong>di</strong>ata» 97 . A mo’<br />
<strong>di</strong> specificazioni: il religioso al secolo promuoverà quelle f<strong>un</strong>zioni sacre che sono le piú fruttuose,<br />
promuoverà le pie <strong>un</strong>ioni affinché mettano <strong>un</strong> argine alle cattive associazioni, promuoverà buone<br />
letture, buone scuole, ricreazioni festive perché la gioventú abbia qualche innocente passatempo e<br />
sollievo, cosí intervenga piú volentieri alle f<strong>un</strong>zioni della Chiesa 98 .<br />
Con la costituzione della Pia Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria per l’avviamento dei giovinetti poveri<br />
allo stato ecclesiastico, che si può considerare il testamento del Frassinetti, tutte le forze si<br />
concentrarono in questa opera che, crescendo, assorbiva sia i membri che il loro zelo apostolico. Era<br />
com<strong>un</strong>que chiaro, <strong>come</strong> specificano le Costituzioni preparate dal Manacorda al capitolo<br />
<strong>di</strong>ciassettesimo, che i giovani non devono essere necessariamente poveri perché «la povertà non è<br />
titolo sufficiente ed assolutamente esclusivo per accettare i giovani nelle nostre case. Il fine stesso<br />
in<strong>di</strong>ca le qualità che lasciano presagire che con l’aiuto <strong>di</strong>vino riusciranno buoni ministri del<br />
Signore» 99 .<br />
In questo zelo impegnato per le vocazioni facilmente si può sentir risuonare l’eco della voce<br />
del Frassinetti: «Appena fui or<strong>di</strong>nato sacerdote si impossessò del mio cuore <strong>un</strong>a brama forte <strong>di</strong><br />
giovare per quanto potessi nella mia nullità, confidando <strong>un</strong>icamente nel <strong>di</strong>vino aiuto, al giovane<br />
clero e mi pareva che molto si sarebbe potuto fare a suo prò» 100 .<br />
Chi dà i tratti fisionomici alla linea apostolica è Padre Piccardo con il suo impegno per i<br />
giovani che aspirano al sacerdozio e per coloro che non hanno “ecclesiastica vocazione”. Egli vi ha<br />
94<br />
L. RAVASI, Nuovo Ca<strong>di</strong>ce – Nuove Costituzioni – Nuovo Direttorio, in AA. VV., Il nuovo <strong>di</strong>ritto dei Religiosi, Rogate,<br />
Roma 1984, 238-240<br />
95<br />
Ecclesiae Sanctae, sez. II, parte I, art. 12.<br />
96<br />
Religioso al secolo, Opere Ascetiche, Vol 2, 174.<br />
97<br />
Ibid.<br />
98<br />
Religioso al secolo, Op. Asc., Vol. 2, passim 145-146.<br />
99<br />
Archivio FSMI, Roma.<br />
100<br />
Schiarimenti sul mio passato, in D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vita del Sac. Giuseppe Frassinetti,<br />
E<strong>di</strong>zione Risonanze, Roma 2004, 15.
45<br />
riversato tutta la sua anima santa, <strong>come</strong> si versa l’acciaio fuso nello stampo. Lo zelo del suo<br />
apostolato non è solo memoria per i suoi figli, ma quasi reliquiario del suo spirito. Bisognerà<br />
cercarlo nello sviluppo storico e nutrirsene per assimilarlo in modo genuino. Il documento <strong>di</strong><br />
erezione della Congregazione a firma del Car<strong>di</strong>nale Pietro Respighi è <strong>un</strong>a in<strong>di</strong>cazione luminosa:<br />
«… <strong>di</strong> qui i summenzionati religiosi lodevolmente esercitano varie opere <strong>di</strong> bene secondo lo spirito<br />
dell’Istituto a favore della gioventù cristiana, soprattutto <strong>di</strong> quelli chiamati alla vita consacrata (in<br />
sortem Domini vocati)» 101 .<br />
La linea mariana è <strong>come</strong> <strong>un</strong> raggio rosso, quasi <strong>un</strong> laser, che con la sua luce trapassa tutte le<br />
varie e<strong>di</strong>zioni delle regole e costituzioni.<br />
«Noi ad<strong>un</strong>que, per la sola ragione che Maria è onorata da Dio, dovremmo segnalatamente<br />
onorare Maria amatissima nostra Madre … Riguardo poi alla confidenza che voi dovete avere<br />
nell’amor suo, io vi esorto a valervene segnatamente per raccomandarvi a lei … Coll’esortarvi alla<br />
devozione a Maria … non posso contenermi dal pregarvi … <strong>di</strong> procurare, che con voi se ne valgano<br />
tutti coloro che aspirano a conseguire la perfezione … e innamorare molte, molte anime» 102 .<br />
«Accenda sovente con calde istruzioni nel cuore dei suoi u<strong>di</strong>tori e fratelli l’amore alle virtú<br />
che meglio valgano a rendersi simili alla Madre Immacolata, parli con frequenza delle prerogative<br />
<strong>di</strong> questa grande Regina del Cielo e della terra, onde in tutti fiorisca soda devozione alla Patrona del<br />
nostro Istituto» 103 .<br />
I toni <strong>di</strong> Padre Piccardo sono piú calmi ma non meno convinti, l’amore, la confidenza e la<br />
devozione a Maria parte dalla certezza <strong>di</strong> essere <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata.<br />
Egli ha lasciato in ere<strong>di</strong>tà la Regola; essa è esclusiva per la Congregazione: in essa c’è il suo<br />
spirito, l’intento e la vita interiore che lo muoveva.<br />
Le “Regole” del Frassinetti sono state per lui fonte <strong>di</strong> ispirazione ma esse non erano<br />
esclusive per i “nuovi” <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria; altri hanno attinto, si sono ispirati e si ispirano e nella Chiesa<br />
sono sorte tante Congregazioni, soprattutto femminili, che hanno modulato da queste regole <strong>un</strong>a<br />
peculiare impronta frassinettiana.<br />
Le Costituzioni invece sono dei e per i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria. Il Padre le ha loro affidate perché<br />
fruttifichino e <strong>di</strong>ventino <strong>un</strong>a scelta personale, <strong>un</strong>a opzione <strong>di</strong> vita, <strong>un</strong> impegno nella libertà della<br />
totale donazione, cioè dei tratti della sua fisionomia, dei geni della sua vita spirituale.<br />
101 Decreto <strong>di</strong> erezione, 8-12-1903, Archivio FSMI.<br />
102 Religioso al secolo, OA, vol. 2, 168-170 passim.<br />
103 MANACORDA E., cap. 5, Archivio FSMI.
46<br />
LA SVOLTA<br />
L’Opera dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria era fiorente e forte, era stimata e piena <strong>di</strong> prestigio, eppure <strong>un</strong>a<br />
domanda serpeggiava nell’aria: “Che cosa ne sarà <strong>di</strong> essa <strong>un</strong> domani?”. La domanda faceva tremare<br />
<strong>di</strong> incertezza chi credeva e desiderava <strong>un</strong> domani.<br />
L’arcivescovo Reggio aveva affermato, <strong>come</strong> testimonia il suo segretario, Tommaso Olcese:<br />
«Se Padre Piccardo fa ora la Congregazione io gliela approvo perché voglio bene a lui e ai <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
Maria, ma non si può sapere <strong>come</strong> la penseranno i miei successori» 104 . Anche il vescovo Manacorda<br />
spingeva in questa <strong>di</strong>rezione, ma Padre Piccardo non dava risposta. Diversa era la concezione <strong>di</strong><br />
Congregazione: Padre Piccardo desiderava <strong>un</strong>a realtà aperta, che potesse spaziare oltre i confini<br />
della Diocesi, avere <strong>un</strong> rapporto con la Chiesa <strong>un</strong>iversale, <strong>un</strong> gruppo <strong>di</strong> uomini <strong>di</strong> Dio che avessero<br />
tra loro <strong>un</strong>a partecipazione ai propri beni materiali e spirituali, che con<strong>di</strong>videssero quoti<strong>di</strong>anamente<br />
i frammenti delle loro vite per creare <strong>un</strong>a nuova realtà ecclesiale piena <strong>di</strong> vigore. Una<br />
Congregazione <strong>di</strong> sacerdoti <strong>di</strong>ocesani, per quanto apprezzabile, non era ciò a cui lui aspirava, o ciò<br />
che sentiva interiormente <strong>come</strong> missione da compiere. L’impegno che poneva per <strong>un</strong>o sbocco<br />
futuro era sotto gli occhi <strong>di</strong> tutti, ma nulla faceva trapelare delle sue intenzioni; il suo cammino <strong>di</strong><br />
ricerca era avvolto quasi certamente dall’oscurità o dalla penombra, ma lui andava avanti perché si<br />
sentiva illuminato dai bagliori <strong>di</strong> <strong>un</strong>a certezza riposta.<br />
Il 10 maggio 1899, <strong>come</strong> registra Padre Minetti nel suo <strong>di</strong>ario, aveva affermato: “Non piú<br />
tar<strong>di</strong> delle future vacanze si farà la Congregazione”. Proprio in quell’anno Mons. Reggio stilò il<br />
documento <strong>di</strong> conclusione della Visita pastorale <strong>di</strong>ocesana, che tra l’altro <strong>di</strong>ce: «Il recente Istituto (i<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria) manca ancora <strong>di</strong> regole vere e proprie. Perciò, poiché totalmente soggetto<br />
all’Or<strong>di</strong>nario, deve <strong>di</strong>pendere, secondo la volontà del Concilio <strong>di</strong> Trento, dal Seminario Maggiore<br />
della Diocesi» 105 . Tutto sembrerebbe in piena coincidenza, considerando che Padre Piccardo era<br />
Rettore del Seminario, ma non era cosí, egli sentiva che il Signore gli aveva posto tra le mani<br />
<strong>un</strong>’opera <strong>di</strong>versa.<br />
Quando pareva che qualcosa si muoveva verso il meglio e le speranze si stavano<br />
riaccendendo, tutto si capovolse e si trasformò in asperità: il 23 novembre 1901 Mons. Reggio<br />
improvvisamente morí e Padre Piccardo dovette misurarsi con il successore.<br />
Già a maggio del 1900 si era recato a Roma e <strong>di</strong> ritorno, il 25 dello stesso mese riferì ai suoi<br />
collaboratori dei passi fatti, delle <strong>di</strong>rettive avute, degli incoraggiamenti ricevuti. Intraprese <strong>un</strong><br />
nuovo viaggio a Roma, continuando le esplorazioni e cercando <strong>di</strong> farsi <strong>un</strong> concetto piú esatto e<br />
completo per raggi<strong>un</strong>gere lo scopo, il 28 febbraio 1902. Fece prima <strong>un</strong> sosta a Firenze per<br />
abboccarsi con il Car<strong>di</strong>nale Mistrangelo suo antico compagno e consigliere. L’andata a Roma è<br />
<strong>come</strong> raccogliere le proprie forze per prendere <strong>un</strong>o slancio che deve essere definitivo.<br />
L’insistenza dell’uomo nel realizzare <strong>un</strong> personale <strong>di</strong>segno può essere propria <strong>di</strong> chi si sente<br />
spinto a compiere <strong>un</strong>’opera, che accrescerà il suo prestigio; tale costanza nella lotta e nello sforzo <strong>di</strong><br />
superare gli ostacoli degrada facilmente però in <strong>un</strong>a ostinazione che si cristallizza in <strong>un</strong><br />
atteggiamento <strong>di</strong> principio e ideologico. Non cosí per il nostro caso: Padre Piccardo era <strong>un</strong><br />
sacerdote sereno, umile, pieno <strong>di</strong> desiderio <strong>di</strong> Dio; egli assumeva il compito del futuro dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
104 FAIN BINDA L., Lettera <strong>di</strong> famiglia n° 33 del 1-12-2003, Archivio FSMI, Roma.<br />
105 Archivio FSMI, Casa A. Piccardo, Genova.
47<br />
Maria in perfetta semplicità, con spirito <strong>di</strong> intraprendenza lontana ugualmente dalla timidezza e<br />
dallo spirito <strong>di</strong> dominio.<br />
Consegnato lo schema delle Regole, nel settembre 1902, al nuovo arcivescovo <strong>di</strong> Genova<br />
Mons. Edoardo Pulciano, ebbe <strong>un</strong> giu<strong>di</strong>zio negativo e <strong>un</strong> rifiuto del progetto; egli voleva <strong>un</strong>a<br />
Congregazione <strong>di</strong>ocesana <strong>di</strong> Oblati.<br />
Padre Piccardo è l’uomo della fiducia, aveva <strong>un</strong>o sguardo positivo dentro e attorno a sé,<br />
nutriva fiducia negli uomini, fiducia nel futuro e perciò rimase ancorato al suo grande sogno, o<br />
meglio all’appello interiore. Il sogno era <strong>un</strong> sogno amico, ma anche pieno <strong>di</strong> incubi, che derivavano<br />
dall’ambivalente dubbio, che non si stia mistificando la volontà <strong>di</strong> Dio con la propria pres<strong>un</strong>zione.<br />
Ci sono momenti in cui nemmeno la preghiera dà conforto, nell’animo dominano principalmente<br />
l’incertezza e l’angoscia. Fu cosí che il 23 settembre, cioè quattro giorni dopo l’incontro con<br />
l’arcivescovo, Padre Piccardo intraprese <strong>un</strong> nuovo viaggio per Roma, senza omettere la sosta a<br />
Firenze per incontrare il Car<strong>di</strong>nale Alfonso Mistrangelo.<br />
È <strong>di</strong>fficile avere idea degli ostacoli che ingombravano il suo cammino: <strong>di</strong>spiaceri,<br />
<strong>di</strong>singanni, delusioni … ma egli va avanti senza scrollarsi <strong>di</strong> dosso i carichi, non in<strong>di</strong>etreggia<br />
<strong>di</strong>nanzi al sacrificio, <strong>come</strong> se vedesse chiaro il traguardo da raggi<strong>un</strong>gere. A Roma incontrò il<br />
Car<strong>di</strong>nale Pietro Respighi, che quasi lo attendeva senza nemmeno conoscerlo personalmente. E gli<br />
avvenimenti gli si srotolarono davanti con <strong>un</strong>a rapi<strong>di</strong>tà sorprendente. Nell’abboccamento con il<br />
Piccardo, il 10 ottobre 1902, il Car<strong>di</strong>nale Vicario lascia scivolare <strong>un</strong>a promessa colma <strong>di</strong> certezza:<br />
“La Congregazione si farà”.<br />
I fatti si svolgono in rapida successione: il 6 novembre 1902 partenza da Genova per Roma<br />
<strong>di</strong> Padre Piccardo ed i suoi collaboratori, il 7 novembre presa <strong>di</strong> possesso della sede provvisoria<br />
dell’Istituto Ecclesiastico ai “Cento preti”, l’11 <strong>di</strong>cembre solenne inaugurazione dell’Istituto, il 20<br />
maggio 1903 Padre Piccardo acquista il palazzo Sinibal<strong>di</strong> in via del Mascherone, il 13 luglio<br />
presenta al Car<strong>di</strong>nale Vicario Pietro Respighi insieme alle bozze delle Costituzioni, formale<br />
domanda dell’erezione in Congregazione, il 24 luglio apertura della Casa <strong>di</strong> San Francesco a<br />
Lugnano in Teverina, offerta dal conte Vannicelli, per la preparazione degli aspiranti della novella<br />
Congregazione.<br />
Padre Piccardo è stupefatto; nella lettera circolare del 21 giugno 1910 scrive: «Pensando ai<br />
tanti benefici che il Signore in tanta abbondanza ci ha concesso, al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> ogni nostro merito,<br />
quale corrispondenza è necessario che abbiamo verso <strong>di</strong> Lui!» 106 .<br />
La prova sofferta gli fece scoprire <strong>un</strong>a nuova <strong>di</strong>mensione, <strong>un</strong>a chiamata interiore ine<strong>di</strong>ta,<br />
fino alla totale de<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> sé. Anche se il percorso era ancora l<strong>un</strong>go, la strada erta e la luce fioca<br />
tuttavia il cammino non era piú a tentoni. Il perfezionamento dell’opera iniziata fu altrettanto rapido<br />
e lo racconta Padre Piccardo stesso: «Proprio in questi giorni devono ritornare alla nostra mente e al<br />
nostro cuore alc<strong>un</strong>e date per noi preziose. Quella del 21 Maggio, vigilia della Pentecoste del 1904,<br />
quando la nostra Congregazione ebbe il suo primo riconoscimento canonico, e, cosa quasi inau<strong>di</strong>ta,<br />
il Decretum Lau<strong>di</strong>s nello stesso Rescritto Pontificio; e quella del 3 Giugno del 1910 che coincideva<br />
colla festa del SSmo Cuore <strong>di</strong> Gesù, quando la Sacra Congregazione dei Religiosi in sua seduta<br />
Plenaria proponeva l'approvazione dell'Istituto, e delle nostre Costituzioni ad sexennium … Per<br />
questi, e per tanti altri benefici spirituali e temporali che abbiamo ricevuto, non è forse giusto,<br />
106 PICCARDO A., Lettera circolare del 30 maggio 1913, Archivio FSMI, Roma.
48<br />
doveroso e salutare, che da noi continuamente si lo<strong>di</strong>, si ringrazi, si bene<strong>di</strong>ca la Bontà infinita <strong>di</strong><br />
quel Dio che cosi manifestamente e largamente ci ha beneficati?» 107 .<br />
La figura <strong>di</strong> Padre Piccardo, <strong>come</strong> autore e fondatore della Congregazione non è l’immagine<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong> eroe solitario ma è contornato dalla presenza del Car<strong>di</strong>nale Pietro Respighi, coa<strong>di</strong>uvato da<br />
Mons. Francesco Faberi e <strong>di</strong> San Pio X°, che hanno partecipato allo spirito del carisma<br />
fondazionale, non solo favorendo e semplificando ma collaborando e intervenendo in modo <strong>di</strong>retto.<br />
Nella richiesta formale <strong>di</strong> erezione della Congregazione, Padre Piccardo chiese che fosse eretta a<br />
Congregazione non <strong>un</strong> gruppo <strong>di</strong> sacerdoti animati da buona volontà ma la Pia Opera dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Maria Immacolata: la presenza del Frassinetti è necessità incastonarla.<br />
107 PICCARDO A., Lettera circolare del 30 maggio 1913, Archivio FSMI, Roma
49<br />
PADRE PICCARDO SUPERIORE<br />
Nella vita com<strong>un</strong>itaria dei primi nove membri, che il 2 ottobre 1904 aveva avuto il suo<br />
inizio, occorreva nominare <strong>un</strong> responsabile quale guida <strong>di</strong> questi fratelli nel cammino spirituale e<br />
apostolico. Padre Piccardo fino allora era stato il perno <strong>di</strong> tutte le svolte e lo strumento qualificato <strong>di</strong><br />
ogni nuova meta, era riconosciuto da tutti <strong>come</strong> il “signor Direttore”.<br />
Con il sorgere della nuova Congregazione veniva costituito nella Chiesa <strong>un</strong> ente nuovo, <strong>un</strong><br />
nuovo carisma dello Spirito si incastonava nella storia quoti<strong>di</strong>ana della Chiesa stessa; era necessario<br />
<strong>un</strong> “episcopus” cioè <strong>un</strong> custode che conservasse gelosamente la forza teologale del dono, animasse<br />
e <strong>di</strong>rigesse i confratelli e scegliesse le modalità adeguate e questo non a nome proprio ma della<br />
suprema autorità ecclesiastica.<br />
Fu papa Pio X che nominò, nel Primo Capitolo <strong>di</strong> sua autorità, Padre Piccardo Superiore<br />
Generale 108 .<br />
La qualifica <strong>di</strong> “Direttore” con cui era designato Padre Piccardo aveva <strong>un</strong> valore f<strong>un</strong>zionale<br />
ad <strong>un</strong> ruolo <strong>di</strong> carattere organizzativo; la com<strong>un</strong>ità religiosa a cui il titolo <strong>di</strong> “Superiore” si riferisce<br />
non è <strong>un</strong> collettivo anonimo bensí il luogo teologico dove si <strong>di</strong>venta fratelli, che fa fiorire la<br />
com<strong>un</strong>ione dalla con<strong>di</strong>visione dei beni dello Spirito. Egli fu il primo responsabile della com<strong>un</strong>ità,<br />
quale guida dei fratelli nel cammino spirituale e apostolico.<br />
Nell’esortazione preliminare al Capitolo il Car<strong>di</strong>nale Respighi, citando San Paolo, si rivolse<br />
ai nuovi professi con queste parole: «Vi preghiamo fratelli <strong>di</strong> aver riguardo per quelli che faticano<br />
tra voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono: trattateli con molto rispetto e carità, a<br />
motivo del loro lavoro» (1 Tes 5,12-13).<br />
Con <strong>un</strong> tale portaban<strong>di</strong>era, dall’alto riconosciuto idoneo, il piccolo drappello si mise in<br />
cammino verso la costituzione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a fraternità e il raggi<strong>un</strong>gimento delle sue finalità spirituali e<br />
apostoliche.<br />
Padre Piccardo prima che “il Superiore” è <strong>un</strong> religioso; egli non è <strong>un</strong> religioso improvvisato,<br />
<strong>un</strong> <strong>padre</strong> Generale per il combinarsi <strong>di</strong> coincidenze, <strong>un</strong> <strong>Figli</strong>o <strong>di</strong> Maria per aver detto <strong>un</strong> “si” in età<br />
ancora giovanile, <strong>un</strong> “si” <strong>un</strong> po’ incosciente e <strong>un</strong> po’ temerario. Egli abbracciò la causa vocazionale<br />
a cui si era de<strong>di</strong>cato con tutto se stesso, <strong>come</strong> ragione <strong>di</strong> vita, senza rimpianti e senza ritorni e si fa<br />
premuroso per questa nuova creatura ecclesiale, <strong>come</strong> erano i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, <strong>come</strong> tenero <strong>padre</strong>.<br />
Il Padre Carlo Olivari, che ha passato la sua vita <strong>come</strong> al<strong>un</strong>no, confratello e Consultore <strong>di</strong><br />
Padre Piccardo ci <strong>di</strong>ce che, quando nel 1872 (quattro anni dopo la morte del Frassinetti), entrò nei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria «non si chiamavano generalmente cosí, ma piuttosto <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Prete Piccardo, e sotto<br />
tale nome li conobbi io la prima volta che ebbi notizia <strong>di</strong> loro» 109 .<br />
Nell’epigrafe della sua tomba, collocata nella cappella della Casa Madre, si legge<br />
“santissime rexit”; egli, <strong>come</strong> si <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> San Gregorio Magno, ha lasciato <strong>un</strong> esempio <strong>di</strong> vita e <strong>un</strong>a<br />
regola <strong>di</strong> azione. Sentiva l’importanza del compito <strong>di</strong> superiore e sapeva che era necessario per<br />
108 Nell’Archivio del Vicariato <strong>di</strong> Roma è conservato il Rescritto del Car<strong>di</strong>nale Vicario Pietro Respighi (R 2, “Archivio,<br />
Ufficio 2, 1-10-1904) in cui si <strong>di</strong>ce tra l’altro: “R.mi Antonii Piccardo…totius Instituti Moderatorem Supremum ultro<br />
libentique animo per sexennium proximum adlegit”.<br />
109 PISONI T., Lettere ai confratelli, lettera n° 11, Archivio FSMI, Roma.
50<br />
consolidare la com<strong>un</strong>ione fraterna e non vanificare i voti professati, in particolare quello <strong>di</strong><br />
obbe<strong>di</strong>enza.<br />
Intraprendente e l<strong>un</strong>gimirante «realizzò il suo <strong>di</strong>segno con imponenti opere tra le quali:<br />
l’acquisto, il rifacimento e l’ingran<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> immobili a Genova, a Pra, a Rivarolo, a Roma, a<br />
Siena; altre proprietà ebbe in ere<strong>di</strong>tà, affitto o affidamento (Lugnano); importanti le biblioteche<br />
ere<strong>di</strong>tate o riscattate ed arricchite; prezioso il Gabinetto Scientifico Capranica: le Case dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
Maria dovevano essere anche centri <strong>di</strong> cultura» 110 .<br />
Lo sguardo <strong>di</strong> Padre Piccardo sulla Congregazione, creatura <strong>di</strong> Dio sbocciatagli tra le mani,<br />
è <strong>di</strong> <strong>un</strong> sano ottimismo sia per lo sviluppo sia per la qualità della vita religiosa. Ne fa fede la<br />
relazione del 26 novembre 1909 (cinque anni dopo l’approvazione), sullo “stato <strong>di</strong>sciplinare” della<br />
Congregazione 111 . In essa conclude : «Il Superiore Generale, <strong>un</strong>itamente ai suoi Consiglieri, crede<br />
<strong>di</strong> poter attestare che, per grazia <strong>di</strong> Dio, in tutte singole le Case e da tutti e singoli i membri<br />
dell’Istituto, viene osservata con buono spirito, la religiosa <strong>di</strong>sciplina, per quanto è possibile nelle<br />
presenti circostanze, e in quantum humana fragilitas sinit» 112 .<br />
Consapevole del suo compito, agiva in modo franco e intrepido, si <strong>di</strong>rebbe oggi con<br />
“paressia”, ma senza pignoleria e meschinità, nello sforzo <strong>di</strong> mantenere l’<strong>un</strong>ità anche quando la<br />
carità era <strong>di</strong>fficile o non sufficiente per <strong>di</strong>stricarsi dentro il pluralismo e i contrasti dei caratteri.<br />
Il Vescovo Ghio lo definisce «meraviglioso nocchiero che la tempesta non impaurisce, che<br />
in faccia al pericolo non trema, che davanti all’ostacolo si esalta, che attraverso la bufera <strong>di</strong> cui fu<br />
feconda la sua l<strong>un</strong>ga esistenza, seppe compiere ar<strong>di</strong>tamente la sua navigazione e arrivare al porto<br />
integris rate et mercibus» 113 .<br />
110<br />
PISONI T., Lettere ai confratelli, lettera n° 11, Archivio FSMI, Roma.<br />
111<br />
Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata<br />
Stato <strong>di</strong>sciplinare<br />
Dopo che la Congregazione ebbe ottenuto dal Santo Padre Pio X il Decretum lau<strong>di</strong>s, il Superiore Generale col suo<br />
Consiglio, continuò le opere che aveva nella Diocesi <strong>di</strong> Genova; stabilí nella Casa <strong>di</strong> Roma il Noviziato: consolidò il<br />
Collegio ecclesiastico <strong>di</strong> Maria Immacolata, in Roma, e procurò che venisse eretta canonicamente la Casa <strong>di</strong> Lugnano in<br />
Teverina (Diocesi <strong>di</strong> Amelia). Inoltre decise l’ampliamento del Collegio <strong>di</strong> Roma per aprire anche <strong>un</strong> pensionato<br />
ecclesiastico; ampliamento che è tuttora in costruzione; e sta per intraprendere l’opera <strong>di</strong> nuove scuole in Busalla,<br />
Diocesi <strong>di</strong> Genova. Sta anche curando l’e<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> tutte le opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te del Priore Frassinetti che si vengono<br />
stampando dalla Tipografia Vaticana.<br />
Le case della Congregazione sono attualmente:<br />
1. La Casa <strong>di</strong> Roma (Collegio e Pensionato ecclesiastico <strong>di</strong> Maria Immacolata)<br />
2. La Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata, nella città <strong>di</strong> Genova<br />
3. La Casa <strong>di</strong> Rivarolo Ligure (Collegio Sacra Famiglia)<br />
4. La Casa <strong>di</strong> Pra, Diocesi <strong>di</strong> Genova (Collegio San Giuseppe)<br />
5. La Casa <strong>di</strong> Lugnano in Teverina, Diocesi <strong>di</strong> Amelia (Casa San Francesco) per gli aspiranti della<br />
Congregazione<br />
Fanno attualmente parte della Congregazione i seguenti membri:<br />
a. Sacerdoti professi n° 13<br />
b. Studenti professi n° 6<br />
c. Conversi professi n° 1<br />
d. Novizi n° 1<br />
112<br />
Archivio FSMI, Roma.<br />
113<br />
GHJO G., Nel ricordo della sua morte, AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004,<br />
74-75.
51<br />
Riferendosi a Padre Piccardo, Pio X <strong>di</strong>sse agli al<strong>un</strong>ni dell’Istituto Ecclesiastico Maria<br />
Immacolata in visita in Vaticano il 30 maggio 1908: «Sono contento che le notizie del Collegio<br />
Maria Immacolata sono ottime. E <strong>di</strong>co ottime, perché, quando il vostro Rettore <strong>di</strong>ce che le cose<br />
vanno benino, io che lo conosco, interpreto che le cose vadano ottimamente» 114 .<br />
Era questione <strong>di</strong> fiducia nell’uomo ma non solo, possiamo caratterizzare questo suo modo <strong>di</strong><br />
educare <strong>come</strong> arte <strong>di</strong> accogliere e vivere l’incompiutezza. Si tratta <strong>di</strong> <strong>un</strong>a pazienza umile ma<br />
rigonfia <strong>di</strong> speranza. Si può accogliere l’incompiutezza dell’altro se si riconosce l’incompiutezza e<br />
la fragilità che alberga dentro <strong>di</strong> sé: Padre Piccardo era cosí; l’ispirazione era l’amore «perché la<br />
carità è paziente» (I Cor 13,4).<br />
Rilevante è l’esortazione ad essere veri religiosi: «Siamo noi riconoscenti e pensiamo spesso<br />
alla grazia grande della vocazione religiosa? Facciamo noi gran conto <strong>di</strong> questa vocazione colla<br />
esatta osservanza dei tre voti <strong>di</strong> povertà, <strong>di</strong> castità e <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza? Ten<strong>di</strong>amo all’acquisto della<br />
perfezione, a questo nostro stretto dovere? Mettiamo in pratica i mezzi per ottenerla, che sono<br />
app<strong>un</strong>to l’osservanza dei voti e l’esatto adempimento delle nostre Costituzioni? Siamo noi uomini<br />
<strong>di</strong> orazione, <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tazione, fonti queste <strong>di</strong> grazie e <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zioni? Amiamo tutti i nostri fratelli<br />
senza <strong>di</strong>stinzioni <strong>di</strong> sorta? Li amiamo in Dio e per Dio?» 115 .<br />
L’autorità <strong>di</strong> Padre Piccardo si coniugava con la paternità; si può <strong>di</strong>re, ad immagine del<br />
Santo, che egli aveva <strong>un</strong> cuore “che ascolta”: sapeva cogliere il contesto situazionale, sapeva<br />
partecipare alle gioie e alle sofferenze <strong>di</strong> chi gli stava attorno, cioè sapeva piangere con chi piange e<br />
gioire con chi era nella gioia. Un esempio evidente lo abbiamo nella triste circostanza della morte<br />
del chierico Giacomo Peluffo: ascoltiamo <strong>un</strong> testimone oculare: «Poi, visto però che le cose<br />
andavano peggiorando, fece chiamare il P. Generale che accorse subito e, trattenendosi alquanto<br />
con lui, ne uscí piangendo e <strong>di</strong>sse: “Mi ha dato l’ad<strong>di</strong>o ...”... appena morto non pareva morto, ma<br />
solo in placido sonno. Il P. Piccardo in quella angoscia <strong>di</strong>ceva: “Non è morto”. Piú volte lo chiamò<br />
ancora per nome; illusione pietosa!» 116 . Simili stati d’animo si colgono nelle lettere circolari in cui<br />
com<strong>un</strong>ica la morte dei chierici Villa e Cesena.<br />
Era attento e preoccupato degli eventi ma non trascurava le piccole cose, <strong>come</strong> quando<br />
rimproverò il cuoco (Antonio Minetti ndr) per aver fatto mancare la frutta a colazione. Una<br />
attenzione alle piccole situazioni dettata da <strong>un</strong> cuore <strong>di</strong> <strong>padre</strong>; scriveva per <strong>un</strong> chierico: deve<br />
coprirsi bene, specialmente nelle giornate brutte e fredde: deve avere <strong>un</strong>a maglia <strong>di</strong>screta alla pelle e<br />
<strong>un</strong>a piú grossa sopra la camicia; il 13 ottobre 1917, durante la prima guerra mon<strong>di</strong>ale partí da Roma<br />
per Lugnano con <strong>un</strong> sacco <strong>di</strong> riso per i suoi bagarilli (= piccoli aspiranti).<br />
Si può definire <strong>un</strong> uomo vigilante, interiormente attento all’uomo e alle sue esigenze e<br />
perciò responsabile, cosciente <strong>di</strong> doversi prendere cura <strong>di</strong> tutto e, in particolare capace <strong>di</strong> vigilare su<br />
quelli a lui affidati e <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>rli.<br />
Anche se il suo sguardo era proteso ai piú vasti orizzonti, quasi in modo telescopico, sapeva<br />
concentrare il suo interesse alle singole persone, ai piccoli bisogni, sapeva occuparsi anche de<br />
minimis. Sembra <strong>di</strong> cogliere nella suo raccontare <strong>un</strong> po’ infantile negli incontri che ha con gli<br />
114 Archivio FSMI, Roma.<br />
115 Circolari dei Padre Generali, Circolare n. 8, Archivio dei FSMI, Roma,<br />
116 BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zione Risonanze, Roma 2004, 48.
52<br />
al<strong>un</strong>ni, i confratelli e dei racconti con cui infioretta questo familiare ritrovarsi, l’espressione della<br />
gioia e della pienezza che aveva nel suo animo e della voglia <strong>di</strong> trasmetterla 117 .<br />
117 De minimis, AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004, 113-115.
53<br />
PADRE PICCARDO E IL PAPA<br />
Il 20 agosto 1914, dopo alc<strong>un</strong>i giorni <strong>di</strong> malattia, Pio X entrò nella pace eterna. Il Padre<br />
Piccardo, profondamente addolorato, da Genova dove si trovava, inviò <strong>un</strong>a lettera circolare ai<br />
confratelli. In essa definiva Pio X «autore, benefattore augusto e <strong>padre</strong> amantissimo e amabilissimo:<br />
infatti la nostra Congregazione ha perduto con Pio X il <strong>padre</strong>, il protettore e il benefattore» 118 .<br />
Una sincera, spontanea amicizia legava le loro anime. Come ci insegna il Siracide, <strong>un</strong>a vera<br />
e durevole amicizia è rarissima, <strong>come</strong> <strong>un</strong> insigne tesoro (6,15-16), ma tra Pio X e Padre Piccardo il<br />
tesoro era stato <strong>di</strong>ssepolto e fatto fruttare.<br />
Padre Piccardo aveva conosciuto Giuseppe Sarto (futuro Pio X) quando, vescovo <strong>di</strong><br />
Mantova, si era recato a Genova nel gennaio del 1887, per tenere il panegirico nella festa <strong>di</strong> San<br />
Francesco <strong>di</strong> Sales nella Chiesa <strong>di</strong> San Siro. Non basta che due uomini si conoscano perché possano<br />
nutrire <strong>un</strong>a reciproca benevolenza; loro in forza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a intuizione spirituale avevano avvertito <strong>un</strong>a<br />
certa com<strong>un</strong>ione <strong>di</strong> idee, <strong>di</strong> sentimenti e <strong>di</strong> volontà.<br />
«Il 20 luglio 1903, tra la costernazione <strong>di</strong> tutto il mondo cattolico, moriva il Santo Padre<br />
Leone XIII e secondo le previsioni puramente umane questo fatto arrecò <strong>un</strong>a certa ansietà<br />
nell’animo <strong>di</strong> Don Piccardo e <strong>di</strong> Don Minetti, perché con la morte del Papa cessavano dal loro<br />
ufficio tutti gli alti <strong>di</strong>gnitari della Curia Romana e del Vicariato, compreso il Card. Vicario Pietro<br />
Respighi, per cui logicamente si prospettava qualche timore sull’avvenire del nuovo Istituto.<br />
Con l’elezione del Card. Giuseppe Sarto al Sommo Pontificato, avvenuta il 4 agosto 1903,<br />
scomparve ogni timore perché <strong>un</strong>o dei suoi primi atti fu quello <strong>di</strong> confermare S. E. il Card. Pietro<br />
Respighi vicario <strong>di</strong> Roma e questo significava la continuazione degli stessi programmi e delle stesse<br />
<strong>di</strong>rettive, cosí l’Istituto poté proseguire sicuro il suo apostolato.<br />
Sua Santità Pio X intuí che, per attuare il suo programma <strong>di</strong> “instaurare omnia in Christo”,<br />
dovendo cominciare dal clero, avrebbe trovato <strong>un</strong>a valida cooperazione nel nostro Istituto» 119 .<br />
Seguirono gesti concreti attraverso i quali si constata l’attenzione e l’amore <strong>di</strong> Pio X verso la<br />
nuova istituzione ma in particolare verso Padre Piccardo che la incarnava e l’animava.<br />
L’otto <strong>di</strong>cembre 1903 il Car<strong>di</strong>nale Vicario firmò il Decreto <strong>di</strong> erezione della Congregazione<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>ocesano, naturalmente con il benestare pontificio, il 21 maggio 1904 venne emesso il<br />
Decreto Pontificio ossia il Decretum Lau<strong>di</strong>s per la Congregazione <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata,<br />
il 2 ottobre 1904 in occasione della emissione dei voti religiosi da parte dei nove confratelli nominò<br />
«ultro libentique animo- Superiore Generale <strong>di</strong> tutta la Congregazione per il prossimo sessennio<br />
Padre Antonio Piccardo (1904-1910)» 120 .<br />
I gesti e «le parole <strong>di</strong> amicizia del Santo Padre Pio X risuonano potentemente in P. Antonio<br />
Piccardo, aprendo le sue labbra ad <strong>un</strong> l<strong>un</strong>go Magnificat: quasi <strong>un</strong> pellegrinaggio <strong>di</strong> ringraziamento<br />
l<strong>un</strong>go quella miriade <strong>di</strong> Santuari Mariani che andava collezionando e catalogando in tre voluminosi<br />
118<br />
VACCARI G., San Pio X e il Piccardo, AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004,<br />
33..<br />
119<br />
BERTOLOTTO T., P. Antonio Piccardo – Vita, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004, 70.<br />
120<br />
VACCARI G., San Pio X e il Piccardo, AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004,<br />
40 .
54<br />
album, quale scrigno dei suoi sentimenti piú delicati e dei suoi desideri vocazionali affidati da<br />
tempo alla Vergine Immacolata» 121 .<br />
Il 4 giugno 1910 «il Santo Padre Pio X nella sua speciale benevolenza, aderendo al voto<br />
favorevole della Congregazione Plenaria dei Religiosi tenutasi in Vaticano il giorno precedente (3<br />
giugno, festa del Sacro Cuore <strong>di</strong> Gesú) concedeva il Decreto <strong>di</strong> Approvazione definitiva al nostro<br />
Istituto e l’Approvazione ad sexennium delle nostre Costituzioni. Nella successiva u<strong>di</strong>enza dell’11<br />
giugno ci spronava cosí: Desidero che siate molti perché facciate molto bene nella Chiesa» 122 .<br />
Pio X amò e protesse Padre Piccardo <strong>come</strong> <strong>un</strong> Padre protegge <strong>un</strong> figlio. Come ebbe a<br />
scrivere il P. Giovanni Vaccari: «Da questo periodo (1904) la figura del P. Piccardo <strong>di</strong>venne cosí<br />
popolare in Vaticano che dallo svizzero al portone <strong>di</strong> bronzo, agli intimi della famiglia Pontificia,<br />
correvano a lui e lo salutavano <strong>come</strong> <strong>un</strong> amico <strong>di</strong> casa. Non vi era f<strong>un</strong>zione, cerimonia, ricevimento<br />
senza che egli vi partecipasse; la familiarità con gli intimi del Pontefice e col Pontefice stesso lo<br />
aveva reso caro a tutti» 123 . La grande bontà <strong>di</strong> Pio X verso il Padre Antonio Piccardo ebbe<br />
manifestazioni <strong>di</strong> vera famigliarità e si sarebbe tentati <strong>di</strong> <strong>di</strong>re <strong>di</strong> fraterna intimità.<br />
Questa benevolenza, quasi preferenziale, era originata dal fatto che si era conosciuto il<br />
grande amore, la profonda venerazione che egli aveva per il Papa e Pio X lo amò e lo protesse <strong>come</strong><br />
<strong>un</strong> <strong>padre</strong> protegge <strong>un</strong> figlio. «Anche nei pubblici ricevimenti se Pio X vedeva il P. Piccardo a lui<br />
rivolgeva sempre la parola e nello scherzo arguto che spesso usciva dalle labbra del Santo<br />
Pontefice, che denotava la serenità del suo animo e il palpito del suo cuore paterno, si vedeva <strong>di</strong><br />
quale affetto lo circondava» 124 .<br />
L’amicizia deve dar prova <strong>di</strong> sé, della sua autenticità, adeguandosi al detto <strong>di</strong> Gesú, che<br />
parlando del suo destino <strong>di</strong> morte afferma : “Non siete piú servi ma amici” (Gv. 15,15). L’amicizia<br />
è <strong>un</strong> dono che deve essere conquistato e messo alla prova. La prova piú forte consisteva nel fatto<br />
che Padre Piccardo voleva che tutti i suoi al<strong>un</strong>ni e confratelli amassero il Papa <strong>di</strong> eguale amore.<br />
L’amicizia in Padre Piccardo non annullava la <strong>di</strong>stanza, il rispetto e l’obbe<strong>di</strong>enza, tanto che<br />
nell’u<strong>di</strong>enza del 27 marzo 1904 il Papa, quasi amichevole rimprovero, ebbe a <strong>di</strong>rgli: «Venite<br />
qualche volta a trovarmi» 125 .<br />
Il suo amore per il Papa era amore per la Chiesa. L’anima della sua adesione alla Chiesa era<br />
la romanità. Roma voleva <strong>di</strong>re Pietro vivente nei suoi successori. Roma era la Chiesa che<br />
presiedeva a tutte le Chiese, Roma era il tipo <strong>di</strong> tutto.<br />
Il Frassinetti nel 1837 nelle sue “Riflessioni proposte agli Ecclesiastici” scriveva: «O<br />
Vaticano, a te mi prostro e bacio, adorandoti, le sante tue falde. Io non allontanerò mai i miei occhi<br />
da te: tu sei quel monte da cui mi aspetto ogni aiuto, tu mi dai luce, tu mi dai lena e speranza» 126 .<br />
121<br />
FAIN BINDA L., Come figli al Padre, AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004,<br />
12.<br />
122<br />
FAIN BINDA L., Come figli al Padre, AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004,<br />
12-13.<br />
123<br />
BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 87.<br />
124<br />
BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 27.<br />
125<br />
VACCARI G., San Pio X e il Piccardo, AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004,<br />
36.<br />
126 OA, Vol II, 534.
55<br />
Queste parole per Padre Piccardo furono veramente parva favilla a cui gran fiamma seconda.<br />
Erede dello spirito del Frassinetti, <strong>come</strong> lo fu della sua opera nascente, egli ebbe sempre per il Papa<br />
<strong>un</strong>a venerazione particolare, tanto che possiamo ben <strong>di</strong>re fu questa <strong>un</strong>a delle note piú caratteristiche<br />
della sua vita.<br />
«Rapiva quando nella sua paterna, soave amabilità raccontava le sue visite al Papa: ne<br />
enumerava le parole, estasiandosi nel suo bianco volto cercando <strong>di</strong> far godere nei figli l'ora<br />
gau<strong>di</strong>osa da lui gustata e la parola semplice che gli sgorgava dal cuore inondato <strong>di</strong> gioia,<br />
commoveva profondamente. Non formavano i racconti delle sue visite al Papa, il centro delle sue<br />
conversazioni? Chi ebbe la fort<strong>un</strong>a <strong>di</strong> stargli a fianco lo sa» 127 .<br />
L’amicizia che Pio X nutriva per Padre Piccardo, la estendeva con naturalezza a tutta la<br />
Congregazione, nello stesso modo con cui si sentono vicini i figli <strong>di</strong> <strong>un</strong>a donna verso la quale si<br />
manifesta attenzione e stima.<br />
L’u<strong>di</strong>enza pontificia concessa due giorni dopo l’emissione dei voti religiosi, viene cosí<br />
descritta da P. Giacomo Bruzzone: «Il S. Padre Pio X ci accolse con benevolenza piú che paterna<br />
nella sua biblioteca, ci fece sedere intorno al suo tavolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, intrattenendoci per circa <strong>di</strong>eci<br />
minuti alla Sua Augusta presenza.<br />
Ci esortò ad essere ubbi<strong>di</strong>enti al Superiore Generale e fedeli alle Costituzioni della nostra<br />
novella Congregazione.<br />
Ci bene<strong>di</strong>sse due volte, ci <strong>di</strong>ede a baciare la Sua Augusta mano augurandoci frutti copiosi<br />
non solo per il lavoro nel nostro Collegio <strong>di</strong> Roma, ma nell'Italia tutta a mezzo dei Collegiali<br />
educati da noi.<br />
Ad multos annos, o Padre Santo, concludeva il P. Bruzzone, Vi conservi il Signore al nostro<br />
affetto e al bene della Chiesa» 128 .<br />
La rivista “L’amico delle famiglie” nel numero del 30 ottobre 1904 scrive: «La sovrana<br />
benevolenza <strong>di</strong> Pio X ebbe <strong>un</strong>a novella prova allorché Sua Santità il martedí 4 ottobre si degnò<br />
ricevere in particolare u<strong>di</strong>enza il Rev.mo P. Piccardo, con i suoi primi professi e con i suoi primi<br />
Novizi.<br />
Si sa della consueta bontà con cui Pio X accoglie quanti vanno a Lui, ma quella che Egli usò<br />
verso i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria fu veramente <strong>un</strong>a cor<strong>di</strong>alità paterna.<br />
Parlò ad essi dei favori del Signore e dalla protezione della Madonna, li esortò a<br />
corrispondere alle grazie <strong>di</strong> Dio, <strong>di</strong>sse del bene che si riprometteva dalla nuova Congregazione e del<br />
Suo gra<strong>di</strong>mento per l'opera che essa già presta a Roma e li bene<strong>di</strong>ceva con effusione <strong>di</strong> cuore» 129 .<br />
Dopo tre<strong>di</strong>ci giorni dalla morte <strong>di</strong> Pio X la Chiesa ebbe il nuovo pastore supremo: Benedetto<br />
XV, Giacomo Della Chiesa, arcivescovo <strong>di</strong> Bologna, <strong>di</strong> nascita ed educazione genovese.<br />
Padre Piccardo lo conosceva bene; in alc<strong>un</strong>e occasioni si erano incontrati, avevano<br />
collaborato in vari affari ed era intercorsa tra loro corrispondenza. Tuttavia la familiarità e la<br />
127<br />
Padre Piccardo e il Papa, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004, 94.<br />
128<br />
VACCARI G., San Pio X e il Piccardo, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma<br />
2004, 40.<br />
129<br />
VACCARI G., San Pio X e il Piccardo, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma<br />
2004, 41.
56<br />
fraterna amicizia che intercorreva con Pio X erano ormai <strong>un</strong> ricordo. Vari fatti lo attestano; vale per<br />
tutti il seguente. «Qualche mese dopo il P. Piccardo fu ammesso in u<strong>di</strong>enza privata e, <strong>come</strong> poi ci<br />
raccontò, iI Santo Padre gli consigliò che per quanto riguardava gli affari della Congregazione e<br />
dell’Istituto, le relative pratiche le inoltrasse regolarmente presso le rispettive Sacre<br />
Congregazioni» 130 .<br />
Questo non significava certamente mancanza <strong>di</strong> benevolenza, era solo per motivi <strong>di</strong><br />
regolarità ma era segnale chiaro <strong>di</strong> <strong>un</strong> nuovo modo <strong>di</strong> rapportarsi che il nuovo Pontefice in<strong>di</strong>cava.<br />
Padre Piccardo era pur sempre <strong>di</strong> casa in Vaticano ed il Papa Benedetto XV non lasciava<br />
passare occasione senza ricordarsi <strong>di</strong> lui e lo riceveva talvolta <strong>di</strong> sera quando era più libero da ogni<br />
occupazione e soleva mandargli anche qualche dono specialmente per il suo onomastico.<br />
Dimostrò <strong>di</strong> avere sempre molta stima e fiducia in P. Piccardo, servendosi <strong>di</strong> lui in<br />
determinate circostanze per opere speciali, specialmente <strong>di</strong> carità in favore <strong>di</strong> sacerdoti bisognosi <strong>di</strong><br />
aiuto spirituale e materiale e verso i poveri.<br />
I segni <strong>di</strong> attenzione del Papa verso Padre Piccardo era numerosi e ben identificabili <strong>come</strong><br />
quando gli mandò <strong>un</strong>a sua splen<strong>di</strong>da fotografia racchiusa in ricca cornice con il seguente autografo:<br />
«Al <strong>di</strong>letto figlio Antonio Piccardo porgiamo affettuosi rallegramenti per i <strong>di</strong>eci lustri <strong>di</strong> operoso<br />
sacerdozio che il Signore gli ha fatto compiere e con la Bene<strong>di</strong>zione Apostolica che gli inviamo <strong>di</strong><br />
cuore esprimiamo non solo la benevolenza <strong>di</strong> Padre ma anche augurio che veda crescere il numero e<br />
non <strong>di</strong>minuito lo zelo dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria Immacolata.<br />
Benedetto XV<br />
Roma, dal Vaticano, 6 giugno 1918».<br />
Padre Piccardo nel leggerlo, dovette fare forza a se stesso per non prorompere in <strong>un</strong><br />
profluvio <strong>di</strong> lacrime. Eppure Benedetto XV fu il Papa che sottoscrisse il Decreto della Visita<br />
Apostolica e dette a vedere che da essa si aspettava <strong>un</strong> in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong>verso per tutta la Congregazione.<br />
Pio XI, il nuovo Pontefice che successe a Benedetto XV, dal suo avvento al trono pontificio,<br />
<strong>di</strong>mostrò stima grande per Padre Piccardo. Sappiamo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a confidenza fattagli, che Pio XI<br />
desiderava che i giovani del Collegio lombardo avessero con il P. Piccardo frequenti contatti,<br />
perché si e<strong>di</strong>ficassero <strong>di</strong>nanzi al suo esempio e profittassero dei suoi consigli, perché <strong>come</strong> suggerí<br />
lo stesso Santo Padre a Mons. Baranzini, la sua compagnia avrebbe contribuito alla formazione dei<br />
giovani chierici.<br />
Pio XI gli ha sempre mandato la medaglia commemorativa degli anni del suo pontificato; e<br />
tutte le volte che vedeva qualche membro dell'Istituto, o qualche vescovo, ospite dell'Istituto a<br />
Roma, domandava sempre: “E Padre Piccardo <strong>come</strong> sta?...”<br />
Ricorrendo l’80° anno <strong>di</strong> età, gli fece pervenire con la facoltà <strong>di</strong> impartire l'apostolica<br />
bene<strong>di</strong>zione ai presenti, la sua fotografia, con le autografe seguenti parole : “Pius P. P. XI,<br />
gratulab<strong>un</strong>dus, augurab<strong>un</strong>dus permanter in Domino”.<br />
Questo atto <strong>di</strong> sovrana bontà consigliò il P. Piccardo, appena ritornato a Roma a chiedere<br />
<strong>un</strong>'u<strong>di</strong>enza particolare, e Pio XI si degnò ancora donargli quattro grosse medaglie due in argento e<br />
130 BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 103.
57<br />
due in bronzo. Durante l'ultima malattia, incaricava l'Arcivescovo <strong>di</strong> Benevento “a portargli la sua<br />
paterna, affettuosissima bene<strong>di</strong>zione”.<br />
Il suo ultimo atto <strong>di</strong> devozione al Papa fu la partecipazione al pellegrinaggio per acquistare<br />
l’indulgenza giubilare, il Papa lo vide e lo riconobbe con enorme compiacenza. Fu cosí che il<br />
pellegrino aveva finito il suo mortale viaggio e la bene<strong>di</strong>zione del Papa <strong>un</strong>ita al perdono giubilare<br />
gli schiudeva la porta del Cielo.<br />
Per questo non c’è da meravigliarsi se il Santo Padre Pio XI, che ben conosceva il P.<br />
Piccardo e l’opera sua lo definì “<strong>un</strong> colosso <strong>di</strong> virtú”.
58<br />
DIFFICOLTÀ DI RELAZIONE<br />
Possiamo immaginare in questi primi do<strong>di</strong>ci anni <strong>di</strong> vita della Congregazione <strong>un</strong>a com<strong>un</strong>ità<br />
<strong>di</strong> <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, in cui tutti avevano occhi gli <strong>un</strong>i per gli altri, anche le speranze e le tristezze, le<br />
gioie e le angosce <strong>di</strong> <strong>un</strong>o erano proprio quelle <strong>di</strong> tutti.<br />
Non ci sono nella pratica gruppi che vengono sottratti alla <strong>di</strong>alettica fondata, talvolta, sulla<br />
ricerca <strong>di</strong> <strong>un</strong> bene utopico, o forse illusorio, che richiama alla mente l’antico proverbio: “Il meglio è<br />
nemico del bene”. E questo provoca <strong>un</strong> malessere generale che può essere reso piú acuto da<br />
quell’insieme <strong>di</strong> problemi feriali, che <strong>come</strong> onde si accavallano e non danno mai la sensazione <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a vera soluzione.<br />
E quella com<strong>un</strong>ità che si <strong>di</strong>batte nella nostra immaginazione è reale ma futura, è presente ma<br />
sotto i segni dell’incompiuto e si percepisce molto confusa nella <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere i bagliori<br />
<strong>di</strong> luce tra le ombre.<br />
Certamente tutti i membri della prima com<strong>un</strong>ità, soprattutto coloro che avevano il compito<br />
della <strong>di</strong>rezione, erano animati da desiderio <strong>di</strong> bene, ma non raramente succede che, per non essere<br />
in<strong>di</strong>fferenti o neutrali, ci si schiera per scelte <strong>di</strong> campo che sono motivate da <strong>un</strong> malinteso senso del<br />
bene.<br />
Riguardo alla Sacra Visita mi avvalgo <strong>di</strong> quanto ha potuto scrivere P. Luigi Fain Binda<br />
nell’introduzione del libro “Il nostro primo Superiore Generale”.<br />
« Il Bertolotto nella biografia del Piccardo (ed. Risonanze 2004) ne fa cenno a pag. 106. Credo sia il<br />
momento per <strong>un</strong>a precisazione dovuta all’aver consultato l’Archivio della Congregazione e quello<br />
Vaticano.<br />
L’occasione è stata la proposta del Padre Generale al Consiglio del 27 <strong>di</strong>cembre 1915<br />
riguardante il provvisorio trasferimento del Noviziato da Roma a Lugnano motivata dalla<br />
opport<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> accogliervi <strong>come</strong> novizi don Pregliasco e don Lombardo, già in quella casa per <strong>un</strong><br />
parziale servizio <strong>di</strong> insegnamento agli aspiranti, ha messo in <strong>di</strong>fficoltà il buon Padre Minetti,<br />
maestro dei novizi in carica. La votazione è passata a maggioranza, si re<strong>di</strong>ge la domanda con cui si<br />
chiede l’autorizzazione alla Congregazione dei Religiosi che viene trasmessa dallo stesso Mons.<br />
Faberi.<br />
Nel frattempo, il 28 <strong>di</strong>cembre 1915 il Padre Maestro inoltrava presso il Card. Basilio<br />
Pompili, Vicario del Papa per Roma <strong>un</strong>a lettera “strettamente confidenziale” confermandola poi <strong>di</strong><br />
persona, nella quale riteneva dannosa la decisione del Consiglio, ad<strong>di</strong>rittura contraria alle nostre<br />
regole ed alle leggi canoniche, e chiedeva che l’istanza venisse respinta, sebbene presentata da<br />
Mons. Faberi, adducendo inoltre particolari e motivazioni solo in parte vere, tratte da <strong>un</strong> contesto<br />
ben più ampio, letto nell’amarezza <strong>di</strong> <strong>un</strong>a decisione non con<strong>di</strong>visa e non ancora ass<strong>un</strong>ta<br />
interiormente in atto <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza. Certamente non c’era mal animo ma eccesso <strong>di</strong> zelo, desiderio<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong> certo perfezionismo, e <strong>di</strong>rei <strong>un</strong>a certa fretta che già aveva manifestato nel 1885 riguardo alla<br />
nascita della Congregazione. Il Padre, pur sentendo fortemente la sua appartenenza alla<br />
Congregazione ed amandola con sincerità la desiderava <strong>un</strong> po’ a sua immagine: devota ed<br />
osservante, cosí <strong>come</strong> andava educando i giovani novizi, non ammettendo deroghe, <strong>di</strong>spense, o<br />
interpretazioni alle leggi canoniche.
59<br />
Tutti siamo <strong>di</strong>sposti a capire il “Sine glossa al Vangelo” coniato da San Francesco ma si<br />
capisce meno la rigi<strong>di</strong>tà del Minetti per <strong>un</strong> atto interno <strong>di</strong> Congregazione che richiedeva solo <strong>un</strong>a<br />
notifica alla <strong>Santa</strong> Sede.<br />
Certamente la pur breve esperienza benedettina a San Giuliano D’Albaro e presso l’Abbazia<br />
<strong>di</strong> Solesmes per il Canto Gregoriano aveva accentuato in lui <strong>un</strong>o stile piuttosto rigido, perfezionista<br />
anche nei particolari <strong>di</strong> poco conto o <strong>di</strong> sola formalità.<br />
Dal fatto, si può trarre <strong>un</strong> insegnamento: a volte si può partire da <strong>un</strong>a luce che viene da Dio,<br />
da <strong>un</strong>a ispirazione sopranaturale, ma poi attraverso ragionamenti piuttosto umani e con<strong>di</strong>zionamenti<br />
dovuti alla nostra psicologia, si può arrivare in tutta fretta a giustificare quanto avevamo in mente <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>re e <strong>di</strong> fare già prima della “<strong>Santa</strong> Ispirazione”<br />
Cosí il 19 agosto 1916 dalla Congregazione dei Religiosi gi<strong>un</strong>ge al Padre Generale la<br />
com<strong>un</strong>icazione della nomina del Visitatore Apostolico, nella persona del Rev.mo P. Giacomo Maria<br />
Cristini dei Padri Redentoristi.<br />
Il Padre Generale continua nel suo ruolo or<strong>di</strong>nario ma “sotto tutela.” Egli obbe<strong>di</strong>sce in<br />
silenzio rispettando le arcane <strong>di</strong>sposizioni della Provvidenza, <strong>come</strong> del resto in ben altra situazione<br />
accadde al Frassinetti.<br />
Il nostro Piccardo, prima occupato in molti servizi, viaggi, incontri, ora può gustare le cose<br />
piú interiormente, nel significato ancor piú genuino della vita religiosa, sperimentando <strong>di</strong> persona<br />
nel momento della prova: “chi mi vuol seguire rinneghi se stesso,” ed ancora: “non c’è amore piú<br />
grande che dare la vita per i propri amici”.<br />
Non si spegne però il suo entusiasmo, anzi cresce il suo amore al Frassinetti e de<strong>di</strong>ca tante<br />
energie ad istruire il processo informativo per la Causa <strong>di</strong> Beatificazione del nostro Servo <strong>di</strong> Dio<br />
presso il trib<strong>un</strong>ale arci<strong>di</strong>ocesano <strong>di</strong> Genova, appena costituitosi. Prestò a questo lavoro gran cura: si<br />
interessò <strong>di</strong> ogni sessione, <strong>di</strong> ogni testimone e poi portò la “positio” a Roma, alla Congregazione dei<br />
Riti e la consegnò <strong>come</strong> <strong>un</strong> consegnare tutto se stesso, con gioia.<br />
Gli erano sempre piaciute le vite dei santi!» 131 .<br />
Questo fu <strong>un</strong> fulmine a ciel sereno, nell’accezione piú autentica dell’espressione. È il<br />
momento drammatico della croce. Rileggendo la storia, con sapienza retrospettiva, appare<br />
abbastanza chiaro che Padre Piccardo abbia sentito e seguito quell’esortazione che nella Bibbia<br />
risuona ben 365 volte ed è rivolta ai profeti, a Maria e agli apostoli: “Non temere” ed anche<br />
“Continua solo ad aver fede”, nello sforzo <strong>di</strong> confermare gli altri fratelli.<br />
Nella commemorazione per il cinquantesimo <strong>di</strong> sacerdozio <strong>di</strong>ce Mons. Giacomo Ghio:<br />
«Sarei in<strong>di</strong>screto se volessi toccare anche da lontano i dolori e le lacrime che hanno spesso nutrito<br />
l’anima vostra, i martiri che avete consumato in silenzio: essi sono scritti in cielo e ciò vi basta» 132<br />
Era <strong>un</strong> impegno interiore <strong>di</strong> Padre Piccardo mantenere l’<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> intenti: il cammino <strong>di</strong><br />
com<strong>un</strong>ione passava attraverso la valle del pianto; mai si rilevano atteggiamenti <strong>di</strong> autocommiserazione,<br />
che sorgono spontanei <strong>di</strong> fronte alla domanda: “Perché mai questa situazione?”.<br />
La com<strong>un</strong>ione con i fratelli, visti e riconsiderati alla luce <strong>di</strong> Dio, non si è atrofizzata in lui, perché la<br />
forma e il fondamento della com<strong>un</strong>ione fraterna è la croce <strong>come</strong> mistero <strong>di</strong> passione e <strong>di</strong> amore. E<br />
131 Come <strong>Figli</strong> al Padre, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, Ed. Risonanze, Roma 2004, 16-17.<br />
132 GHIO G., Il suo giubileo sacerdotale, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, Ed. Risonanze, Roma 2004, 67.
60<br />
proprio quella sofferenza fecondava e cementava l’<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> Padre Piccardo con la Congregazione,<br />
sua creatura e dei membri tra <strong>di</strong> loro.<br />
Sembra <strong>di</strong> sentire riecheggiare le parole del Frassinetti: «Io non avrei mai creduto che questo<br />
tempo che si <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> tribolazione dovesse essere sí <strong>come</strong> finora il fu, il piú felice della mia vita; ciò<br />
che mi rincresce è che non ne approfitto, quanto sarebbe conveniente» 133.<br />
Nel momento del suo ritiro forzato, del suo governo “sotto tutela”, mentre sperimentava la<br />
verità dell’affermazione del Vangelo «Chi mi vuol seguire rinneghi se stesso» (Lc 9, 23) e «Non c’è<br />
amore piú grande che dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13), il Padre Piccardo <strong>di</strong>venta il nuovo<br />
“genitore” della Congregazione: la genera nel dolore; si può <strong>di</strong>re che si chiude l’arco <strong>di</strong><br />
congi<strong>un</strong>zione tra lui e il Frassinetti.<br />
«Se dolori ed amarezze non gli mancarono, grazie alla nobiltà dell’animo suo e quell’arte<br />
sapiente che usava nel saperle nascondere, tutto seppe sopportare forte e tranquillo; nel silenzio<br />
paziente e nella confidente preghiera seppe aspettare l’ora della serenità» 134<br />
L’immagine <strong>di</strong> <strong>un</strong> uomo riconciliato emerge da alc<strong>un</strong>e righe <strong>di</strong> <strong>un</strong>a lettera circolare <strong>di</strong> Padre<br />
Piccardo: «Inculco ai Superiori … <strong>un</strong>a larghezza <strong>di</strong> cuore e <strong>un</strong>a grande carità che influisca<br />
efficacemente su tutta la famiglia religiosa … E questa grande larghezza <strong>di</strong> cuore e questa grande<br />
carità raccomando a tutti e ai singoli confratelli, <strong>come</strong> quella che chiamerà sul capo in modo<br />
speciale le bene<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Dio» 135 .<br />
La relazione <strong>di</strong> Padre Piccardo con i singoli confratelli e anche con coloro che <strong>di</strong>videvano<br />
con lui la responsabilità <strong>di</strong> governo non ha subito turbamento e inclinazioni. Con i suoi piú stretti<br />
collaboratori esistevano tensioni, che mal gestite, gli hanno procurato dolori e <strong>di</strong>ssapori, ma queste<br />
tensioni non sono <strong>di</strong>ventate conflitti, e questo ha favorito la com<strong>un</strong>icazione nella verità e impe<strong>di</strong>to il<br />
crearsi <strong>di</strong> <strong>un</strong> ambiente settario.<br />
Nei l<strong>un</strong>ghi nove anni <strong>di</strong> guida della Congregazione “sotto tutela” del visitatore, non ha<br />
parlato o scritto granché ma si può facilmente intuire che sia la sua parola <strong>come</strong> il suo silenzio<br />
avevano <strong>un</strong> carattere altamente com<strong>un</strong>icativo.<br />
La sua è stata <strong>un</strong>a com<strong>un</strong>icazione “buona” perché avvenuta nella verità e nella carità<br />
animata dalla paressia, cioè da quella franchezza evangelica, che non cede il posto alla pavi<strong>di</strong>tà e<br />
all’acquiescenza. Scrive per esempio nella circolare n° 11: «Abbiamo giu<strong>di</strong>cato essere necessario<br />
pigliare e segnalarvi <strong>di</strong>sposizioni tassative» 136 .<br />
Nelle sue com<strong>un</strong>icazioni scritte nel periodo del Visitatore troviamo sempre <strong>di</strong>scorsi e<br />
messaggi “oggettivi”: i sentimenti in genere e in particolare quelli piú veri che albergano nelle<br />
pieghe della sua anima Padre Piccardo non li metteva sulla carta … certi <strong>di</strong>amanti esposti alla luce,<br />
perdono <strong>di</strong> lucentezza.<br />
Se cerchiamo <strong>un</strong>a prova per valutare positivamente la testimonianza <strong>di</strong> sofferenza silenziosa<br />
<strong>di</strong> Padre Piccardo, la troviamo nel suo vivere con gli altri, con i confratelli, con i chierici e con gli<br />
133<br />
FRASSINETTI G., Opere ascetiche, vol. II, 637.<br />
134<br />
CHIESA G., Il ritorno alla casa <strong>madre</strong>, in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, Ed. Risonanze, Roma 2004,<br />
152.<br />
135<br />
Circolare n° 11, 22 ottobre 1924, 15, Archivio FSMI, Roma.<br />
136 Ibid., 14.
61<br />
aspiranti nella semplicità e nella quoti<strong>di</strong>anità. Non traspare neppure <strong>un</strong> atteggiamento <strong>di</strong> chi accusa<br />
<strong>un</strong>a forma “<strong>di</strong> asse<strong>di</strong>o” ma trova il delicato <strong>di</strong>to <strong>di</strong> Dio che scrive in bella calligrafia su pagine<br />
sgualcite la sua storia <strong>di</strong> salvezza.<br />
La sofferenza che il giusto sopporta per la fedeltà all’alleanza è <strong>un</strong>a prova della vali<strong>di</strong>tà della<br />
sua testimonianza e <strong>un</strong>a profezia per la fecon<strong>di</strong>tà della sua opera.
62<br />
IL TRASFERIMENTO DEL NOVIZIATO<br />
Era scoppiata la prima guerra mon<strong>di</strong>ale e l’Italia <strong>come</strong> il resto d’Europa era in fermento e in<br />
agitazione. I chierici e i sacerdoti giovani adatti alle armi erano stati richiamati chi al fronte, chi nei<br />
servizi logistici dell’esercito; il Concordato sarà stipulato solo nel 1929.<br />
Da quasi due anni erano entrati <strong>come</strong> can<strong>di</strong>dati alla Congregazione due sacerdoti: Giovanni<br />
Battista Pregliasco della <strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> Mondoví e Tommaso Lombardo <strong>di</strong> Genova. La loro esperienza<br />
<strong>di</strong> avvicinamento e <strong>di</strong> conoscenza della Congregazione si svolgeva a Lugnano in Teverina, facendo<br />
contemporaneamente scuola agli aspiranti che lí stu<strong>di</strong>avano.<br />
Era ormai maturo il tempo che anche essi facessero il noviziato. A causa del richiamo alle<br />
armi si lamentava <strong>un</strong>a scarsezza <strong>di</strong> personale; chi avrebbe potuto sostituirli nell’insegnamento? A<br />
Roma c’era la com<strong>un</strong>ità del noviziato con tre novizi e il loro Maestro Padre Antonio Minetti.<br />
Nella ri<strong>un</strong>ione del Consiglio Generalizio del 27 <strong>di</strong>cembre 1915 fu approvata la proposta del<br />
trasferimento provvisorio del noviziato a Lugnano in Teverina, in modo da dare ai due sacerdoti la<br />
possibilità <strong>di</strong> fare il noviziato e agli aspiranti <strong>di</strong> continuare con regolarità l’anno scolastico. La<br />
proposta messa ai voti ebbe tre voti favorevoli e due contrari, fu d<strong>un</strong>que approvata.<br />
L’<strong>un</strong><strong>di</strong>ci gennaio 1916 il Padre Piccardo in qualità <strong>di</strong> Superiore Generale in<strong>di</strong>rizzò<br />
<strong>un</strong>’istanza alla Sacra Congregazione dei Religiosi chiedendo licenza per il trasferimento provvisorio<br />
fino al novembre del 1916 dei tre novizi con il loro Maestro a Lugnano in Teverina e chiedeva la<br />
facoltà per i due sacerdoti Tommaso Lombardo e Giovanni Pregliasco <strong>di</strong> poter continuare, durante<br />
il loro noviziato, quell’insegnamento che già portavano avanti con gli aspiranti. Aggi<strong>un</strong>geva: «Si fa<br />
notare che nella Casa <strong>di</strong> Lugnano i novizi possono essere benissimo custo<strong>di</strong>ti, ed in <strong>un</strong> locale<br />
apposito adattissimo e separato dal resto della Casa» 137 . La Sacra Congregazione concesse con<br />
facilità i permessi richiesti.<br />
Padre Piccardo edotto dalla sua l<strong>un</strong>ga esperienza, capiva che la capacità <strong>di</strong> adattare la legge<br />
alla situazione, senza infrangere la vali<strong>di</strong>tà e la sostanza della stessa, l’accettare il bene lac<strong>un</strong>oso,<br />
con sguardo l<strong>un</strong>gimirante in vista del meglio e della pienezza dell’osservanza della legge, è frutto <strong>di</strong><br />
sapienza, è intelligenza e senso del reale.<br />
Aiuta la comprensione della situazione la riflessione <strong>di</strong> <strong>un</strong> noto autore: «L’adattamento alle<br />
situazioni concrete, espresse dal tempo – luogo, non è solo frutto <strong>di</strong> accorgimento prudenziale<br />
umano.<br />
Gli antichi ammaestrati da <strong>un</strong>a costante lettura della Sacra Scrittura, spingevano lo sguardo<br />
oltre le leggi <strong>di</strong> <strong>un</strong> sano adattamento prudenziale.<br />
La <strong>di</strong>screzione, che i Padri avevano in grande stima, era <strong>come</strong> <strong>un</strong>a luce dello Spirito che<br />
faceva scorgere l’ora <strong>di</strong> Dio, in ogni momento, in ogni situazione. Da ciò il bisogno dell’adattabilità<br />
a quel momento, a quella situazione <strong>di</strong>retti e guidati dalla Parola <strong>di</strong> Dio e dalla carità.<br />
Se esiste il rischio <strong>di</strong> relativizzare la verità o <strong>di</strong> farla coincidere con <strong>di</strong>scutibili soluzioni<br />
soggettive, non è minore quello <strong>di</strong> rendere statica la regola, avulsa dal cammino della storia in cui si<br />
invera.<br />
137 Lettera alla Sacra Congregazione dei Religiosi, Archivio FSMI, Roma.
63<br />
È in fondo il rischio della fede che bisogna correre. L’ambiente e il tempo sono con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong>a rilettura pluralistica della regola» 138 .<br />
Fu in quella situazione che si volle tradurre <strong>un</strong>a regola o forse semplicemente <strong>un</strong>a<br />
consuetu<strong>di</strong>ne anziché riprodurre <strong>un</strong>o standard adattandola alla situazione contingente. Era capriccio<br />
o <strong>di</strong>scernimento?<br />
Padre Antonio Minetti si sentí stravolto da quella decisione. Egli era il Maestro dei novizi<br />
che doveva trasferirsi a Lugnano. La sua fu <strong>un</strong>a reazione rigida, <strong>di</strong>fensiva e senza richiamo ad <strong>un</strong>o<br />
scambio <strong>di</strong>alettico. Si può forse pensare ad <strong>un</strong> letteralismo morale che porta ad interpretare in<br />
maniera gretta la norma, impedendo visuali ampie dove c’è spazio per il buon senso, l’eccezione, la<br />
comprensione ed in ultima analisi l’umano?<br />
Il giorno seguente 28 <strong>di</strong>cembre Padre Minetti si recò dal Car<strong>di</strong>nale Vicario Basilio Pompili,<br />
Protettore della Congregazione, con <strong>un</strong>a lettera (pensata e scritta probabilmente nella notte)<br />
confidenziale e riservata in cui sottolineava l’assenza <strong>di</strong> giustificazione “per <strong>un</strong> provve<strong>di</strong>mento così<br />
grave”. «Io le chiedo per amore alla nostra Congregazione <strong>di</strong> aiutarci a fare le cose bene e <strong>come</strong> si<br />
deve e quin<strong>di</strong> a respingere l’istanza» 139<br />
Aggi<strong>un</strong>ge inoltre che la volontà del Superiore Generale sempre prevale su tutto e che<br />
Monsignor Faberi «<strong>come</strong> al solito, appoggiò la proposta, che credo dannosa, perché si continua a<br />
fare le cose alla meglio per non <strong>di</strong>re alla peggio» 140 .<br />
Si legge in “Acta et agenda” redatta da Padre Tommaso Gaggero: «16 maggio. E<br />
specialmente dell’essere andato D. Minetti in giro prima <strong>di</strong> partire per Lugnano a fare chiacchiere<br />
con Car<strong>di</strong>nali, Prelati e altolocati facendo loro notare la grande inconvenienza <strong>di</strong> trasportare il<br />
noviziato a Lugnano» 141 . La lettera riservata e confidenziale <strong>di</strong> Padre Minetti passa <strong>di</strong> mano in<br />
mano e le notizie <strong>di</strong> bocca in bocca.<br />
Nel voto contrario nel Consiglio Generalizio aveva appoggiato Padre Minetti, Padre<br />
Tommaso Olcese terzo Consultore. Padre Carlo Olivari in <strong>un</strong>a lettera al Padre Minetti del 20<br />
gennaio 1916 scrive: «Io ho votato pel noviziato a Lugnano, non per alc<strong>un</strong> riguardo personale, ma<br />
per l’opport<strong>un</strong>ità della cosa che mi pareva troppo evidente … Non ho capito l’opposizione <strong>di</strong> Don<br />
Olcese il quale troppo volentieri tira le questioni nel campo della personalità»; piú avanti definisce<br />
quella dell’Olcese «opposizione sistematica al Superiore» 142 .<br />
Una reazione a catena a maglie così strette ci fa capire che essa era la p<strong>un</strong>ta <strong>di</strong> <strong>un</strong> iceberg e<br />
l’occasione per far emergere ciò che da tempo era nascosto ma con frequenza serpeggiava.<br />
C’è <strong>un</strong> episo<strong>di</strong>o, che <strong>come</strong> spesso accade, nella sua apparente insignificanza getta luce sulla<br />
personalità e anche sulle motivazioni a doppio corso.<br />
Nel secondo Capitolo Generale P. Minetti <strong>di</strong> sua iniziativa corresse segretamente <strong>un</strong> verbale.<br />
La cosa resa nota causò il <strong>di</strong>ssapore <strong>di</strong> Padre Piccardo e <strong>un</strong> rimprovero all’autore del gesto.<br />
138 B. CALATI, Pluralismo <strong>di</strong> interpretazione della Regola Benedettina, in Figura e f<strong>un</strong>zione dell’autorità nella<br />
com<strong>un</strong>ità religiosa, E<strong>di</strong>zioni Paoline, Cinisello Balsamo 1978, 419.<br />
139 Archivio FSMI, Roma.<br />
140 Archivio FSMI, Roma.<br />
141 Archivio FSMI, Roma.<br />
142 Archivio FSMI, Roma.
64<br />
Proprio durante il secondo Capitolo Generale nel 1910, i primi otto religiosi emisero i voti<br />
perpetui e in tale occasione si era invertito l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> precedenza nell’emettere la professione.<br />
I primi tre della Congregazione Diocesana Romana (Piccardo, Minetti e Olcese) erano stati<br />
equiparati agli altri sei che si erano aggi<strong>un</strong>ti nella costituzione della Congregazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
pontificio. La cosa agli occhi <strong>di</strong> Padre Minetti non aveva solo valore nominale, infatti «questa<br />
affermazione <strong>di</strong> uguaglianza – egli scrive – dei nuovi venuti con i tre padri, <strong>di</strong>rei, confondatori<br />
…» 143 .<br />
Egli si sentiva confondatore e sentiva <strong>come</strong> ingombrante la onnipresenza e la decisionalità<br />
del Padre Piccardo e assillante l’ingerenza <strong>di</strong> Monsignor Faberi, che ne era <strong>come</strong> l’ombra.<br />
Il doversi conquistare il dovuto, a suo parere, legittimo e meritato riconoscimento, lo sforzo<br />
<strong>di</strong> riguadagnare la stima <strong>di</strong> sé, nel momento in cui veniva mandato a Lugnano cioè emarginato e<br />
spiazzato, ha giocato in lui <strong>un</strong> brutto scherzo.<br />
Egli era entrato tra i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria nel 1874, accolto da Padre Piccardo. Non aveva<br />
praticamente ness<strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o e fu messo inizialmente a fare il cuoco. Ricuperati alc<strong>un</strong>i anni <strong>di</strong><br />
scuola, <strong>di</strong>venuto al<strong>un</strong>no or<strong>di</strong>nario, non si <strong>di</strong>stingueva per la scienza ma per la pietà.<br />
Dopo l’or<strong>di</strong>nazione sacerdotale era stato coa<strong>di</strong>utore nella parrocchia <strong>di</strong> Pedemonte in Val<br />
Polcevera ma poi era ritornato alla Casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, dove svolse alc<strong>un</strong>i ruoli ausiliari.<br />
Convinto <strong>di</strong> <strong>un</strong>’idea personale <strong>di</strong> perfezione aderí alla Congregazione e seguí Padre Piccardo<br />
a Roma.<br />
Carenza <strong>di</strong> elasticità piú che <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> idee creò <strong>un</strong>a certa <strong>di</strong>stanza dagli altri, e questo<br />
isolamento soffuso <strong>di</strong> pietà e <strong>di</strong> <strong>un</strong>’aureola <strong>di</strong> santità lo poneva sopra <strong>un</strong>a specie <strong>di</strong> pie<strong>di</strong>stallo. Di<br />
Padre Piccardo aveva <strong>un</strong> timore reverenziale connotato da <strong>un</strong> <strong>di</strong>stacco e <strong>un</strong> non meglio espresso<br />
<strong>di</strong>ssenso; rivolgendosi al Visitatore lo definisce, <strong>come</strong> in concorrenza con Padre Piccardo, «quasi<br />
nostro Superiore» 144 . In <strong>un</strong>a lettera al Padre Piccardo scrive <strong>un</strong> po’ risentito: « … salva la riverenza,<br />
mi permetto farle notare <strong>un</strong>a cosa ed è: che prima mi ha sempre in<strong>di</strong>rizzato le lettere … Al P.<br />
Minetti, ed ora le in<strong>di</strong>rizza al Sig. Don Minetti» 145 .<br />
Padre Piccardo lo ha avuto a fianco fin dall’inizio. Ha vissuto con lui il tempo della<br />
costruzione e il tempo delle ansie; non si conosce ness<strong>un</strong>a parola, ness<strong>un</strong>o scritto <strong>di</strong> rimostranza<br />
verso Padre Minetti.<br />
Egli ha sempre accolto tutti quelli che il Signore inviava <strong>come</strong> doni e nella misura delle<br />
capacità li valorizzava. In lui non c’erano moine e <strong>di</strong>stinzioni ma virile atteggiamento <strong>di</strong> fraternità,<br />
anche se l’altro era debole e anche se, forse senza saperlo, stava tradendo la sua fiducia.<br />
143 Relazione all Congregazione dei Religiosi del 22 giugno 1915. Archivio della Congregazione per gli istituti <strong>di</strong> vita<br />
consacrata e le società <strong>di</strong> vita apostolica, Città del Vaticano, 40/16.<br />
144 Lettera circolare del 30 giugno 1917. Archivio FSMI, Roma.<br />
145 Archivio FSMI, Roma.
65<br />
LA VISITA APOSTOLICA<br />
La visita richiama la tensione umano-<strong>di</strong>vina dell’incontro; sia da <strong>un</strong> p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista biblico<br />
(Dio visita il suo popolo), sia umano in<strong>di</strong>ca l’attesa, l’accoglienza, la gioia della con<strong>di</strong>visione e del<br />
ritrovarsi.<br />
La storia della Vita religiosa ci descrive la visita 146 <strong>come</strong> strumento <strong>di</strong> coesione e <strong>di</strong> identità.<br />
La visita detta canonica è quella attuata a scadenza perio<strong>di</strong>ca dal Vescovo e dai legittimi superiori;<br />
<strong>di</strong> altra natura è la visita detta apostolica. Essa è or<strong>di</strong>nata dalla suprema autorità della Chiesa e ogni<br />
visitatore riceve facoltà speciali e adatte ai problemi che si devono affrontare e ai casi che si<br />
incontrano.<br />
La prassi semplificata, dal Concilio Vaticano II, prevede la nomina <strong>di</strong> <strong>un</strong> visitatore per<br />
l’insorgere <strong>di</strong> <strong>un</strong> problema particolare in <strong>un</strong> determinato Istituto; è prevista quin<strong>di</strong> <strong>un</strong>a attività ad<br />
inquirendum et referendum. Non era cosí nel precedente Diritto Canonico, in cui era tratteggiata<br />
<strong>un</strong>a <strong>di</strong>versa figura <strong>di</strong> visitatore.<br />
C’era il visitatore-superiore, vicario per la <strong>Santa</strong> Sede per <strong>un</strong> determinato istituto con potestà<br />
<strong>di</strong> Superiore maggiore; veniva nominato quando si intendeva cambiare il governo dell’Istituto.<br />
C’era anche il visitatore apostolico or<strong>di</strong>nario, che veniva messo a capo dell’Istituto senza però<br />
sospendere il regime or<strong>di</strong>nario. La nomina dell’<strong>un</strong>o e dell’altro era riservata al Sommo Pontefice.<br />
Nonostante che la visita fosse <strong>un</strong>o strumento giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> coesione e <strong>di</strong> aiuto, non ha mai<br />
goduto la simpatia tra i religiosi, che lo hanno sentito <strong>come</strong> strumento <strong>di</strong> controllo, <strong>come</strong> <strong>di</strong> fatto<br />
veniva applicato, e il piú delle volte non ha avuto esiti felici.<br />
«È con questa lettera, che il 2 del venturo ottobre – scriveva Padre Piccardo ai confratelli il<br />
30 giugno del 1916 – ann<strong>un</strong>zio la Convocazione del Capitolo Generale or<strong>di</strong>nario della nostra<br />
Congregazione nella Casa Generalizia <strong>di</strong> Roma».<br />
Le attese che riponeva nel Capitolo erano rilevanti: «<strong>Figli</strong> carissimi, cominciamo a pregare<br />
per il buon esito del Capitolo generale, che è cosa <strong>di</strong> alta importanza per l’avvenire della<br />
Congregazione» 147 .<br />
L’aspettativa e la sicura tranquillità del Padre Piccardo furono recise con <strong>un</strong> solo colpo;<br />
recatosi in u<strong>di</strong>enza dal Santo Padre il 23 luglio, nel corso <strong>di</strong> <strong>un</strong> l<strong>un</strong>go colloquio ebbe l’amara<br />
sorpresa <strong>di</strong> apprendere che veniva nominato <strong>un</strong> visitatore apostolico e che la Congregazione veniva<br />
posta fuori del <strong>di</strong>ritto com<strong>un</strong>e, era perciò sospesa la celebrazione del Capitolo e i poteri passavano<br />
in mano alla persona che sarebbe stata designata 148 .<br />
146<br />
Ve<strong>di</strong> AA.VV, Visita, in G. PELLICCIA-G. ROCCA, Dizionario degli Istituti <strong>di</strong> Perfezione, E<strong>di</strong>zioni Paoline, Roma<br />
2003, Vol. X, 112-159.<br />
147<br />
Lettera circolare n° 10 del 30-06-1916, in Circolari dei Superiori Generali 1903-1965, Roma 1968, 13-14. (Pro<br />
manuscripto)<br />
148<br />
Vale la pena riportare <strong>come</strong> P. Gaggero in Acta et Agenda riporta l’episo<strong>di</strong>o: «Col Superiore vado all’u<strong>di</strong>enza del<br />
Papa. I palafrenieri fanno osservare che sul biglietto non vi è scritto che lui, il Generale. Mi fanno poi passare nella sala<br />
degli arazzi in aspettativa finché il Superiore lo doman<strong>di</strong> al Papa…Il Superiore ebbe <strong>un</strong>’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> circa venti minuti e<br />
dopo sono introdotto anche io. Il Papa <strong>di</strong>ce che non c’è bisogno <strong>di</strong> domandarmi <strong>come</strong> sto … soggi<strong>un</strong>gendo al Superiore<br />
che sono persona importante avendo in mano la borsa della Congregazione … (si capisce tutte queste cose <strong>di</strong>sse<br />
scherzando). Ed essendo venuto il cameriere partecipante Mons. Gerlac ad avvisare che era ora dell’U<strong>di</strong>enza generale ci<br />
bene<strong>di</strong>ce e ci congeda.
66<br />
C’erano in giro chiacchiere <strong>di</strong> questo tipo, ma erano voci <strong>di</strong> corridoio a cui è prudente non<br />
porgere l’orecchio. Il trasferimento del Noviziato e per conseguenza del Maestro dei Novizi a<br />
Lugnano in Teverina, aveva suscitato il risentimento e tutto l’ardore <strong>di</strong> opposizione <strong>di</strong> qualc<strong>un</strong>o. Il<br />
pellegrinare da Monsignori e Car<strong>di</strong>nali <strong>di</strong> Padre Minetti, <strong>come</strong> si esprime P. Tommaso Gaggero nei<br />
suoi <strong>di</strong>ari, produsse <strong>un</strong> effetto insperato. In <strong>un</strong>a lettera ufficiale al Car<strong>di</strong>nale Cagiano Prefetto della<br />
Congregazione dei Religiosi, il Car<strong>di</strong>nale Pompili, Vicario <strong>di</strong> Roma e Protettore della<br />
Congregazione cosí si esprime: «P. Antonio Piccardo … pur volendo il contrario, avvia la<br />
Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata alla <strong>di</strong>ssoluzione e alla rovina. In questo stato<br />
<strong>di</strong> cose, credo mio dovere, a scanso <strong>di</strong> responsabilità, <strong>di</strong> invocare dalla S. C. la nomina <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
Visitatore Apostolico, il quale con prudenza, pazienza e dottrina esamini le presenti con<strong>di</strong>zioni dei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata, suggerisca gli opport<strong>un</strong>i rime<strong>di</strong>, e con energia e vigilanza instauri<br />
la vera vita religiosa, e con questa l’or<strong>di</strong>ne e la saggia amministrazione» 149 .<br />
Il Car<strong>di</strong>nale Pietro Respighi, era stato nominato da Pio X Protettore e sostegno del nascente<br />
Istituto; egli si serviva <strong>come</strong> plenipotenziario e persona <strong>di</strong> fiducia <strong>di</strong> Mons. Faberj. Il nuovo Vicario<br />
<strong>di</strong> Roma, il Car<strong>di</strong>nale Pompili, aveva emarginato Mons. Faberj, non considerandolo adatto per i<br />
compiti che svolgeva in Vicariato, e lo aveva fatto Canonico della Basilica <strong>di</strong> San Pietro. Egli<br />
tuttavia partecipava ancora alla vita e alle decisioni dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, essendone stato incaricato<br />
dalla Congregazione dei Religiosi, sebbene non avesse tutti i sacri crismi dal <strong>di</strong>retto Superiore, che<br />
non glieli aveva com<strong>un</strong>que revocati. Due Consultori, ossia P. Minetti e P. Olcese, non vedevano <strong>di</strong><br />
buon occhio Mons. Faberi, perché troppo obbe<strong>di</strong>ente al Padre Piccardo e troppo remissivo. Questo<br />
intreccio <strong>di</strong> circostanze fece sí che non si considerò la gravità <strong>di</strong> <strong>un</strong> Visitatore Apostolico, ma si<br />
desiderò solo <strong>un</strong> successore del poco apprezzato Monsignore.<br />
Lo spirito con il quale il visitatore si è introdotto nella nuova realtà è <strong>di</strong> non facile e <strong>un</strong>ivoca<br />
interpretazione. Certamente egli non era a conoscenza della storia e della vita interna della<br />
Congregazione; scrive infatti nella lettera <strong>di</strong> presentazione: «La S. Congregazione dei Religiosi, a<br />
mia insaputa, mi ha nominato visitatore apostolico del vostro benemerito Istituto, che da oltre<br />
trecento (!?!) anni sta operando tanto bene nella mistica vigna del Signore» 150 .<br />
È complicato comprendere il motivo e i retroscena della visita apostolica; il visitatore in<br />
alc<strong>un</strong>e righe della stessa lettera descrive i suoi compiti: «La cosa che soprattutto raccomando ora e<br />
sempre, è la pace, l’<strong>un</strong>ione, la carità fraterna; sapendosi compatire l’<strong>un</strong> l’altro, badando piú<br />
all’adempimento dei propri doveri, che alla <strong>di</strong>fesa dei nostri <strong>di</strong>ritti». Ed aggi<strong>un</strong>ge piú avanti: «Mi<br />
perdonerete, Padri e Fratelli <strong>di</strong>lettissimi, se vi scrivo in questa maniera, lo faccio perché questo è il<br />
desiderio <strong>di</strong> Sua Santità e della S. Congregazione. Dalla pace, <strong>un</strong>ione e carità fraterna, <strong>di</strong>pende il<br />
conseguimento del fine pel quale fu mandata la Visita Apostolica» 151 .<br />
Il Superiore poi mi <strong>di</strong>ce che parlò al Papa della nostra Congregazione, ed egli, <strong>come</strong> già altra volta, gli chiese se non<br />
aveva <strong>un</strong> Visitatore. Il Superiore rispose che non ve ne fu mai, e che v’è Mons. Faberi che conosce bene tutto e tutti e i<br />
nostri <strong>di</strong>fetti e le nostre virtú se ve ne sono, il quale fu delegato alla nostra Congregazione dei Religiosi e non già <strong>come</strong><br />
facente parte del Vicariato, il quale però ora per delicatezza essendo uscito dal Vicariato <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> non volersene piú<br />
occupare, ma che però faceva assai bene ecc. Il Papa sorrise <strong>un</strong> pochino, ma nulla aggi<strong>un</strong>se. Il Superiore continuò<br />
<strong>di</strong>cendo che a ottobre avremo il Capitolo e che egli scade da Superiore, avendo già governato per 12 anni. Il Papa si<br />
meravigliò che fossero già do<strong>di</strong>ci anni, ma nulla <strong>di</strong>sse in proposito … Non <strong>di</strong>sse al Papa che Padre Minetti fece ricorso<br />
alla Congregazione».<br />
149 Archivio del Vicariato <strong>di</strong> Roma, 5, 19/16, 24 gennaio 1916.<br />
150 Archivio FSMI, Roma.<br />
151 Ibid.
67<br />
Padre Piccardo negli scritti ufficiali e nelle relazioni non rileva problemi <strong>di</strong> grande entità,<br />
osserva che la vita procede normalmente e se ci sono <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> relazione, sono <strong>di</strong> genere<br />
caratteriale. La lettera del Padre Minetti al Car<strong>di</strong>nale Pompili ha fatto saltare equilibri e scattare<br />
meccanismi, forse da tempo innescati; ed è stato mandato <strong>un</strong> visitatore, non per risolvere problemi<br />
specifici ma per essere <strong>un</strong> “Padre Generale” alternativo.<br />
Padre Giacomo Cristini 152 , della Congregazione del Santissimo Redentore, visitatore<br />
apostolico della Congregazione, aveva avuto dalla <strong>Santa</strong> Sede vari incarichi <strong>come</strong> visitatore; era<br />
nato a Veroli (Fr) il 1 marzo 1853. Entrò nel seminario <strong>di</strong>ocesano dove fece gli stu<strong>di</strong> teologici. Per<br />
sfuggire il servizio militare si fece amputare due <strong>di</strong>ta e abusando <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali, sempre allo stesso<br />
scopo, contrasse malattie, che dovette portare fino alla morte. Fu fatto Vice rettore e Professore del<br />
seminario, ma sentendosi chiamato a perfezione piú alta, decise <strong>di</strong> entrare tra i Redentoristi, fra i<br />
quali professò il 27 luglio 1879. Scrisse libri <strong>di</strong> carattere ascetico, fu eletto provinciale della<br />
Provincia Romana ed in seguito Rettore della Casa Generalizia. Si de<strong>di</strong>cò soprattutto alla<br />
confessione e alla <strong>di</strong>rezione spirituale. Morí a Roma il 16 <strong>di</strong>cembre 1928.<br />
La sua supposta considerazione <strong>di</strong> aver trovato nella Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria <strong>un</strong><br />
nuovo campo <strong>di</strong> comando piú che <strong>un</strong> nuovo campo <strong>di</strong> lavoro, lo faceva intervenire in ogni<br />
circostanza con <strong>di</strong>sposizioni molto dettagliate, rimproveri al Padre Piccardo e sforzo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a captatio<br />
benevolentiae dei vari confratelli. Un paio a lui continuamente si rivolgevano ma piú per sfogo che<br />
vera collaborazione; <strong>di</strong> essi, anche involontariamente, egli <strong>di</strong>venta <strong>un</strong>a copertura per celare il<br />
desiderio <strong>di</strong> prevalere.<br />
Si deve anche notare che il buon Padre Cristini era stato visitatore soprattutto <strong>di</strong> Istituti<br />
femminili. Il richiamo ai <strong>di</strong>ritti del visitatore, l’ampliamento dei poteri, la facoltà <strong>di</strong> indagare, la<br />
possibilità <strong>di</strong> intervenire incontravano nelle religiose piú debole resistenza e piú facile ossequiosità.<br />
Tale fu il nostro, <strong>come</strong> si rileva dai verbali dei Consigli, che sempre a lui dovevano riferirsi e da lui<br />
essere presieduti.<br />
La visita si protrasse per tre<strong>di</strong>ci anni, il decreto <strong>di</strong> chiusura è del 7 gennaio 1928. Scrive il<br />
visitatore il 13 febbraio 1920 (dopo quattro anni <strong>di</strong> visita), <strong>di</strong> aver ricevuto dalla Sacra<br />
Congregazione l’ingi<strong>un</strong>zione <strong>di</strong> proseguire nel delicatissimo compito <strong>di</strong> visitatore 153 . Nelle norme<br />
dei Decreti pontifici e nella prassi ecclesiastica si <strong>di</strong>ce che la visita non doveva durare piú <strong>di</strong> tre<br />
giorni, al massimo cinque 154 ; <strong>un</strong> tempo infinito <strong>come</strong> la presenza del visitatore tra i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria si<br />
può considerare <strong>un</strong>a grossa rarità nella storia della Chiesa.<br />
In <strong>un</strong>a lettera del 10 novembre 1927 il Car<strong>di</strong>nale Vicario <strong>di</strong> Roma Basilio Pompili scrivendo<br />
al prefetto della S. Congregazione dei Religiosi per raccomandare l’approvazione delle costituzioni<br />
dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria, aggi<strong>un</strong>ge: «Ritengo poi che, … sia opport<strong>un</strong>o che abbia termine la Visita<br />
Apostolica» 155 .<br />
Il Padre Cristini seriamente ammalato considera chiusa la visita, per cui viene emesso il<br />
Decreto della S. Congregazione dei Religiosi in cui si afferma che i problemi sono risolti. Nel<br />
frattempo il «troppo vecchio e malandato per la grave età e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute» 156 Padre Generale,<br />
152<br />
Cfr Analecta Congregationis SSmi Redentoris, Typis Cuggiani, Roma 1929, Annus VII, 378-381.<br />
153<br />
Ibid.<br />
154<br />
Cfr Visita, op. cit.<br />
155<br />
Archivio FSMI, Roma.<br />
156<br />
Cfr Verbale del Consiglio Generalizio del 12-14 Agosto 1925, Archivio FSMI, Roma.
68<br />
Padre Antonio Piccardo aveva lasciato da oltre due anni questo mondo. In tutti quegli anni non si<br />
era arreso, non si era ritirato “sull’Aventino” o in “standby”, aveva continuato ad assistere, curare e<br />
amare i suoi figli e la sua Congregazione, anche se avrebbe potuto ripetere con il salmista: «Sei tu,<br />
mio compagno, mio amico e confidente; ci legava <strong>un</strong>a dolce amicizia, verso la casa <strong>di</strong> Dio<br />
camminavamo in festa» (Sal. 55,14-15).<br />
Resta <strong>un</strong>a prassi senza spiegazione quella <strong>di</strong> nominare <strong>un</strong> visitatore senza nemmeno sentire<br />
il Superiore Generale e <strong>di</strong> congelare <strong>un</strong> Capitolo già convocato, che poteva essere la chiave <strong>di</strong><br />
soluzione <strong>di</strong> eventuali incongruenze. Forse la Congregazione era sotto osservazione, forse non<br />
godeva buona stima e fiducia e si pensava che non era sufficiente <strong>un</strong> Capitolo Generale per<br />
apportare cambiamenti significativi. Sorge pur sempre la domanda: quali erano le situazioni che<br />
dovevano essere cambiate, <strong>di</strong> quali problemi si trattava? Nel Decreto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zione della Visita non è<br />
specificato 157 .<br />
I sacerdoti che cooperavano con Padre Piccardo nella istruzione e quelli poi che lo avevano<br />
seguito nella vita religiosa nella Congregazione erano tutti “cosa” sua, e lo riguardavano <strong>come</strong><br />
Padre. Ad <strong>un</strong> tratto qualc<strong>un</strong>o si ribella al Padre, si cerca <strong>un</strong> rifugio estraneo, pur con i sacri sigilli<br />
del Vaticano, ma è <strong>un</strong> rifugio senza il cuore <strong>di</strong> <strong>padre</strong>. Restano <strong>come</strong> orfani. Il Padre rimane vigile e<br />
soffre.<br />
La prova a cui è stato sottoposto Padre Piccardo è stato <strong>un</strong> cammino duro e faticoso, <strong>un</strong><br />
tempo l<strong>un</strong>go, infinito. Il Signore lo ha chiamato a fare il noviziato, da cui, per indulto <strong>di</strong> Pio X,<br />
insieme ai suoi compagni, era stato <strong>di</strong>spensato; nel noviziato occorre avanzare, non è consentito<br />
sostare o in<strong>di</strong>etreggiare. Il viaggio interiore lo ha portato dal Tabor al Golgota. Il suo deserto lo ha<br />
condotto all’incontro, all’amicizia, ad <strong>un</strong> amore genuino che scaturisce da <strong>un</strong>a sorgente profonda.<br />
Deve essere avvenuto <strong>un</strong> passaggio interiore e <strong>di</strong> purificazione che si sintetizza nella nota frase:<br />
“Quanti lo amavano e quanto lo amavano!”.<br />
Padre Piccardo si è <strong>di</strong>mostrato <strong>un</strong> uomo paziente. La pazienza non era in lui impassibilità<br />
ma <strong>un</strong> l<strong>un</strong>go respiro del suo desiderio e della sua fiducia nel futuro. Dalla sua bocca e dalla sua<br />
penna non è uscita <strong>un</strong>a sola parola <strong>di</strong> lagnanza per la situazione che si era creata; la sua era <strong>un</strong>a<br />
pazienza umile che gli faceva accettare la personale limitatezza; ma era nello stesso tempo speranza<br />
che generava fedeltà e perseveranza. Con la sua pazienza è stato <strong>un</strong> supporto per gli altri, <strong>un</strong><br />
sostegno per la Congregazione e la sua storia: ha continuato, nonostante che fosse stato<br />
surrettiziamente esautorato, ad essere Superiore Generale, ed interiormente si sentiva nella<br />
pienezza delle sue f<strong>un</strong>zioni. Era certo che il Signore non turba mai la gioia dei suoi figli se non per<br />
prepararne <strong>un</strong>a piú grande.<br />
Dato l’ostracismo a Padre Piccardo, alc<strong>un</strong>i sono rimasti alla conduzione, guidati dal filo<br />
rosso della voglia <strong>di</strong> affermarsi, quasi continuamente domandandosi chi fra <strong>di</strong> loro era il maggiore.<br />
Si è isolata la figura carismatica <strong>di</strong> Padre Piccardo, ma la Congregazione non è rimasta senza p<strong>un</strong>to<br />
<strong>di</strong> riferimento perché lui, sebbene sul Calvario è stato sempre ben visibile.<br />
157 Cfr. Decreto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zione della Visita Canonica, Archivio FSMI, Roma.
69<br />
LE DUE LAMPADE<br />
Ci racconta don Rosina che Padre Piccardo aveva visto <strong>un</strong>a sola volta il Frassinetti mentre<br />
con la camerata dei seminaristi andava a passeggio. Era allora Genova <strong>un</strong>a piccola città <strong>di</strong> provincia<br />
non molto popolata: ogni avvenimento o fatto veniva socialmente omologato e correva perciò <strong>di</strong><br />
bocca in bocca, le gesta del Frassinetti e dei suoi amici non potevano passare inosservate e i suoi<br />
scritti in particolare erano novità ed anche <strong>un</strong>a rarità. Che Padre Piccardo li conoscesse e li<br />
apprezzasse lo si deduce dalle numerose citazioni e riferimenti <strong>di</strong> cui sono piene le pagine del <strong>di</strong>ario<br />
della Pia Casa, che redasse lui personalmente i primi quattro anni e dall’in<strong>di</strong>rizzo data alla sua<br />
azione pedagogica, perfettamente in linea con il pensiero del Priore.<br />
Padre Luigi Fain Binda nell’introduzione ad <strong>un</strong>o scritto su P. Piccardo afferma che chi<br />
conobbe il priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina in Genova, anche solo attraverso i suoi scritti e chi conobbe ed<br />
ebbe familiarità con P. Piccardo è portato a confessare che queste due anime sante si sono davvero<br />
incontrate spiritualmente nel cammino della vita e che lo spirito dell’<strong>un</strong>a si è trasfuso in quella<br />
dell’altro 158 dove il giovane ere<strong>di</strong>ta dal maestro lo spirito <strong>di</strong> servire la Chiesa ad ogni costo, lí, dove<br />
è piú <strong>di</strong>fficile, quello <strong>di</strong> giovare ai sacerdoti.<br />
L’in<strong>di</strong>cazione del Piccardo <strong>come</strong> responsabile della “Casa per l’avviamento dei giovinetti<br />
poveri agli stu<strong>di</strong> ecclesiastici” fatta dal Semino, era piaciuta al Frassinetti che lo vedeva <strong>come</strong> suo<br />
collaboratore nell’opera che stava muovendo i primi passi 159 . «Egli fece sua la risposta <strong>di</strong> Pietro<br />
Olivari al Frassinetti riguardo al primo giovane: "Pren<strong>di</strong>amolo con noi". Tutta la sua vita fu <strong>un</strong><br />
"cerchiamoli noi, teniamoli noi, educhiamoli noi, formiamoli noi ed anche alle spese pensiamo noi"<br />
e con questo spirito <strong>di</strong> audace intraprendenza apostolica, sorsero nuove Case, e sorse cosí <strong>un</strong>a nuova<br />
Congregazione, la nostra, per tanti <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria» 160 .<br />
L’opera <strong>di</strong> P. Piccardo è <strong>un</strong>a risposta ai bisogni del tempo, ere<strong>di</strong>tà accolta dal Frassinetti, ed<br />
anche a Roma, fin dai primi approcci, il Piccardo è segnato <strong>come</strong> erede <strong>di</strong> quel fuoco <strong>di</strong> Elia che<br />
ardeva nel Frassinetti. Egli aveva scritto in <strong>un</strong>a nota della Teologia Morale (era il 1867): «In<br />
Genova alc<strong>un</strong>i pochi <strong>Figli</strong> (della Pia Unione) <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata si sono rad<strong>un</strong>ati a far vita<br />
com<strong>un</strong>e … e si accingono a promuovere altra opera, che, benedetta da Dio, avrà grande risultato per<br />
il bene della Chiesa» 161 .<br />
Padre Piccardo stesso in <strong>un</strong>a lettera circolare racconta: «Era la terza domenica <strong>di</strong> gennaio<br />
dell'anno 1866 ed alc<strong>un</strong>i giovani furono veduti salire insieme, <strong>di</strong> buon mattino, al Santuario della<br />
Madonnetta in Genova, ascoltare la <strong>Santa</strong> Messa ed accostarsi, con grande devozione, alla <strong>Santa</strong><br />
Com<strong>un</strong>ione. Dopo avere implorato la bene<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> Maria Santissima, ritornati in città, presero<br />
alloggio in <strong>un</strong> piccolo appartamento presso la canonica <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina.<br />
Chi erano? Erano giovani operai appartenenti alla Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria<br />
Immacolata, fondata dal servo <strong>di</strong> Dio Priore Giuseppe Frassinetti, i quali, con la guida del <strong>di</strong>rettore<br />
della Tipografia della Gioventú, Pietro Olivari, anch'egli della Pia Unione, si <strong>un</strong>ivano a vita com<strong>un</strong>e<br />
sotto la <strong>di</strong>rezione del loro Fondatore.<br />
158<br />
Come figli al Padre (nota a pie’ <strong>di</strong> pagina), AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma<br />
2004, 4.<br />
159<br />
FAIN BINDA L., Come figli al Padre, AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004,<br />
7.<br />
160<br />
P. PISONI T., Lettera n° 11 del 1-12-94, Archivio FSMI, Roma.<br />
161<br />
FRASSINETTI G., Compen<strong>di</strong>o della Teologia morale, Vol. II, Società E<strong>di</strong>trice Internazionale, Torino 1948, 219.
70<br />
E quale era lo scopo <strong>di</strong> questa vita che essi intraprendevano? Oltre al fine principale della<br />
loro santificazione, si erano proposti, ritenendo ciasched<strong>un</strong>o il proprio impiego, coi risparmi che<br />
avrebbero fatto vivendo cosí insieme, <strong>di</strong> mantenere e prendersi cura <strong>di</strong> qualche giovanetto che<br />
avesse inclinazione allo stato ecclesiastico. Ecco, fratelli e figli carissimi, l'origine dell'Opera<br />
nostra» 162 .<br />
Con la sua de<strong>di</strong>zione che non aveva ness<strong>un</strong>a attrattiva carrieristica e che egli aveva<br />
abbracciato con spirito <strong>di</strong> fede in Dio e <strong>di</strong> fiducia in colui che ne aveva promosso lo sboccio, ha<br />
<strong>di</strong>schiuso la porta del santuario a <strong>un</strong>a innumerevole schiera <strong>di</strong> giovani e ai piú <strong>di</strong> essi la via<br />
sembrava chiusa da ogni parte.<br />
Questa creatura che Padre Piccardo aveva ricevuta in gemma e che coltivava con forza e con<br />
delicatezza, vero depositario dell’idea frassinettiana, da valente artefice la nutriva e la potenziava<br />
nel suo sviluppo e nella trasformazione in corso d’opera. Egli stesso era pieno <strong>di</strong> stupore per ciò che<br />
si operava attraverso <strong>di</strong> lui, per tutto quello che gli fioriva tra le <strong>di</strong>ta. «Pensando <strong>come</strong> la piccola<br />
pianticella dell’Opera nostra sia poco a poco <strong>di</strong>venuta grande, si sia <strong>di</strong>latata, <strong>come</strong> abbia potuto, per<br />
grazia speciale della <strong>Santa</strong> Sede, mettersi in Congregazione perché essa si possa perpetuare<br />
nell’avvenire, noi dobbiamo sentirci pieni <strong>di</strong> gratitu<strong>di</strong>ne verso Gesú e verso Maria Santissima» 163 .<br />
La consapevolezza che questa opera era chiamata a valicare le soglie dell’inatteso, cresceva<br />
e si chiariva sempre <strong>di</strong> piú. «Lo Spirito che continuò a regnare nei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria perio<strong>di</strong>camente<br />
faceva riproporre la questione e rinnovare i tentativi <strong>di</strong> costituirsi in vera e propria congregazione<br />
religiosa» 164 . Era desiderio <strong>di</strong> creare forme nuove era, o forse era <strong>un</strong> tuffo salutare alle acque delle<br />
origini che lo spirito del Frassinetti aveva creato e che egli dal Cielo teneva vivo nel cuore e nella<br />
mente degli spirituali suoi figli? Si può affermare che era <strong>un</strong>a pianta nuova innestata su <strong>un</strong> verde<br />
ceppo preesistente.<br />
Il carisma <strong>di</strong> fondatore emergeva poco a poco fino a <strong>di</strong>venire quella consapevolezza che<br />
portò Padre Piccardo a rifiutare con sicurezza interiore ogni proposta <strong>di</strong> “Associazione <strong>di</strong> Oblati”<br />
sia da parte del Vescovo Manacorda, che <strong>di</strong> Reggio e in particolare <strong>di</strong> Pulciano. Eppure «egli non<br />
permise mai che la sua figura e le sue opere sviassero l'attenzione dal Ven. G. Frassinetti <strong>di</strong> cui si<br />
considerava continuatore e che ad<strong>di</strong>tò sempre <strong>come</strong> Fondatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. M. Immacolata» 165 .<br />
In tutte le circostanze, soprattutto in quelle ufficiali, mise sempre in grande risalto la figura<br />
del santo sacerdote Giuseppe Frassinetti. Il 6 agosto 1877 festa <strong>di</strong> San Luigi, si tenne l’accademia<br />
per l’inaugurazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> nuovo ritratto del Priore. Tema dell’Accademia vita e opere del<br />
Frassinetti 166 . Il 15 <strong>di</strong>cembre del 1904, ricorreva il primo centenario della nascita: felice<br />
coincidenza anche questa, per cui era possibile festeggiare con l'Immacolata Patrona <strong>di</strong> cui ricorreva<br />
il cinquantesimo della <strong>di</strong>chiarazione del dogma, la memoria <strong>di</strong> chi, gettandone le basi, volle a Lei<br />
sacro quell'Istituto che fu la pupilla degli occhi suoi. Come ricordo delle feste giubilari il P.<br />
Piccardo fece pubblicare <strong>un</strong> bel numero <strong>un</strong>ico <strong>di</strong> 70 pagine con 22 illustrazioni dal titolo:<br />
“L’Immacolata ed il Frassinetti” (Tipografia della Gioventú 1907) ... nella prima parte si descrivono<br />
le feste giubilari e nella seconda si parla del Frassinetti, ricorrendo il centenario della sua nascita. In<br />
refettorio sulle pareti laterali era presentati in bellissimo or<strong>di</strong>ne i ritratti <strong>di</strong> Mons. Charvaz, <strong>di</strong> Mons.<br />
162 PICCARDO A., Lettera circolare del 13 gennaio 1916, Archivio FSMI, Roma.<br />
163 PICCARDO A., Lettera Circolare. del 13 gennaio 1916, Archivio FSMI, Roma.<br />
164 FAIN BINDA L., Lett. <strong>di</strong> fam. n° 33, 1-12-2003, Archivio FSMI, Roma.<br />
165 PISONI T., lettera 11 del 1-12-94, Archivio FSMI, Roma.<br />
166 FASSIOLO D., Memorie storiche intorno alla vita del Sac. Giuseppe Frassinetti, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, 2003, 104.
71<br />
Magnasco e Mons. Reggio e quello del fondatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria il Priore Giuseppe Frassinetti,<br />
cui facevano corona quelli degli antichi superiori, collaboratori e benefattori della Pia Opera 167 .<br />
Il fascino, si può <strong>di</strong>re la <strong>di</strong>pendenza riconoscente, era cosí profonda che il Superiore<br />
Generale P. Antonio Piccardo non si contentò solo <strong>di</strong> semplici commemorazioni o rievocazioni, ma<br />
volle erigere al Fondatore <strong>un</strong> monumento, stanziando, insieme al Suo Consiglio Superiore, a fondo<br />
perduto, la somma, allora ingente, <strong>di</strong> lire centomila per la stampa <strong>di</strong> tutti i suoi scritti, e<strong>di</strong>ti e ine<strong>di</strong>ti,<br />
che <strong>di</strong>ede <strong>un</strong>a collana <strong>di</strong> 13 volumi, vero arco trionfale attorno alla gigantesca figura <strong>di</strong> Giuseppe<br />
Frassinetti 168 , incaricando Don Giuseppe Capurro che, passò buona parte della vita a cercare ed<br />
or<strong>di</strong>nare, anche fuori Genova e tra notevoli <strong>di</strong>fficoltà, quanto piú o meno oggi sappiamo ed abbiamo<br />
del Ven. Priore 169 . «Raccolse e fece raccogliere tutto il Provabile per scoprirne e <strong>di</strong>vulgarne i meriti<br />
anche in vista del processo canonico che Egli ardentemente volle» 170 . «P. Piccardo con senso <strong>di</strong><br />
grande umiltà e da uomo <strong>come</strong> era animato dallo Spirito Divino <strong>di</strong>ceva: “Sancta Santis”, quin<strong>di</strong><br />
trattava veramente le cose del Frassinetti <strong>come</strong> <strong>di</strong> <strong>un</strong> santo e in modo santo. Non si <strong>di</strong>chiarò<br />
contento e sod<strong>di</strong>sfatto finché non vide coronati i suoi desideri col processo della causa <strong>di</strong><br />
beatificazione del Frassinetti... Il Consiglio Superiore della Congregazione in seduta plenaria del 3<br />
aprile 1909 aveva deliberato l’introduzione del processo canonico e che egli stesso era stato eletto<br />
postulatore ... Si mise subito al lavoro, nel luglio del 1915 si poté iniziare il processo or<strong>di</strong>nario; il 26<br />
gennaio 1916, con tutta la formalità <strong>di</strong> rito, venne costituito il trib<strong>un</strong>ale <strong>di</strong>ocesano. Da allora il P.<br />
Piccardo si interessò <strong>di</strong> ogni singola sessione del trib<strong>un</strong>ale, <strong>di</strong> ogni singolo teste, <strong>di</strong>mostrando cosí<br />
con quanto amore e calore caldeggiava la causa.<br />
«Nel 1921 il processo or<strong>di</strong>nario a Genova era terminato e negli ultimi giorni dell’aprile <strong>di</strong><br />
quello stesso anno, accompagnato dal vice postulatore, Don G. Capurro, volle egli stesso essere il<br />
portatore degli atti del processo a Roma e presentarli alla Sacra Congregazione dei Riti. In quel<br />
momento sembrò che egli facesse la consegna <strong>di</strong> tutto se stesso all’autorità apostolica. Chi scrive<br />
queste memorie in quell’anno si trovava a Genova nella casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria e ricorda in<br />
proposito questo particolare. Un bel pomeriggio <strong>di</strong> aprile 1921 il P. Piccardo fece ri<strong>un</strong>ire in salone<br />
tutta la com<strong>un</strong>ità, Superiori e al<strong>un</strong>ni. Su <strong>un</strong> tavolo aveva fatto preparare i 27 volumi sigillati in otto<br />
grossi pacchi e ad<strong>di</strong>tandoli <strong>di</strong>sse: “Questi pacchi contengono tutti gli atti del processo svoltosi<br />
presso la Curia <strong>di</strong> Genova riguardanti la causa del Frassinetti. Questa sera parto per Roma e li porto<br />
con me perché voglio consegnarli personalmente alla <strong>Santa</strong> Sede. È <strong>un</strong> grande avvenimento e<br />
desidero che lo ricor<strong>di</strong>ate”. II giorno stesso in cui gli atti del processo furono depositati presso la<br />
Sacra Congregazione dei Riti, Sua Santità Benedetto XV riceveva in u<strong>di</strong>enza privata il Padre<br />
Piccardo e Don Capurro. Si compiacque che il processo fosse stato portato a Roma, augurandosi <strong>di</strong><br />
poter presto salutare il Frassinetti Venerabile. Ma non cosí presto doveva terminare l’esame degli<br />
scritti e d’altra parte anche i giorni del Padre Piccardo erano contati, per cui non gli fu possibile<br />
vedere compiuti questi suoi voti» 171 .<br />
«La figura del nostro primo Superiore Generale, osserva Padre Minetti nella Lettera<br />
Circolare del 4-4-1926, eletto da Dio a prendere quasi in culla l’opera del Frassinetti e portarla a<br />
rigoglioso sviluppo, rimane scolpita nell’animo <strong>come</strong> <strong>un</strong>a forte personalità, illuminata da profonda<br />
pietà, da generoso spirito <strong>di</strong> sacrificio e da operosità instancabile».<br />
167<br />
BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 83-84.<br />
168<br />
VACCARI G., S. Pio X e il Piccardo , in AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma<br />
2004, 45<br />
169<br />
PISONI T., Lettera n° 11 del 1-12-94, Archivio FSMI, Roma.<br />
170<br />
Ibid.<br />
171<br />
BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 111-112.
72<br />
«Il Frassinetti non vide che l'alba dell'Opera, il Piccardo non vide la Congregazione aperta al<br />
ministero nelle parrocchie ed in Opere fuori d'Italia: la Provvidenza ha i suoi tempi» 172 , ma l’<strong>un</strong>o e<br />
l’altro splendono <strong>come</strong> lampade e riverberano sui loro figli ed ere<strong>di</strong> il bagliore della loro grazia.<br />
172 PISONI T., Lettera n° 11 del 1-12-94, Archivio FSMI, Roma.
73<br />
LA SUA MORTE<br />
Il 10 maggio del 1903 segna la data del testamento <strong>di</strong> Padre Piccardo. «È reale che l’uomo<br />
non vuole e non desidera prendere in considerazione la fine della propria vita sulla terra e solo<br />
occasionalmente e <strong>di</strong> sfuggita accetta <strong>di</strong> riflettere sulla possibilità della propria morte» 173 . Eppure la<br />
vita ci chiama ad essere obbe<strong>di</strong>enti alla caducità che essa contiene: l’uomo ha <strong>un</strong> legame stretto con<br />
la terra da cui è stato tratto. Riconoscere che Dio è creatore, è accettare lo stato <strong>di</strong> creatura, cioè il<br />
risultato della volontà e dell’azione <strong>di</strong> Dio.<br />
Scrivendo il suo testamento Padre Piccardo si abbandona a Dio per essere accolto, al <strong>di</strong> là<br />
della morte, da quelle mani che l’hanno plasmato dalla terra. Significativamente il foglio riporta<br />
nell’intestazione la scritta “In osculo Domini”<br />
«Raccomando l'anima mia al mio Dio, mio Creatore, mio Redentore, mio ultimo fine. La<br />
raccomando alla SS. Vergine Maria Immacolata, a San Giuseppe, al mio Angelo Custode a<br />
Sant’Antonio Abate e a tutti gli Angeli e Santi del Para<strong>di</strong>so. Imploro dalla misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Dio il<br />
perdono <strong>di</strong> tutti i miei peccati voglio morire nelle braccia della <strong>Santa</strong> Romana Chiesa,<br />
protestandomi <strong>di</strong> voler essere fino all'ultimo istante della mia vita figlio obbe<strong>di</strong>entissimo <strong>di</strong> tanta<br />
Madre, sottomesso con piena e tutta sincerità <strong>di</strong> mente e <strong>di</strong> cuore a tutti gli insegnamenti, precetti e<br />
consigli del Sommo Pontefice, Vicario <strong>di</strong> Dio in terra, rifiutando e abominando tutto ciò che a<br />
questi insegnamenti e in qual<strong>un</strong>que maniera si oppone. Cosí il buon Dio mi aiuti e la SS. Vergine<br />
Immacolata.<br />
Di tutti i miei beni immobili, <strong>come</strong> anche <strong>di</strong> quel poco denaro, mobiglio, oggetti che potessi<br />
avere all’epoca della mia morte, istituisco e nomino mio erede <strong>un</strong>iversale mio nipote, figlio del<br />
def<strong>un</strong>to mio fratello Tommaso, cioè il sacerdote Antonio Piccardo, nativo <strong>di</strong> Voltri (Genova),<br />
residente a Rivarolo Ligure.<br />
Da ultimo annullo qualsiasi altro testamento che potessi aver fatto anteriormente alla data<br />
del presente».<br />
Roma 10 maggio 1903<br />
Sacerdote Antonio Piccardo fu Pasquale» 174 .<br />
Padre Piccardo era <strong>un</strong> uomo mi intensa attività, <strong>di</strong> luci<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> mente e <strong>di</strong> vivacità<br />
d’espressione e questo suo modo <strong>di</strong> essere poteva ingannare molti sulla sua età ma ormai si avviava<br />
verso il compimento dell’ottant<strong>un</strong>esimo anno <strong>di</strong> vita. «Egli sorrideva sempre a tutti <strong>di</strong> <strong>un</strong> sorriso<br />
che, anche negli ultimi anni della sua vita, si mantenne, anche quando <strong>un</strong>a piega <strong>un</strong> po’ amara agli<br />
angoli delle sue labbra sottili, tra<strong>di</strong>va l’interna sofferenza; quel sorriso era l’espressione della carità<br />
che animava il suo spirito a fare il bene sempre e dov<strong>un</strong>que» 175 .<br />
Padre Tommaso Bertolotto, testimone oculare, cosí ci racconta gli ultimi giorni <strong>di</strong> Padre<br />
Piccardo. «L’anno successivo, Anno Santo 1925, fu l’ultimo della sua vita. P. Piccardo presagiva<br />
forse la sua prossima fine? Scrisse il P. Vaccari: “In settembre, <strong>un</strong>a sera, improvvisamente gi<strong>un</strong>se a<br />
Roma da Genova il veneratissimo Padre e alla nostra domanda per sapere <strong>come</strong> mai si era deciso a<br />
fare <strong>un</strong> simile viaggio da solo, rispose che era venuto per acquistare il giubileo con il<br />
pellegrinaggio genovese presieduto dall’Arcivescovo Mons. Dalmazio Minoretti e prendere ancora<br />
173<br />
BIANCHI E., Vivere la morte, Piero Gribau<strong>di</strong> E<strong>di</strong>tore, Torino 1987, 74.<br />
174<br />
Archivio FSMI, Roma.<br />
175<br />
MARCHI G., Settantacinquesimo, Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata, Roma 1941, 60.
74<br />
<strong>un</strong>a bene<strong>di</strong>zione dal Papa. Infatti, nonostante le forze gli mancassero, compí tutte le pratiche<br />
prescritte per il giubileo e partecipò all’u<strong>di</strong>enza pontificia.<br />
Quando il Santo Padre Pio XI, passando in rassegna i pellegrini, vide il P. Piccardo esclamò:<br />
“Ecco <strong>un</strong> pellegrino carissimo e desideratissimo” e <strong>di</strong>cendo queste parole gli passò sopra le spalle,<br />
quasi in paterno abbraccio, la sua augusta mano. In questo gesto e in queste parole vi era il<br />
riconoscimento più augusto e solenne della profonda filiale venerazione del P. Piccardo per il<br />
Vicario <strong>di</strong> Cristo in terra.<br />
II pellegrino stava per finire il suo mortale pellegrinaggio e la bene<strong>di</strong>zione del Papa <strong>un</strong>ita al<br />
perdono giubilare gli schiudeva le porte del cielo» 176 .<br />
Si mise in viaggio da Genova a Roma <strong>come</strong> se presentisse qualche scherzo da parte del<br />
Signore. Il venire a Roma per ricevere l’indulgenza del giubileo e poi mettersi nelle mani <strong>di</strong> Dio,<br />
effettuando la consegna <strong>di</strong> se stesso tra i suoi e nel luogo in cui il mandato, per il quale era vissuto,<br />
aveva raggi<strong>un</strong>to il compimento, era in fondo morire da “Padre generale”.<br />
«La mattina del 24 il Padre Minetti, entrando nella sua camera, lo trovò bocconi a terra, alla<br />
sua chiamata d’urgenza fu <strong>un</strong> accorrere <strong>di</strong> al<strong>un</strong>ni, confratelli e persone <strong>di</strong> servizio. Il malato fu<br />
messo a letto e gli fu riscontrata <strong>un</strong>a forte febbre e <strong>un</strong>a grande depressione intellettiva; gli furono<br />
apprestate le cure piú urgenti e, data la gravità del caso, anche il santo viatico» 177 . E lí al<br />
Mascherone nella manifestazione della sua debolezza era sommerso in <strong>un</strong> mare <strong>di</strong> attenzioni, <strong>di</strong><br />
cure, <strong>di</strong> delicatezze anche da parte <strong>di</strong> persone che non avevano ness<strong>un</strong> motivo particolare che le<br />
obbligasse a questo, e da coloro dai quali non ti saresti aspettato <strong>un</strong>a simile <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> affetto.<br />
«II Santo Padre Pio XI informato della gravità dello stato <strong>di</strong> P. Piccardo, per mezzo <strong>di</strong> S. E.<br />
Mons. Lavitrano, Arcivescovo <strong>di</strong> Palermo, nostro ospite, gli inviò la sua paterna affettuosissima<br />
Bene<strong>di</strong>zione» 178 . «L’interessamento per la sua preziosa esistenza fu generale e molte personalità del<br />
clero e del laicato <strong>di</strong> Roma furono a visitarlo; quando saltuariamente il male gli lasciava qualche<br />
lucido intervallo, si mostrava <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>re la visita <strong>di</strong> persone a lui piú care» 179 .<br />
Il corpo si andava esaurendo sempre piú e la mente non sempre era lucida, «II giorno 28,<br />
con piena conoscenza, poté confessarsi <strong>un</strong>’ultima volta e ricevere con trasporto nuovamente il Santo<br />
Viatico dopo il quale esclamò: “Sono tanto contento <strong>di</strong> aver fatto la <strong>Santa</strong> Com<strong>un</strong>ione”. II giorno<br />
seguente gli fu amministrata l’Estrema Unzione ed egli seguí con attenzione la cerimonia,<br />
rispondendo alle preghiere» 180 .<br />
I <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria: Padri e chierici erano intorno al suo letto. Egli nel sopore rivedeva i suoi<br />
al<strong>un</strong>ni, quelli che erano <strong>di</strong>venuti suoi figli, la meravigliosa bontà del Signore, la provvida presenza<br />
della Vergine Immacolata, il bene fatto e ricevuto, l’amore dato, il Regno <strong>di</strong> Dio che si era <strong>un</strong><br />
tantino allargato …<br />
Nel 1893 in occasione del suo venticinquesimo <strong>di</strong> sacerdozio gli antichi al<strong>un</strong>ni gli avevano<br />
donato <strong>un</strong> ritratto con contorni <strong>di</strong> figure allegoriche. «Spiccavano tra l’altro, due graziosi angioletti<br />
recanti <strong>un</strong> cartello con questa frase del Salmo: Venite, filii, au<strong>di</strong>te me, timorem Domini docebo vos.<br />
176 BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2003, 137.<br />
177 Ibid., 138.<br />
178 Ibid., 139.<br />
179 Ibid., 138.<br />
180 Ibid., 138.
75<br />
Il commento che ne fece Padre Piccardo nel ringraziare gli al<strong>un</strong>ni fu: Non potevate interpretare<br />
meglio il mio pensiero a vostro riguardo, sí, proprio questo voglio insegnarvi, il santo timore <strong>di</strong> Dio;<br />
ma prima <strong>di</strong> tutto fate <strong>di</strong> amarlo Dio, se lo amerete vi guarderete dal commettere colpa per timore <strong>di</strong><br />
offenderlo» 181 .<br />
II 1° novembre il P. Profumo S.J. professore nel Collegio Leoniano <strong>di</strong> Anagni, che fu <strong>un</strong>o<br />
dei primi al<strong>un</strong>ni <strong>di</strong> Don Piccardo, gli chiese <strong>un</strong>a speciale bene<strong>di</strong>zione ed in lui bene<strong>di</strong>sse tutta la<br />
falange dei suoi ex al<strong>un</strong>ni sparsi per ogni dove. A chi si accomiatava da lui <strong>di</strong>ceva: “Lavorate, fate,<br />
fate, fate del bene”.<br />
La notte tra il 2 e il 3 entrò in agonia; P. Minetti rinnovò l’assoluzione e, recitate le<br />
preghiere degli agonizzanti, il veneratissimo Superiore, all’1,40 sentí <strong>un</strong> grido “Ecco lo sposo<br />
andategli incontro” e cosí spirò serenamente nel bacio del Signore, e <strong>come</strong> <strong>di</strong>ce il libro <strong>di</strong> Ester “si<br />
presentò al Re”.<br />
Con questo suo ultimo atto <strong>di</strong> consegna nella morte interrompeva ogni com<strong>un</strong>icazione con i<br />
suoi figli <strong>di</strong> cui si era sentito e professato <strong>padre</strong>, che gli erano stati attorno ed avevano fatta propria<br />
in qualche modo la morte del Padre, <strong>come</strong> la morte <strong>di</strong> <strong>un</strong> patriarca. Il suo cammino era gi<strong>un</strong>to al<br />
p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> rottura <strong>di</strong> ogni relazione personale ma si apriva su <strong>un</strong> nuovo firmamento che gli permetteva<br />
<strong>di</strong> vedere il Volto <strong>di</strong> Dio cosí a l<strong>un</strong>go cercato. Ed arrivò sorella morte, <strong>un</strong>a sorella strana ed<br />
implacabile ma che gli dava l’occasione <strong>di</strong> raggi<strong>un</strong>gere il desiderio profondo che lo animava: essere<br />
con Cristo, sentire la calda luce dell’Immacolata Vergine; <strong>un</strong>a mano pietosa gli chiuse gli occhi e <strong>un</strong><br />
velo bianco ne coprí il volto.<br />
Il compianto fu grande, le esequie a Roma e a Genova furono solenni, la partecipazione<br />
numerosissima 182 . «Egli tornò santamente al Signore, dopo l<strong>un</strong>ga operosa giornata. Lo<br />
“bene<strong>di</strong>ssero gli uomini; lo premi Id<strong>di</strong>o! Il suo nome <strong>di</strong>venne strumento <strong>di</strong> opere sante nelle mani<br />
della Provvidenza <strong>di</strong>vina; sarà in memoria eterna, perché è il nome <strong>di</strong> <strong>un</strong> giusto» 183 .<br />
181 G. CHIESA, Patres nostri, Settantacinquesimo, Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Maria Immacolata, Roma, 1941, 19.<br />
182 Per notizie circa le esequie si rimanda a BERTOLOTTO T., Vita del Padre Antonio Piccardo, E<strong>di</strong>zioni Risonanze,<br />
Roma 2003, 138-144 e a AA.VV., Il nostro primo Superiore Generale, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004, passim.<br />
183 In memoria del P. Antonio Piccardo, Risonanze, numero speciale, s.d., Genova.
76<br />
INDICE<br />
Introduzione pag. 3<br />
I primi anni “ 4<br />
Nella casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> Maria “ 7<br />
Uomo dai rapporti forti “ 11<br />
Padre Piccardo, uomo <strong>di</strong> preghiera “ 15<br />
Con i suoi compagni “ 18<br />
Rettore dei Seminari “ 23<br />
Padre Piccardo educatore “ 26<br />
Seguire l’ispirazione e , tra le opposizioni, rimanere fedele alla Chiesa “ 31<br />
Padre Piccardo fondatore? “ 35<br />
Lo sguardo p<strong>un</strong>tato verso terre lontane e verso nuovi orizzonti “ 39<br />
Il cammino della Regola “ 42<br />
La svolta “ 46<br />
Padre Piccardo Superiore “ 49<br />
Padre Piccardo e il Papa “ 53<br />
Difficoltà <strong>di</strong> relazione “ 58<br />
Il trasferimento del noviziato “ 62<br />
La visita apostolica “ 65<br />
Le due lampade “ 69<br />
La sua morte “ 73