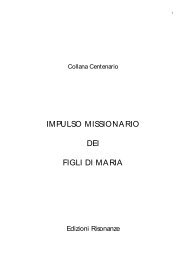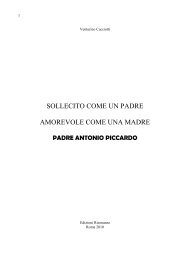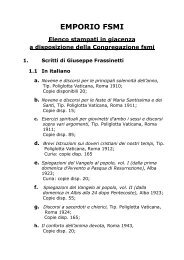terza università degli studi di roma - Figli di Santa Maria Immacolata
terza università degli studi di roma - Figli di Santa Maria Immacolata
terza università degli studi di roma - Figli di Santa Maria Immacolata
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Collana <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Frassinettiani<br />
A cura <strong>di</strong><br />
Venturino Cacciotti<br />
MISCELLANEA MAIOR<br />
Volume 1<br />
E<strong>di</strong>zioni Risonanze<br />
Roma 2010<br />
1
A mo‘ <strong>di</strong> introduzione<br />
Prefazione<br />
SOMMARIO<br />
LA CONGREGAZIONE DEL BEATO LEONARDO A GENOVA NEL QUADRO<br />
DELL’ANTIGESUITISMO GIOBERTIANO (1831 - 1848) (Francesco Puddu)….pag.<br />
Premessa<br />
1. Oggetto della ricerca 2. Riferimenti storiografici 3 Fonti utilizzate<br />
Capitolo Primo<br />
LA CONGREGAZIONE DEL BEATO LEONARDO DALLA FONDAZIONE AI<br />
PRODROMI DELL‘ ANTIGESUITISMO GIOBERTIANO (1831 - 1846)<br />
1. Antefatti 2. Fondazione 3. Sviluppo 4. La polemica anti giansenista 5. Difficoltà interne<br />
Capitolo Secondo<br />
VINCENZO GIOBERTI E LA POLEMICA SUL ―GESUITISMO‖<br />
Capitolo Terzo<br />
LA CONGREGAZIONE DEL BEATO LEONARDO DALLE REAZIONI A GIOBERTI<br />
ALLA SOPPRESSIONE<br />
1. La polemica sul gesuitismo a Genova 2. Chiusura della Congregazione<br />
CONCLUSIONI<br />
Bibliografia<br />
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE PER GLI ADOLESCENTI E GIOVANI<br />
SECONDO LA SPIRITUALITÀ DEL SACERDOTE GIUSEPPE FRASSINETTI<br />
(Dominic Tabal)<br />
Abbreviazioni<br />
Introduzione<br />
Capitolo Primo<br />
GIUSEPPE FRASSINETTI E IL SUO TEMPO<br />
A. Panorama Storico<br />
B. Giuseppe Frassinetti 1. Giuseppe Frassinetti: un dono <strong>di</strong> Dio 2. La famiglia <strong>di</strong> Frassinetti:<br />
una scuola <strong>di</strong> santità 3. Giuseppe Frassinetti: un <strong>di</strong>rettore spirituale a quattor<strong>di</strong>ci anni 4.<br />
Giuseppe Frassinetti: un apostolo per i giovani 5. La Formazione <strong>di</strong> giovani sacerdoti per i<br />
giovani<br />
C. I Giovani durante l‘epoca <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti 1. Con<strong>di</strong>zioni culturali e morali 2.<br />
Con<strong>di</strong>zioni politiche e religiose<br />
D. La Spiritualità del sac. Giuseppe Frassinetti<br />
Capitolo Secondo<br />
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE DEL SACERDOTE GIUSEPPE FRASSINETTI<br />
A. Significato ed importanza della <strong>di</strong>rezione spirituale<br />
B. Finalità della <strong>di</strong>rezione spirituale<br />
C. Il rapporto nella <strong>di</strong>rezione spirituale 1. Lo Spirito Santo: il <strong>di</strong>rettore spirituale <strong>di</strong> ogni<br />
cristiano 2. Il <strong>di</strong>rettore spirituale come ambasciatore dello Spirito Santo a. Qualità <strong>di</strong> un buon<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale b. Ruolo <strong>di</strong> un buon <strong>di</strong>rettore spirituale c. Scegliere il giusto <strong>di</strong>rettore<br />
2
spirituale d. Considerazioni sulla <strong>di</strong>rezione spirituale non desiderata 3. Atteggiamento e<br />
comportamento del credente guidato<br />
D. Origini della <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti 1. S. Alfonso <strong>Maria</strong> Liguori 2. S.<br />
Teresa d‘Avila e S. Giovanni della Croce 3. S. Francesco <strong>di</strong> Sales 4. S. Filippo Neri come<br />
prototipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore spirituale.<br />
Capitolo Terzo<br />
DIREZIONE SPIRITUALE PER GLI ADOLESCENTI E GIOVANI<br />
A. L‘importanza della <strong>di</strong>rezione spirituale per i giovani<br />
B. Giuseppe Frassinetti: <strong>di</strong>rettore spirituale dei giovani<br />
C. Direzione spirituale singolare 1. La formazione dell‘anima del giovane a. Ricor<strong>di</strong> per la<br />
coscienza b. Ricor<strong>di</strong> per l‘importanza della preghiera c. Ricor<strong>di</strong> per i santi sacramenti. d.<br />
Ricor<strong>di</strong> per la famiglia e. Ricor<strong>di</strong> per le virtú dell‘umiltà e onestà f. Ricor<strong>di</strong> per il timore <strong>di</strong> Dio<br />
g. Ricor<strong>di</strong> per l‘amore <strong>di</strong> Dio 2. Le due vie per arrivare alla santità a. L‘Eucaristia b. La castità e<br />
virginità. 3. L‘accompagnamento e <strong>di</strong>scernimento della propria vocazione a. Il <strong>di</strong>scernimento<br />
per il sacerdozio b. Il <strong>di</strong>scernimento per la vita consacrata c. Il <strong>di</strong>scernimento della cristiano<br />
laico. 4. La devozione per la Beata Vergine <strong>Maria</strong><br />
D. Direzione spirituale in gruppo 1. L‘amicizia spirituale 2. Pie unioni e associazioni <strong>degli</strong><br />
amici<br />
E. Direzione spirituale e le letture<br />
F. Direzione spirituale e le lettere<br />
Capitolo Quarto<br />
ATTUALITÁ DELL‘INSEGNAMENTO DEL SACERDOTE GIUSEPPE FRASSINETTI<br />
A. La situazione dei giovani nel nostro tempo<br />
B. L‘urgenza e necessità per il pastorale giovanile oggi 1. Il bisogno della <strong>di</strong>rezione spirituale 2.<br />
Il bisogno della figura del <strong>di</strong>rettore spirituale<br />
C. Rilevanza attuale della <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti 1. Educare i giovani al<br />
vero significato dell‘amore 2. Guidare i giovani a capire il dono della sessualità umana 3<br />
Accompagnare i giovani verso la strada della vera felicità<br />
D. Le sfide attuali 1. ―Siamo venuti per adorarlo‖ (Mt 2,2) 2. ―La tua Parola è lampada per i<br />
miei passi‖ (Ps 119:105) 3. ―Non ci ardeva forse il cuore…‖(Lc 24,32)<br />
CONCLUSIONE<br />
Bibliografia<br />
LA PREGHIERA, VINCOLO D’AMORE TRA DIO E L’UOMO. STUDIO ALLA LUCE<br />
DEL PATER NOSTER DI SANTA TERESA. UN TRATTATO SULLA PREGHIERA DI<br />
GIUSEPPE FRASSINETTI (Jimmy Pantin)<br />
Abbreviazioni<br />
Introduzione<br />
Capitolo Primo<br />
PADRE GIUSEPPE FRASSINETTI: CHI SEI?<br />
A. Profilo <strong>di</strong> un uomo apostolico<br />
B. Note sull‘ambiente sociale e politico<br />
C. La sua famiglia e la sua vita<br />
D. Animatore, collaboratore e fondatore <strong>di</strong> pie unioni, associazioni ed altri gruppi ecclesiali<br />
E. Fautore e guida spirituale <strong>di</strong> santi 1. Paola Frassinetti 2.Giovanni Bosco 3.Domenica <strong>Maria</strong><br />
Mazzarello 4.Antonio <strong>Maria</strong> Granelli 5.Tommaso Reggio 6.Rosa Gattorno<br />
F. Teologo e scrittore<br />
Capitolo Secondo<br />
3
SANTA TERESA D‘AVILA ED IL SUO DISCEPOLO IL TEOLOGO GIUSEPPE<br />
FRASSINETTI COME MAESTRI DI PREGHIERA<br />
A. La scoperta dei santi carmelitani<br />
1 <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú<br />
2 San Giovanni della Croce<br />
3 <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Maddalena de‘ Pazzi<br />
B. Il Padre nostro<br />
1 Relazione fraterna<br />
2 Relazione paterna - filiale<br />
3 Relazione sponsale<br />
Capitolo Terzo<br />
L‘IMPORTANZA DI GIUSEPPE FRASSINETTI NEL TERZO MILLENNIO<br />
A. L‘mato teologo dei santi<br />
B. Apostolato mistico<br />
C. Giuseppe Frassinetti un teologo <strong>di</strong> vita spirituale?<br />
CONCLUSIONE<br />
Bibliografia<br />
A MO’ DI INTRODUZIONE<br />
Nel 2004 si è celebrato il duecentesimo anniversario della nascita del Venerabile<br />
Giuseppe Frassinetti. Anche se l‘evento ha avuto una risonanza circoscritta tuttavia è stato<br />
commemorato nelle zone dove sono presenti i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, soprattutto a<br />
Genova, dove era nato e aveva operato.<br />
Come sviluppo <strong>di</strong> questa celebrazione ne è scaturito l‘impegno dello <strong>stu<strong>di</strong></strong>o e<br />
dell‘approfon<strong>di</strong>mento della sua versatile personalità, che ha tanto influito sul clero e sulla storia<br />
genovese nel secolo <strong>di</strong>ciannovesimo.<br />
La sua figura non è stata mai troppo appariscente durante tutta la vita, perché era esperto<br />
nel celarsi <strong>di</strong>etro ad altri collaboratori, che potevano riscuotere la gloria delle varie iniziative;<br />
sebbene egli ne rimanesse sempre e l‘ispiratore e l‘animatore.<br />
Questo porta il ricercatore a tentare <strong>di</strong> scoprire lo stile dell‘autore che trapela <strong>di</strong>etro le<br />
sinuosità dell‘impresa, e non è un compito <strong>di</strong>fficile, perché sembra che si possa ripetere per lui il<br />
verso del Manzoni: che il ―Massimo Fattore volle in lui del creator suo spirito piú vasta orma<br />
stampar‖.<br />
I germi <strong>di</strong> bene lasciati nel suo solco affermano che la sua opera è stata considerevole.<br />
L‘attenzione alla sua persona, alla sua azione e ai suoi scritti non è una scoperta <strong>di</strong><br />
questi ultimi anni: la pubblicazione delle Opera Omnia, l‘e<strong>di</strong>zione delle Opere Ascetiche, <strong>di</strong>eci<br />
biografie, incominciando dalla vita scritta nove anni dopo la sua morte dal Fassiolo fino<br />
all‘ultima del Falasca, sono un chiaro invito allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o <strong>di</strong> un personaggio non comune.<br />
Molti lavori composti a suo riguardo giacevano in un qualche archivio. La presente<br />
Miscellanea si propone <strong>di</strong> estrarli dalla polvere della <strong>di</strong>menticanza e dell‘anonimato e portarli a<br />
conoscenza del lettore, perché dalle posizioni acquisite si possa, nella conoscenza e nella<br />
valorizzazione dei tesori nascosti nelle pieghe della storia, ottenere luce per il futuro.<br />
La Redazione<br />
4
PREFAZIONE<br />
Miscellanea Maior. Ecco una seconda occasione.<br />
Se per la Miscellanea Minor è stato opportuno un atto <strong>di</strong> cortesia, <strong>di</strong> alcune parole <strong>di</strong><br />
introduzione, per la Miscellanea maior una introduzione si rende necessaria proprio per capire la<br />
motivazione dell‘aggettivo ―Maior‖.<br />
Nel primo volume, quello ―minor‖ della Miscellanea si è compiuta l‘operazione <strong>di</strong><br />
raccogliere scritti occasionali sulla figura e sulle opere del Venerabile Giuseppe Frassinetti.<br />
Al <strong>di</strong> là dell‘accoglienza del lavoro e dei suoi contenuti, che avrebbe potuto avvenire in<br />
un modo piú o meno entusiastico, la sua pubblicazione era stata pensata come un primo gra<strong>di</strong>no<br />
in vista <strong>di</strong> arrivare alla Miscellanea Maior.<br />
C‘era dunque un progetto da realizzare con un inizio in sor<strong>di</strong>na, ma con crescendo<br />
sonoramente piú ampio e mirato. L‘aggettivo ―maior‖ designa lo scopo e il fine <strong>di</strong> questo<br />
progetto perché entriamo nel campo <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> eseguiti sotto la guida <strong>di</strong> insegnanti esperti negli<br />
argomenti trattati e strutturati per raggiungere titoli accademici nelle piú o meno prestigiose<br />
<strong>università</strong> civili e pontificie.<br />
È desiderio del progetto stimolare quanti stanno per concludere i propri itinerari<br />
universitari a collocare temi che consentono <strong>di</strong> focalizzare meglio come il fondatore Giuseppe<br />
Frassinetti possa aiutare oggi a vivere meglio il santo Vangelo. Ci sarebbe anche il vantaggio <strong>di</strong><br />
una maggiore conoscenza e popolarità che consentirebbero una maggiore devozione e stima<br />
verso <strong>di</strong> lui.<br />
Dieci e lode, quin<strong>di</strong>, a tutti coloro che hanno de<strong>di</strong>cato tempo, fatica e denaro per<br />
realizzare questo progetto.<br />
Scendendo nello specifico dei singoli argomenti troviamo all‘inizio il lavoro <strong>di</strong> P.<br />
Francesco Puddu che ci riporta all‘esperienza promossa dai sacerdoti Giuseppe Frassinetti e<br />
Luigi Sturla, che a Genova si fecero promotori <strong>di</strong> un‘associazione <strong>di</strong> giovani sacerdoti e<br />
seminaristi, che si proponeva <strong>di</strong> rinnovare la spiritualità del giovane clero, <strong>di</strong> elevare la sua<br />
cultura religiosa e favorire l‘attuazione della <strong>di</strong>sciplina ecclesiastica.<br />
Nel quadro delle varie associazioni ecclesiali del tempo si presentò con la caratteristica<br />
<strong>di</strong> un programma pastorale rivolto principalmente all‘ambito religioso con un in<strong>di</strong>rizzo ascetico<br />
che contrastava fortemente i rigi<strong>di</strong> principi, allora prevalenti nel clero.<br />
Si trovò però coinvolta in quella, che nelle letture storiche dei nostri giorni per il 150°<br />
dell‘unità d‘Italia, è considerata una complessa situazione culturale e politica, legata allo<br />
sviluppo <strong>degli</strong> ideali liberali e alla maturazione del concetto della nazione italiana.<br />
Le vicende illustrate da Francesco Puddu stanno a <strong>di</strong>mostrare quanto sia illusorio ridurre<br />
al solo livello privato, l‘influsso <strong>di</strong> un‘esperienza autenticamente religiosa. Inoltre certifica che<br />
l‘agire pastorale della Chiesa non può essere slegato dalla costruzione <strong>di</strong> un retto sentire<br />
dell‘azione politica e sociale esercitata nel contesto civile delle varie nazioni a livello mon<strong>di</strong>ale.<br />
Non a caso quin<strong>di</strong> questa tesi <strong>di</strong> laurea è stata presentata in una <strong>università</strong> civile nel 1994.<br />
Il lavoro <strong>di</strong> P. Dominic Tabal sposta l‘attenzione su un punto dell‘attività pastorale del<br />
Frassinetti, che acquista rilevanza quando si considera che in esso consiste l‘ere<strong>di</strong>tà spirituale<br />
lasciata come fine specifico al gruppo dei suoi collaboratori nel momento in cui ha lasciato<br />
questo mondo.<br />
I componenti della Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> comprenderanno<br />
quanto è importante la preparazione e la formazione personale per poter svolgere in modo<br />
proficuo e adeguato il servizio <strong>di</strong> accompagnamento vocazionale dei giovani.<br />
Essi, oltre che aiutare i giovani e dotarsi <strong>di</strong> una retta coscienza, li educheranno alla<br />
preghiera, al senso della famiglia, alle virtú, alla devozione verso la Vergine, ai sacramenti.<br />
Ogni pastore d‘anime potrà toccare con mano quale profonda gioia e sod<strong>di</strong>sfazione<br />
abbia provato il Frassinetti nel rendersi <strong>di</strong>sponibile a riconoscere il progetto che il Signore<br />
5
vorrebbe realizzare con il singolo giovane anche attraverso le scelta del sacerdozio e della<br />
consacrazione religiosa. Di conseguenza si comprende oggi l‘urgenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare punto <strong>di</strong><br />
riferimento per quei giovani che vogliono assumersi la responsabilità <strong>di</strong> incamminarsi per quelle<br />
strade che portano alla piena realizzazione delle capacità ricevute in dono da Dio.<br />
Sicuramente si avvertirà anche la preziosità dell‘accompagnamento vocazionale dei<br />
giovani poveri, affidatoci dal Magistero pontificio, con l‘approvazione canonica delle<br />
Costituzioni.<br />
Nel presentare la dottrina sulla preghiera P. Jimmy Pantin si sofferma a rilevare i legami<br />
che uniscono il Frassinetti alla spiritualità dei mistici carmelitani e sulle amicizie spirituali,<br />
mutuate da <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú, che egli promosse e intrattenne con i suoi contemporanei.<br />
Buona e proficua lettura.<br />
P. Valter Palombi<br />
6
LA CONGREGAZIONE DEL BEATO LEONARDO A GENOVA NEL<br />
QUADRO DELL‘ANTIGESUITISMO GIOBERTIANO (1831 - 1848) 1<br />
1. OGGETTO DELLA RICERCA<br />
PREMESSA<br />
La presente ricerca tratta <strong>di</strong> un‘associazione <strong>di</strong> giovani sacerdoti e seminaristi, sorta a<br />
Genova nel 1831 nell‘ambito culturale della Restaurazione: essa si proponeva insieme <strong>di</strong><br />
rinnovare la spiritualità del giovane clero, <strong>di</strong> elevarne la cultura religiosa e <strong>di</strong> restaurarne la<br />
<strong>di</strong>sciplina ecclesiastica.<br />
Promotori dell‘iniziativa, che durò fino al 1847, furono Luigi Sturla e Giuseppe<br />
Frassinetti e ne presero parte numerosi ecclesiastici, alcuni dei quali svolsero poi un ruolo <strong>di</strong><br />
primo piano nelle vicende religiose e culturali del tempo (Salvatore Magnasco, Gaetano<br />
Alimonda, Domenico Gualco e altri).<br />
Il titolo finale dell‘associazione, frutto <strong>di</strong> elaborazioni successive, suona:<br />
“Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima, regina <strong>degli</strong> Apostoli,<br />
dei Santi Apostoli e del Beato Leonardo da Porto Maurizio”; comunemente chiamata<br />
“Congregazione del Beato Leonardo”.<br />
Nel quadro delle varie associazioni sacerdotali del tempo, si caratterizzò per un<br />
impegno ―militante‖ nelle questioni ritenute importanti per la <strong>di</strong>fesa del Cattolicesimo. Nota<br />
particolarmente caratteristica fu il suo impegno filo-<strong>roma</strong>no e la stretta <strong>di</strong>pendenza volontaria<br />
dalla <strong>Santa</strong> Sede, sia nelle questioni teologiche, che in quelle morali e <strong>di</strong>sciplinari.<br />
Accanto a questo aspetto, ed in connessione con esso, si presenta un marcato<br />
orientamento antigiansenista, sia nel campo teologico che in quello morale. L‘esplicita adesione<br />
al sistema morale <strong>di</strong> S. Alfonso de‘ Liguori costituiva il supporto <strong>di</strong> un in<strong>di</strong>rizzo ascetico -<br />
pastorale tendenzialmente conflittuale con i principi rigoristi allora prevalenti nel clero<br />
genovese della prima metà dell‘Ottocento.<br />
Tali caratteristiche fornirono le basi per un progressivo avvicinamento alla Compagnia<br />
<strong>di</strong> Gesú che, iniziato in forma occasionale attraverso relazioni personali con alcuni gesuiti,<br />
assunse un carattere via via piú intenso e impegnativo.<br />
Benché l‘associazione intendesse qualificarsi prioritariamente, se non esclusivamente,<br />
nell‘ambito religioso, essa si trovò coinvolta in una complessa situazione culturale e politica,<br />
legata allo sviluppo <strong>degli</strong> ideali liberali da un lato e al maturare della questione nazionale<br />
italiana dall‘altro.<br />
Nelle complesse vicende del Risorgimento italiano essa fu coinvolta nelle vivaci<br />
polemiche tra il movimento neoguelfo <strong>di</strong> ispirazione giobertiana ed i Gesuiti. Schieratasi dalla<br />
parte <strong>di</strong> questi ultimi, venne travolta dal prevalere delle correnti liberali nei moti politici del<br />
1847 - 49.<br />
Dopo la chiusura della Congregazione, molte idee ed attività furono riprese e sviluppate<br />
da una nuova associazione <strong>di</strong> carattere prettamente laicale, la “Pia Associazione per la<br />
conservazione e l‟incremento della santa Fede”, che può essere considerata la forma<br />
embrionale dell‘Azione Cattolica a Genova.<br />
La continuità tra queste due associazioni, pur nelle mutate con<strong>di</strong>zioni politiche, è<br />
attestata anche dall‘identità <strong>di</strong> una buona percentuale dei <strong>di</strong>rigenti.<br />
1 Tesi <strong>di</strong> laurea nella facoltà dl lettere e filosofia della Terza Università <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> Roma. Studente<br />
Francesco Puddu, corso <strong>di</strong> laurea in materie letterarie n. 08117755. Relatore: Prof. G. Talamo,<br />
Correlatore: Prof. Stella, Anno Accademico 1993 – 1994.<br />
P. Francesco Puddu, sacerdote dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, licenziato in teologia e laureato in<br />
materie letterarie, è missionario – pastore in Polonia, dove vive fin dagli anni dei noti cambiamenti<br />
politici, sperimentando quanto il messaggio evangelico deve connaturarsi con la storia.<br />
7
Alcuni <strong>di</strong> essi, come Salvatore Magnasco e Giuseppe Frassinetti, furono tra i promotori<br />
<strong>di</strong> una società <strong>di</strong> Mutuo Soccorso intitolata a “N. S. del Soccorso e S. Giovanni Battista”, la<br />
prima in Liguria <strong>di</strong> carattere cattolico (1845).<br />
L‘argomento trattato riguarda, pertanto, sia gli orientamenti culturali del clero italiano,<br />
particolarmente <strong>di</strong> quello genovese, sia le vicende che prepararono il sorgere dell‘Azione<br />
Cattolica e piú in generale <strong>di</strong> un movimento cattolico <strong>di</strong> ispirazione intransigente.<br />
2. RIFERIMENTI STORIOGRAFICI<br />
Non sono mancati in Italia, in tempi recenti, <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> approfon<strong>di</strong>ti sulle caratteristiche<br />
ed il ruolo del clero italiano nell‘Ottocento.<br />
Accanto ai contributi <strong>di</strong> Giacomo Martina 2 , considero fondamentali i saggi <strong>di</strong> Xenio<br />
Toscani 3 , Maurilio Guasco 4 negli annali Einau<strong>di</strong> ed il volume collettivo curato da Mario Rosa 5 .<br />
Maurilio Guasco ha mostrato come il problema della formazione del sacerdote, per<br />
quanto avvertito ed impostato nel Concilio <strong>di</strong> Trento, sia rimasto un problema aperto fino agli<br />
inizi del XX secolo, quando Pio X prescrisse l‘obbligatorietà della presenza in Seminario per<br />
poter accedere all‘or<strong>di</strong>nazione sacerdotale.<br />
D‘altra parte i pilastri ideali dell‘educazione ecclesiastica in<strong>di</strong>viduati da S. Carlo<br />
Borromeo: la pietà, la formazione intellettuale, la <strong>di</strong>sciplina erano punto <strong>di</strong> riferimento a quanti<br />
si occupassero dei seminaristi anche nell‘Ottocento, e si ritrovano certamente presenti nel<br />
programma <strong>di</strong> formazione spirituale della Congregazione del Beato Leonardo.<br />
Nel corso dell‘Ottocento, inoltre, si sviluppa e <strong>di</strong>venta irreversibile il processo, già<br />
iniziato nel Settecento, che lega la con<strong>di</strong>zione sacerdotale alla ―cura <strong>di</strong> anime‖, e perciò ad una<br />
concreta attività pastorale in <strong>di</strong>pendenza dal proprio Vescovo. Questo processo richiede anche<br />
un aumento della consapevolezza dell‘identità e del ruolo dell‘ecclesiastico nella Chiesa e nella<br />
società.<br />
Di qui l‘utilità <strong>di</strong> seguire non solo la letteratura tesa a delineare l‘ideale e le<br />
caratteristiche del clero, ma anche <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>are istituzioni e iniziative volte a riqualificare in senso<br />
pastorale la figura del sacerdote.<br />
Tale processo <strong>di</strong> orientamento in senso pastorale del clero si sviluppa nel corso <strong>di</strong><br />
complesse e movimentate vicende socio - politico - culturali che interagiscono con l‘aspetto<br />
religioso, lo con<strong>di</strong>zionano e ne subiscono l‘influsso.<br />
Il trapasso da una concezione teocratica dell‘organizzazione socio - politica, ad una <strong>di</strong><br />
tipo laica e secolarizzata, preconizzata dall‘illuminismo e messa in moto dalla Rivoluzione<br />
francese, rappresenta una trasformazione culturale <strong>di</strong> vasta portata temporale, che costrinse la<br />
Chiesa a ridefinire il suo ruolo e le sue strategie rispetto al quadro ideale della societas<br />
christiana che aveva fino ad allora dominato, pur tra le inevitabili tensioni tra potere politico ed<br />
autorità religiosa.<br />
L‘Ottocento visse con particolare intensità questo trapasso sia per lo sviluppo <strong>roma</strong>ntico<br />
dell‘ideale <strong>di</strong> ―nazionalità‖, sia per l‘affermarsi in numerosi Stati <strong>di</strong> regimi costituzionali, sia per<br />
2 G. MARTINA, Il clero italiano e la sua azione pastorale verso la metà dell‟Ottocento, Appen<strong>di</strong>ce I al<br />
libro <strong>di</strong> R. AUBERT, Il pontificato <strong>di</strong> Pio IX 1846-1878, Torino 1970, 2 voll., 751 - 782 del vol. II; ID., Il<br />
clero nell‟Italia centrale dalla restaurazione all‟Unità, Napoli 1982; ID., L‟atteggiamento della gerarchia<br />
<strong>di</strong> fronte alle prime iniziative organizzative <strong>di</strong> apostolato dei laici in Italia, Padova 1969.<br />
3 X. TOSCANI, Il reclutamento del clero secoli XVI-X1X, in Storia d‟Italia. Annali 9. La chiesa e il potere<br />
politico dal Me<strong>di</strong>oevo all‟età contemporanea, Torino 1986, 575-626.<br />
4 M. GUASCO, La formazione del clero: i Seminari, in Storia d‟Italia. Annali 9, op. cit., 634-715.<br />
5 M. ROSA, Clero e società nell‟Italia contemporanea, Bari 1992.<br />
8
l‘allargamento della partecipazione civile alle vicende politiche ed il sorgere <strong>di</strong> organizzazioni<br />
<strong>di</strong> massa, principalmente democratiche e socialiste, ma anche cattoliche.<br />
Il sorgere <strong>di</strong> queste organizzazioni <strong>di</strong> massa tra i cattolici, i loro rapporti con gli<br />
orientamenti teologici e sociali della Gerarchia cattolica e del clero, con le parallele vicende<br />
politiche che portarono all‘unificazione italiana ed alla proclamazione <strong>di</strong> Roma capitale d‘Italia,<br />
sono state oggetto, nel recente dopoguerra, <strong>di</strong> un rinnovato interesse storiografico 6 .<br />
Pur nella <strong>di</strong>versità <strong>degli</strong> orientamenti culturali <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>osi è stata compresa la<br />
necessità <strong>di</strong> non limitare lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o ai vari filoni del Cattolicesimo liberale, come<br />
prevalentemente aveva fatto la storiografia liberale, ma <strong>di</strong> esaminare nel suo sorgere e nel suo<br />
svilupparsi, fino al suo organizzarsi come movimento <strong>di</strong> massa, quella ―opposizione cattolica‖<br />
allo Stato Italiano unitario e liberale, quale si venne poi configurando negli anni 70-80, dopo la<br />
caduta del potere temporale dei Pontefici <strong>roma</strong>ni.<br />
Dando al termine una valenza piú ristretta, e cioè considerando determinante la<br />
<strong>di</strong>pendenza organizzativa dalla <strong>Santa</strong> Sede, Fausto Fonzi considera preliminare alla nascita del<br />
Movimento Cattolico il sorgere dello Stato unitario e liberale, e perciò inizia la sua esposizione<br />
con il 1861 7 . Lo stesso autore però rivolge la sua attenzione al periodo precedente, agli anni tra<br />
il 1849 e il 1859, esaminando in un articolo le vicende dei Cattolici liguri nel Regno <strong>di</strong><br />
Sardegna 8 .<br />
La storiografia <strong>di</strong> ispirazione marxista, sulla scia <strong>di</strong> Antonio Gramsci, tende a<br />
considerare il 1848 come lo spartiacque tra un lungo ―periodo <strong>di</strong> incubazione‖ ed il sorgere<br />
dell‘Azione Cattolica come fenomeno socio – culturale specificatamente contemporaneo 9 .<br />
Per Gramsci l‘Azione Cattolica è un‘innovazione, in quanto «segna l‘inizio <strong>di</strong> una<br />
epoca nuova nella storia della religione cattolica: quando essa da una concezione totalitaria (nel<br />
duplice senso: che era una totale concezione del mondo <strong>di</strong> una società nel suo totale), <strong>di</strong>venta<br />
parziale (anche nel duplice senso) e deve avere un proprio partito. I <strong>di</strong>versi or<strong>di</strong>ni religiosi<br />
rappresentano la reazione della Chiesa dall‘alto o dal basso, contro le <strong>di</strong>sgregazioni parziali<br />
della concezione del mondo (eresie, scismi, ecc., e anche degenerazione delle gerarchie),<br />
l‘Azione Cattolica rappresenta la reazione contro l‘apostasia <strong>di</strong> intere masse, imponente, cioè<br />
contro il superamento <strong>di</strong> massa della concezione religiosa del mondo» 10 .<br />
Per Gramsci ci troviamo davanti ad una crisi storico politico - intellettuale <strong>di</strong><br />
proporzioni epocali, oggi <strong>di</strong>fficilmente immaginabile, che costrinse la Chiesa a mettersi su<br />
posizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa.<br />
Rispetto al ricco fiorire <strong>di</strong> associazioni cattoliche in tutti i tempi (es. corporazioni <strong>di</strong><br />
mestieri, confraternite sotto il patrocinio <strong>di</strong> qualche santo), il Movimento Cattolico, a nostro<br />
avviso, va <strong>di</strong>stinto per la sua comparsa in un mondo in cui la qualifica religiosa non è piú un<br />
dato scontato del vivere sociale ed il peso politico <strong>di</strong> un‘associazione è in<strong>di</strong>ssolubilmente legato<br />
al suo organizzarsi a livello <strong>di</strong> massa.<br />
Poiché questo processo ha nell‘Ottocento una portata europea, almeno in ambito<br />
occidentale, è preferibile assumere un concetto ampio <strong>di</strong> Movimento Cattolico, capace <strong>di</strong> dar<br />
6 Per una panoramica sulla ricerca storica nel settore riman<strong>di</strong>amo all‘introduzione <strong>di</strong> BARTOLO GARIGLIO<br />
ed ETTORE PASSERIN D‘ENTREVES all‘antologia da essi curata dal titolo: Introduzione alla storia del<br />
movimento cattolico in Italia, Bologna 1973.<br />
7 Cfr. F. FONZI, Per una storia del Movimento Cattolico italiano 1861-1919, in Rassegna del<br />
Risorgimento, XXXVII 1950, 140-150, ed anche ID., I cattolici e la società italiana dopo l‟Unità, Roma<br />
1982.<br />
8 F. FONZI Correnti <strong>di</strong> opposizione alla politica piemontese tra i cattolici liguri negli anni1849-1859, in<br />
Rassegna storica del Risorgimento, XXXIX 1952, fasc. IV, 552<br />
9 A. GRAMSCI, Lettere dal carcere, ed. a cura <strong>di</strong> V. Gerrantana, Torino 1975, vol. III, 2081ss., 2086 s.<br />
10 A. GRAMSCI, L‟Azione Cattolica, citato da BARTOLO GARIGLIO - ETTORE PASSERIN D‘ENTREVES a cura<br />
<strong>di</strong> Introduzione alla storia, op. cit., 71.<br />
9
conto del variegato organizzarsi dei cattolici in organizzazioni tendenzialmente ―<strong>di</strong> massa‖ nelle<br />
<strong>di</strong>verse nazioni europee 11 .<br />
La Congregazione del Beato Leonardo, in quanto raccolta <strong>di</strong> ecclesiastici, non può, a<br />
mio parere, essere considerata parte integrante del Movimento Cattolico. La corrente neoguelfa,<br />
e quella giobertiana in particolare, possono essere viste come un tentativo <strong>di</strong> dar vita ad un<br />
movimento politico cattolico, <strong>di</strong> orientamento filo-liberale ed anti-intransigente 12 .<br />
Proprio nell‘appassionato scontro tra la concezione intransigente e quella liberale si<br />
venne a determinare, con il ra<strong>di</strong>calizzarsi delle posizioni, un‘emarginazione <strong>di</strong> quelle cattolicoliberali<br />
con l‘espulsione della corrente giobertiana dall‘ambito delle organizzazioni cattoliche,<br />
ed un progressivo rafforzarsi della concezione intransigente nella Gerarchia, nel clero e nel<br />
laicato cattolico organizzato.<br />
La presente ricerca, pur nel suo argomento estremamente circoscritto, vuole essere un<br />
contributo a quanti avvertono l‘utilità <strong>di</strong> indagare sulla ―preistoria‖ dell‘Azione Cattolica, e sul<br />
periodo d‘incubazione del Movimento cattolico intransigente in Italia 13 .<br />
3. FONTI UTILIZZATE<br />
Le fonti principali utilizzate per lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o sulla congregazione del Beato Leonardo sono<br />
gli scritti <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti e <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti.<br />
Il primo è autore, nel 1847, <strong>di</strong> alcune note sulla storia del sodalizio, che furono<br />
pubblicate anonime con il titolo <strong>di</strong> “Notizie della Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la<br />
protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Regina <strong>degli</strong> Apostoli, dei ss. Apostoli e del Beato Leonardo da Porto<br />
Maurizio”, ad Oneglia nel 1857. L‘e<strong>di</strong>zione fu curata da Luigi Bottaro, anch‘egli membro della<br />
Congregazione, e presenta omissioni rispetto al manoscritto, che si trova riprodotto<br />
integralmente nell‘e<strong>di</strong>zione dell‘Opera Omnia, Roma 1912, 521-611 del volume XIII.<br />
Si tratta dell‘unica monografia finora pubblicata sulla Congregazione. Da essa<br />
<strong>di</strong>pendono i biografi del Frassinetti quando trattano dell‘argomento ed i Manoscritti <strong>di</strong> Arturo<br />
che vi de<strong>di</strong>ca alcuni capitoli 14 .<br />
Il Frassinetti è poi tornato sugli stessi argomenti in ―Memorie intorno alla vita del sac.<br />
Luigi Sturla”, scritto qualche tempo dopo la morte del sacerdote (19 IV 1864), ma pubblicato<br />
postumo a Genova nel 1871.<br />
Accenni all‘operato della Congregazione si trovano anche in uno scritto del Frassinetti,<br />
“Rischiarimenti sul mio passato” <strong>di</strong> carattere apologetico, datato 1857, ma rimasto ine<strong>di</strong>to 15 .<br />
11 Il <strong>di</strong>scorso richiede delle precisazioni terminologiche, visto il carattere, per cosi <strong>di</strong>re, promiscuo delle<br />
organizzazioni del laicato cattolico operanti tanto nel settore religioso che in quello socio-politico,<br />
talvolta senza neppure una chiara demarcazione dei <strong>di</strong>versi settori. Qui si intende per Azione Cattolica<br />
non solo l‘omonima organizzazione religiosa, ma tutto il complesso <strong>di</strong> associazioni <strong>di</strong> laici cattolici che<br />
intendevano <strong>di</strong>fendere la Fede e gli interessi della Chiesa Cattolica in stretta <strong>di</strong>pendenza dalla Gerarchia<br />
ecclesiastica. Il termine Movimento Cattolico mi sembra vada inteso in un senso piú ampio e generico<br />
come l‘insieme delle attività culturali e organizzative, politiche e socio-economiche svolte dal laicato<br />
cattolico, in forma organizzata o quantomeno tendente alla mo<strong>di</strong>ficazione della società civile. Entrambi<br />
questi fenomeni vanno qualificati come avvenimenti <strong>di</strong> carattere laicale, in cui cioè tutti i fedeli possono<br />
partecipare ed assumere ruoli <strong>di</strong>rigenti.<br />
12 Allo svilupparsi, nel pensiero e nell‘azione <strong>di</strong> Gioberti, della polemica anti-intransigente, focalizzata<br />
intorno alla lotta con la Compagnia <strong>di</strong> Gesú, è de<strong>di</strong>cato il secondo capitolo della Tesi, come necessaria<br />
premessa allo sviluppo ulteriore delle vicende della Congregazione<br />
13 Le espressioni tra virgolette sono mutuate da Antonio Gramsci, cfr. A. GRAMSCI, L‟azione cattolica, in<br />
BARTOLO GARIGLIO ETTORE PASSERIN D‘ENTREVES a cura <strong>di</strong>, Introduzione alla storia, op. cit., 71 ss.<br />
14 Questi manoscritti si trovano nella Biblioteca del seminario <strong>di</strong> Genova.<br />
15 È stato dattiloscritto a cura <strong>di</strong> R. MORELLI E R. REGOLI, con note <strong>di</strong> A. Remon<strong>di</strong>ni e ciclostilato in una<br />
raccolta dal titolo Archivio Frassinettiano, dove si trova alle pp.12-34 vol II. I due volumi ciclostilati <strong>di</strong><br />
10
Oltre a queste opere, che, pur non avendo un carattere scientifico, hanno però<br />
un‘impostazione storica, ho preso in esame quegli scritti che <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente<br />
riguardano gli ideali e le attività della Congregazione 16 .<br />
Vincenzo Gioberti de<strong>di</strong>ca varie pagine del suo “Gesuita Moderno” alla Congregazione<br />
del Beato Leonardo ed alla polemica con il Frassinetti, ed ospita tra i documenti una relazione<br />
sul ―Gesuitismo in Liguria” (Il Gesuita Moderno, vol. VI doc XXIII) ed il Memoriale dei<br />
parroci a Placido Ta<strong>di</strong>ni Car<strong>di</strong>nale (doc. VII Delle accuse mosse contro i parroci <strong>di</strong> Genova).<br />
Di impostazione giobertiana sono anche gli scritti <strong>di</strong> Cristoforo Bonavino, piú <strong>di</strong>rettamente<br />
impegnati nella polemica con il Frassinetti 17 .<br />
Per la ricostruzione della polemica <strong>di</strong> Gioberti con i Gesuiti ho utilizzato inoltre, i<br />
Prolegomeni dell‘abate torinese 18 .<br />
Sia gli scritti del Frassinetti che quelli giobertiani devono essere considerati fonti <strong>di</strong><br />
parte. La possibilità <strong>di</strong> un‘ulteriore verifica su documenti ecclesiali mi è stata preclusa dalle<br />
attuali con<strong>di</strong>zioni dell‘Archivio Diocesano <strong>di</strong> Genova, in fase <strong>di</strong> ristrutturazione. Tale Archivio<br />
potrebbe contenere materiale molto prezioso ai fini <strong>di</strong> una ricostruzione documentata <strong>degli</strong><br />
avvenimenti qui trattati.<br />
È stata mia preoccupazione piú che giu<strong>di</strong>care i fenomeni esaminati, cercare <strong>di</strong><br />
descriverli; ed è tuttavia corretto riconoscere che sono stato incline a dare maggiore cre<strong>di</strong>bilità<br />
ed attenzione alla esposizione frassinettiana delle vicende, curandomi però <strong>di</strong> registrare anche le<br />
valutazioni contrarie 19 .<br />
Era comunque mio desiderio ricostruire in termini il piú possibile organici, sereni e<br />
documentati una pagina controversa e <strong>di</strong>menticata della cultura religiosa del Risorgimento<br />
italiano, e spero pertanto <strong>di</strong> non essermi allontanato troppo dall‘obbiettivo prefissatomi.<br />
Archivio Frassinettiano, del 1967 e del 1969, <strong>di</strong>ffusi dal Centro Vocazionale ―G. Frassinetti‖, Roma, via<br />
del Mascherone 55, sono reperibili al medesimo in<strong>di</strong>rizzo.<br />
16<br />
G. FRASSINETTI, Riflessioni proposte agli ecclesiastici, Genova 1837 Tip.Ferrando, ID., Saggio intorno<br />
alla <strong>di</strong>alettica ed alla religione <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti, Genova 1846, Tip.Faziola.<br />
17<br />
G. BONAVINO, I Gesuiti. Risposte al M .R .D. Frassinetto per G. B. Anonimo Genova 1846; ID.,<br />
Autentiche prove contro i Gesuiti e i loro affiliati e il celebre <strong>di</strong>alettico M. R. Frassinetto per B. C. in<br />
risposta a C. Anonimo, Italia 1846.<br />
18<br />
Ulteriori approfon<strong>di</strong>menti bibliografici e storiografici si trovano all‘interno del capitolo II: Vincenzo<br />
Gioberti e la polemica sul gesuitismo.<br />
19<br />
Del Frassinetti ho potuto anche prendere in visione i manoscritti originali conservati nell‘Archivio della<br />
Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, in via del Mascherone 55 a Roma.<br />
11
1. ANTEFATTI<br />
CAPITOLO PRIMO<br />
LA CONGREGAZIONE DEL BEATO LEONARDO DALLA<br />
FONDAZIONE AI PRODROMI DELL’ANTIGESUITISMO<br />
GIOBERTIANO (1831 – 1846)<br />
L‘idea <strong>di</strong> una particolare cura dei giovani aspiranti alla vita sacerdotale non era nuova in<br />
Genova.<br />
Il Colletti 20 ricorda, a questo proposito, le iniziative prese dal card. Luigi Lambruschini 21<br />
il quale, quando era ancora a Roma, si era occupato del problema, ed aveva scritto per il<br />
vescovo <strong>di</strong> Macerata un “Piano <strong>di</strong> educazione per i giovani, che sono prossimi ad accostarsi al<br />
sacerdozio” 22 .<br />
In esso si consigliava <strong>di</strong> formare una Congregazione, con proprio locale, per i giovani<br />
prossimi al sacerdozio; due ―pii e dotti‖ sacerdoti dovrebbero adunarli due ore la mattina per<br />
curarne la formazione spirituale, e due ore la sera per un‘istruzione dogmatica, il tutto per la<br />
durata <strong>di</strong> sei mesi. La proficua partecipazione al corso doveva essere con<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>spensabile<br />
per l‘ammissione agli or<strong>di</strong>ni sacri.<br />
Il Lambruschini, <strong>di</strong>venuto nel 1819 arcivescovo <strong>di</strong> Genova, ritenne opportuno tradurre<br />
in atto le sue proposte ed incaricò il Rev. G. B. De Albertis <strong>di</strong> stendere il regolamento e <strong>di</strong><br />
guidare l‘erigenda Congregazione, per la cui attività destinava l‘oratorio <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
Angelorum. Pare che il De Albertis, per non creare un doppione con la Congregazione <strong>degli</strong><br />
Operai evangelici, fondata dall‘abate Paolo Gerolamo Franzoni 23 , abbia esteso a tutti i chierici<br />
prossimi al sacerdozio, i corsi <strong>di</strong> S. Scrittura, Dogmatica, Morale, Storia ecclesiastica, Diritto<br />
Canonico, Eloquenza e <strong>di</strong> Spirito, che un tempo tale Congregazione organizzava e che poi erano<br />
caduti in <strong>di</strong>suso. Il progetto <strong>di</strong> De Albertis, presentato il 15 aprile 1820, fu approvato dal Card.<br />
Lambruschini il 28 agosto dello stesso anno.<br />
La successiva partenza del Car<strong>di</strong>nale come Nunzio apostolico a Parigi rese poco<br />
efficace il provve<strong>di</strong>mento adottato.<br />
Esistevano dunque già in Genova dei sodalizi o associazioni per ecclesiastici, che da<br />
tempo operavano nella Chiesa Cattolica genovese e godevano <strong>di</strong> buon prestigio.<br />
La Congregazione <strong>degli</strong> Operai evangelici o ―Franzoniani‖ era stata fondata nel 1751<br />
dal sacerdote Paolo Gerolamo Franzoni, <strong>di</strong> famiglia nobile, uomo <strong>di</strong> vasta cultura. Aprí, nei vari<br />
―sestieri‖ della città, <strong>degli</strong> Oratori, ciascuno per una <strong>di</strong>versa categoria <strong>di</strong> persone, per favorire<br />
l‘istruzione catechistica e la partecipazione ai Sacramenti della Chiesa. Lo scopo <strong>degli</strong> Operai<br />
Evangelici era principalmente quello <strong>di</strong> provvedere al funzionamento ed alla crescita <strong>di</strong> questi<br />
Oratori. In seno alla Congregazione il fondatore istituí Accademie o Scuole <strong>di</strong> scienze sacre.<br />
Piú antica era la Congregazione dei Missionari urbani sorta nel 1643 per opera <strong>di</strong><br />
numerosi sacerdoti <strong>di</strong>ocesani, sotto gli auspici del Card. Stefano Durazzo. Scopo <strong>di</strong> questa<br />
istituzione era la pre<strong>di</strong>cazione delle Missioni dentro la cerchia della città; i congregati si erano<br />
scelti come patrono San Carlo Borromeo.<br />
In qualche modo parallela a questa era la Congregazione dei Missionari Rurali, sorta nel<br />
1713 per le Missioni nelle campagne per opera <strong>di</strong> altri ecclesiastici 24 .<br />
20<br />
Arturo Colletti è un ecclesiastico genovese, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo antimodernista, che ha <strong>stu<strong>di</strong></strong>ato alcuni aspetti<br />
della storia della Chiesa <strong>di</strong> Genova nel sec. XIX. Ha lasciato, tra l‘altro, dei Manoscritti, conservati nella<br />
Biblioteca del Seminario Arcivescovile <strong>di</strong> Genova. Al Capo X La Congregazione del Beato Leonardo da<br />
Porto Maurizio alle pp.1-6 si parla <strong>di</strong> tali iniziative del Card. Lambruschini.<br />
21<br />
Cfr. M. MENGHINI, Luigi Lambruschini, in Enciclope<strong>di</strong>a Italiana, vol. XX, Roma 1933, 414.<br />
22<br />
Lo scritto si trova tra i Manoscritti <strong>di</strong>versi, LUIGI LAMBRUSCHINI, vol. I, Archivio dei P. Barnabiti,<br />
Collegio Vittorino da Feltre, Genova.<br />
23<br />
Cfr. A. SERRA, L‟abate P. C. Franzoni e le opere religiose e culturali da lui fondate, Genova 1937.<br />
24<br />
Tutt‘e tre queste Congregazioni erano attive nel tempo <strong>di</strong> cui ci occupiamo. La Congregazione <strong>degli</strong><br />
Operai Evangelici collaborava con le altre due e da esse attingeva i suoi elementi.<br />
12
Il Frassinetti si iscrisse ai missionari Urbani e collaborò poi con gli Operai Evangelici 25<br />
dei quali fece parte anche lo Sturla, in qualità <strong>di</strong> chierico.<br />
Questa esperienza riteniamo sia stata preziosa per formare nei due giovani la<br />
consapevolezza del valore <strong>di</strong> una collaborazione tra gli ecclesiastici.<br />
Tuttavia i problemi del presente richiedevano ai loro occhi delle nuove proposte<br />
organizzative. Per quanto riguarda gli aspiranti al sacerdozio, è utile tener presente che un‘alta<br />
percentuale non viveva in Seminario, ma nella propria famiglia, oppure ―a pensione‖ in qualche<br />
casa privata. Molti, perciò, avevano solo una preparazione scolastica, mancando <strong>di</strong> una piú<br />
specifica formazione spirituale al ministero.<br />
Secondo il Frassinetti, però, anche nel Seminario la <strong>di</strong>sciplina era scaduta e vi era<br />
<strong>di</strong>ssipazione: «Per la qual cosa generalmente i chierici crescevano poco colti nello spirito<br />
ecclesiastico, e moltissimi cominciavano a comprendere che cosa fosse lo stato ecclesiastico, e<br />
le <strong>di</strong>sposizioni che si richiedono per abbracciarlo, quando si ritiravano per gli Esercizi spirituali<br />
in preparazione al Sud<strong>di</strong>aconato» 26 .<br />
Il tentativo <strong>di</strong> istituire una Congregazione per la formazione dei chierici era stato fatto<br />
decenni prima anche da un gesuita: il Luigi Mozzi, il quale aveva radunato nella chiesa <strong>di</strong> S.<br />
Ambrogio un buon numero <strong>di</strong> giovani, e li formava con la pre<strong>di</strong>cazione e la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> libri.<br />
Pare sia stato un giovane sacerdote che aveva fatto parte della Congregazione del<br />
Mozzi, Luigi Botto, a suggerire a Luigi Sturla l‘idea <strong>di</strong> organizzare qualcosa <strong>di</strong> simile 27 .<br />
Luigi Sturla 28 , nato a Genova nel 1805, ebbe un‘accurata educazione cattolica, e <strong>stu<strong>di</strong></strong>ò<br />
come ―esterno‖ in Seminario, dove terminò gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> Retorica sotto la guida del prof. Antonio<br />
M. Gianelli 29 . Come ―chierico‖ fu ammesso all‘istituzione <strong>degli</strong> Operai Evangelici, e gli fu<br />
assegnato il compito <strong>di</strong> fare l‘istruzione catechistica nell‘oratorio festivo <strong>di</strong> Pre. Qui affluivano i<br />
fanciulli del sestiere popolare <strong>di</strong> S. Teodoro.<br />
Lo Sturla curava non solo la loro educazione cristiana, ma animava i loro giochi<br />
portandoli sulla collina <strong>di</strong> S. Benigno sia al mattino che al pomeriggio delle domeniche.<br />
A partire dai primi mesi del 1829 la sua attività con i fanciulli si <strong>di</strong>latò notevolmente.<br />
Durante la Quaresima <strong>di</strong> quell‘anno infatti, era venuto per pre<strong>di</strong>care in Genova don Luca dei<br />
conti Passi, nobile sacerdote bergamasco, che aveva fondato, per la cura e l‘istituzione<br />
catechistica delle bambine, la Pia Opera <strong>di</strong> S. Dorotea, ed un‘analoga associazione per i bambini<br />
intitolata a S. Raffaele.<br />
Desideroso <strong>di</strong> impiantare le due Pie Opere anche in Genova, come già in molte città<br />
d‘Italia, si consigliò con l‘abate Agostino De Mari, presidente <strong>degli</strong> Operai Evangelici, che gli<br />
in<strong>di</strong>cò il chierico Sturla come il piú in<strong>di</strong>cato a sostenerlo nell‘impresa.<br />
Durante la Quaresima e nei due mesi successivi il Passi e lo Sturla girarono per quasi<br />
tutte le parrocchie <strong>di</strong> Genova e <strong>di</strong>ntorni, riuscendo ad impiantare le Pie Opere <strong>di</strong> S. Raffaele e <strong>di</strong><br />
S. Dorotea in molte <strong>di</strong> esse. Alla partenza del Passi l‘iniziativa poteva <strong>di</strong>rsi ben avviata, ma il<br />
25 Giuseppe Frassinetti fu iscritto ―coa<strong>di</strong>utore‖ dei Missionari Urbani nel 1828 e promosso ―Operaio‖ il<br />
29 gennaio 1829. Poco dopo <strong>di</strong>ede il suo nome anche alla Congregazione <strong>degli</strong> operai Evangelici. In<br />
quello stesso anno Luigi Sturla era iscritto alla medesima Congregazione in qualità <strong>di</strong> ―chierico‖.<br />
26 G. FRASSINETTI, Notizia della Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. Regina<br />
<strong>degli</strong> Apostoli, dei ss. Apostoli e del Beato Leonardo da Porto Maurizio, in Opera Omnia, vol. XIII,<br />
Roma 1912 Tip. Poliglotta Vaticana, 521.<br />
27 La notizia è riferita dal FRASSINETTI in Notizia, op. cit., 523. Luigi Botto fu a lungo membro della<br />
Congregazione del Beato Leonardo, ed anche parroco dell‘Albergo dei poveri.<br />
28 Le principali notizie biografiche sulla vita <strong>di</strong> Luigi Sturla si ricavano da G. FRASSINETTI, Memorie<br />
intorno alla vita del Sac. Luigi Sturla, I ed. Genova 1871, 95; II ed. Genova 1905 Tip.della Gioventú, a<br />
cura del Prof. A. Monti, con lettere ine<strong>di</strong>te. Ulteriori notizie si trovano in: TEODOSIO DA VOLTRI OFM<br />
CAPP., Un prete rinnovatore, ritratto <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, Genova 1868, soprattutto alle pagine 23-32,<br />
46-49, 67-68, 93-114; G.B. TRAGHELLA, Un “Gesuitante” missionario <strong>di</strong> occasione, in Stu<strong>di</strong>a<br />
missionalia, vol. VII, 1952, 353. Tutte le biografie del Frassinetti contengono cenni fondamentali sulla<br />
vita <strong>di</strong> Sturla. Si veda anche G.B. TRAGHELLA, Luigi Sturla, in Enciclope<strong>di</strong>a Cattolica vol. XI, Città del<br />
Vaticano 1953, 1449.<br />
29 Antonio <strong>Maria</strong> Giannelli 1789 – 1846, santo.<br />
13
compito <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigerla e svilupparla ricadeva nelle mani dello Sturla. Egli affrontò il compito con<br />
molto impegno, mettendo a frutto le sue buone capacità <strong>di</strong> organizzatore. Era lui inoltre a<br />
cercare i collaboratori tra i ―chierici‖ e i sacerdoti per le Pie Opere, ed a ripartirli nelle varie<br />
parrocchie secondo i bisogni. Fu nel vivo <strong>di</strong> questa attività che maturò in lui l‘idea <strong>di</strong> una<br />
Congregazione per i giovani ecclesiastici che consentisse una comune formazione spirituale ed<br />
un migliore coor<strong>di</strong>namento operativo tra gli ecclesiastici collaboratori delle Pie Opere <strong>di</strong> S.<br />
Raffaele e S. Dorotea.<br />
Comunicò l‘idea, ancora informe, ad alcuni <strong>di</strong> essi e, ricevutone un pieno<br />
incoraggiamento, convocò gli interessati a casa sua.<br />
2. FONDAZIONE<br />
La prima riunione dell‘erigenda Congregazione avvenne nei primi mesi del 1831 30 . Ne<br />
prendevano parte, oltre al padrone <strong>di</strong> casa Luigi Sturla, i novelli sacerdoti Luigi Botto, Pietro<br />
Boccalandro, Nicolò Richeri, Giuseppe Frassinetti ed una mezza dozzina <strong>di</strong> chierici.<br />
Al termine dell‘incontro si decise - su proposta del Frassinetti - <strong>di</strong> ritrovarsi il giovedí<br />
successivo. Ciascuno avrebbe portato per iscritto le idee e le proposte che riteneva piú<br />
importanti per la buona riuscita dell‘iniziativa. Cosí si fece, e il Frassinetti, che ci pensava da<br />
tempo, portò una bozza <strong>di</strong> ―regolamento‖ che fu approvato con qualche mo<strong>di</strong>fica.<br />
Si supponeva una certa <strong>di</strong>ffidenza verso una nuova organizzazione e perciò si preferí<br />
evitare il titolo <strong>di</strong> ―Congregazione‖. La si chiamò ―Conferenza <strong>di</strong> ecclesiastici collaboratori<br />
nella Pia Opera <strong>di</strong> S. Raffaele e S. Dorotea‖ 31 . Come si può notare, la nuova organizzazione<br />
appariva in questo primo titolo, come interamente ―interna‖ alle Pie opere <strong>di</strong> S. Raffaele e S.<br />
Dorotea; il rapporto concreto con questa istituzione già esistente, se aveva facilitato l‘aggregarsi<br />
dei promotori, rischiava <strong>di</strong> rinchiuderli in una prospettiva un po‘ angusta; questo almeno agli<br />
occhi del Frassinetti, che mirava ad interessare tutto il giovane clero; egli perciò si adoperò<br />
all‘interno dell‘associazione per ampliarne gli orizzonti culturali ed il campo d'intervento.<br />
Giuseppe Frassinetti 32 era nato a Genova il 15 <strong>di</strong>cembre 1804, da Giovanni Battista ed<br />
Angela Viale, modesti commercianti. Ebbe una sorella minore, Paola, poi fondatrice delle Suore<br />
30 Cfr. G. FRASSINETTI, in Notizia, op. cit., 525.<br />
31 Ibid., 526: «È da notare che molte <strong>di</strong>scussioni si sono fatte per assegnare un titolo alla novella<br />
Congregazione; giacché, sebbene quei primi fossero tutti giovani, e privi <strong>di</strong> esperienza, non<strong>di</strong>meno già<br />
immaginavano che una novità avrebbe eccitato molte <strong>di</strong>cerie, e che, per questa sola ragione che si volesse<br />
formare una nuova Congregazione, molti si sarebbero allarmati; non immaginavano però che tanti fossero<br />
al mondo i quali si credono quasi in dovere <strong>di</strong> gridare contro tutte le cose nuove, senza credersi obbligati<br />
prima ad osservare se e se siano buone o cattive... Tuttavia, <strong>stu<strong>di</strong></strong>arono il modo <strong>di</strong> dare alla nuova unione<br />
il titolo piú modesto e semplice che fosse possibile, e convennero d‘intitolarla: ―Conferenza <strong>di</strong><br />
ecclesiastici collaboratori nella Pia Opera <strong>di</strong> S. Raffaele e S. Dorotea‖. La nominarono ―Conferenza‖<br />
per evitare quello <strong>di</strong> ―Congregazione‖, che esprime piú chiara l‘idea <strong>di</strong> corpo; ―<strong>di</strong> ecclesiastici<br />
collaboratori etc‖., per lasciare che ognuno potesse aspirare a farne parte, come ciascuno può lavorare in<br />
quella Pia Opera. Compariva per tal maniera una semplice conferenza, <strong>di</strong>retta soltanto a promuoverla. È<br />
da notare che l‘Opera suddetta da molti era tenuta in nessun conto, anzi <strong>di</strong>sapprovata come cosa inutile e<br />
portata in Genova da un forestiero bergamasco».<br />
32 Fra le principali biografie ricor<strong>di</strong>amo: D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vita del sac.<br />
Giuseppe Frassinetti. Priore a S. Sabina in Genova, Tip.della Gioventú, Genova 1879; C. OLIVARI, Della<br />
vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio sac. Giuseppe Frassinetti, Priore a S. Sabina in Genova, fondatore dei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Tip.Poliglotta Vaticana, Roma 1928; E. F. FALDI, Il Priore <strong>di</strong> S. Sabina, il<br />
Servo <strong>di</strong> Dio Don Giuseppe Frassinetti, Scuola Grafica don Bosco, Genova Sampierdarena 1967; T. DA<br />
VOLTRI, Un Prete Rinnovatore, ritratto <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, Tipo-Litografia Opera ss. Vergine <strong>di</strong><br />
Pompei, Genova 1969; V. VAILATI, Un maestro <strong>di</strong> vita sacerdotale, il Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti,<br />
Postulazione generale, Roma 1967; A. COLLETTI, Il sacerdote Giuseppe Frassinetti, Priore <strong>di</strong> S. Sabina<br />
in Genova, Archivio Seminario Arcivescovile, ms. ine<strong>di</strong>to; G. CAPURRO, Giuseppe Frassinetti e l‟opera<br />
sua - Stu<strong>di</strong>o storico-critico con un catalogo generale delle opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te dello stesso Frassinetti,<br />
Tip. della Gioventú, Genova 1908. Altri <strong>stu<strong>di</strong></strong> e articoli illustrativi della vita e delle opere <strong>di</strong> G. Frassinetti<br />
14
Dorotee e successivamente canonizzata dalla Chiesa Cattolica, e tre fratelli che abbracciarono<br />
poi lo stato ecclesiastico. Stu<strong>di</strong>ò in Seminario come esterno, e vi completò gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> filosofici e<br />
teologici. Fu or<strong>di</strong>nato Diacono il 5 giugno 1827 e nello stesso anno <strong>di</strong>venne Presbitero il 22<br />
settembre. Si iscrisse alla Congregazione dei Missionari Urbani e successivamente agli Operai<br />
evangelici. Aveva 27 anni al sorgere della Congregazione <strong>di</strong> cui parliamo, e sul finire del 1831<br />
fu nominato parroco a Quinto al mare, paese <strong>di</strong> pescatori a pochi chilometri da Genova.<br />
Le prime riunioni della ―conferenza‖ si tennero in casa dello Sturla; frattanto il numero<br />
dei partecipanti cresceva e lo Sturla ottenne dal Rev. abate De Mari, preside <strong>degli</strong> Operai<br />
Evangelici, <strong>di</strong> poter fare la riunione mensile nella chiesa <strong>di</strong> S. Marta. Il carattere semi-pubblico<br />
dell‘iniziativa imponeva un‘approvazione ecclesiastica; si presentò l‘associazione al Vicario<br />
Generale, Can. Lorenzo Biale, che la incoraggiò e <strong>di</strong>ede approvazione ad experimentum per un<br />
anno, con lettera del 2 luglio 1831.<br />
Ma quali erano le caratteristiche dell'Associazione, secondo tale regolamento? «Lo<br />
scopo <strong>di</strong> questa Conferenza è doppio: l‘aumento cioè <strong>di</strong> spirito <strong>di</strong> pietà nei membri che la<br />
compongono ed il ravve<strong>di</strong>mento dei giovani, i quali per mancanza <strong>di</strong> educazione o per propria<br />
malizia, vivendo lontani dai Sacramenti e dalla istruzione cristiana, minacciano <strong>di</strong> riuscire<br />
male» 33 .<br />
L'elemento centrale (per appartenere all'organizzazione) era l‘adempimento del ―metodo<br />
<strong>di</strong> vita‖. Esso consisteva in mezz‘ora <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tazione giornaliera per i sacerdoti (un quarto d‘ora<br />
per i ―chierici‖), in un quarto d‘ora <strong>di</strong> lettura spirituale (per i ―chierici‖ due mezze ore la<br />
settimana o solo mezz‘ora per i ―chierici‖ alle scuole inferiori), nella partecipazione quoti<strong>di</strong>ana<br />
alla S. Messa, nella confessione frequente (quin<strong>di</strong>cinale per i ―chierici‖, settimanale per i<br />
sacerdoti) ed in alcune altre pratiche <strong>di</strong> devozione.<br />
Sul piano organizzativo era prevista una riunione generale una volta al mese (poi<br />
<strong>di</strong>venne quin<strong>di</strong>cinale). In essa ciascuno doveva presentare al Superiore, o a chi per esso,<br />
l‘attestato <strong>di</strong> aver osservato il ―metodo <strong>di</strong> vita‖, notando anche le proprie mancanze. Era<br />
impegno <strong>degli</strong> assenti mandare per iscritto questo attestato anche attraverso terzi, giacché<br />
secondo il capitolo III, art. 3 ―il non dare questo attestato sarà lo stesso che <strong>di</strong>chiararsi separato<br />
ipso facto dalla Conferenza‖.<br />
Dopo questa ―verifica‖ la riunione generale proseguiva con la lettura <strong>di</strong> qualche libro <strong>di</strong><br />
vita spirituale da parte del Superiore; ad ogni paragrafo ci si fermava ed era possibile a chiunque<br />
dei presenti fare brevi riflessioni sull‘argomento trattato. Questa lettura durava circa mezz‘ora.<br />
L‘ultima parte dell‘incontro era de<strong>di</strong>cata ai problemi organizzativi delle Pie Opere <strong>di</strong> S. Raffaele<br />
e S. Dorotea, ed il Superiore aveva il compito <strong>di</strong> provvedere alla <strong>di</strong>stribuzione <strong>degli</strong> incarichi<br />
(capitolo I, art. 4). Dai partecipanti si chiedeva una sorta <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza al Superiore, ―quando la<br />
necessità o la debita convenienza non ne impe<strong>di</strong>scano l‘esecuzione‖ (capitolo III, art. 8).<br />
Il Superiore aveva il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> correggere in privato gli inadempienti e <strong>di</strong> <strong>di</strong>rimere le<br />
eventuali controversie nelle <strong>di</strong>scussioni. I partecipanti erano inoltre invitati ad esercitare la<br />
correzione fraterna, con franchezza, ma senza mancare <strong>di</strong> carità (capitolo III, art. 4.5). Era<br />
proibito parlare male <strong>degli</strong> assenti, ―qualora però sarà necessario manifestarne per ovviare a<br />
qualche inconveniente pregiu<strong>di</strong>ziale della Pia opera, si parlerà al Superiore da solo a solo‖<br />
(capitolo III, art. 7).<br />
Per quanto riguarda il rapporto con i ragazzi, si invitavano gli aderenti ad informarsi<br />
sulla loro pratica religiosa e ad esortarli con pazienza e perseveranza a frequentare le istruzioni<br />
catechistiche ed i sacramenti, conformemente alla possibilità del luogo e della persona.<br />
3. SVILUPPO<br />
Si propose all‘abate De Mari <strong>di</strong> fare il Superiore della nuova associazione, ed egli<br />
accettò designando a suo vice il Rev. Matteo Caprile. La scelta del De Mari, preside <strong>degli</strong><br />
si trovano in G. RENZI, Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche, Catalogo bibliografico generale<br />
delle Opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te del Servo <strong>di</strong> Dio, Postulazione Generale, Roma 1979, 66-68.<br />
33 Il regolamento presentato al Vicario Generale è stato stampato come Documento I in appen<strong>di</strong>ce a: G<br />
FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 565-570. Seguono le firme dei primi congregati, fino al giugno 1831.<br />
15
Operai Evangelici, Congregazione già affermata, voleva - a nostro avviso - rassicurare sulla<br />
serietà della nuova associazione, suggerendo una continuità con altre istituzioni già apprezzate,<br />
ed un riferimento ideale all‘opera culturale dell‘abate Paolo Gerolamo Franzoni.<br />
Il De Mari (Genova, 24-X-1794 + ivi 14-XII-1840) patrizio genovese, nominato da<br />
Carlo Alberto suo elemosiniere in Genova nel luglio del 1831, rimase Superiore della nuova<br />
organizzazione fino alla sua elezione a Vescovo <strong>di</strong> Savona (fu consacrato il 13–V-1833).<br />
«Terminato l‘anno <strong>di</strong> prova si domandò nuovamente l‘approvazione al Superiore ecclesiastico,<br />
che allora era Sua Eccellenza Mons. Ta<strong>di</strong>ni, che la <strong>di</strong>ede a voce soltanto, finché si ebbe in<br />
iscritto nel 1834» 34 . In questo primo periodo venne effettuata una mutazione nel nome<br />
dell‘associazione, che fu definita ―Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong><br />
ss. ma Regina <strong>degli</strong> Apostoli, e dei Santi Apostoli‖. Secondo il Frassinetti «la mutazione si è<br />
fatta perché meglio fosse espresso lo scopo della Congregazione e potesse abbracciare anche gli<br />
ecclesiastici non collaboratori nell‘opera <strong>di</strong> S. Raffaele e S. Dorotea» 35 .<br />
Lo stesso Frassinetti ricorda che lui e lo Sturla consultarono per l‘occasione il P.<br />
Antonio Bresciani, della Compagnia <strong>di</strong> Gesú, allora rettore in S. Ambrogio 36 . Il gesuita<br />
incoraggiò la variazione del nome, che estendeva l‘organizzazione ad uno scopo piú vasto della<br />
semplice collaborazione con la pia opera.<br />
Da allora fino alla sua partenza da Genova (ottobre 1834), il Bresciani fu consultato su<br />
tutti i problemi <strong>di</strong> maggior rilievo. Occorre infatti tener presente che lo Sturla ed il Frassinetti, e<br />
poi il Rev. Giovan Battista Cattaneo e qualche altro, si vedevano spesso per parlare della<br />
Congregazione, ed avevano formato un ―drappello scelto‖ - cosí lo chiamavano -<br />
particolarmente impegnato per lo sviluppo della Congregazione.<br />
Essi si proposero un ―metodo <strong>di</strong> vita‖ speciale, raddoppiando il tempo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tazione<br />
quoti<strong>di</strong>ana, facendo un‘offerta mensile (per la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> ―buoni libri‖ e per l‘aiuto reciproco)<br />
e speciali atti <strong>di</strong> mortificazione, nonché partecipando agli esercizi spirituali <strong>di</strong> S. Ignazio <strong>di</strong><br />
Loyola ogni anno.<br />
Se si tiene presente che lo Sturla fu il promotore dell‘organizzazione ed il piú attivo<br />
propagan<strong>di</strong>sta, e che il Frassinetti il piú lucido e fecondo elaboratore teorico, non è <strong>di</strong>fficile<br />
comprendere che il centro propulsivo della Congregazione era questo nucleo, che prese poi il<br />
nome <strong>di</strong> ―Consulta‖.<br />
La ―Consulta‖ non ebbe sul principio un‘esistenza legalizzata, e tuttavia si <strong>di</strong>ede una sua<br />
organizzazione, eleggendosi un superiore, che fu per un primo periodo Giuseppe Frassinetti. Gli<br />
altri si impegnavano ad una speciale obbe<strong>di</strong>enza a questo superiore della Consulta, che però<br />
aveva tre correttori, con il potere <strong>di</strong> invalidarne (―irretirne‖) gli or<strong>di</strong>ni.<br />
Dopo l‘elezione del De Mari a Vescovo <strong>di</strong> Savona, <strong>di</strong>venne Superiore della<br />
Congregazione Raffaele Biale, allora canonico della Collegiata <strong>di</strong> N. S. delle Vigne 37 .<br />
Si deve a lui, se al già lungo titolo (Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong><br />
<strong>Maria</strong> SS .ma Regina <strong>degli</strong> Apostoli e dei Santi apostoli) si aggiunse anche ―e del Beato<br />
Leonardo da Porto Maurizio‖, aggiunta che finí poi per sostituire il resto, cosí che per la brevità<br />
la si nominava generalmente ―Congregazione del Beato Leonardo‖ 38 .<br />
Nella seconda metà del 1833 le conferenze si trasferirono dalla chiesa <strong>di</strong> S. Marta<br />
all‘Oratorio detto ―dei Fattorini‖, messo a <strong>di</strong>sposizione dai RR. PP. Gesuiti, e qui si tennero fino<br />
34<br />
Cfr. G FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 528.<br />
35<br />
Ibid.<br />
36<br />
Cfr. E. BELLORINI, Antonio Bresciani Borsa, in Enciclope<strong>di</strong>a Italiana, Roma 1930, 815. Per la<br />
informazione sulle consultazioni cfr. G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 532.<br />
37<br />
Frassinetti scrive che «esercitò la carica con molto zelo per circa due anni». Cfr. G. FRASSINETTI,<br />
Notizia, op. cit., 527.<br />
38<br />
Tale titolo, <strong>di</strong> cui ci serviamo anche noi, era comunemente usato dai sostenitori della Congregazione.<br />
L‘appellativo <strong>di</strong> ―Sturlisti‖ venne usato prevalentemente dagli avversari, ed ebbe una sfumatura <strong>di</strong><br />
carattere spregiativo. Analogo, ma molto piú raro, l‘appellativo <strong>di</strong> ―Frassinettisti‖. Cfr. G. FRASSINETTI,<br />
Memorie del sac. Luigi Sturla, op. cit., 37.<br />
16
alla fine 39 . Di notevole importanza fu l‘istituzione <strong>di</strong> una Accademia <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> ecclesiastici nel<br />
1834. Fu il Frassinetti a proporla, anzi in qualche modo ad imporla in qualità <strong>di</strong> superiore della<br />
―Consulta‖ segreta 40 .<br />
«Il fine <strong>di</strong> questi <strong>stu<strong>di</strong></strong> è che i giovani sacerdoti, ed i chierici, s‘uniscano nel provvedersi<br />
<strong>di</strong> quei sani principi che sono come le basi sopra le quali dovranno fondare i loro <strong>stu<strong>di</strong></strong> quando<br />
vi si daranno da loro stessi ex professo» 41 .<br />
L‘Accademia si componeva <strong>di</strong> sei <strong>di</strong>scipline: Ascetica (―<strong>di</strong> spirito‖), Sacra Scrittura,<br />
Dogmatica, Morale, Storia Ecclesiastica, Eloquenza Sacra. Ogni giorno era de<strong>di</strong>cato ad una<br />
<strong>di</strong>versa materia, una per ciascun giorno della settimana, il sabato era libero; le lezioni duravano<br />
un‘ora. Ciascuna <strong>di</strong>sciplina aveva un Direttore, scelto dal Superiore con il consenso<br />
dell‘Arcivescovo.<br />
Nell‘elenco dei nomi dei Direttori che presiedettero nei quattor<strong>di</strong>ci anni <strong>di</strong> attività<br />
dell‘Accademia, si possono rintracciare alcuni <strong>degli</strong> ecclesiastici piú ragguardevoli della città,<br />
quali Gaetano Alimonda, Salvatore Magnasco e Domenico Gualco 42 .<br />
I principi su cui si basavano gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> sono <strong>di</strong> grande importanza, anche per comprendere<br />
la successiva evoluzione della Congregazione 43 . Per quanto riguarda l‘Ascetica, considerata<br />
basilare, il Direttore aveva la facoltà <strong>di</strong> scegliere per la lettura uno tra i libri spirituali piú sicuri.<br />
Dopo la lettura e le riflessioni adatte, si sarebbe inoltre svolto l‘attestato del ―metodo <strong>di</strong> vita‖,<br />
con conseguente correzione fraterna.<br />
Nella Sacra Scrittura si sarebbe usata la volgata (<strong>di</strong> S. Gerolamo) salvo il caso <strong>di</strong> un<br />
ricorso ai testi originali per appianare qualche <strong>di</strong>fficoltà. «Inevitabilmente si dovranno seguire le<br />
39<br />
Sebbene la nuova sede per la riunione quin<strong>di</strong>cinale si raccomandasse per la maggior centralità del<br />
luogo, riteniamo che essa segnali anche un progressivo avvicinamento della Congregazione alla<br />
Compagnia <strong>di</strong> Gesú.<br />
40<br />
Cfr. G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 534.<br />
41<br />
Regolamento per l‘Accademia del Beato Leonardo, Capitolo I, art. I; in appen<strong>di</strong>ce a G. FRASSINETTI,<br />
Notizia, ocít., 605 ss.<br />
42<br />
Ecco l‘elenco completo dei <strong>di</strong>rettori delle <strong>di</strong>scipline dell‘Accademia nei circa 13 anni della sua attività,<br />
quali sono in<strong>di</strong>cati in C. OLIVARI FSMI, Della vita e delle opere del servo <strong>di</strong> Dio sac. Giuseppe Frassinetti,<br />
op. cit., 66:<br />
<strong>di</strong> Spirito:<br />
Rev.mo Can. G.B. Cattaneo;<br />
Priore Vittorio Storace;<br />
Priore Giuseppe Frassinetti.<br />
<strong>di</strong> S. Scrittura:<br />
Rev. G.B. Cattaneo;<br />
Prof. G. Oliva;<br />
Rev. Gaetano Alimonda;<br />
Rev. Tommaso Reggio.<br />
<strong>di</strong> Dogmatica:<br />
Can. Salvatore Magnasco;<br />
Can. Stefano Morchio.<br />
<strong>di</strong> Morale:<br />
Rev.mo abate Filippo Gentile;<br />
Rev.mo Domenico Gualco.<br />
<strong>di</strong> Storia ecclesiastica:<br />
Can. Nicolò Barabino;<br />
Priore Giuseppe Frassinetti;<br />
Rev. Filippo Storace;<br />
Rev. Gaetano Quartino.<br />
<strong>di</strong> Eloquenza sacra:<br />
Rev. Filippo Poggi;<br />
Rev. Antonio Campanella.<br />
43<br />
Furono composti dal Frassinetti, e successivamente approvati dall‘Arcivescovo Mons. Ta<strong>di</strong>ni il 4<br />
<strong>di</strong>cembre 1837. Formano il nucleo dell‘elaborazione successiva <strong>di</strong> Frassinetti, che si può leggere nello<br />
scritto: Osservazione sopra gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> ecclesiastici, Genova 1839 Tip.Pellas, 112, ora in Opera Omnia,<br />
Tip.Poliglotta Vaticana, Roma 1912, vol. XIII.<br />
17
spiegazioni ed interpretazioni dei santi Padri, tanto nel senso letterale quanto nel senso<br />
spirituale» 44 , essendo questo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o molto vasto si consiglia <strong>di</strong> toccare solo gli argomenti piú<br />
importanti e fruttuosi; trattando anche del senso spirituale dei passi prescelti. Non si userà un<br />
manuale e si in<strong>di</strong>cheranno espressamente i testi considerati pericolosi.<br />
Nella Dogmatica si sottolineerà l‘esistenza e la verità della Rivelazione. Si farà chiara<br />
<strong>di</strong>stinzione tra «le verità definite che formano dogma irrefragabile, da quelle che non sono<br />
ancora tali» 45 . Si daranno però per certe le tesi che hanno l‘appoggio della Chiesa Romana e<br />
quelle che le attribuiscono i <strong>di</strong>ritti che esercita 46 . Si tratteranno velocemente le eresie ormai<br />
superate e si parlerà piú a lungo <strong>degli</strong> errori persistenti. A questo proposito ha un chiaro sapore<br />
antigiansenistico l‘articolo XIX: «Si vigilerà grandemente affinché alle bolle dogmatiche, e<br />
specialmente alle due Unigenitus e Auctorem Fidei, attribuiscasi uguale autorità, quanta ai<br />
decreti <strong>di</strong> fede dei Concili generali, considerando come vero eretico chiunque contumacemente<br />
resistesse alle loro definizioni <strong>di</strong> fede» 47 . Non ci si impegnerà invece per nessuno dei partiti,<br />
nelle questioni <strong>di</strong> scuola ancora <strong>di</strong>battute liberamente 48 .<br />
Nello <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della Morale veniva in<strong>di</strong>cato come punto <strong>di</strong> riferimento il sistema <strong>di</strong> S.<br />
Alfonso <strong>Maria</strong> de‘ Liguori. Si trattava <strong>di</strong> una scelta non priva <strong>di</strong> conseguenza. La morale<br />
alfonsiana infatti non solo si opponeva decisamente ai principi giansenisti, ma si <strong>di</strong>staccava<br />
nettamente da ogni forma <strong>di</strong> rigorismo, e propugnava una misurata larghezza, sia<br />
nell‘amministrazione dei Sacramenti, sia nella soluzione dei casi <strong>di</strong> coscienza. È importante<br />
notare che i principi morali prevalenti allora tra il clero genovese erano quelli rigoristi 49 .<br />
Diffondendo la morale del Liguori, la Congregazione andava in qualche modo controcorrente,<br />
ed introduceva una <strong>di</strong>fferenziazione teologica, che si sommava con la <strong>di</strong>stanza<br />
psicologico - generazionale, tra il clero giovane e quello anziano. Si aggiunga che la morale <strong>di</strong><br />
S. Alfonso era <strong>di</strong>fesa dai gesuiti e combattuta dai rigoristi come lassista. Con il passare del<br />
tempo sarà comunque la morale alfonsiana a prevalere, e per quanto riguarda Genova, un ruolo<br />
non in<strong>di</strong>fferente fu giocato dalla Congregazione e dal Frassinetti in particolare 50 .<br />
44<br />
Regolamento per l‘Accademia del Beato Leonardo, Capitolo V, art. II., in G. FRASSINETTI, Notizia, op.<br />
cit., 607.<br />
45<br />
Ibid., Capitolo VI, art. 15.<br />
46<br />
Cfr. gli articoli 16 e 17 del Capitolo VI.<br />
47<br />
In queste due Bolle dogmatiche infatti venivano condannate alcune proposizioni come rinnovanti le<br />
eresie <strong>di</strong> Giansenio.<br />
48<br />
Regolamento, Capitolo VI, art. 18. L‘art. XX suggerisce <strong>di</strong> parlar bene <strong>degli</strong> scolastici, perché sono<br />
<strong>di</strong>sprezzati dai nemici della Chiesa. Forse anche qui c‘è una punta anti-giansenista.<br />
49<br />
In quegli anni, ad esempio, il professore <strong>di</strong> Morale nel Seminario <strong>di</strong> Genova, il Rev. Massa, uomo<br />
austero e stimato, seguiva i principi rigoristi. Fu considerato avversario dei Gesuiti.<br />
50<br />
Il ―Liguorinismo‖ fu, in qualche modo, una delle ―ban<strong>di</strong>ere‖ non solo della Congregazione del Beato<br />
Leonardo, ma anche <strong>di</strong> altre associazioni simili, come quelle fondate dal rev. Antonio <strong>Maria</strong> Gianelli<br />
prima a Chiavari e poi nella <strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> Bobbio. Il Gianelli, amico e consigliere del Frassinetti, fu vescovo<br />
<strong>di</strong> Bobbio. È stato beatificato dalla Chiesa Cattolica. Il Frassinetti, dal canto suo, fu un attento <strong>stu<strong>di</strong></strong>oso e<br />
sostenitore della morale alfonsiana sin dalla giovane età. Frutto maturo <strong>di</strong> una decennale riflessione sul<br />
de‘ Liguori è lo scritto: Compen<strong>di</strong>o della Teologia Morale <strong>di</strong> S. Alfonso de‟ Liguori, con apposite note e<br />
<strong>di</strong>ssertazioni, Genova 1865-66 Tip.della Gioventú, 2 voll. <strong>di</strong> p 495 e 525. La <strong>terza</strong> e<strong>di</strong>zione venne corretta<br />
ed accresciuta dall‘Autore e stampata dalla medesima tipografia a Genova nel 1867. Le altre e<strong>di</strong>zioni<br />
furono postume. Nel 1941 uscí la II e<strong>di</strong>zione per i tipi della SEI, aggiornata dal Felice <strong>Maria</strong> Cappello e<br />
dal sac. Andrea Gennaro. Fu tradotta in francese 1894, spagnolo 1902, portoghese 1872. Si tratta <strong>di</strong> una<br />
chiara esposizione, con commento ed esempi pratici, dell‘opera <strong>di</strong> S. Alfonso ―Homo Apostolicus‖<br />
corredata <strong>di</strong> ampliamenti fatti sulla base delle altre opere del de‘ Liguori, e dei principali commentari su<br />
<strong>di</strong> esse particolarmente gli scritti del Gousset, del Gury e del Ballerini S.J.. Alcuni considerano questa la<br />
principale opera del Frassinetti. Lo scritto ebbe larga <strong>di</strong>ffusione tra il clero cattolico e fu oggetto <strong>di</strong><br />
numerosi apprezzamenti, tra cui quello del Card. Della Chiesa, poi Benedetto XV. Cfr. GIORDANO RENZI,<br />
Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche, catalogo bibliografico generale delle opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te<br />
del servo <strong>di</strong> Dio, Postulazione generale F.S.M.I., Roma 1979, 106-109.<br />
18
Per la Storia ecclesiastica si «seguirà la Storia generale della Chiesa ad uso dei<br />
Seminari e del Clero, uscita nuovamente in Francia» 51 . Il Direttore «si fermerà ai tratti piú<br />
e<strong>di</strong>ficanti e <strong>di</strong> maggiore conseguenza per la dogmatica ed il ius canonico» 52 .<br />
Molto semplici infine le in<strong>di</strong>cazioni per lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o dell‘Eloquenza: «Si darà la vera idea e<br />
le buone regole della soda eloquenza popolare affinché la Parola <strong>di</strong> Dio venga annunciata con<br />
quella semplicità e forza che richiede» 53 .<br />
L‘accademia era <strong>di</strong>retta particolarmente ai ―chierici‖ che <strong>stu<strong>di</strong></strong>avano Teologia, ma<br />
poteva esservi ammesso qualunque ecclesiastico lo desiderasse. Continuavano a far parte<br />
dell‘Accademia anche quegli ecclesiastici che avessero frequentato i corsi, ma volessero tenersi<br />
uniti ad essa. Fu istituita per essi e per tutti gli altri Accademici, una riunione quin<strong>di</strong>cinale (si<br />
teneva il 1° e il 3° giovedí del mese, la mattina), analoga a quella della Congregazione del Beato<br />
Leonardo, composta da mezz‘ora <strong>di</strong> Lettura Spirituale con riflessioni anche spontanee dei<br />
presenti, ren<strong>di</strong>conto del ―metodo <strong>di</strong> vita‖, e proposte organizzative 54 .<br />
L‘Accademia iniziò con molto entusiasmo ed una certa <strong>di</strong>sorganizzazione, entrambe poi<br />
andarono <strong>di</strong>minuendo. Non essendoci ancora un locale, si cominciò in Seminario, fino a quando<br />
fu offerta la propria casa dal Can. Barabino 55 . Nell‘ottobre 1835 si passò in piazza Campetto.<br />
Nel maggio 1840 l‘Accademia fu trasferita nel piccolo oratorio <strong>di</strong> S. Croce, presso N. S. delle<br />
Vigne, in piazza della Lepre. Ultima sede, dal 1846, la casa <strong>di</strong> Luigi Sturla, per i motivi che si<br />
vedranno.<br />
All‘Accademia partecipò un buon numero <strong>di</strong> chierici soprattutto quelli ―esterni‖ che,<br />
cioè, non vivevano in Seminario. Essa ebbe una gran importanza per <strong>di</strong>ffondere nel clero i<br />
principi teologici e morali della Congregazione 56 . Sul finire del 1834, precisamente il 17<br />
<strong>di</strong>cembre, giunse alla Congregazione l‘approvazione scritta del Card. Ta<strong>di</strong>ni.<br />
Il Ta<strong>di</strong>ni, inoltre, scelse come Vicario generale Mons. Cogorno, che non nutriva alcuna<br />
simpatia per la Congregazione. In questa situazione il nucleo <strong>di</strong>rigente ritenne opportuno<br />
insistere per una approvazione ecclesiastica che tutelasse l‘esistenza della Congregazione, ma<br />
credette bene non palesare in tutta la sua estensione il proprio progetto, e stese perciò un<br />
regolamento ristretto, preceduto dai principi generali, dai quali potessero scaturire gli ulteriori<br />
ampliamenti. Nel regolamento, tra l‘altro, si taceva della Consulta. Fu appunto questo<br />
regolamento ―ristretto‖ ad essere approvato. Il passo era comunque <strong>di</strong> grande importanza per la<br />
Congregazione che aveva cosí pieno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza nella Chiesa cattolica genovese.<br />
Nell‘occasione, per giunta, l‘Arcivescovo accettò <strong>di</strong> essere egli stesso il Superiore<br />
dell‘organizzazione, Mons. Raffaele Biale, fino ad allora Superiore, <strong>di</strong>venne automaticamente<br />
Vice Superiore. Sul finire del ‘34 e nei due anni successivi, la Congregazione sembrava<br />
svilupparsi in modo confortante agli occhi dei suoi fondatori. Ottenuto un riconoscimento<br />
giuri<strong>di</strong>co, sebbene parziale, avviata un‘incisiva presenza culturale con l‘Accademia, assicurato<br />
lo sviluppo delle Opere <strong>di</strong> S. Raffaele e S. Dorotea me<strong>di</strong>ante il continuo reclutamento <strong>di</strong> nuovi<br />
aderenti, si poteva pensare ad una ulteriore estensione nel campo <strong>di</strong> azione e nella sfera <strong>di</strong><br />
influenza della Congregazione.<br />
Essa in effetti era concepita dai promotori come un mezzo per una continua elevazione<br />
spirituale cristiana del giovane clero, e perciò si faceva promotrice <strong>di</strong> varie iniziative <strong>di</strong> carattere<br />
51<br />
Regolamento, Capitolo VIII, art. 23. Cfr. G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 609.<br />
52<br />
Capitolo VIII, art. 24.<br />
53<br />
Capitolo IX, art. 27.<br />
54<br />
Capitolo XIII, art. 39-43.<br />
55<br />
Scrive Frassinetti del Barabino: «Egli era stato quasi dei primi della Congregazione, ed era sacerdote <strong>di</strong><br />
segnalata pietà e d‘ingegno, squisitamente colto nella letteratura e profondamente nelle scienze sacre».<br />
Cfr. G. FRASSINETTI, Memorie del sac. Luigi Sturla, op. cit., 71 della I e<strong>di</strong>zione.<br />
56<br />
Stralciamo ancora dal Frassinetti: «È chiaro che questa Accademia aveva solo lo scopo <strong>di</strong> stabilire i<br />
principi <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>; affinché tutti si basassero sui principi veri e conformi per quanto fosse possibile, e<br />
questo scopo si è ottenuto, si può <strong>di</strong>re mirabilmente, <strong>di</strong> modo che tutti coloro i quali frequentarono per<br />
qualche tempo l‘Accademia presero e conservarono sino al presente 1857, ndr le stesse massime a<br />
riguardo <strong>di</strong> tutti i rami <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> sacri; il frutto poi non si può calcolare perché nei circa tre<strong>di</strong>ci anni che<br />
durò l‘Accademia, v‘intervennero piú centinaia <strong>di</strong> novelli ecclesiastici, e tutto assolutamente il fiore del<br />
novello clero». Cfr. G. FRASSINETTI, Rischiarimenti sul mio passato, oci t., 24.<br />
19
ascetico e devozionale. «Erano essi i promotori <strong>degli</strong> Esercizi spirituali al popolo, in città ed in<br />
campagna. Di modo che mentre prima essi erano dati rarissimamente, ed in molti luoghi<br />
principali anche non mai, da allora in poi si dettero con molta frequenza...» 57 . «Furono anche<br />
essi gli autori <strong>di</strong> dare gli Esercizi Spirituali ai giovanetti ed alle giovinette in Genova e fuori,<br />
cosa non mai prima tentata tra noi, e grandemente fruttuosa» 58 .<br />
Grande attenzione era data dai Congregati al culto eucaristico e mariano. Contro il<br />
timore giansenistico <strong>di</strong> abusare dei Sacramenti, essi propagavano l‘utilità della Comunione<br />
frequente, purché ricevuta in stato <strong>di</strong> grazia, secondo la tra<strong>di</strong>zione cattolica 59 .<br />
Degna <strong>di</strong> rilievo è l‘attività spirituale svolta a favore dei carcerati e piú precisamente<br />
<strong>degli</strong> ergastolani. In Genova, in quei tempi, esistevano i lavori forzati, che si svolgevano nella<br />
Darsena, dove lavoravano 700 - 800 condannati e nel cantiere della Foce, che occupava circa<br />
200 condannati. La cura spirituale <strong>degli</strong> ergastolani era impegno dei Missionari Urbani, che<br />
sostenevano anche <strong>di</strong> averne l‘esclusiva.<br />
Nell‘anno 1829 la Compagnia <strong>di</strong> Gesú chiese all‘Ammiraglio della Regia Marina il<br />
permesso <strong>di</strong> svolgere un servizio pastorale tra gli ergastolani. I Missionari Urbani, interpellati<br />
dall‘Ammiraglio, opposero un rifiuto, proponendosi <strong>di</strong> migliorare la loro attività, ma <strong>di</strong> fatto<br />
senza profon<strong>di</strong> cambiamenti. Fin dai primi anni della Congregazione, si iniziò una cura<br />
spirituale <strong>degli</strong> ergastolani mettendosi però sotto la <strong>di</strong>rezione dei Missionari Urbani, che<br />
continuavano a pretendere l‘esclusiva (fu da allora appunto che i Missionari Urbani accolsero<br />
dei ―chierici‖ tra i propri iscritti). L‘attività dei congregati consisteva nella pre<strong>di</strong>cazione<br />
settimanale, nell‘ascolto delle confessioni al sabato, e nella pratica del mese mariano, oltre che<br />
nella missione annuale e nella Messa domenicale, già da tempo esistenti. Secondo il Frassinetti<br />
questa attività <strong>di</strong>ede frutti vistosi nella partecipazione dei condannati alle attività religiose 60 .<br />
Questo è a gran<strong>di</strong> linee, il quadro delle caratteristiche e delle attività della<br />
Congregazione del Beato Leonardo. Si trattava <strong>di</strong> una presenza <strong>di</strong> un certo rilievo, nella città e<br />
nelle campagne a<strong>di</strong>acenti. Sebbene la sua influenza fosse limitata quasi esclusivamente al<br />
giovane clero e ai chierici, a questo livello essa era notevole. Attraverso la Pia Opera <strong>di</strong> S.<br />
Raffaele e <strong>di</strong> S. Dorotea inoltre poteva contare su una presenza in quasi tutte le parrocchie; vista<br />
la giovane età dei suoi componenti essa sembrava destinata a estendere, con il passare del<br />
tempo, la sua influenza, ed apparire per piú aspetti come una delle aggregazioni religiose<br />
emergenti nella <strong>di</strong>ocesi genovese. Accanto alle iniziative promosse dalla Congregazione come<br />
tale, si possono inoltre tenere presenti alcune attività ed istituzioni in qualche modo collaterali<br />
favorite a livello in<strong>di</strong>viduale dai fondatori della Congregazione.<br />
Il Frassinetti, ad esempio, aveva sostenuto la sorella Paola nella fondazione <strong>di</strong> un<br />
Istituto religioso per ragazze povere, le quali fossero accolte nella vita consacrata senza<br />
necessità <strong>di</strong> portare una dote, come era invece costume nel tempo. La nuova comunità religiosa,<br />
avviatasi il 12 agosto 1834 a Quinto, fu visitata nel 1835 da don Luca Passi il quale propose con<br />
successo a Paola Frassinetti che il nuovo Istituto si prendesse particolare cura della Pia Opera <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Dorotea. Per questo motivo la novella Congregazione religiosa femminile mutò il nome<br />
iniziale <strong>di</strong> ―<strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Fede‖ in quello <strong>di</strong> ―Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea‖. Esse dopo alcune<br />
notevoli <strong>di</strong>fficoltà iniziali, ebbero un sod<strong>di</strong>sfacente incremento e collaborarono attivamente<br />
all‘estendersi della Pia Opera <strong>di</strong> S. Dorotea nella città. Lo Sturla, che sosteneva materialmente e<br />
57 Cfr. G. FRASSINETTI, Rischiarimenti sul mio passato, op. cit., 25.<br />
58 Ibid. Frassinetti fu tra i piú zelanti propugnatori <strong>di</strong> queste iniziative che introdusse nelle sue parrocchie,<br />
prima a Quinto e poi a S. Sabina in Genova. Scrisse anche un opuscolo <strong>di</strong> esercizi spirituali per<br />
adolescenti, che venne segnalato e lodato dalla Civiltà Cattolica.<br />
59 La <strong>di</strong>ffusione della frequenza al sacramento dell'Eucaristia fu uno dei principali impegni pastorali del<br />
Frassinetti; in un tempo in cui era piuttosto raro accostarsi alla Comunione, egli <strong>di</strong>fese la vali<strong>di</strong>tà della<br />
frequenza al sacramento con argomenti tratti dalla S. Scrittura, dai Padri della Chiesa, e dai Concili<br />
Ecumenici. Sintesi della sua impostazione è il libretto: Il convito del <strong>di</strong>vino Amore, Genova 1867,<br />
Tip.della Gioventú. Ebbe traduzioni in spagnolo 1865, francese 1907, tedesco 1907 e fiammingo.<br />
Stampato anche in Opera Omnia, Opere Ascetiche vol. I, Roma 1908, Tip.Poliglotta Vaticana.<br />
60 Ibid., 530.<br />
20
moralmente l‘istituto, affidò ad esso la guida <strong>di</strong> una scuola per fanciulle povere che aveva<br />
fondato nel popolare quartiere <strong>di</strong> S. Teodoro 61 .<br />
Le stesse suore aprirono dopo poco tempo altre scuole per fanciulle, in via Giustiniani e<br />
a Rivarolo.<br />
Preponderante era poi l‘influenza della Congregazione nel Seminario. La stessa idea<br />
della Congregazione era sorta in gran parte al fine <strong>di</strong> trovare uno strumento per la crescita<br />
spirituale dei chierici. Il Frassinetti, per vari anni, tenne un corso domenicale sul Vangelo ai<br />
Seminaristi. Lo Sturla si fece nominare ―prefetto‖, cioè tutore <strong>di</strong> un gruppo determinato <strong>di</strong><br />
Seminaristi, e trasformò profondamente lo stile <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> molti ―chierici‖. L‘esperienza fu<br />
apprezzata dal Card. Placido <strong>Maria</strong> Ta<strong>di</strong>ni, che nominò Luigi Sturla segretario per la<br />
commissione <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>nan<strong>di</strong>. Questa Commissione aveva il potere <strong>di</strong> ammettere o no i<br />
can<strong>di</strong>dati agli Or<strong>di</strong>ni Sacri. Determinante era inoltre il fatto che il Rettore del Seminario, Can.<br />
Giovanni Battista Cattaneo, aveva aderito ben presto alla Congregazione, e <strong>di</strong>venuto membro<br />
della Consulta, se ne considerava uno dei fondatori, al pari <strong>di</strong> Sturla e Frassinetti, i quali, per<br />
giunta, erano stati suoi compagni <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o.<br />
4. LA POLEMICA ANTIGIANSENISTA<br />
Nel corso del 1835 apparve in Genova un opuscoletto anonimo intitolato<br />
―Congregazione <strong>di</strong> Ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. ma e dei ss. Apostoli e del<br />
Beato Leonardo da Porto Maurizio‖ 62 . Lo aveva scritto il Frassinetti per presentare all‘opinione<br />
pubblica la Congregazione e propagandarla.<br />
Lo scopo della Congregazione, si chiariva in esso, era la formazione del giovane clero,<br />
affinché fosse zelante e unito. «Zelante sicché si prendesse veramente a cuore gli interessi della<br />
gloria <strong>di</strong> Dio e della salute delle anime, e questi interessi non solo preferisse a tutti gli altri, ma<br />
li considerasse come suoi, unicamente importanti. Unito sicché ciascuno, ben persuaso delle<br />
medesime e sane massime, agisse in conformità e concerto con i suoi fratelli ecclesiastici, onde<br />
gli uni aiutassero gli altri, e tutti stretti come in bene or<strong>di</strong>nata falange avessero una forza<br />
insuperabile a tutti gli assalti nemici».<br />
Mezzo generale per il conseguimento <strong>di</strong> questo scopo era «quello <strong>di</strong> imparare la<br />
prudenza dai nemici della Religione» 63 .<br />
Sulla base <strong>di</strong> questo principio venivano in<strong>di</strong>cati i mezzi particolari usati dai ―nemici<br />
della Religione‖ e contrapposti ad essi i mezzi che voleva usare la Congregazione. Primo mezzo<br />
era l‘unione ad un centro, ed a questo si voleva opporre l‘unione al centro <strong>di</strong> Roma «non solo in<br />
quanto è necessario per essere membri del Cattolicesimo, che ciò è da supporsi assolutamente in<br />
ogni cattolico, ma un‘unione speciale a Roma; talché anche nelle cose dalle quali, salva la fede e<br />
la cattolica unità, si potrebbe in qualche modo <strong>di</strong>ssentire da Roma, giammai da essa si <strong>di</strong>ssenta».<br />
«Quin<strong>di</strong> ne viene che nella Congregazione non si <strong>di</strong>scute mai ciò che fa Roma; e per Roma qui<br />
s‘intende non solo il Romano Pontefice, ma tutte le Congregazioni, che quali suoi organi<br />
vigilano sulla fede, sul costume e sopra la Gerarchia» 64 . Secondo mezzo era l‘obbe<strong>di</strong>enza, che i<br />
Congregati dovrebbero usare verso i legittimi superiori, non solo in ciò che viene or<strong>di</strong>nato, ma<br />
anche solo consigliato.<br />
Terzo mezzo era il <strong>di</strong>stacco dalle proprie idee particolari per il trionfo dell‘ideale<br />
comune, che per i Congregati è la Fede Cattolica. Quarto, il <strong>di</strong>sinteresse. Come i nemici del<br />
Cattolicesimo affrontano sacrifici e <strong>di</strong>fficoltà per <strong>di</strong>ffondere le loro idee, cosí i Congregati sono<br />
chiamati a promuovere il bene senza badare al lucro, ed anzi accettando fatiche e rinunce anche<br />
pecuniarie. Gli altri mezzi in<strong>di</strong>cati sono: il <strong>di</strong>stacco dal proprio genio, la costanza nelle<br />
61 Cfr. TEODOSIO DA VOLTRI, Un prete rinnovatore, op. cit., 47.<br />
62 ANONIMO, Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. ma, dei ss. Apostoli e del<br />
Beato Leonardo da Porto Maurizio, Genova 1835, Tip. Ferrando pagine 12; ora in Opera Omnia, vol.<br />
XIII, Roma 1912, Tip. Poliglotta Vaticana, con il titolo ―Idea della Congregazione‖ come Appen<strong>di</strong>ce a<br />
―Notizia della Congregazione‖, 586-592.<br />
63 G. FRASSINETTI, Idea della Congregazione, in Opera Omnia, vol. XIII, 586.<br />
64 Ibid., 587.<br />
21
contrarietà ed una confidenza vicendevole. A proposito del penultimo punto, l‘Autore scriveva:<br />
«Facciamo il bene, che questo sta tanto piú se lo facciamo con costanza; mentre le parole, le<br />
prevenzioni, gli stolti giu<strong>di</strong>zi sono tutte cose che passano. Che se pure dovessimo soffrire<br />
qualche vera persecuzione, quel detto <strong>di</strong>vino: Beati qui persecutionem patiuntur propter<br />
iustitiam ci dovrebbe dare tanta costanza da emulare, se cosí è lecito chiamarla, l‘eroica dei<br />
nostri nemici» 65 .<br />
Sulla confidenza vicendevole si mostra l‘importanza dello scambio <strong>di</strong> idee, <strong>di</strong> progetti<br />
ed anche della comunicazione <strong>di</strong> problemi e <strong>di</strong>fficoltà, per un aiuto vicendevole. Anche i<br />
superiori dovrebbero trattare, per quanto possibile, amichevolmente gli inferiori, e sulla base<br />
della fiducia reciproca dovrebbe basarsi la correzione fraterna. Queste, a gran<strong>di</strong> linee, le idee<br />
proposte nell‘opuscoletto, con il quale la Congregazione si can<strong>di</strong>dava come una presenza<br />
ecclesiale impegnata in prima linea a <strong>di</strong>fesa del Cattolicesimo e <strong>di</strong> una stretta obbe<strong>di</strong>enza al<br />
Pontefice Romano. È naturale che si venissero sviluppando attorno alla Congregazione<br />
sentimenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza ed ostilità, oltre che <strong>di</strong> simpatia e <strong>di</strong> approvazione. Per il momento essi<br />
non ebbero particolare modo <strong>di</strong> manifestarsi, cosa che avvenne invece dopo la pubblicazione <strong>di</strong><br />
un nuovo opuscolo del Frassinetti, nel 1837.<br />
Questi aveva scritto una ―Esortazione‖ da leggersi nella Consulta ed eventualmente in<br />
Congregazione, nella quale invitava gli ecclesiastici a combattere in <strong>di</strong>fesa della Chiesa<br />
Cattolica, contro tutti i suoi nemici, stringendosi intorno alla Chiesa <strong>di</strong> Roma ed al Papa.<br />
«O miei fratelli, quanto grande è l‘o<strong>di</strong>o dei nostri nemici contro <strong>di</strong> Roma, altrettanto sia<br />
grande il nostro amore per lei. Essa è il cuore del cristianesimo; noi, suoi membri, non possiamo<br />
vivere che del suo sangue: apprezziamo, <strong>di</strong>fen<strong>di</strong>amo il nostro cuore. La nostra credenza sia la<br />
<strong>roma</strong>na, le pratiche <strong>roma</strong>ne siano le nostre, il nome <strong>di</strong> cui an<strong>di</strong>amo gloriosi sia <strong>di</strong> Romani. Gran<br />
tempo è già nella Chiesa che <strong>roma</strong>no e cattolico suona la stessa cosa; e quanto del nome <strong>di</strong><br />
cattolici an<strong>di</strong>amo superbi, altrettanto dobbiamo andar superbi <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> <strong>roma</strong>ni» 66 .<br />
Il Frassinetti si sofferma a <strong>di</strong>fendere le sue affermazioni con motivazioni patristiche ed<br />
ecclesiologiche. Invita poi i confratelli nel sacerdozio a riporre la loro fiducia in Cristo ed a<br />
ricorrere al Suo aiuto, pregandolo presente nel Sacramento dell‘Eucaristia.<br />
Lo scritto termina con la calda esortazione <strong>di</strong> prendersi a cuore gli interesse e la gloria<br />
della <strong>Santa</strong> Chiesa: «Siete veri ecclesiastici? E come potrebbe essere altrimenti? L‘eterno<br />
sacerdote Gesú, amando la <strong>Santa</strong> Chiesa, a costo d‘innumerevoli fatiche, a costo <strong>di</strong> una morte <strong>di</strong><br />
croce, non ha creduto <strong>di</strong> eccedere nel suo amore; sarà per avventura possibile che noi<br />
ecce<strong>di</strong>amo? O santa Chiesa, o bella Madre dei figlioli <strong>di</strong> Dio…noi siamo qui per te; non<br />
ricuseremo <strong>di</strong> profondere a tua <strong>di</strong>fesa i nostri sudori, il nostro sangue: per noi che abbiamo la<br />
sorte <strong>di</strong> contemplare da vicino la tua bellezza, sei la gioia del nostro cuore e, <strong>di</strong>rei, l‘estasi<br />
dell‘anima nostra» 67 .<br />
Lo scritto fu letto dagli amici del Frassinetti, che lo apprezzarono e lo fecero leggere a<br />
loro volta. Capitò anche nelle mani del marchese Giuseppe Durazzo che ne fu entusiasta e fece<br />
proporre al Frassinetti <strong>di</strong> stamparlo a sue spese. Questi rimase sorpreso e in un primo tempo<br />
perplesso in quanto lo scritto era rivolto agli amici della Congregazione. L‘esortazione fu<br />
presentata al Picconi, barnabita, perché la correggesse a suo piacimento. Questi ritenne <strong>di</strong> non<br />
dovervi cambiare parola, solo propose che lo scritto venisse pubblicato con il titolo <strong>di</strong><br />
Riflessioni considerato piú modesto e meno impegnativo <strong>di</strong> Esortazione. Lo stesso Picconi<br />
ottenne dal Vicario Generale la facoltà <strong>di</strong> rivederle come revisore arcivescovile, e lo scritto fu<br />
mandato alle stampe.<br />
L‘opuscolo fu subito al centro dell‘attenzione, ed ebbe ripercussioni impreve<strong>di</strong>bili. Non<br />
mancarono certo le lo<strong>di</strong> ed i consensi, come quelli del Rev. Antonio M. Gianelli, del resto amico<br />
del Frassinetti. Lo Spotorno, pur essendo <strong>di</strong> orientamento culturale <strong>di</strong>fferente, gli de<strong>di</strong>cò un<br />
65 Ibid., 591. La citazione, dall‘Evangelo secondo Matteo, cap. 5, versetto 10a, in italiano suona: ―Beati i<br />
perseguitati per causa della giustizia perché <strong>di</strong> essi è il regno dei cieli‖. Cfr. La Bibbia <strong>di</strong> Gerusalemme,<br />
Bologna 1982 5 ed., EDB, 2094.<br />
66 G. FRASSINETTI, Riflessioni, op. cit., 42.<br />
67 Ibid., 55 ss.<br />
22
articolo sul Nuovo Giornale Ligustico 68 . In esso mette in dubbio l‘opportunità che un giovane<br />
sacerdote (Frassinetti aveva allora 33 anni) si facesse maestro e guida dei confratelli piú esperti<br />
e consolidati nel ministero. Trovava alcune espressioni poco chiare e bisognose <strong>di</strong> ulteriori<br />
precisazioni, per evitare <strong>di</strong> cadere in affermazioni grossolane, che supponeva lontane<br />
dall‘intenzione dell‘autore delle Riflessioni. Nel complesso però approvava lo scritto e si<br />
augurava <strong>di</strong> vederlo ristampato, con le opportune delucidazioni.<br />
Fortemente risentita fu la reazione dei giansenisti, i quali però non erano in grado <strong>di</strong><br />
esporsi pubblicamente e <strong>di</strong> rispondere <strong>di</strong>rettamente alle dure reazioni che li riguardavano. La<br />
corrente giansenista era stata molto forte a Genova, ed in tutta la Liguria, sul finire del sec.<br />
XVIII ed al principio XIX, ed aveva avuto un ruolo <strong>di</strong> primo piano ai tempi della Repubblica<br />
Genovese. Esponente <strong>di</strong> rilievo del giansenismo ligure fu Eustachio Degola, noto in tutta Italia<br />
ed all‘estero 69 . Nei tempi ai quali ci riferiamo i sostenitori veri e propri del giansenismo si erano<br />
ridotti ad un gruppo ristretto <strong>di</strong> sacerdoti, per lo piú avanti negli anni. Costretti dalle condanne<br />
pontificie e dall‘opposizione <strong>degli</strong> Arcivescovi ad un‘esistenza clandestina, non cessavano però<br />
<strong>di</strong> incontrarsi e <strong>di</strong> operare, per quanto era loro possibile. Se ne può avere un‘informazione<br />
insospettabile attraverso le lettere scritte al figlio dalla madre <strong>di</strong> Giuseppe Mazzini, <strong>Maria</strong><br />
Drago, <strong>di</strong> cui è nota la marcata pietà giansenistica, e nella cui abitazione si davano talvolta<br />
convegno alcuni dei piú autorevoli giansenisti 70 . Tra <strong>di</strong> essi si possono nominare: Pellegro<br />
Boggiano (1768-1849) allora parroco a S. Giorgio in Bavari, Luca Agostino Descalzi (1763-<br />
1840) insegnante, che era stato precettore <strong>di</strong> Giuseppe Mazzini, ed inoltre Stefano de Gregori e<br />
Paolo Sconnio (17631845). Oltre a questo gruppo limitato <strong>di</strong> sacerdoti dotti e attempati, ma che<br />
avevano anche qualche giovane seguace, vi era un‘area piú vasta <strong>di</strong> ecclesiastici che pur<br />
mantenendosi nell‘ortodossia cattolica, <strong>di</strong>fendevano i principi rigoristi in morale e nella<br />
pastorale sacramentale, non vedevano tutto nero nel giansenismo ed avevano una decisa<br />
antipatia per i gesuiti. Molti <strong>di</strong> essi furono infasti<strong>di</strong>ti dalle affermazioni del Frassinetti, cosí<br />
apertamente filo<strong>roma</strong>ne ed anti-giansenistiche.<br />
Fu un correre <strong>di</strong> voci e <strong>di</strong> accuse <strong>di</strong> cui non è facile ricostruire il percorso, ma che<br />
finirono per convergere e coagularsi: si <strong>di</strong>sse che il Frassinetti era un presuntuoso che si<br />
atteggiava arbitrariamente a censore e giu<strong>di</strong>ce dei sacri ministri, che in<strong>di</strong>rettamente accusava il<br />
clero genovese <strong>di</strong> essere infetto da giansenismo e in tal modo si faceva accusatore dello stesso<br />
Arcivescovo per aver permesso un tale abuso, che, in definitiva, l‘Autore delle Riflessioni non<br />
aveva fatto altro che prestare il proprio nome ai Gesuiti, i quali avevano scritto l‘opuscolo per<br />
fomentare la <strong>di</strong>visione nel clero <strong>di</strong>ocesano.<br />
Qualcuno provò anche a denunciare l‘opuscolo all‘In<strong>di</strong>ce: senza successo. Ma non era<br />
tanto il Frassinetti ad essere ad<strong>di</strong>tato allo scherno ed al <strong>di</strong>sprezzo, quanto l‘intera Congregazione<br />
del Beato Leonardo ad essere nell‘occhio del ciclone. Fu allora che i sospetti, le invi<strong>di</strong>e,<br />
l‘avversione che essa aveva suscitato nei suoi sei anni <strong>di</strong> vivace sviluppo, ebbero l‘occasione <strong>di</strong><br />
manifestarsi pubblicamente, accrescendosi. Agli occhi <strong>di</strong> molti era <strong>di</strong>venuta una ―setta‖ <strong>di</strong><br />
giovani intriganti, che volevano esautorare il vecchio clero accusandolo <strong>di</strong> giansenismo, e che<br />
frattanto andavano accaparrandosi i posti chiave della Diocesi, emarginando con il favore dei<br />
Gesuiti chi non apparteneva alla ―setta‖. In quest‘atmosfera carica <strong>di</strong> tensione, qualcuno,<br />
intenzionato a soffiare sul fuoco, mise in giro ad arte due voci, che finirono per essere credute.<br />
La prima era che i capi della Congregazione avevano composto una lista <strong>di</strong> sacerdoti<br />
infetti da giansenismo, e che in questa lista fossero in<strong>di</strong>cati i nomi <strong>di</strong> quasi tutti i parroci della<br />
città e <strong>di</strong> molti autorevoli sacerdoti 71 . La seconda è che la ―setta‖ <strong>di</strong>ffondeva una dottrina<br />
perversa secondo la quale si poteva obbligare il penitente a confessare il nome del proprio<br />
complice, nel sacramento della confessione; dottrina già condannata dal Magistero Pontificio 72 .<br />
68 Cfr. Nuovo Giornale Ligustico, serie II, vol. I, fasc. 4°. Lo Spotorno, barnabita, era moderatamente<br />
aperto alle idee liberali, e considerato avversario dei Gesuiti.<br />
69 Cfr. M CAFFIELLO, Degola Eustacchio, in Dizionario biografico <strong>degli</strong> italiani.<br />
70 A. LUZIO, La madre <strong>di</strong> Giuseppe Mazzini in un carteggio ine<strong>di</strong>to dal 1834 al 1839, Torino 1819.<br />
71 Cfr, G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 540.<br />
72 Frassinetti dà una sua spiegazione dell‘origine <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>ceria: «Questa accusa, ossia calunnia, fu<br />
inventata in Chiavari, contro i Missionari colà istituiti da Mons. Gianelli, quando vi era arciprete, e<br />
23
Per quanto nessuno avesse mai visto la lista, era tale ormai la concitazione, tale la sicurezza con<br />
cui la cosa veniva spacciata per vera, che un buon numero <strong>di</strong> parroci vi credette e non pochi si<br />
sdegnarono. Venne riunito il collegio dei parroci ed i piú accesi proposero ed ottennero che<br />
l‘intero Corpo dei parroci della città si recasse dall‘Arcivescovo per protestargli la propria<br />
irreprensibile ortodossia e chiedere giustizia dei calunniatori 73 . Cosí si fece. L‘Arcivescovo<br />
rimase sorpreso della visita, ma ascoltò attentamente i suoi interlocutori e si mostrò <strong>di</strong>spiaciuto<br />
della calunnia e sicuro della fede e dell‘ortodossia dei Parroci. Disse che era stata inoltrata<br />
l‘accusa contro due sacerdoti sospetti <strong>di</strong> giansenismo, ma questi non erano parroci ed erano già<br />
stati da lui ammoniti. Chiese infine <strong>di</strong> mostrargli la lista e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>carne gli estensori. A queste<br />
domande non fu possibile dare sod<strong>di</strong>sfazione e qualcuno provò a ripetere da capo le accuse,<br />
tirando in ballo anche le ―Riflessioni‖ del Frassinetti. L‘Arcivescovo, che le conosceva, fece<br />
notare che il tratto contro i giansenisti era del tutto generico, e non accusava nessuno del clero<br />
genovese <strong>di</strong> giansenismo. Alla fine il Car<strong>di</strong>nale rimandò a casa i parroci, assicurandoli della sua<br />
fiducia. Nulla si poté <strong>di</strong>mostrare in quella occasione a carico della Congregazione, ma<br />
l‘episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong>venne oggetto della pubblica valutazione. «Quel fatto commosse tutta la città, né si<br />
parlava piú d‘altro che dell‘accusa <strong>di</strong> giansenisti data ai Parroci, della lista dove si supponevano<br />
descritti i migliori del clero, nonché della <strong>di</strong>visone del clero, che si <strong>di</strong>ceva operata dalla<br />
Congregazione del Beato Leonardo» 74 . La tensione era tale che il Car<strong>di</strong>nale ritenne opportuno,<br />
in data 9 giugno 1838, in<strong>di</strong>rizzare una Lettera ai MM. RR. Parrochi della Città <strong>di</strong> Genova, in cui<br />
ancora assicurava la sua stima ―per quella illibata dottrina, che li rese sempre commendevoli e<br />
segnalati‖. Ed a tranquillizzare ulteriormente i piú esacerbati aggiungeva: «Cre<strong>di</strong>amo che le<br />
voci, cosí <strong>di</strong>vulgate, non possano provenire da gente che s‘intendano <strong>di</strong> quel che parlano, o che<br />
probabilmente venne dall‘aver obbligato alcune penitenti alle necessarie denunzie; allora i cattivi preti,<br />
che avevano da temere per sé, fecero gran chiasso e misero nel timore anche i buoni ma semplicissimi.<br />
Frattanto quei missionari e l‘Arciprete loro capo erano alienissimi da quella pratica, e non si poté trovare<br />
alcun caso da cui si potesse cavare alcun sospetto... Avvenne però che conoscendosi la relazione che<br />
passava tra l‘Arciprete e i missionari e la Congregazione del Beato Leonardo, si <strong>di</strong>sse che anche noi<br />
obbligavamo i penitenti alla manifestazione condannata dalla Chiesa». G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit.,<br />
547.<br />
73<br />
Tra i promotori dell'iniziativa si possono nominare Amedeo Giovannelli, prevosto a S. Donato, il priore<br />
Solari <strong>di</strong> S. Carlo e don Costà arciprete delle Grazie.<br />
74<br />
G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 542. Dell‘episo<strong>di</strong>o abbiamo anche la versione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Drago in una<br />
lettera al figlio Giuseppe Mazzini:<br />
«16 giugno 1838<br />
Amo il nostro clero che sta dando segni <strong>di</strong> vitalità. Ecco la cosa. Vi sono due partiti, alla testa <strong>di</strong><br />
uno stanno i Gesuiti. Dunque perveniva all‘Arcivescovo una lista <strong>di</strong> preti denunziati come giansenisti, e si<br />
<strong>di</strong>ce che essi tenevano conciliaboli nel locale dei sordomuti. In cima alla lista avvi un certo arciprete <strong>di</strong><br />
Bavari, che fra parentesi non fu mai e non vide mai il locale suddetto. In<strong>di</strong> d. Luca Luca Agostino<br />
Descalzi, ndr e altri, enunciati in numero <strong>di</strong> cinquanta o sessanta, quasi tutti parroci. Ora essendosi saputa<br />
tale calunnia, si presentarono al Vescovo trentaquattro, a nome <strong>di</strong> tutti, ed esposero energicamente come<br />
volevano sod<strong>di</strong>sfazione e schiarimenti sopra tali cabale. Il Vescovo accordava loro che fosse cosa<br />
architettata dai Gesuiti, e quin<strong>di</strong> dovevasi usare prudenza, onde non nascessero scismi nel sacro gregge.<br />
Bisogna <strong>di</strong>re che avvi un partito, che è quello dei Gesuiti, il quale va pre<strong>di</strong>cando una morale <strong>di</strong>abolica ed<br />
è quella <strong>di</strong> svelare il complice nella confessione: e questa dottrina fu pre<strong>di</strong>cata da alcuni nella propria<br />
parrocchia. Sento <strong>di</strong>re da buoni e veri teologi che i trentaquattro protestanti cioè i parroci autori della<br />
―protesta‖, ndr fecero bene, avendo pur detto che, se il Vescovo non ponesse freno agli altri, questi<br />
sarebbero <strong>di</strong>sposti anche a ricorrere a Roma e a Torino. Invero non si supponeva tanta energia nel nostro<br />
clero». G. LUZIO, op. cit., 199 s.<br />
Giuseppe Mazzini rispose:<br />
«29 giugno 1838<br />
Capperi! Avete scisma in Genova! Conviene che i Gesuiti o impazziscano o credano <strong>di</strong> esser<br />
franchi da ogni sinistro futuro. Avrei creduto che i Gesuiti abbiano, anche oggi, altre occupazioni che<br />
quelle <strong>di</strong> turbare gli ultimi anni <strong>di</strong> santi uomini come il mio buon istitutore Luca Agostino Descalzi, ndr e<br />
gli altri che mi nominate... » G. MAZZINI, Epistolario, vol. VII, Imola 1913, Ed. Nazionale, 49-50.<br />
24
vadano persuase <strong>di</strong> <strong>di</strong>re la verità. Imperciocché <strong>di</strong> nessuno, né <strong>di</strong> voi né <strong>di</strong> alcun altro del nostro<br />
clero abbiamo mai risaputo simili enormità, né ce ne fu mai data la minima <strong>di</strong>mostrazione» 75 .<br />
La reale preoccupazione dell‘Arcivescovo si poteva cogliere nel finale: «Noi<br />
terminiamo lasciandovi due esortazioni. Sia la prima che serbiate ognora tra voi, come per lo<br />
ad<strong>di</strong>etro, unità nella fede, libertà nelle opinioni tra i cattolici controverse, carità in tutto e con<br />
tutti, e soprattutto l‘antica sottomissione e devozione vostra <strong>di</strong> cuore e <strong>di</strong> mente verso i legittimi<br />
Superiori e principalmente il Supremo Gerarca <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Chiesa, base e centro della cattolica<br />
unità... La seconda esortazione sia che vogliate adoperarvi a sopire, con ogni prudenza e carità<br />
quelle voci stesse dei malevoli che vi offendono; non curatele, che fia forse meglio; o se pure<br />
non giu<strong>di</strong>caste ciò conveniente... venite allora a deporre i giusti vostri risentimenti solamente nel<br />
nostro seno, e ―sussurrone subtracto, jurgia cessabunt‖ (Prov. 26,20) ». L‘episo<strong>di</strong>o ebbe,<br />
insomma, vasta risonanza nell‘opinione pubblica, non solo genovese e non solo per<br />
l‘imme<strong>di</strong>ato 76 .<br />
Ma come reagiva la Congregazione alla valanga <strong>di</strong> accuse che le erano rivolte? Prima <strong>di</strong><br />
esaminare questo aspetto è necessario tenere presenti alcuni avvenimenti che ancora non<br />
abbiamo avuto modo <strong>di</strong> esporre. Raffaele Biale, che dal ‗33 era stato Superiore (con<br />
l‘acquisizione del titolo da parte dell‘Arcivescovo era rimasto Vice Superiore), dopo due anni<br />
circa <strong>di</strong> intensa attività aveva dato le <strong>di</strong>missioni, Luigi Sturla ottenne che venisse eletto Gian<br />
Battista Cattaneo, che era da tempo Direttore nell‘Accademia per l‘in<strong>di</strong>rizzo ascetico, ed era<br />
inoltre membro della Consulta. La sua elezione a Vice Superiore segnava in qualche modo una<br />
svolta, in quanto per la prima volta questa carica era ricoperta da uno dei membri del gruppo dei<br />
fondatori; la Congregazione sentiva forse che non aveva piú bisogno della copertura <strong>di</strong><br />
un‘autorità esterna, come era avvenuto ai primi tempi.<br />
Il Cattaneo, che era Rettore del Seminario, aveva ottimi rapporti con i Gesuiti, cosí che<br />
la sua elezione, a cavallo tra il ‗36 e il ‗37, segnò un ulteriore avvicinamento della<br />
Congregazione alla Compagnia <strong>di</strong> Gesú. Dopo la partenza del Bresciani da Genova, i membri<br />
della Consulta ricorsero spesso ai consigli del R. Spinelli, vincenziano 77 . Tra l‘altro lo<br />
consultarono sull‘opportunità <strong>di</strong> trasformare la Congregazione del Beato Leonardo in una<br />
Congregazione <strong>di</strong> religiosi regolari, e ne ebbero risposta che era meglio lasciarla com‘era, cioè<br />
un‘associazione <strong>di</strong> sacerdoti <strong>di</strong>ocesani. Alla morte dello Spinelli, nell‘anno 1837, la Consulta<br />
non cercò un altro consigliere. In quel torno <strong>di</strong> tempo però il Cattaneo avviò una corrispondenza<br />
epistolare con il Roothan, Preposito Generale dei Gesuiti, che teneva informato dei principali<br />
avvenimenti riguardanti la Congregazione e dal quale riceveva valutazioni e consigli.<br />
Attraverso questa comunicazione, la convergenza della Congregazione verso la<br />
Compagnia <strong>di</strong> Gesú era avviata a non restare limitata al campo teologico e spirituale (lotta al<br />
giansenismo, <strong>di</strong>fesa della morale <strong>di</strong> S. Alfonso, stretta obbe<strong>di</strong>enza al Papa, <strong>di</strong>ffusione della<br />
75 Brani della lettera dal carcere, ricavati da A. COLETTI, Manoscritti, op. cit., cap. XI, 19s.<br />
76 Il Frassinetti racconta cosí l‘episo<strong>di</strong>o: «Sua Eminenza, sebbene avesse sempre riguardato con una certa<br />
in<strong>di</strong>fferenza la nostra Congregazione, conosceva però che i suoi membri erano ben intenzionati, e non<br />
temeva <strong>di</strong> sette, e non badava alle ciarle; ciononostante, e per dare maggiore sod<strong>di</strong>sfazione a quei parrochi<br />
che si erano fitti in capo <strong>di</strong> essere stati calunniati, pubblicò una notificazione, nella quale manifestava la<br />
buona stima che aveva della loro dottrina... La qual cosa fu da molti <strong>di</strong>sapprovata come espe<strong>di</strong>ente capace<br />
a dar, come si suol <strong>di</strong>re, corpo alle ombre; perciò si <strong>di</strong>ceva che avrebbero forse fatto meglio a far sentire<br />
la sua autorità ai veri autori del <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne, che erano pochi e facili a potersi conoscere; ma forse pel timore<br />
<strong>di</strong> fare peggio, timore che tante volte fa rispettare gli insolenti piú <strong>di</strong> quello che converrebbe, non ha<br />
creduto bene inquietarli». G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 542 e s.<br />
Sul versante opposto ecco l‘opinione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Drago:<br />
«23 giugno 1838<br />
È uscita una pastorale del Car<strong>di</strong>nale <strong>di</strong>retta ai parrochi, che si presentarono reclamando contro la<br />
fazione opposta per la pre<strong>di</strong>cata dottrina dell‘obbligo <strong>di</strong> svelare il complice in confessione... La pastorale<br />
slitta sulla questione, solo esorta alla pace ed unione ecclesiastica... Il Car<strong>di</strong>nale è troppo vecchio per<br />
agire con la dovuta energia, per quanto conosca i sani principi; almeno un tempo li sfoggiava: ora poi<br />
taluni dei suoi benvisi gli fanno fare quello che vogliono». A. LUZIO, La madre <strong>di</strong> Giuseppe Mazzini, op.<br />
cit., 203 e s.<br />
77 Cfr. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 533.<br />
25
spiritualità e delle pratiche ascetiche ignaziane) ma a svilupparsi nel senso <strong>di</strong> una collaborazione<br />
anche sul piano organizzativo, <strong>di</strong> cui però non siamo in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ricostruire con precisione i<br />
tempi e i mo<strong>di</strong>. In questa situazione organizzativa la Congregazione affrontò le tensioni che<br />
seguirono la pubblicazione delle ―Riflessioni‖. Un primo elemento da rilevare è che essa rimase<br />
compatta, malgrado i colpi <strong>di</strong> cui era fatta bersaglio. Pare che ad eccezione <strong>di</strong> un solo membro,<br />
tutti gli aderenti continuassero a frequentarla ed a sostenerla, convinti della bontà della causa 78 .<br />
La cosa non è priva <strong>di</strong> significato, in quanto ad un certo momento i chierici ed i sacerdoti della<br />
Congregazione furono oggetto <strong>di</strong> pubbliche derisioni e oltraggi.<br />
Il Frassinetti, sebbene non volesse alimentare le polemiche, ritenne opportuno, ad un<br />
certo punto, ristampare le ―Riflessioni‖ corredandole <strong>di</strong> note esplicative, per non sottrarsi alla<br />
richiesta fattagli dallo Spotorno nel giornale ligustico. Nell‘occasione chiarí che la sua polemica<br />
contro i giansenisti era <strong>di</strong>retta alla setta in generale, e che era ben lontano dal voler accusare <strong>di</strong><br />
giansenismo il clero <strong>di</strong> Genova. Sebbene dopo la lettera del car<strong>di</strong>nale le polemiche andarono<br />
attenuandosi, tuttavia il trauma del clero genovese era stato cosí forte, che il Car<strong>di</strong>nale era<br />
incerto su come comportarsi con la Congregazione; da piú parti gli veniva suggerito <strong>di</strong><br />
sopprimerla.<br />
Molti <strong>di</strong>cevano che, poiché le <strong>di</strong>visioni nel clero prima non c‘erano, ed erano iniziate<br />
solo dopo la comparsa della Congregazione, era meglio liquidarla anche se il suo fine era<br />
buono 79 . Preoccupati della prospettiva, i <strong>di</strong>rigenti della Congregazione si rivolsero al Car<strong>di</strong>nale<br />
per via epistolare: il Frassinetti scrisse una lettera personale, mentre il Cattaneo due Memorie,<br />
una a nome proprio, l‘altra da parte dei <strong>di</strong>rigenti della Congregazione.<br />
Il Frassinetti scriveva <strong>di</strong> aver fin allora taciuto, malgrado le calunnie, per amor <strong>di</strong> pace;<br />
ora per evitare che il suo silenzio fosse interpretato come paura e ricadesse sulla Congregazione,<br />
desiderava <strong>di</strong>chiarare: essere lui l‘unico autore delle ―Riflessioni‖, averle scritte <strong>di</strong> propria<br />
iniziativa e non per darle alle stampe, la Congregazione non aver alcuna parte in esse, non aver<br />
voluto offendere il clero genovese, non aver desiderato suscitare <strong>di</strong>visioni, ma solo favorire una<br />
salda unione con il Papa, non aver voluto usurpare l‘autorità dell‘Arcivescovo essendo le sue<br />
parole quelle <strong>di</strong> un fratello che si rivolge ad altri fratelli. Il Nostro si <strong>di</strong>chiarava <strong>di</strong>sposto a<br />
fornire qualsiasi chiarimento gli venisse richiesto e a seguire le in<strong>di</strong>cazioni del Car<strong>di</strong>nale senza<br />
peraltro domandare sod<strong>di</strong>sfazione dai suoi denigratori 80 . Nella memoria da lui scritta il Cattaneo<br />
riespone i fini e le attività della Congregazione, ricorda l‘approvazione e la benevolenza<br />
accordatele dall‘arcivescovo stesso, viene in fine a parlare della guerra <strong>di</strong> cui è oggetto; la<br />
Congregazione viene accusata <strong>di</strong> spirito <strong>di</strong> partito, ma ciò è falso: basta guardare il modo con<br />
cui i suoi aderenti lavorano anche con coloro che conoscono piú avversi; scorretto è invece il<br />
modo <strong>di</strong> procedere dei denigratori che <strong>di</strong>ffondono <strong>di</strong>cerie false, accuse infamanti, pubbliche<br />
satire senza alcun ritegno. Il Cattaneo lamenta inoltre che queste voci siano credute anche da<br />
persone buone e rispettabili. Conclude <strong>di</strong>chiarandosi pronto a documentare le sue affermazioni,<br />
non per avere la punizione dei colpevoli, ma perché ―Sua Eminenza resti pienamente persuasa‖<br />
della retta intenzione e dell‘obbe<strong>di</strong>enza dei congregati 81 .<br />
Non molto <strong>di</strong>ssimile era l‘altra Memoria, che ricordava anch‘essa le principali<br />
benemerenze dell‘organizzazione. Cattaneo cosí conclude: «È già da molto tempo che si<br />
sentono delle <strong>di</strong>cerie contro questa Congregazione, si calunniano con scritti anonimi e con<br />
infamanti imputazioni i principali membri <strong>di</strong> essa, si proverbiarono con moti insultanti i chierici<br />
che le appartengono, si composero satire, e si recitarono in adunanze <strong>di</strong> ecclesiastici e se ne<br />
fecero correr le copie. A queste ed altrettante ingiurie non si oppose finora che il silenzio ... Ma<br />
sentendo adesso che alcuni maligni, valendosi della delicatezza dei MM. RR. Parrochi, in punto<br />
<strong>di</strong> massima, per inimicarli alla Congregazione, con manifesta calunnia, accusarono questa<br />
d‘averli tutti o quasi tutti tacciati <strong>di</strong> Giansenismo; e che <strong>di</strong>vulgarono la calunnia cosí<br />
sfrontatamente, con ogni genere <strong>di</strong> persone, da cagionare scandali nel popolo, da farne<br />
78 Cfr. G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 544 e s.<br />
79 Al quale ragionamento Frassinetti ribatte: «con il quale argomento si poteva argomentare anche la<br />
religione cristiana ai tempi delle persecuzioni...», G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 543.<br />
80 Cfr. A. COLLETTI, Manoscritti, op. cit., cap. XI, 46.<br />
81 Ibid., 42-45.<br />
26
vivamente risentire il ven. Collegio dei Parrochi e da amareggiarne l‘animo <strong>di</strong> Vostra Eminenza,<br />
la Congregazione, e il vice-Superiore a nome <strong>di</strong> essa, protesta pronta a giurare, <strong>di</strong> non aver mai<br />
dato tale accusa, né in serio, né in scherzo, ad un Collegio sí rispettabile, non solo per <strong>di</strong>gnità,<br />
ma per pietà e per dottrina. Supplica inoltre Vostra Eminenza ad esaminare la cosa, affinché se<br />
qualcuno della Congregazione (il che non può credersi) avesse osato fare un‘accusa sí empia, sí<br />
insussistente e sí goffa sia rigorosamente punito; e ad assicurare altresí i MM. RR. Parrochi<br />
della stima e del rispetto, che, a tutto <strong>di</strong>ritto, la Congregazione loro professa e <strong>di</strong> cui è pronta a<br />
dare qualunque attestato potesse venire richiesto» 82 .<br />
Dopo queste <strong>di</strong>chiarazioni, seguite da qualche chiarimento a voce, il Card. Ta<strong>di</strong>ni<br />
rimase persuaso dell‘utilità della Congregazione e dell‘innocenza dei suoi componenti nella<br />
vicenda dei parroci. Era tuttavia tale l‘astio che la Congregazione aveva contro, che<br />
l‘Arcivescovo nel sinodo <strong>di</strong>ocesano riunito in settembre, mentre ebbe chiare parole <strong>di</strong> elogio per<br />
le Congregazioni dei Missionari Urbani e Rurali, e per gli Operai Evangelici, riguardo alla<br />
Congregazione del Beato Leonardo preferí semplicemente tacere.<br />
Frattanto consultatosi con un Vescovo amico, Mons. Albertis, ebbe come suggerimento<br />
<strong>di</strong> lasciare sussistere la Congregazione, ma <strong>di</strong> sopprimere le Accademie. Il Cattaneo, dal canto<br />
suo, fece notare che sopprimere le Accademie era praticamente lo stesso che sopprimere la<br />
Congregazione; che tuttavia si sarebbero eseguiti gli or<strong>di</strong>ni del Car<strong>di</strong>nale, nei tempi e nei mo<strong>di</strong><br />
in cui volesse fossero eseguiti.<br />
Mentre l‘Arcivescovo rifletteva sulle parole del Cattaneo, e la Congregazione stava in<br />
apprensione 83 , per le sue prospettive, avvenne un fatto nuovo che determinò una svolta decisiva<br />
a favore della stessa Congregazione. Il Vicario capitolare Cogorno si era, nel frattempo,<br />
<strong>di</strong>messo, forse per or<strong>di</strong>ne superiore. Egli era considerato un punto <strong>di</strong> riferimento da parte <strong>degli</strong><br />
avversari della Congregazione, che egli infatti non vedeva <strong>di</strong> buon occhio. A sostituirlo come<br />
Vicario Generale fu chiamato sul finire del novembre 1838, il Rev. Domenico Gualco, parroco<br />
<strong>di</strong> N. S. delle Vigne. Il Gualco era fortemente anti-giansenista, nemico dei liberali ed amico dei<br />
gesuiti 84 . In ogni caso era amico personale del Cattaneo, del Frassinetti e dello Sturla e<br />
simpatizzava per la Congregazione del Beato Leonardo. Essa ebbe perciò una valida protezione<br />
ed anche il Car<strong>di</strong>nale optò per la decisione <strong>di</strong> far continuare insieme alla Congregazione anche<br />
la Accademie.<br />
In questa nuova situazione cessò la lotta aperta contro i congregati, sebbene<br />
continuassero fermenti <strong>di</strong> ostilità contro <strong>di</strong> essi, alimentati anzi dalle supposte parzialità che il<br />
Vicario compiva a loro vantaggio. La Congregazione del Beato Leonardo aveva superato il<br />
momento piú <strong>di</strong>fficile della sua ancora breve esistenza e poteva riprendere con fiducia la sua<br />
attività 85 .<br />
5. DIFFICOLTÀ INTERNE<br />
La Congregazione aveva sottoposto nuovamente al Card. Ta<strong>di</strong>ni le sue regole sul finire<br />
del 1837, questa volta presentandole in forma piú ampia ed esplicitando l‘esistenza della<br />
Consulta, affinché <strong>di</strong>ventasse legale, ed altrettanto aveva fatto per l‘Accademia; quest‘ultima<br />
era stata approvata il 4 ottobre 1837, mentre il regolamento della Congregazione il 12 gennaio<br />
1838, prima cioè della <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> cui si è parlato nel paragrafo precedente.<br />
Superata la ―bufera‖ sul finire del '38 la Congregazione riprese regolarmente la sua<br />
attività e godette <strong>di</strong> una relativa tranquillità fin verso il 1843 86 . Nel 1839 il Frassinetti pubblicò<br />
82 Ibid., 40-42.<br />
83 Cfr. G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 544 s.<br />
84 Gualco pubblicò nel 1844 un libro dal titolo ―Giansenio d‟Ipri‖, Tip. Ferrando, Genova 1844, in cui<br />
narra la storia del fondatore e del movimento giansenista, dandone una valutazione nettamente negativa.<br />
85 Questo il commento del Frassinetti: «Cosí finí quella tempesta che in tutta la sua fierezza non si può<br />
descrivere, e a nessuno può apparire tanto incre<strong>di</strong>bile, quanto a chi l‘ha veduta». G. FRASSINETTI, Notizia,<br />
op. cit., 544.<br />
86 Cfr. G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 598<br />
27
un libretto dal titolo: ―Osservazioni sugli <strong>stu<strong>di</strong></strong> ecclesiastici‖ 87 nel quale raccoglieva, in qualche<br />
modo, il frutto dell‘esperienza maturata nelle Accademie, oltre che dei suoi propri <strong>stu<strong>di</strong></strong>. Lo<br />
scritto era rivolto particolarmente ai ―chierici‖ ed ai giovani sacerdoti. Esso conferma la<br />
particolare attenzione rivolta dal Frassinetti alla formazione dei giovani ecclesiastici 88 , ed<br />
insieme riba<strong>di</strong>sce ed amplia le idee già espresse dall‘autore in precedenti occasioni. Vengono<br />
fatte delle dettagliate osservazioni sulle principali <strong>di</strong>scipline <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> teologici (Dogmatica,<br />
Scrittura, Morale, Storia Ecclesiastica) con un‘appen<strong>di</strong>ce sulla Filosofia e l‘Eloquenza,<br />
precedute da un capitolo <strong>di</strong> osservazioni generali.<br />
Noi qui esamineremo, per ragione <strong>di</strong> spazio, solamente le osservazioni generali, e quelle<br />
che ci sembrano interessare piú da vicino gli argomenti presi in esame della nostra esposizione.<br />
«Bisogna che l‘ecclesiastico si consideri tutto tale, e si contenti <strong>di</strong> non essere altro che<br />
ecclesiastico», questa era l‘affermazione iniziale del Nostro, con la quale voleva sottolineare il<br />
carattere primario e totalizzante <strong>di</strong> questa scelta, che non escludeva, come chiariva in nota,<br />
interessi culturali e scientifici, ma li vedeva moralmente subor<strong>di</strong>nati al raggiungimento del<br />
proprio fine religioso.<br />
«Deve dunque <strong>di</strong>rigere ogni cura, e in modo particolare i suoi <strong>stu<strong>di</strong></strong>, al conseguimento<br />
del suo fine, che si è <strong>di</strong> essere un buon ecclesiastico». Carattere dell‘ecclesiastico, oltre la<br />
vocazione <strong>di</strong>vina, dovrebbe essere: «Fede pura, costumi integerrimi, scienza dei propri doveri e<br />
<strong>degli</strong> altrui, pietà che lo renda zelante per la gloria <strong>di</strong> Dio e per la salute dei suoi prossimi». «A<br />
tutto ciò ci vuole l‘istruzione: l‘ignoranza non è un buon mezzo per veruno <strong>di</strong> essi». La scienza<br />
sacra però deve essere congiunta con la carità, e su <strong>di</strong> essa fondarsi, ed insieme con l‘umiltà:<br />
«Vi vuol molto d‘umiltà, tanto piú che gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> ecclesiastici, molto avendo <strong>di</strong> soprannaturale,<br />
s‘innalzano sopra la sfera dell‘umano inten<strong>di</strong>mento, e perciò il volersi servire soltanto dei propri<br />
lumi nel loro corso, sarebbe lo stesso che volersi servire delle braccia per volare. Ciascuno deve<br />
dubitare dei propri lumi, e persuadersi <strong>di</strong> avere gran bisogno dei lumi altrui, e nelle materie<br />
ecclesiastiche, dei lumi della Chiesa. Le decisioni, le approvazioni o <strong>di</strong>sapprovazioni espresse o<br />
tacite della Chiesa ci somministreranno quei lumi <strong>di</strong>etro i quali non si può errare» 89 .<br />
L‘autore passa poi ad esaminare lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della Dogmatica, definita come la «prima<br />
scienza in cui ha da essere formato un ecclesiastico». Conferma la <strong>di</strong>stinzione tra dogmi,<br />
opinioni comuni dei teologi (alle quali bisogna credere) e questioni <strong>di</strong> scuola o interpretazioni<br />
dei singoli, che si possono accogliere, ma lasciando la libertà <strong>di</strong> respingerle. «Osservazione<br />
importantissima infine sarà <strong>di</strong> non lasciarsi sorprendere dalle fro<strong>di</strong> dei moderni ―Razionalisti‖, i<br />
quali convenendo con i protestanti, <strong>di</strong>scendono dall‘imo del socinianesimo. Ormai credono che<br />
per essere cristiano, si possa fare a meno della Rivelazione: <strong>di</strong>cono <strong>di</strong> aver conosciuto che la<br />
religione cristiana non è altro che una religione <strong>di</strong> ragione. In conseguenza <strong>di</strong> questo loro<br />
sistema è forza che non credano nemmeno alla <strong>di</strong>vinità <strong>di</strong> Gesú Cristo e siano semplici deisti,<br />
nonostante che si chiamino cattolici» 90 .<br />
«Dopo la sana dogmatica è necessaria all‘ecclesiastico la sana morale». «Si osservi che<br />
<strong>di</strong> questa scienza dovrà usare piú spesso che della prima. Per istruire il popolo, per sentire le<br />
confessioni ci vuole sana morale, perché questi sono gli uffizi che formano la maggior parte del<br />
ministero ecclesiastico» 91 .<br />
Qui il Frassinetti consiglia <strong>di</strong> seguire gli autori piú santi, piú pratici e piú sicuri, oltre<br />
che piú dotti. Riguardo alla Sacra Scrittura si ricorda: «L‘ecclesiastico deve essere persuaso<br />
dell‘importanza <strong>di</strong> questo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o, considerando che la Chiesa affida a lui la Scrittura perché la<br />
spieghi al popolo. L‘ecclesiastico è quegli che deve sminuzzare questo pane <strong>di</strong>vino ai figli <strong>di</strong><br />
essa» 92 . L‘Autore raccomanda <strong>di</strong> considerare la Bibbia come libro <strong>di</strong>vinamente ispirato, <strong>di</strong>verso<br />
87 G. FRASSINETTI, Osservazioni sopra gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> ecclesiastici proposte ai chierici, Tip. Pellas, Genova<br />
1839, 112, Ora in Opera Omnia, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1912, vol. XIII fu pubblicato anche<br />
come opuscolo a sé, come stralcio. Il lavoro è frutto <strong>di</strong> un lungo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o, cfr. G. FRASSINETTI,<br />
Rischiarimenti sul mio passato, op. cit., 32.<br />
88 Cfr. G. FRASSINETTI, Rischiarimenti sul mio passato, op, cit., 12.<br />
89 G. FRASSINETTI, Osservazioni, op. cit., 226.<br />
90 Ibid., 232.<br />
91 Ibid., 235.<br />
92 Ibid., 240.<br />
28
dai libri umani; e <strong>di</strong> attenersi nella sua interpretazione alle <strong>di</strong>rettive della Chiesa, dalla quale lo<br />
si riceve; particolarmente importante è la tra<strong>di</strong>zione patristica. L‘autore <strong>di</strong>fende poi l‘uso della<br />
Vulgata <strong>di</strong> S. Gerolamo, e lo motiva.<br />
Il paragrafo piú lungo è de<strong>di</strong>cato allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della Storia ecclesiastica. L‘autore espone i<br />
caratteri che deve avere la buona storiografia cattolica e si <strong>di</strong>lunga sul modo <strong>di</strong> adoperare la<br />
critica nelle forme a suo avviso piú corrette. A noi interessa il lungo brano in cui tratta dei<br />
caratteri delle ―storie‖ influenzate dai principi giansenisti, che condanna: «I° Carattere. Tale<br />
unzione e pietà nei loro proemi, è sparsa qua e là, ove cade in acconcio, che a prima vista vi<br />
ravvisate la penna <strong>di</strong> S. Bernardo: però questa unzione e pietà, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quella vera,<br />
invece <strong>di</strong> allargarvi il cuore a gran<strong>di</strong> affetti e fortificare a gran<strong>di</strong> opere la mano, vi stringe il<br />
cuore e vi intorpi<strong>di</strong>sce la mano. 2° Carattere. Eccessivo rispetto per l‘antichità. All‘oscuro <strong>di</strong><br />
quei primi secoli, fanno giocare bene la loro lanterna magica, e fanno vedere tutte le cose<br />
nell‘aspetto in cui piace <strong>di</strong>pingerle. Conciliano questo rispetto all‘antichità, con il persuadere gli<br />
allocchi che i primi cristiani erano tutti santi, gli o<strong>di</strong>erni tutti dannati. 3° Carattere. Grande<br />
devozione a S. Agostino, per l‘eccesso della quale si credono <strong>di</strong>spensati da quella <strong>di</strong> molti altri<br />
santi Padri, ed anche da quella <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima. Molti poi piú moderni hanno ribrezzo a<br />
chiamarli tali. 4° Carattere. Zelo e tenerezze pei <strong>di</strong>ritti che chiamano inalienabili del vescovato.<br />
Questi rivoluzionari della Chiesa vorrebbero tutti amici i capitani dell‘armata, perché il principe<br />
restasse abbandonato da tutti i suoi. 5° Carattere. O<strong>di</strong>o giurato ai Romani, che non cederebbe a<br />
quello <strong>di</strong> Annibale. Tutto ciò che viene da Roma, Brevi, Dispense, Indulgenze, Reliquie, tutto è<br />
trista merce falsificata, alterata, senza valore. Tutto ciò che è <strong>di</strong> Roma secondo essi si deve<br />
stimare poco, anzi ancor <strong>di</strong>sprezzare: le Congregazioni, il Messale, il Breviario, il Rituale,<br />
l‘In<strong>di</strong>ce dei libri proibiti: oh questo poi è opera dell‘ignoranza, della pretensione, della barbarie,<br />
è una reliquia della spaventosa inquisizione ... Questa gente, per far guerra ai Romani, altre armi<br />
non trovando si servirebbe fin <strong>degli</strong> spilli: perciò procurano <strong>di</strong> infiorare ogni pagina delle loro<br />
storie ecclesiastiche con qualche motto, sale o sentenza anti-<strong>roma</strong>na. 6° Carattere. Gran rispetto<br />
per i príncipi temporali. Si mostrano teneri e zelanti del loro onore e dei loro <strong>di</strong>ritti, piú che<br />
dell‘onore <strong>di</strong> Gesú Cristo e della sua Chiesa. Cercano cosí d‘affezionarseli per averli amici <strong>di</strong><br />
qualche colpo, con il quale, abbattuta la Chiesa, se fosse possibile, li sbalzino tosto dal trono.<br />
Conviene porre ben mente ai due ultimi caratteri, che sono tra i piú <strong>di</strong>stintivi delle storie<br />
ecclesiastiche <strong>di</strong> questa gente».<br />
L‘autore infine cosí commentava: «Le storie che sono contrad<strong>di</strong>stinte da questi caratteri<br />
non si leggano, o almeno si leggano soltanto da chi è istruito in questa scienza, e sempre con<br />
grande cautela, perciò gli autori sono cosí fini, da cambiarci le idee, guastarci la massima, quasi<br />
senza che ce ne avve<strong>di</strong>amo» 93 . Tralasciamo qui le brevi considerazioni sul Diritto canonico, e<br />
l‘appen<strong>di</strong>ce sopra lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della Filosofia e dell‘Eloquenza. Negli anni che vanno dal 1838 al<br />
1843 circa, la Congregazione riprese con regolarità la sua attività, senza che siano molti gli<br />
elementi <strong>di</strong> novità che si possano registrare.<br />
Nel 1842 il Frassinetti, che dal 1839 era <strong>di</strong>ventato parroco a S. Sabina in Genova, con il<br />
titolo <strong>di</strong> Priore, pubblicava un ―Compen<strong>di</strong>o della teologia dogmatica‖, che cambiò poi il titolo<br />
in quello <strong>di</strong> Catechismo dogmatico 94 . A partire dal 1843 circa ebbe inizio un periodo <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fficoltà interne, che portò ad una crisi latente dell‘organizzazione, <strong>di</strong> cui non avremmo notizia<br />
se non ce ne informasse il Frassinetti nei manoscritti della sua ―Notizia della Congregazione‖ 95 .<br />
Egli parla <strong>di</strong> ―raffreddamento‖ del fervore iniziale, e ne in<strong>di</strong>ca tre cause: 1) la poca salute del<br />
Canonico Cattaneo; 2) l‘attività ridotta e <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata della Consulta; 3) il proposito dello Sturla<br />
<strong>di</strong> fondare un Or<strong>di</strong>ne religioso regolare.<br />
93 Ibid., 255 ss.<br />
94 G. FRASSINETTI, Compen<strong>di</strong>o della teologia dogmatica, Tip. Ferrando, Genova 1842, 239. Ebbe<br />
ristampe a Genova, Torino e Parma. Fu tradotto in spagnolo 1906. Ora in Opera Omnia, vol. III. «È una<br />
breve e lucida esposizione del dogma cattolico. Viene posta la domanda e si dà la risposta. Il Frassinetti<br />
l‘aveva scritto per i catechisti, ma corse nelle mani dei laici adulti, come una breve teologia dogmatica per<br />
laici, <strong>di</strong> cui si sentiva una gran<strong>di</strong>ssima necessità nell‘ottocento».G. BRUNO RENZI, Giuseppe Frassinetti e<br />
le sue opere ascetiche, catalogo bibliografico, op. cit., 72.<br />
95 G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 553-562.<br />
29
Giovanni Battista Cattaneo era, come si è detto, rettore del Seminario Arcivescovile (dal<br />
1830) ed anche Vice-Superiore della Congregazione (dal 1836/37); egli «dopo una forte<br />
malattia non riacquistò piú la sanità, e dovette andare qua e là, poté far piú poco per la<br />
Congregazione» 96 , essendo anche assorbito dalle preoccupazioni. La malattia secondo il<br />
Frassinetti lasciò in lui uno strascico <strong>di</strong> instabilità nel pensiero, <strong>di</strong> timore eccessivo ed<br />
indecisione. «Avvenne allora, o che non interveniva alle consulte, e rimanendo queste senza<br />
capo nulla si sapeva determinare, oppure se vi interveniva, invece <strong>di</strong> promuovere il bene<br />
opportuno faceva nascere dubbi e <strong>di</strong>fficoltà, sicché tutto restava in sospeso, e ciò che un‘ora<br />
pareva conveniente, ad un‘altra ora pareva inconveniente, ad un‘altra ora pareva incongruo;<br />
dava quin<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni e contror<strong>di</strong>ni con troppa facilità» 97 .<br />
Il secondo motivo è in larga misura una conseguenza del primo e del terzo. In ogni caso<br />
è da rilevare che, per la prima volta in modo profondo e vistoso, si era creata una forte<br />
<strong>di</strong>varicazione <strong>di</strong> prospettiva tra i <strong>di</strong>rigenti della Congregazione. Lo Sturla infatti, questo è il<br />
terzo motivo, inseguiva un suo progetto <strong>di</strong> fondare un nuovo Istituto regolare intitolandolo<br />
―Fratelli <strong>di</strong> S. Raffaele‖, il cui scopo sarebbe stato <strong>di</strong> curare sia l‘istituto <strong>di</strong> S. Dorotea <strong>di</strong> Paola<br />
Frassinetti, sia la Pia Opera <strong>di</strong> S. Raffaele e S. Dorotea per l‘educazione dei fanciulli.<br />
Soprattutto però si era affievolito il suo apporto organizzativo alla Congregazione, che<br />
al tempo dei suoi inizi era stato determinante per il decollo dell‘associazione, ma rimaneva<br />
tuttavia <strong>di</strong> grande importanza per il suo mantenimento. La situazione giunse ad un punto tale <strong>di</strong><br />
incomprensione che lo stesso Sturla propose le proprie <strong>di</strong>missioni dalla Consulta. Malgrado in<br />
essa, scrive il Frassinetti, «facesse sí cattivo gioco che i compagni erano molto propensi a<br />
<strong>di</strong>simpegnarnelo... l‘antica amicizia, il bene incalcolabile che aveva fatto alla Congregazione, ed<br />
il timore che separandosi da loro si lasciasse trasportare piú in questo santo capriccio, ne li<br />
trattenne...» 98 . In questa situazione piuttosto confusa «la Congregazione languiva, ed al fine del<br />
1844 era raffreddatissima» 99 .<br />
Nell‘estate del ‗46 la con<strong>di</strong>zione era tale che quasi non si fecero le Accademie per la<br />
scarsità <strong>degli</strong> u<strong>di</strong>tori. Le poche riunioni della Consulta erano fonte <strong>di</strong> ulteriori <strong>di</strong>scordanze, e<br />
sembravano piú <strong>di</strong> impaccio che <strong>di</strong> aiuto. Ad un certo punto il Vice-Superiore, <strong>di</strong>sgustato dal<br />
comportamento <strong>di</strong> un membro della Consulta, che aveva interpretato come <strong>di</strong>sobbe<strong>di</strong>enza,<br />
designò un altro a fare le sue veci, e scelse a ciò il can. Barabino. Continuava però a dare<br />
<strong>di</strong>rettive, e queste erano che si togliesse dalla Congregazione tutto ciò che sapesse <strong>di</strong> singolarità,<br />
e quanto fosse piú sgra<strong>di</strong>to agli avversari o sembrasse alimentare <strong>di</strong>visioni nel clero.<br />
Fatto sta che sul finire del 1846, il Cattaneo «chiamò a sé il can. Barabino <strong>di</strong>cendogli<br />
che ormai la Congregazione aveva fatto molto bene, ma che non pareva dovesse farne in<br />
avvenire; che se alcun poco continuava a farne, era maggiore il danno che apportava,<br />
mantenendo la <strong>di</strong>visione del clero 100 ; che perciò era suo <strong>di</strong>visamento far sciogliere la<br />
Congregazione; che però per non dare troppa ammirazione si cominciassero le Accademie, e poi<br />
si lasciasse andare tutto a terra quasi in silenzio» 101 . Il Barabino, che non acconsentiva ad un tale<br />
progetto, comunicò la notizia al Frassinetti, mentre si trovava nella canonica <strong>di</strong> S. Sisto a parlare<br />
con il can. Salvatore Magnasco 102 (penitenziere della Metropolitana) e con il Priore <strong>di</strong> S. Sisto,<br />
Vittorio Storace, sullo stato <strong>di</strong> ―impasse‖ in cui si trovava la Congregazione. Il Barabino ed il<br />
Frassinetti, infatti, avevano pensato <strong>di</strong> rivolgersi ai due prelati, stimati come prudenti ed<br />
96 Ibid., 553.<br />
97 Ibid., 555.<br />
98 Ibid., 554.<br />
99 Ibid.<br />
100 Commenta Frassinetti, in una parentesi: «.... cosí anch‘egli era caduto nelle idee dei nemici a poco a<br />
poco senza avvedersene!». Cfr. G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 557. In effetti il 1846 è l‘anno della<br />
polemica tra Frassinetti ed il Bonavino sul ―Gesuitismo‖ ed è anche un anno <strong>di</strong> grande <strong>di</strong>ffusione <strong>degli</strong><br />
ideali risorgimentali. Fino a che punto il <strong>di</strong>sagio <strong>di</strong> Cattaneo sia un riflesso <strong>di</strong> questi nuovi eventi, e<br />
dell‘isolamento verso cui la Congregazione andava incontro, è <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>rlo.<br />
101 G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 557.<br />
102 A. DURANTE, Mons. Salvatore Magnasco Arcivescovo <strong>di</strong> Genova, Milano 1942.<br />
30
avveduti, per chiedere consiglio su come comportarsi nella <strong>di</strong>fficile situazione 103 . Conosciuta<br />
con sorpresa la notizia, si accettò la proposta <strong>di</strong> Magnasco, che si incaricava <strong>di</strong> andare a parlare<br />
con il Cattaneo. Questi frattanto aveva comunicato la sua idea anche al Vicario Generale<br />
Domenico Gualco, il quale tuttavia aveva sconsigliato una decisione cosí ra<strong>di</strong>cale.<br />
Sentito anche il parere nettamente contrario del Magnasco, il Cattaneo si limitò a<br />
proporre un profondo mutamento della Congregazione che ―facesse cessare tutte le <strong>di</strong>cerie‖. Si<br />
riunirono allora il Barabino, Magnasco, Storace e Frassinetti per dar mano alla ―riforma‖ e<br />
stabilirono dei nuovi Direttori per le Accademie, levarono il ren<strong>di</strong>conto del ―metodo <strong>di</strong> vita‖<br />
dall‘Accademia <strong>di</strong> spirito, lasciandolo però alla Conferenza generale dei quin<strong>di</strong>ci giorni,<br />
notarono inoltre alcune trasformazioni da fare ai regolamenti.<br />
«Il Vice-Superiore, tra il poco fatto e il piú da farsi, rimase contento. È da notare che<br />
tutto si fece in tanto silenzio che i Congregati non seppero nulla <strong>di</strong> tanto imbroglio, e<br />
cominciando le Conferenze e le Accademie al solito, non sospettarono <strong>di</strong> nulla, credendo fatte a<br />
caso quelle variazioni» 104 . Riprese le attività esterne della Congregazione, rimaneva precaria la<br />
situazione tra i <strong>di</strong>rigenti.<br />
Quattro membri della Consulta decisero <strong>di</strong> riunirsi la domenica sera, dopo l‘Accademia,<br />
clandestinamente, per fare privatamente ciò che si faceva dai piú impegnati all‘inizio della<br />
Congregazione: non volevano che le future ―riforme‖ alterassero la natura della Congregazione.<br />
Dopo la prima riunione decisero <strong>di</strong> comunicare l‘iniziativa anche agli altri membri della<br />
Consulta, ad eccezione del Vice-Superiore Cattaneo. «Avvisati che furono, tutti convennero con<br />
entusiasmo nella proposta, e in quella sera si può <strong>di</strong>re rinascesse la Congregazione dalla sua<br />
quasi morte. Vi fu tale unione e conformità <strong>di</strong> sentimenti e tale trasporto <strong>di</strong> buono spirito che<br />
questa radunanza emulava precisamente quelle <strong>degli</strong> anni primieri. Mi pare che fosse la<br />
domenica <strong>di</strong> quinquagesima» 105 .<br />
Il Frassinetti ci dà i nomi <strong>di</strong> questi consultori: il can. Nicolò Barabino, il Priore<br />
Giuseppe Frassinetti, don Luigi Sturla, don Luigi Bottaro, don Giovanni Battista Ra<strong>di</strong>f, don<br />
Gaetano Alimonda. Lo Sturla inoltre aveva abbandonato il progetto <strong>di</strong> un nuovo Istituto<br />
regolare, e riprese a lavorare per la Congregazione con tutte le sue molteplici capacità 106 . I<br />
consultori stabilirono <strong>di</strong> riunirsi settimanalmente, <strong>di</strong> darsi il resoconto del ―metodo <strong>di</strong> vita‖, <strong>di</strong><br />
correggersi reciprocamente, <strong>di</strong> contribuire con cinque lire mensili, e <strong>di</strong> fare delle mortificazioni;<br />
inoltre accettarono <strong>di</strong> avere una speciale <strong>di</strong>pendenza dal can. Barabino, il quale però doveva<br />
rimettersi al parere unanime <strong>degli</strong> altri, se fosse opposto.<br />
Il Barabino provò anche a fare un nuovo regolamento, secondo i desideri del Vice-<br />
Superiore, ma, giunto alla fine, si convinse che un tale regolamento avrebbe snaturato la<br />
Congregazione. Con l‘approvazione <strong>di</strong> tutti i consultori si propose al Cattaneo <strong>di</strong> lasciare le cose<br />
come stavano, ed egli acconsentí, forse perché colpito dall‘unanimità <strong>degli</strong> altri, forse perché in<br />
parte pentito del suo proposito <strong>di</strong> liquidare la Congregazione: si decise perciò <strong>di</strong> rimandare la<br />
103<br />
Entrambi gli interpellati insegnavano come <strong>di</strong>rettori nell‘accademia del Beato Leonardo. Magnasco era<br />
allora penitenziere della Metropolitana. Ci piace riportare l‘episo<strong>di</strong>o come viene raccontato dalla penna<br />
del Frassinetti: «Convennero all‘ora fissata il can. Magnasco e i due priori <strong>di</strong> S. Sisto e S. Sabina<br />
Frassinetti, ndr. Ritardando molto il can. Barabino, il priore <strong>di</strong> S. Sabina espose lo stato della<br />
Congregazione, le freddezze ed i <strong>di</strong>sgusti del Vice-Superiore Cattaneo, ndr, affinché essi consigliassero<br />
come potessero ristabilire le cose; ma ecco che arrivando il can. Barabino, manifesta la strana idea del<br />
Vice-Superiore che in quel giorno gli aveva comunicato. I due consultori restarono sorpresi e la<br />
<strong>di</strong>sapprovarono; il piú sorpreso fu il priore <strong>di</strong> S. Sabina, che ebbe a <strong>di</strong>re, nessuna cosa avergli fatto<br />
altrettanto colpo giammai». Cfr. G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 558.<br />
104<br />
G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 560.<br />
105<br />
Ibid.<br />
106<br />
Cosí Frassinetti descrive l‘avvenimento: È da notare che il Signore aveva operato una mutazione che ci<br />
parve mirabile in don Sturla, poiché, contro ogni nostra aspettazione, abbandonò il suo strano <strong>di</strong>visamento<br />
che già da vari anni lo aveva travagliato, e tanto piú sul finire del passato 1846, ndr. Riconobbe egli il suo<br />
errore, e si rimise a lavorare uniformandosi al parere dei compagni; quin<strong>di</strong> riacquistò la pace che in gran<br />
parte aveva perduta e si <strong>di</strong>ede a faticare per la Congregazione con il primiero fervore, il che fu <strong>di</strong> grande<br />
aiuto per due motivi: e perché tosto si ebbe uniformità <strong>di</strong> sentimenti tra noi, e perché la sua grande attività<br />
aiutò molto novello movimento che prendeva la Congregazione‖.G. FRASSINETTI, Notizia, op. cit., 561.<br />
31
stesura <strong>di</strong> un nuovo regolamento ad un tempo piú opportuno. Lo stesso Cattaneo, anzi, riprese,<br />
sebbene con un certo <strong>di</strong>stacco, ad intervenire talvolta alle riunioni della Consulta 107 . La<br />
Congregazione sembrava riprendere nuovamente slancio e vita, ma nuove, <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong>fficoltà<br />
dovevano <strong>di</strong> lí a poco, troncarne l‘attività.<br />
107 Ibid., 562.<br />
32
CAPITOLO II<br />
VINCENZO GIOBERTI E LA POLEMICA SUL “GESUITISMO”<br />
La formulazione <strong>di</strong> un programma politico nazionale <strong>di</strong> orientamento liberale moderato<br />
ricevette un impulso decisivo dalla pubblicazione del libro <strong>di</strong> V. Gioberti: Del Primato morale e<br />
civile <strong>degli</strong> italiani 108 .<br />
L‘Autore, esule a Bruxelles, applicava le sue originali elaborazioni filosoficoteologiche,<br />
improntate ad un idealismo <strong>di</strong> orientamento cattolico, alla situazione politica<br />
italiana.<br />
Il Piemontese riven<strong>di</strong>cava alla nazione italiana una missione civilizzatrice universale,<br />
fondata sul genio conciliatore della civiltà <strong>roma</strong>na-pelasgica e la missione religiosa universale <strong>di</strong><br />
Roma cattolica. Una prima efficace sintesi <strong>di</strong> questi elementi si ebbe nel primo me<strong>di</strong>oevo<br />
quando Roma, latina e papale, <strong>di</strong>venne <strong>di</strong>spensatrice <strong>di</strong> civiltà tra i popoli barbari.<br />
Per poter riprendere la sua funzione storica civilizzatrice, sintesi <strong>di</strong> unità - la religione<br />
cattolica - e varietà - le scienze e le arti – l‘Italia deve valorizzare la propria tra<strong>di</strong>zione culturale<br />
(Dante, Vico) e ritrovare l‘autonomia e l‘unità politica.<br />
Il ricostituirsi politico della nazione italiana, per rispettarne le caratteristiche peculiari,<br />
dovrà mantenere la pluralità <strong>degli</strong> stati e realizzarsi come confederazione tenuta unita da un<br />
principio ideale eterno: il Cattolicesimo. Essendo il Papa il Capo supremo della Cattolicità,<br />
spetterebbe perciò a lui il ruolo morale <strong>di</strong> presiedere e ricondurre ad unità la ipotizzata<br />
―Confederazione Italiana‖.<br />
Il progetto, qui sommariamente delineato, venne comprensibilmente denominato ―neoguelfo‖,<br />
ed animò una delle piú consistenti correnti del liberalismo moderato italiano.<br />
Netto era il <strong>di</strong>stacco dalla prospettiva <strong>di</strong> Mazzini, non solo rispetto alla forma dello<br />
Stato, confederale anziché unitario, ed a quella <strong>di</strong> governo, monarchico anziché repubblicano,<br />
ma anche in rapporto ai soggetti ed ai mo<strong>di</strong> del cambiamento. Alla concezione democratica e<br />
metodo rivoluzionario nella collaborazione <strong>di</strong>plomatica tra gli stati italiani faceva riscontro,<br />
nello scritto <strong>di</strong> Gioberti, una collaborazione tra il sovrano riformatore e gli istituti consultivi,<br />
rappresentativi <strong>di</strong> una aristocrazia del merito e non del sangue. La via tracciata alle riforme era<br />
perciò quella legale e graduale, tanto che in questo primo scritto Gioberti non propugnava la<br />
necessità <strong>di</strong> una Costituzione.<br />
Il carattere conciliativo dello scritto, indubbiamente ancorato ai presupposti ideali del<br />
filosofo, era stato consapevolmente <strong>di</strong>latato dall‘Autore sia per guadagnare alla causa nazionale<br />
il maggior numero possibile <strong>di</strong> interlocutori, sia per evitare gli ostacoli della censura.<br />
Si spiega cosí il silenzio sulla scottante questione del dominio austriaco in Italia, e la<br />
sor<strong>di</strong>na posta sul malgoverno negli Stati Pontifici e l‘opposizione <strong>di</strong> larghi settori dell‘opinione<br />
cattolica alle idee liberali.<br />
Il successo del ―Primato‖ malgrado la complessità (e la pesantezza) dello scritto, fu<br />
notevole, e Gioberti fu considerato un ―capo – scuola‖ 109 .<br />
Per quanto la prospettiva della questione nazionale, o forse proprio per questo, fosse<br />
delineata in termini idealizzati, ampi strati dell‘opinione pubblica cominciarono per la prima<br />
volta a sentire l‘importanza e l‘ardore del riscatto nazionale 110 . L'ideale neoguelfo fece breccia<br />
108<br />
V . GIOBERTI, Del Primato morale e civile <strong>degli</strong> Italiani, Bruxelles 1843. L‘opera nelle varie e<strong>di</strong>zioni<br />
superò le 81000 copie.<br />
109<br />
Si vedano a questo proposito le sincere parole <strong>di</strong> Cesare Balbo: «Ella è capo <strong>di</strong> scuola oramai.<br />
Manzoni fa capo allo scrivere cristianamente <strong>di</strong> nuovo in Italia, ma Ella è capo al trarre gran<strong>di</strong><br />
conseguenze filosofiche, storiche, politiche, morali dal principio cristiano posto». V. GIOBERTI, Ricor<strong>di</strong><br />
biografici e carteggio, Torino 1860-63 vol. II, 359.<br />
110<br />
Scrive Anzilotti: «Questo era il libro del momento. Come tale sollevò entusiasmi e <strong>di</strong>spute: agli uni<br />
parve riassumere in maniera smagliante le idee piú nobili del secolo; agli altri, <strong>di</strong>ssenzienti o ad<strong>di</strong>rittura<br />
decisi avversari, <strong>di</strong>ede occasione, con una violenta scossa, a determinare meglio il proprio atteggiamento<br />
politico e a comprendere piú chiaramente le ragioni del <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o fra il loro in<strong>di</strong>rizzo e quello enunciato nel<br />
libro dell‘esule piemontese. Certo è che l‘interesse stesso <strong>di</strong> un vasto pubblico, in ogni regione d‘Italia,<br />
per il Primato <strong>di</strong>mostrò quanto fosse cambiato lo stato morale della penisola. Il primo scopo che si<br />
33
anche nel clero e trovò simpatie tra qualche gesuita poiché evitava i rischi e i sacrifici del<br />
rivoluzionarismo mazziniano (si veda la stessa ―Tempesta del dubbio‖ del Mazzini).<br />
Non mancarono però le critiche, non solo tra i democratici o i <strong>di</strong>fensori della<br />
Restaurazione ma, sebbene per opposte ragioni, tra gli stessi liberali moderati, anche in campo<br />
cattolico, che vedevano nelle idee del Primato genericità e confusione (si veda ad esempio la<br />
questione d‘Austria).<br />
Cesare Balbo, pur apprezzando sinceramente l‘opera, notava che i tempi presenti<br />
camminavano piú verso una reciproca autonomia della sfera spirituale e <strong>di</strong> quella temporale che<br />
verso una supremazia temporale della sfera spirituale. Legando troppo strettamente il papato<br />
alla riscossa nazionale c‘era inoltre il pericolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>menticare il carattere universale e<br />
trascendente del Cattolicesimo. Pur con questi rilievi, <strong>di</strong> non piccolo valore teorico, Balbo si<br />
muoveva su una linea cattolico liberale-moderata sostanzialmente compatibile con il progetto<br />
giobertiano, e con il suo <strong>di</strong>verso stile, molto piú concreto e politico, affrontava nel libro ―Le<br />
Speranze d‟Italia‖, alcuni problemi nazionali, tra cui quello capitale delle relazioni con<br />
l‘Austria.<br />
Altri come Mamiani, Pivelli, Massari, per quanto amici del Gioberti, trovavano<br />
inopportuno il silenzio, che rischiava <strong>di</strong> significare avallo verso la politica retrograda dello Stato<br />
Pontificio e piú in generale dei cattolici <strong>di</strong> orientamento ultra - conservatore, <strong>di</strong>fensori<br />
dell‘Ancien régime e nemici <strong>di</strong> ogni riforma. E poiché lo stesso papato e la curia <strong>roma</strong>na<br />
aderivano prevalentemente a questo in<strong>di</strong>rizzo, trovavano il progetto dell‘abate torinese<br />
praticamente irrealizzabile.<br />
Raffaello Lambruschini, cattolico liberale, riteneva che un rinnovato influsso della<br />
Curia Romana, stanti le attuali con<strong>di</strong>zioni dello Stato Pontificio e del Papato, potesse essere<br />
ad<strong>di</strong>rittura controproducente per lo sviluppo del movimento nazionale e delle idee liberali.<br />
Piú critici gli intellettuali che si richiamavano ad una tra<strong>di</strong>zione anticuriale o ad<strong>di</strong>rittura<br />
anticlericale, come il Niccolini, il Giusti ed il Guerrazzi.<br />
Giuseppe Ferrari, democratico <strong>di</strong> convinzioni atee ed anticlericali, in una serie <strong>di</strong> articoli<br />
su giornali <strong>di</strong> Francia, dove si trovava in esilio volontario, considerava il neo - guelfismo come<br />
oggettivamente alleato dell‘Austria e delle forze reazionarie e clericali.<br />
Gioberti si trovava perciò nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> doversi <strong>di</strong>fendere e giustificare <strong>di</strong> fronte a<br />
consistenti settori della cultura liberale, ed eventualmente <strong>di</strong> puntualizzare o rettificare gli<br />
aspetti carenti del suo progetto. In questo clima nacque una lunga Avvertenza che Gioberti<br />
intese premettere alla seconda e<strong>di</strong>zione del Primato, e che cresciuta grandemente nel corso<br />
dell‘elaborazione, finí poi per circolare autonomamente come ―Prolegomeni del Primato morale<br />
e civile <strong>degli</strong> Italiani‖ 111 .<br />
L‘autore insiste sul concetto <strong>di</strong> ―<strong>di</strong>alettica‖ intesa come assunzione e conciliazione della<br />
varietà in una armonica unità.<br />
In campo politico, respinti i due estremi della demagogia e del <strong>di</strong>spotismo, Gioberti<br />
affida il ruolo <strong>di</strong> conciliatore al Principe, che governi nell‘interesse <strong>di</strong> tutti i ceti, secondo<br />
l‘opinione della classe colta.<br />
Questa volta l‘Autore afferma esplicitamente l‘utilità <strong>di</strong> una Costituzione e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni<br />
rappresentativi, insieme ad una sostanziale libertà <strong>di</strong> stampa e ad una censura piú aperta ed<br />
illuminata.<br />
Lo scrittore torinese ribatté alle accuse rivolte al Primato <strong>di</strong> favorire un governo<br />
clericale, chiarendo che nelle sue intenzioni il sacerdozio (secolare ma anche regolare) può sí<br />
svolgere un alto magistero civile, qualora accolga i valori <strong>di</strong> libertà socialmente emergenti, ma<br />
che il ruolo <strong>di</strong> impegnarsi e <strong>di</strong> governare le attività temporali spetta al laicato, <strong>di</strong> cui auspica una<br />
rinascita in senso cattolico, italiano ed attivo. Gioberti fa presente inoltre che la proposta <strong>di</strong> una<br />
Confederazione italiana deve essere considerata prioritaria rispetto alla sua possibile presidenza<br />
da parte del Papa, elemento secondario ma non impossibile a realizzarsi.<br />
proponeva il Gioberti, cioè <strong>di</strong> smuovere, provocare, eccitare l‘opinione italiana, era cosí raggiunto». A.<br />
ANZILOTTI, Gioberti, Firenze 1923, 98.<br />
111 V. GIOBERTI, Prolegomeni del Primato morale e civile <strong>degli</strong> Italiani, Bruxelles, 1845. Le citazioni<br />
seguenti sono secondo l'e<strong>di</strong>zione curata da E. Castelli, e<strong>di</strong>z. Bocca, Milano 1938.<br />
34
La novità piú vistosa dell‘opera è però costituita da un attacco, sommario nelle<br />
affermazioni, ma profondo nelle recriminazioni, alla Compagnia <strong>di</strong> Gesú.<br />
Che cosa Gioberti rimproverava ai Gesuiti?<br />
Essi avrebbero abbandonato l‘ideale evangelico, eroico, <strong>di</strong>alettico <strong>di</strong> Ignazio <strong>di</strong> Loyola e<br />
lo avrebbero sostituito con uno gretto e meschino e cioè la ―mondana ambizione e la subdola<br />
potenza‖ della Compagnia stessa 112 .<br />
Per raggiungere questo scopo (il prestigio ed il potere della Compagnia), ricorsero<br />
anche a mezzi illeciti od ad<strong>di</strong>rittura nefan<strong>di</strong>.<br />
Per questo motivo un grande Papa, Clemente XIV, li avrebbe giustamente soppressi sul<br />
finire del XVIII secolo. Pio VII, all‘inizio del XIX, li avrebbe ripristinati, nella speranza che<br />
essi tornassero al primitivo fervore 113 .<br />
A questo punto Gioberti si domanda se i Gesuiti abbiano risposto positivamente ai<br />
―nobili voti‖ <strong>di</strong> Pio VII, o non abbiano piuttosto ricalcato le orme del Gesuitismo degenere. Pur<br />
non negando la presenza <strong>di</strong> alcuni religiosi buoni e pii, il filosofo torinese ritiene che la<br />
Compagnia, come istituzione, abbia ripreso un cammino deteriore, nel quale si mostra anzi<br />
ostinata.<br />
Inoltre, parlando <strong>di</strong> Gesuitismo, «non si dee solamente intendere la Compagnia, ma ezian<strong>di</strong>o la<br />
sua clientela numerosissima e composta non d‘in<strong>di</strong>vidui spicciolati, ma <strong>di</strong> congreghe secolari e<br />
subalterne, che ricevono l‘impulso loro dal corpo principale e ne fanno penetrare gli spiriti per<br />
ogni dove....<br />
Ora tali congregazioni constano per or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> uomini ignoranti, i quali credono che lo<br />
spegnere il lume della ragione sia il miglior espe<strong>di</strong>ente per accendere quello della fede; <strong>di</strong><br />
fanatici, che stimano leciti i mezzi piú detestabili per conseguire un fine che reputano buono e<br />
santo; d‘ipocriti che si valgono della cecità e dello zelo dei loro confratelli per provvedere ai<br />
propri interessi o per saziare le loro cupi<strong>di</strong>gie d‘invi<strong>di</strong>a, <strong>di</strong> livore, <strong>di</strong> o<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> animosità, <strong>di</strong><br />
vendetta; e in fine <strong>di</strong> una folla <strong>di</strong> ingegni me<strong>di</strong>ocrissimi o nulli, buoni a far numero, nei quali<br />
non troveresti fiore <strong>di</strong> quelle virtú, che in alcuni Gesuiti risplendono» 114 .<br />
L‘azione <strong>di</strong> queste succursali, che sono la caricatura del Gesuitismo, deve essere <strong>di</strong>stinta<br />
da quella della Compagnia, ma questa si rende colpevole proteggendole e tutelandole.<br />
Scendendo piú dettagliatamente alle conseguenze negative dell‘ambizione dei Gesuiti,<br />
l‘abate torinese in<strong>di</strong>vidua le seguenti: combattono la civiltà quando sembra sottrarsi al loro<br />
dominio, si ingeriscono indebitamente negli affari pubblici e privati, si procurano ricchezze<br />
senza moderazione, si appropriano dell‘educazione per rendersi docili i giovani, cercano <strong>di</strong><br />
accattivarsi con le lusinghe e con le minacce gli uomini illustri, abusano del pulpito e del<br />
112 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit. 93: «All‘incontro i Gesuiti dei nostri giorni antepongono la loro<br />
dominazione a ogni altro rispetto e non cercano quegli altri beni, se non come cose secondarie,<br />
postergandoli sovente e anso immolandoli, se occorre, alla loro boria. In ciò consiste la funesta<br />
mutazione, a cui soggiacque l‘in<strong>di</strong>rizzo dell‘or<strong>di</strong>ne illustre, e per questo io <strong>di</strong>co che è anti<strong>di</strong>alettico per<br />
eccellenza, e che si <strong>di</strong>stingue essenzialmente da tutti gli altri instituti che onorano la Chiesa e le sono <strong>di</strong><br />
giovamento».<br />
113 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 87: «Chiunque venera il <strong>roma</strong>no seggio e gli porta nel cuore quella<br />
riverenza che i Gesuiti gli professano almeno nelle parole, dee credere che giusto e opportuno fu il<br />
decreto del Ganganelli, che furono vere e fondate le accuse che lo cagionarono; e che se ciò non ostante il<br />
suo successore ripristinò l‘or<strong>di</strong>ne illustre, egli intese <strong>di</strong> richiamarlo ai suoi principi, sapendo che i <strong>di</strong>fetti<br />
<strong>degli</strong> uomini non si hanno da imputare alle istituzioni. Perciò si dee conchiudere che il Chiaramonti si<br />
propose <strong>di</strong> risuscitare, non già i Gesuiti del secolo <strong>di</strong>ciottesimo, che colle esorbitanti ricchezze, con il<br />
traffico scolaresco, con il rilassamento dottrinale, colle <strong>di</strong>spute inutili, colle vessazioni religiose, con i<br />
clandestini maneggi, colle brighe <strong>di</strong> corte, aveano conciata contro <strong>di</strong> sé l‘opinione dei principi e dei<br />
popoli ed erano meritamente morti, ma bensí quei primi <strong>di</strong>scepoli e compagni <strong>di</strong> Ignazio, che con virtú<br />
straor<strong>di</strong>narie e con generose fatiche aveano conquistato l‘amore e l‘ammirazione dell‘universale. E il<br />
fece, pigliando fidanza che il terribile ammaestramento dato dal cielo ai degeneri ere<strong>di</strong> <strong>di</strong> quelli sarebbe<br />
stato proficuo, e che la Chiesa e la Società civile avrebbero ricevuti dai re<strong>di</strong>vivi Gesuiti quei servigi e<br />
conforti <strong>di</strong> sana dottrina, <strong>di</strong> can<strong>di</strong>do zelo e <strong>di</strong> prudente fervore, onde oggi tanto abbisognano».<br />
114 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 90 ss.<br />
35
confessionale per piegare gli animi delle persone semplici, particolarmente delle donne,<br />
annacquano la morale evangelica per non perdere la loro clientela 115 .<br />
Pur avvertendo <strong>di</strong> non potersi <strong>di</strong>lungare su ciascuno <strong>di</strong> questi punti in un <strong>di</strong>scorso<br />
proemiale, Gioberti tocca i punti per lui principali.<br />
Nel campo dell‘educazione i Gesuiti spegnerebbero la spontaneità e la volontà dei<br />
giovani. Come i Gesuiti devono rinunciare alla propria volontà e prestare alla Compagnia<br />
un‘obbe<strong>di</strong>enza passiva e cieca, cosí i giovani sarebbero educati a sacrificare per la Compagnia i<br />
piú cari affetti familiari, municipali, nazionali. L‘educazione gesuitica inoltre sarebbe priva <strong>di</strong><br />
virilità e formerebbe persone me<strong>di</strong>ocri e ipocrite 116 . L‘Autore rimprovera poi la Compagnia <strong>di</strong><br />
atteggiamento oscurantista verso le Università (Parigi, Torino) e <strong>di</strong> opporsi alla promozione<br />
sociale delle classi lavoratrici, nonché agli Asili Infantili 117 .<br />
115 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 94: «Essi sono costretti, non volendo deporre il superbo proposito,<br />
a combattere quella civiltà, che non vuole accettare il loro imperio, a cercar <strong>di</strong> spegnere quelle virtú che<br />
non sono ligie e devote alla loro ambizione, a tentar <strong>di</strong> rompere quegli ostacoli, che si attraversano al loro<br />
assoluto dominio. A tal effetto essi hanno per costume d‘ingerirsi in ogni luogo, dalle sale dei gran<strong>di</strong> e<br />
dalle reggie dei principi sino ai tuguri del povero, brigando <strong>di</strong> acquistare il favore per governare le<br />
coscienze dell‘universale; e quando trovano gli stati indocili e restii alla loro inframmettenza, ne<br />
apparecchiano la rovina, sia debilitandoli colle <strong>di</strong>ssenzioni religiose, sia perturbandoli colle <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>e<br />
politiche, spargendo massime concitatrici, e pre<strong>di</strong>cando, se occorre, la ribellione. A tal effetto<br />
procacciano <strong>di</strong> arricchire, per avere il modo <strong>di</strong> usufruttuar l‘in<strong>di</strong>genza o la cupi<strong>di</strong>tà <strong>degli</strong> uomini,<br />
ampliando con il denaro il numero dei loro clienti; ma siccome una me<strong>di</strong>ocre opulenza a ciò non basta,<br />
s‘ingegnano <strong>di</strong> accrescerla, carpendo i doni e i re<strong>di</strong>taggi. A tal effetto si <strong>stu<strong>di</strong></strong>ano <strong>di</strong> recarsi in mano<br />
l‘educazione dei fanciulli e dei giovani per rendersi docili ed ossequienti le future generazioni; e quando<br />
trovano nei loro alunni una tempra d‘ingegno e d‘animo ar<strong>di</strong>ta e gagliarda, che potrebbe mettere in<br />
compromesso la loro balía, essi usano ogni arte per innervarla, ammollirla, conquiderla.<br />
... A tal effetto finalmente abusano dell‘amministrazione delle anime e del pulpito cristiano,<br />
onde maneggiare piú agevolmente gli intelletti ed i cuori, me<strong>di</strong>ante la molla efficace della religione, e<br />
<strong>di</strong>spor sopratutto <strong>di</strong> quel sesso che supplisce alla forza con la gentilezza, e ha sovente nel nostro vivere<br />
moderno una partecipazione notabile agli affari pubblici e privati; ma siccome l‘austera morale<br />
dell‘Evangelo restringerebbe <strong>di</strong> troppo questo campo, perché non molti sono coloro, che si risolvono <strong>di</strong><br />
professarla, essi per ampiarlo ed accrescere il novero dei propri sud<strong>di</strong>ti nelle cose <strong>di</strong> spirito, travisano la<br />
santa legge <strong>di</strong> Cristo, piegandola alle cupi<strong>di</strong>gie, e recandola a un tal rilassamento, che i savi del<br />
gentilesimo se ne sarebbero vergognati. Sono alienissimo dall‘asserire, quante volte dovrò replicarlo? che<br />
tutti i Gesuiti si rendano complici <strong>di</strong> questi eccessi; ma tali sono, generalmente parlando, le consuetu<strong>di</strong>ni<br />
della loro fazione, e tali debbono essere, da che, posposto il santo fine del fondatore, essi han rivolto le<br />
loro cure all‘acquisto <strong>di</strong> una mondana potenza».<br />
116 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 112 ss. : «Ora i Gesuiti fanno tutto il contrario; e frangendo i<br />
nervi del volere, prostrando la ragione, spegnendo l‘affetto, tarpando le ali all‘immaginativa, adusando i<br />
loro alunni a <strong>di</strong>ffidare soverchiamente <strong>di</strong> sé, a <strong>di</strong>pendere ciecamente dagli altrui cenni, a non sapersi<br />
risolvere, a essere impacciati..., imprimono ad essi un abito gretto e meticoloso, una mollezza d‘affetti,<br />
una meschinità <strong>di</strong> cuore, una pusillanimità <strong>di</strong> spiriti, una docilità funesta <strong>di</strong> animo, che lo rende<br />
pieghevole al male come al bene, anzi piú a quello che a questo, quanto meglio il primo è corroborato<br />
dalle inclinazioni della natura corrotta e dalle attrattive del mondo».<br />
117 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 116: «Non importa che il re<strong>di</strong>mere la povera plebe dai mali che la<br />
travagliano e il nobilitar la classe piú benemerita del consorzio umano, come quella che lo sostenta con i<br />
sudori e colle fatiche, sia un debito strettamente <strong>di</strong> carità e <strong>di</strong> giustizia imposto dall‘Evangelio agli uomini<br />
<strong>di</strong>sciplinati e ai governi dei paesi cristiani; non importa in fine che gli stati si avvantaggino non poco <strong>di</strong><br />
questi miglioramenti dal canto della ricchezza, della potenza, della moralità pubblica e privata, e <strong>di</strong> tutto<br />
ciò che fa crescere e fiorire le civili popolazioni. Tali avvertenze non sono <strong>di</strong> alcun peso per la coscienza<br />
<strong>di</strong> una fazione dura e spietata, che si fa giuoco <strong>degli</strong> affetti piú sacri, che posterga alle sue mire ambiziose<br />
ogni riguardo e che, conoscendo il suo miglior fondamento essere l‘ignoranza e l‘abiezione dei piú,<br />
contrasta gagliardamente a ciò che potria <strong>di</strong>ssiparla e porvi rime<strong>di</strong>o. Onde nasce la sua avversione verso<br />
quelle scuole infantili, che <strong>di</strong>ffuse in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, nella Germania, in America,<br />
vennero anco introdotte in alcuni stati italiani e segnatamente in Lombar<strong>di</strong>a per le cure generose <strong>di</strong><br />
Ferrante Aporti; delle quali Giovanni Arrivabene, promotore anch‘egli oculato e fervente <strong>di</strong> civiltà<br />
popolana, ci <strong>di</strong>ede una succinta notizia. Ma i Gesuiti moderni, a cui piange il cuore che l‘alfabeto e la<br />
stampa non si possono sterminare dal mondo, non vogliono almeno che i poveri fanciulli imparino a<br />
leggere e a scrivere, né che avvezzandosi a gustare i nobili <strong>di</strong>letti dello spirito, si premuniscano contro<br />
36
In campo politico i Reveren<strong>di</strong> Padri sono rimproverati <strong>di</strong> favorire il <strong>di</strong>spotismo e<br />
avversare le Costituzioni, la libertà, il progresso.<br />
La loro presenza, fasti<strong>di</strong>osa ma non pericolosa in uno Stato forte e unitario, può essere<br />
deleteria in una nazione <strong>di</strong>visa ed oppressa, come l‘Italia: «A ciò debbono pensare seriamente<br />
tutti i buoni Italiani, perché, sebbene molte sieno le cagioni dello stato miserando in cui si trova<br />
la nostra patria, io oso <strong>di</strong>re che la prima <strong>di</strong> esse è il Gesuitismo, questo è il verme che ci rode, la<br />
cancrena che ci <strong>di</strong>vora, la peste che ci uccide, e da esso nascono, per <strong>di</strong>retto o per in<strong>di</strong>retto tutti i<br />
nostri travagli e dolori» 118 .<br />
Gioberti ammette in effetti che il nemico principale dell‘Italia sia l‘Austria, ma ritiene<br />
che i Gesuiti siano il principale alleato e puntello del dominio austriaco in Italia 119 .<br />
Il Gesuitismo tuttavia non è nocivo solo dal lato civile e temporale. Anche nel campo<br />
religioso, dopo un inizio positivo, la Compagnia <strong>di</strong>venne fonte <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione e <strong>di</strong> intolleranza.<br />
Attraverso un abuso del casismo si <strong>di</strong>ffuse poi una morale rilassata, che corrompe la sublimità <strong>di</strong><br />
quella evangelica. A ragione Biagio Pascal la combatté, e malgrado non sia privo <strong>di</strong> deviazioni<br />
l‘ozio <strong>di</strong>ssoluto e le ignobili abitu<strong>di</strong>ni, che avviliscono e addecimano la plebe delle città. Perciò non<br />
ebbero rossore <strong>di</strong> male<strong>di</strong>re in Genova ed altrove dal pulpito cristiano le pietose scuole, seminando vili ed<br />
assurde calunnie contro l‘uomo illibato e venerabile, a cui il governo sardo affidava l‘assunto <strong>di</strong> avviare<br />
in Piemonte il benefico istituto».<br />
118 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 120. L‘Autore continua in una serrata polemica: «È il Gesuitismo<br />
che scre<strong>di</strong>ta, molesta, tribola, calunnia perseguita, rovina i valorosi ingegni, gli uomini dotati <strong>di</strong> libero<br />
arbitrio, <strong>di</strong> petto forte e magnanimo, animosi e prudenti, esperti e operosi, atti ad ideare ed eseguire, a<br />
conservare e a riformare, a comporre <strong>di</strong>aletticamente il passato e l‘avvenire, le tra<strong>di</strong>zioni e le speranze,<br />
l‘antico e il moderno, il ristauro e le innovazioni; i quali uomini sono quelli che possono suggerire,<br />
cominciare, aiutare, promuovere, effettuare, condurre a prospero fine le gran<strong>di</strong> imprese <strong>di</strong> civiltà e <strong>di</strong><br />
pace, che partoriscono od accrescono la felicità dei popoli e la gloria de‘ principi. È il Gesuitismo, che<br />
rimossi o spiantati dai carichi pubblici i buoni e i valenti, vi sostituisce i dappochi, i tristi ed i vili, e non<br />
contento <strong>di</strong> agguagliare gl‘inferiori ai sommi, secondo il costume <strong>di</strong> quell‘antico re, che pareggiava con il<br />
bacolo gli steli del suo verziere, attende a calcare i sommi, e a sollevare gli infimi sulle loro cervici. È il<br />
Gesuitismo, che rende eccessive ed intollerabili la censura dei libri e la servitú della stampa, che rallenta,<br />
inceppa molesta, frastorna, indebolisce, corrompe in mille guise l‘istruzione pubblica e privata,<br />
elementare e sublime, nobile e popolana, ecclesiastica e scolaresca, speciale ed universale, e che insomma<br />
favorisce la miseria, l‘ozio, la <strong>di</strong>ssolutezza degl‘in<strong>di</strong>genti e dei doviziosi, inimicando le industrie,<br />
accrescendo la poveraglia, creando ostacoli al traffico, e scomunicando persino dalla cattedra evangelica<br />
le vie ferrate e le macchine a vapore. È il Gesuitismo, che semina rancori, <strong>di</strong>ffidenze, animosità, o<strong>di</strong>,<br />
<strong>di</strong>scor<strong>di</strong>e palesi e nascoste fra gli in<strong>di</strong>vidui, le famiglie, le classi, i municipi, le provincie, gli stati, governi<br />
ed i popoli, confidandosi <strong>di</strong> vincere e schiacciare <strong>di</strong>sgiunte quelle forze, che riunite insieme vorrebbe<br />
indarno signoreggiare. È il Gesuitismo, che arrozzisce gl‘intelletti coll‘ignoranza, doma i cuori e i voleri<br />
coll‘ignavia, snerva i giovani con una molle <strong>di</strong>sciplina, corrompe l‘età matura con una morale arrendevole<br />
ed ipocrita, e combatte, intiepi<strong>di</strong>sce, spegne l‘amicizia, gli affetti domestici, la pietà filiale, il santo amor<br />
della patria nel maggior numero dei citta<strong>di</strong>ni. È il Gesuitismo infine, che in<strong>di</strong>rizza a tutti questi<br />
lacrimevoli effetti le dottrine e le pratiche religiose, travolgendone i dettati, alternandone gli spiriti,<br />
spogliandole della essenza loro, e mutando la cosa piú augusta e salutare del mondo nella piú nociva ed<br />
ignobile, cioè la fede in superstizione».<br />
119 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 123 ss. : «E qual meraviglia che l‘Austria e la Compagnia abbiano<br />
contratta insieme amicizia e alleanza, poiché mirano a uno scopo comune, e aiutandosi scambievolmente,<br />
si rendono piú facile il conseguirlo? Il quale scopo si è <strong>di</strong> tener la penisola <strong>di</strong>visa, debole, inferma,<br />
affinché torni ad entrambe piú spe<strong>di</strong>to l‘accollarle il giogo e metterla in catena ... Certamente l‘Italia, a<br />
cui mancano con l‘unità tutte le altre parti del perfetto vivere civile, non potrà mai ottenerle finché vi<br />
signoreggia la setta concitatrice; la quale, ravvisando a buona ragione nel risorgimento della penisola la<br />
propria rovina, farà sempre ogni opera per impe<strong>di</strong>rlo. Ora siccome tutti i buoni ingegni sono d‘accordo ...<br />
che l‘unione per via <strong>di</strong> lega è al dí d‘oggi il solo effettuabile, siccome da tale unione <strong>di</strong>pende il rime<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
tutti i mali che ci affliggono, e l‘acquisto dei beni che possiamo ragionevolmente desiderare; siccome<br />
vano è lo sperare <strong>di</strong> conseguirla, finché l‘Italia non è padrona <strong>di</strong> se stessa, finché si sobbarca e soggiace al<br />
dominio straniero; siccome i Gesuiti sono tenerissimi <strong>di</strong> questo domino appunto perché mette un<br />
insuperabile ostacolo a quella congiunzione, che essi tengono per infesta, non che all‘aumento, alla<br />
conservazione della loro potenza; ne segue che la fazion <strong>di</strong> costor, inseparabile dall‘imperio e dalla<br />
influenza dei barbari, è la sorgente principale delle sventure italiane, e che debbono contro <strong>di</strong> essa<br />
rivolgersi unanimi e volenterosi tutti i leali ed ardenti amatori della comune patria».<br />
37
giansenistiche, la sua lotta alla morale rilassata dei Gesuiti rimane valida. Con Pascal, Gioberti<br />
ammette che i Gesuiti, personalmente, non si comportino con il rilassamento che permettono<br />
agli altri, né desiderino corrompere la morale evangelica, tuttavia per non perdere la loro<br />
clientela, finiscono per tollerare o anche proteggere <strong>degli</strong> autentici abusi.<br />
«Ra<strong>di</strong>ce logica <strong>degli</strong> scandali, in cui trascorrono i casisti, è il probabilismo per cui i<br />
doveri piú sacrosanti perdono la loro forza, <strong>di</strong>ventando lu<strong>di</strong>brio e zimbello dell‘umano<br />
ingegno» 120 .<br />
L‘Autore accusa poi il Molinismo, <strong>di</strong> <strong>di</strong>storcere la sana dogmatica 121 .<br />
Conseguenze pratiche <strong>di</strong> queste impostazioni sono, sul piano pastorale, la preferenza<br />
delle pratiche esterne alle virtú interiori, la proliferazione delle devozioni secondarie a scapito<br />
delle liturgie antiche, l‘importanza data ai precetti umani anziché a quelli <strong>di</strong>vini, l‘accento posto<br />
sugli elementi secondari anziché centrali della Fede.<br />
Inoltre i Gesuiti propugnerebbero un ideale ascetico incompatibile con la cultura<br />
contemporanea e legato a schemi storici del passato.<br />
Nel culto deturperebbero la semplicità originaria, nella <strong>di</strong>sciplina obbe<strong>di</strong>rebbero solo<br />
finché ritornasse loro utile.<br />
Con tutte queste <strong>di</strong>storsioni, secondo il filosofo torinese, la Compagnia rende<br />
spregevole la religione agli occhi <strong>di</strong> molti uomini del suo tempo 122 .<br />
Facendo questa accusa, Gioberti intende riferirsi agli effetti delle loro opere, non alle<br />
intenzioni dei Gesuiti.<br />
Tuttavia «Il male è oggimai cosí grave che sarebbe empietà il <strong>di</strong>ssimularlo,<br />
massimamente che gli autori <strong>di</strong> esso osano spacciarsi per i <strong>di</strong>fensori piú periti della fede<br />
ortodossa e pei sostegni piú vali<strong>di</strong> della sua causa» 123 .<br />
Il Piemontese contesta a lungo questa pretesa, basandosi sul fatto che nessun istituto<br />
umano, per quanto benemerito, può essere in<strong>di</strong>spensabile alla Chiesa, che è un istituto <strong>di</strong> origine<br />
<strong>di</strong>vina.<br />
Perciò Gioberti condanna l‘usanza, attribuita ai gesuiti, <strong>di</strong> considerare nemico del<br />
Cattolicismo chi non favorisce la Compagnia.<br />
Secondo l‘Autore invece, tra Cattolicesimo e Gesuitismo esiste una <strong>di</strong>fferenza<br />
sostanziale 124 . Il primo infatti è universale, amante della civiltà, della libertà, tollerante,<br />
immutabile nella sostanza ma progressivo nelle deduzioni, valido, forte, italiano. Al contrario il<br />
120 L‘Autore continua: «Imperocché nelle cose morali tra la debolezza nativa o le nebbie dello spirito, per<br />
le agitazioni, le tempeste del cuore, e per la moltitu<strong>di</strong>ne, la varietà, l‘intrico dei fatti e delle circostanze<br />
loro, la certezza riducendosi spesso a una grande probabilità, che <strong>di</strong>s<strong>di</strong>ce al probabile, che sovrasta <strong>di</strong><br />
peso al suo contrario, la virtú obbligatrice, toglie in mille casi ogni freno alle passioni dell‘animo, e apre<br />
la via a un pirronismo <strong>di</strong> intelletto, che può <strong>di</strong>ventare talvolta quasi assoluto e universale».V. GIOBERTI,<br />
Prolegomeni, op. cit., 129.<br />
121 In una nota a piè <strong>di</strong> pagina Gioberti precisa: «La connessione del Molinismo colle principali eresie fu<br />
chiarita da molti. Si noti però che io sono lontanissimo dall‘affermare e dal credere che i Gesuiti facciano<br />
buone le conseguenze funeste <strong>di</strong> questo sistema, o che sia illecito il professarlo, come opinione, nei<br />
termini ortodossi».V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 130, nota I.<br />
122 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 134: «Chi dunque potrà meravigliarsi che una instituzione, la<br />
quale corrompe la morale, offende il dogma, avvilisce il culto, snerva la <strong>di</strong>sciplina, debilita la gerarchia,<br />
non lascia intatta alcuna parte delle cose sacre, e pretessendo un pio zelo alle proprie opere, comprime,<br />
altera, traveste, affievolisce, combatte, estingue l‘ingegno, il sapere, il costume, gli affetti domestici, la<br />
buona educazione, la virtú civile, la libertà patria, l‘unità politica, l‘in<strong>di</strong>pendenza nazionale, e tutto quanto<br />
il corredo, gli acquisti, i voti, le speranza dell‘incivilimento, in nome della religione, la renda spregevole,<br />
ri<strong>di</strong>cola, o<strong>di</strong>osa, formidabile al mondo? Eccovi la colpa capitale del Gesuitismo, il pericolo piú grave, il<br />
danno supremo, che ne ridonda all‘orbe cristiano, la somma delle accuse, che lo fecero abolire nel secolo<br />
scorso, e che ora meritano <strong>di</strong> essere rinnovellate con tanto piú <strong>di</strong> vigore, quanto che agli antichi falli si<br />
aggiunge una cecità e una pervicacia incre<strong>di</strong>bile».<br />
123 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 135.<br />
124 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 142: «Ciascuno può ritrarre dalle cose <strong>di</strong>scorse quanto s‘ingannino<br />
coloro che mescolano e ragguagliano due instituti cosí <strong>di</strong>spari per ogni verso, come sono la religione<br />
cattolica e la setta gesuitica».<br />
38
Gesuitismo è parziale, nemico della civiltà, del progresso, della filosofia, incerto nei principi,<br />
stazionario e retrogrado, intollerante, misero e fiacco, infesto alla nostra penisola.<br />
Terminando il lungo raffronto, l‘abate conclude: «Finalmente il cattolicismo è <strong>di</strong>alettico<br />
per eccellenza, e questa proprietà, che nasce principalmente dal suo genio universale cosí verso<br />
le cose, come verso le cognizioni, compen<strong>di</strong>a tutte le altre, <strong>di</strong> cui abbiamo <strong>di</strong>scorso, essendone<br />
ad un tempo il principio e l‘effetto; dove che il Gesuitismo è sofistico, e da per tutto dove<br />
s‘insinua attizza le opposizioni, vietando loro <strong>di</strong> ridursi ad amichevole temperamento» 125 .<br />
Quali sono i rime<strong>di</strong> per questo male?<br />
Negli Stati dove non sono ammessi i Gesuiti, si raccomanda <strong>di</strong> non introdurli. Negli<br />
altri, se il principe non se la sente <strong>di</strong> liberarsene, è però opportuno negar loro ogni patrocinio ed<br />
impe<strong>di</strong>re che si intromettano nell‘educazione e nella politica, ed anche che sfruttino la religione<br />
a fini reazionari o per acquisire donazioni e lasciti.<br />
«Cosí facendo, senza ricorrere a mezzi straor<strong>di</strong>nari, ma con savie e apposite leggi<br />
puntualmente eseguite, i governi italiani non solo provvederanno al bene dei loro sud<strong>di</strong>ti, ma a<br />
quello dei Gesuiti medesimi, inducendoli ad essere buoni, se non per amore, almeno per<br />
forza...» 126 .<br />
Per Gioberti è compito sia dei laici che dei chierici combattere il Gesuitismo. I primi<br />
devono <strong>di</strong>stinguere bene tra Cattolicesimo e Gesuitismo, e nel combattere quest‘ultimo devono<br />
rispettare il primo. Il clero, dal canto suo, deve evitare ogni ―connivenza e comunella‖ con esso<br />
e mostrare con i fatti la <strong>di</strong>stanza tra la religione cattolica e la setta dei Gesuiti. Questo è<br />
particolarmente importante perché molti attribuiscono all‘intera religione cattolica, e al papato,<br />
le dottrine e il comportamento della Compagnia 127 .<br />
Nel contrastare la Compagnia il clero dovrebbe usare moderazione, <strong>di</strong>stinguendo tra la<br />
Compagnia <strong>di</strong> Gesú delle origini ed il Gesuitismo degenere, onorando la virtú laddove si<br />
manifesti, biasimando gli errori dell‘istituzione e non gli uomini 128 .<br />
125 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 148. L‘Autore continua: «Il contrasto <strong>di</strong> tali due doti compie il<br />
quadro delle contrarietà capitali, che corrono fra le due instituzioni, e ci ad<strong>di</strong>ta la <strong>di</strong>versa loro origine;<br />
giacché la prima, essendo sommamente conciliativa, si fonda nel principio <strong>di</strong> creazione e muove da quello<br />
spirito, che riuní i cuori e le favelle, quando il Cristianesimo nascente rimise il dogma primigenio in<br />
onore, laddove la seconda, perturbatrice <strong>di</strong> sua natura e nemica dell‘unità, s‘innesta nel panteismo, i cui<br />
primi semi entrarono nel mondo rinnovellato allorché la <strong>di</strong>visione babelica <strong>degli</strong> animi e delle lingue,<br />
sottentrò alla nativa concor<strong>di</strong>a del genere umano».<br />
126 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cít., 143.<br />
127 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 152 ss. : «Questi lieti principii e cosí ben promettenti tornarono a<br />
nulla per opera del Gesuitismo, che non contento <strong>di</strong> scandalizzare il mondo con le sue imprese, è giunto a<br />
persuadere a nove decimi <strong>di</strong> coloro che parlano e scrivono nei paesi cristiani, la <strong>Santa</strong> Sede essere<br />
consigliera e fautrice delle dottrine e dei portamenti della Compagnia, che è quanto <strong>di</strong>re nemica ban<strong>di</strong>ta<br />
dei popoli e <strong>di</strong> ogni progresso civile. Grazie ai Gesuiti tutte le vecchie accuse <strong>di</strong>messe contro Roma<br />
ringiovaniscono e vengono agitate, come Dio vel <strong>di</strong>ca, da una follia <strong>di</strong> fogliettisti e <strong>di</strong> scrittorelli, che<br />
s‘intendono <strong>di</strong> queste materie, quanto i ciechi della prospettiva, ma che mostrano con la violenza dei loro<br />
<strong>di</strong>scorsi la vivacità dei rancori ripullanti. Ora egli tocca agli uomini religiosi, e specialmente ai chierici, il<br />
rime<strong>di</strong>are a un sí gran male, <strong>di</strong>singannando i popoli, restituendo alla <strong>Santa</strong> Sede la riverenza che le è<br />
dovuta, e soprattutto assuefacendo gl‘intelletti a <strong>di</strong>stinguerla da ciò che non è dessa e non appartiene alla<br />
sua essenza».<br />
128 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 153 ss. : «Né paia ad alcuno poco <strong>di</strong>cevole all‘ufficio e al decoro<br />
sacerdotale il contrastare moderatamente ad un or<strong>di</strong>ne tollerato dalla Chiesa; perché lo scrupolo sarebbe<br />
ragionevole ogni qual volta il silenzio fosse permesso dall‘amore e dalla riverenza dovuta alla madre<br />
comune. Ma quando all‘incontro il bene evidente <strong>di</strong> questa vuol che si parli, quando si tratta <strong>di</strong><br />
smascherare i suoi piú gravi nemici, <strong>di</strong> mantenere illibato nel concetto <strong>di</strong> molti il suo onore, ogni<br />
<strong>di</strong>ssimulazione sarebbe colpevole e dannosa. Dico moderatamente, affinché niuno creda che io voglia<br />
comechessia approvare e giustificare quei termini e or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> guerra, che oggi si costumano in alcuni paesi<br />
e soprattutto in Parigi. La riserva e la <strong>di</strong>screzione nello svelare e combattere i <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni e gli abusi <strong>di</strong> ogni<br />
sorta, sono prescritti universalmente, ma soprattutto ai chierici, soprattutto allorché si <strong>di</strong>scorre <strong>di</strong> un<br />
istituto, che per quanto sia sviato dal buon cammino, non è escluso dal seno della Chiesa e ne fu<br />
benemerito nella sua origine. Distinguasi adunque il Gesuitismo antico e primitivo dal moderno, la pianta<br />
nobile, fruttifera e salubre dallo sterpigno imbozzacchito e degenere, e si rendano al primo largamente e<br />
sinceramente tutte le lo<strong>di</strong>, <strong>di</strong> cui è meritevole. E anche nella setta coetanea si <strong>di</strong>scerna accuratamente il<br />
39
L‘obbligo <strong>di</strong> osteggiare il Gesuitismo riguarda non solo gli scrittori italiani, ma anche<br />
quelli <strong>di</strong> tutta l‘Europa, sia perché il sostegno dato dalla Compagnia alle monarchie assolute si<br />
oppone al generale movimento culturale verso gli or<strong>di</strong>ni rappresentativi, sia perché il<br />
Cattolicesimo potrà vincere la sfida rappresentata dal Razionalismo solo a patto <strong>di</strong> liberarsi dalle<br />
degenerazioni gesuitiche.<br />
Gioberti si ferma quin<strong>di</strong> un attimo a considerare le vie possibili <strong>di</strong> una trasformazione<br />
della Compagnia <strong>di</strong> Gesú, non volendo precludere nessuna via ad una conversione, giu<strong>di</strong>cata per<br />
altro quasi impossibile.<br />
La prima via sarebbe quella <strong>di</strong> riconciliarsi con i tempi, <strong>di</strong> precorrere la civiltà e <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ventare un Or<strong>di</strong>ne religioso ―altamente incivilitore‖ 129 .<br />
Una seconda possibilità sarebbe quella <strong>di</strong> rinunciare ad ingerirsi negli affari civili,<br />
limitandosi al ministero religioso, come la maggioranza <strong>degli</strong> altri Or<strong>di</strong>ni religiosi fanno 130 .<br />
Ultimo partito sarebbe <strong>di</strong> abbandonare l‘Europa e de<strong>di</strong>carsi alle missioni 131 .<br />
Prima <strong>di</strong> concludere la parte relativa al Gesuitismo, Gioberti sente il bisogno <strong>di</strong> riba<strong>di</strong>re<br />
il perché <strong>di</strong> questa polemica, e <strong>di</strong> giustificare quin<strong>di</strong> il silenzio tenuto precedentemente 132 .<br />
Dopo aver ricordato il suo esilio, che attribuisce alle <strong>di</strong>ffamazioni della setta presso le<br />
autorità, egli si sarebbe trovato in una posizione delicata, per non dare la sensazione <strong>di</strong><br />
mescolare questioni personali a problemi <strong>di</strong> carattere teorico. «Perciò quando nel 1839 -<br />
continua il filosofo - io <strong>di</strong>stesi la mia Introduzione, dove mi accadde la prima volta <strong>di</strong> far cenno<br />
ai Gesuiti, riprovando in modo espresso benché generico, l‘educazione che si porge da loro, e<br />
certi pareri dottrinali <strong>di</strong> cui fanno special professione, mi <strong>stu<strong>di</strong></strong>ai <strong>di</strong> usare i mo<strong>di</strong> piú cortesi e piú<br />
riverenti, per rimuovere ogni sospetto e ombra <strong>di</strong> rancore dalle mie intenzioni e dal mio<br />
buono dal tristo; perché il male nelle cose umane non è quasi mai <strong>di</strong>sgiunto dal bene, non tutte le parti<br />
della Compagnia sono degne <strong>di</strong> censura e <strong>di</strong> biasimo, specialmente per ciò che concerne le operazioni<br />
in<strong>di</strong>viduali, anzi che l‘azione collettiva e le comuni influenze. Si onorino insomma la virtú, l‘ingegno, la<br />
dottrina, la pietà lo zelo, dovunque si trovano; ma si <strong>di</strong>stingua l‘uomo dal Gesuita; e i biasimi feriscano<br />
sempre le parti viziose dell‘Or<strong>di</strong>ne, non mai le persone; perché inonesta, brutta, infame, è la consuetu<strong>di</strong>ne<br />
invalsa al dí d‘oggi presso certuni, che pur si vantano <strong>di</strong> religione, <strong>di</strong> lacerar la fama e la vita altrui sotto<br />
pretesto <strong>di</strong> confutar l‘errore e <strong>di</strong> provvedere alla utilità pubblica».<br />
129 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op cit., 160: «Il primo <strong>di</strong> tali partiti sarebbe quello <strong>di</strong> trasformarsi<br />
compitamente, <strong>di</strong> mettersi in accordo coll‘indole migliorata dei tempi, <strong>di</strong> precorrere alla civiltà in vece <strong>di</strong><br />
fermarla, e <strong>di</strong> eseguire ciò che quella gran testa d‘Ignazio <strong>di</strong> Loyola tenterebbe forse <strong>di</strong> fare, se tornasse<br />
fra gli uomini, supplendo a un bisogno manifesto della Cristianità nei giorni nostri, e somministrandole un<br />
Or<strong>di</strong>ne religioso altamente incivilitore, che con il capitanare il secolo acefalo e sviato, e con il<br />
costringerlo a riconoscere l‘autorità propria colla triplice forza irrepugnabile <strong>di</strong> una virtú austera, <strong>di</strong> molti<br />
ingegni eminenti e <strong>di</strong> una dottrina straor<strong>di</strong>naria, emendasse e perfezionasse gli andamenti <strong>di</strong> esso».<br />
130 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 161: «Un altro spe<strong>di</strong>ente <strong>di</strong> piú facile esecuzione sarebbe quello<br />
d‘imitare gli altri Or<strong>di</strong>ni religiosi, rinunziando a ogni ingerenza civile, ritirandosi nel santuario,<br />
<strong>di</strong>smettendo ogni ambizione e cura secolaresca, riducendosi alla sola amministrazione delle anime, e<br />
cercando insomma <strong>di</strong> farsi <strong>di</strong>menticare dal mondo. Ma una ritratta assoluta, benché onorevole, è troppo<br />
aliena dalle inclinazioni e dalla consuetu<strong>di</strong>ne dei Gesuiti; i quali si brigano soprattutto <strong>di</strong> menar gran<br />
romore, <strong>di</strong> far parlare <strong>di</strong> sé a ogni modo, <strong>di</strong> occupar gli animi e le passioni <strong>degli</strong> uomini, se non altro,<br />
colle risse, con i tafferugli, e cogli scandali, e sogliono antiporle all‘oscurità e al silenzio una fama assai<br />
dubbia, poco talvolta <strong>di</strong>ssimile dall‘infamia».<br />
131 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 161: «Per ultimo partito non meno spiccio ed agevole a effettuarsi<br />
che il secondo, e forse piú utile, piú nobile e pellegrino, la Compagnia potrebbe abbandonare l‘Europa, a<br />
cui è d‘ingombro e <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio, trapiantandosi nell‘Asia, nell‘America, nell‘Africa, nell‘Oceania, quasi<br />
colonia apportatrice <strong>di</strong> religione e d‘incivilimento presso tante infelici nazioni barbare e selvagge, che<br />
mancano affatto <strong>di</strong> questi due beni. Egli è certo cosa assai singolare, che i Gesuiti ostentando tanto amor<br />
delle anime, tanto zelo per la propagazione della fede, per la <strong>di</strong>latazione della Chiesa, contemplino con<br />
occhio tranquillo la cecità e la miseria dei popoli innumerabili, e invece <strong>di</strong> correre in aiuto loro e <strong>di</strong><br />
assumere un‘impresa, dove la messe sarebbe abbondante, il guadagno certo e gran<strong>di</strong>ssimo,<br />
s‘incaponiscono a rimaner nei paesi, dove son piú atti a dannar gli uomini che a salvarli, e riescano assai<br />
meglio a spegnere la religione che a metterla in fiore».<br />
132 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 164: «Egli è con rincrescimento e dolore, lo <strong>di</strong>co non per<br />
cerimonia, ma con tutta l‘anima, ch‘io sono entrato in questo <strong>di</strong>scorso sui Gesuiti; e non mi sarei indotto a<br />
farlo, se un debito piú grave <strong>di</strong> ogni altro riguardo non mi ci obbligasse».<br />
40
<strong>di</strong>scorso» 133 . «Qualche anno dopo, dettando il presente libro - è ancora Gioberti che scrive<br />
riferendosi al Primato - in cui mi propongo principalmente riunire al possibile i pareri e gli<br />
animi de‘ miei nazionali a pro della comune patria, io non poteva tacere, né passarmi<br />
brevemente dei Gesuiti, come quelli che occupano un luogo notabile ed hanno un potere non<br />
piccolo in molte parti della penisola. E stando che dovessi parlarne, il lodarli senza riserva,<br />
tacendo affatto ai <strong>di</strong>fetti e ai vizi del loro instituto, non mi era consentito né dal mio decoro e dal<br />
mio costume, alieno da ogni simulazione, né dalla verità e dallo scopo del libro, essendo io<br />
persuaso che il Gesuitismo, com‘è presentemente, è uno dei principali ostacoli al riscatto<br />
d‘Italia. D‘altra parte il rimproverare a viso aperto i vizi della setta, messi da canto, come si<br />
<strong>di</strong>ce, i convenevoli e le cerimonie, e venendo a spada tratta, non mi pareva opportuno per piú<br />
ragioni» 134 .<br />
L‘Autore in<strong>di</strong>ca tra queste il fine dello scritto, che consisteva nel conciliare l‘animo <strong>di</strong><br />
tutti i connazionali all‘unione italica; la necessità <strong>di</strong> mostrare prudenza per non essere biasimato<br />
<strong>di</strong> rancore, temerarietà, leggerezza, in<strong>di</strong>screzione 135 . Vi era inoltre la speranza, molto tenue in<br />
verità, che l‘Or<strong>di</strong>ne si correggesse, cessasse <strong>di</strong> combattere il progresso, contribuisse al<br />
risorgimento della nazione 136 .<br />
133 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 164. Con una nota in calce, l‘Autore rimanda alle pagine <strong>di</strong> cui<br />
parla e cioè al suo libro: Introduzione allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della Filosofia, Bruxelles 1840, prima e<strong>di</strong>zione, tom. I°,<br />
178 - 180; tom. II, 814 - 824, 875 - 876.<br />
134 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 164 ss.<br />
135 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 165: «Io doveva inoltre parlare in modo, che il mio <strong>di</strong>re fosse<br />
giustificato e non potesse essere ascritto a privato risentimento né tassato <strong>di</strong> leggerezza, <strong>di</strong> temerità,<br />
d‘in<strong>di</strong>screzione; biasimi, nei quali sarei incorso senza alcun fallo presso molti, censurando apertamente un<br />
illustre instituto, tollerato dalla Chiesa, <strong>di</strong>ffuso per la Cristianità, prima <strong>di</strong> esser ben chiaro che i suoi vizi<br />
e <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni non siano capaci <strong>di</strong> emendazione. Egli è debito dell‘uomo prudente il non ricorrere ai rime<strong>di</strong><br />
estremi, se non quando si sono sperimentati inutilmente le me<strong>di</strong>cine meno forti e men dolorose; e<br />
quest‘obbligo universale milita in ispecie per gli scrittori, i quali non credono che lo scrivere sia manco<br />
soggetto alla legge morale dell‘operare, e antipongono la moderazione ad ogni altro rispetto. E io mi<br />
trovo in questo caso forse piú <strong>di</strong> altri autori; perché facendo professione <strong>di</strong> una dottrina, che aborrisce da<br />
ogni esclusività ed intolleranza, che osserva come norma suprema la <strong>di</strong>alettica conciliatrice, che ammette<br />
il libero conflitto <strong>di</strong> tutte le varietà e opposizioni naturali, e non avversa se non quelle, che si mostrano<br />
assolutamente restie al reciproco accordo, non potea, senza contrad<strong>di</strong>rmi, avere il Gesuitismo per tale,<br />
tenerlo per incorreggibile affatto, pre<strong>di</strong>care per <strong>di</strong>sperata la sua guarigione, e assalirlo come nemico,<br />
finché mi rimaneva un filo <strong>di</strong> speranza <strong>di</strong> poter convincerlo dei suoi torti, chiarirlo dei suoi veri interessi e<br />
ridurlo a piú sani consigli».<br />
136 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 165 ss. : «Dico un filo <strong>di</strong> speranza e anche molto tenue; che<br />
quantunque io abbia il piú alto concetto della sagacità, della penetrativa, della profonda politica de‘ miei<br />
critici, non vorrei però che a loro ragguaglio mi stimassero semplice affatto e cosí dolce <strong>di</strong> sale, che io<br />
possa avere giammai tenuto per molto probabile la conversione dei Gesuiti. La quale all‘incontro mi<br />
parve sempre <strong>di</strong>fficilissima; onde, parlando <strong>di</strong> essi nel mio libro, secondo quei termini che il lettor può<br />
vedere, io non <strong>di</strong>ssimulai punto a me stesso, che il mio tentativo sarebbe stato verisimilmente inutile, che<br />
avrei fatto un buco nell‘acqua, e che mi sarei trovato in fine costretto a mutar registro. Tuttavia, siccome<br />
ciò che improbabile non è per questo impossibile, io non poteva scagliar via quel po‘ <strong>di</strong> fiducia prima <strong>di</strong><br />
vedere e toccar con mano se reggesse alla prova; tanto piú che procrastinando a portare un giu<strong>di</strong>zio<br />
definitivo, da un lato io non incorreva in nessun inconveniente, la verità rimaneva al suo luogo, la causa<br />
<strong>di</strong> essa se ne vantaggiava, e dall‘altro lo sperare potea avere allora qualche fondamento, e quando non<br />
fosse stato deluso, il bene che ne risultava sarebbe stato gran<strong>di</strong>ssimo. E per verità io non sono mai stato<br />
cosí lieto della riserva da me usata, come al presente; imperocché, dovendo mutar contegno, i riguar<strong>di</strong> da<br />
me avuti <strong>di</strong>mostrano chiaro che, siccome per l‘ad<strong>di</strong>etro io non <strong>di</strong>ssimulai per piacenteria o paura, cosí ora<br />
non parlo per levità né inconsiderazione, e tampoco per impeto d‘ira o appetito <strong>di</strong> vendetta; cosicché le<br />
due e<strong>di</strong>zioni del mio libro riscontrate insieme si spiegano e giustificano a vicenda, rispetto alle<br />
imputazione opposte, che taluno potrebbe muovere contro <strong>di</strong> esse, considerandole <strong>di</strong>visamento. La mia<br />
fidanza poi, per quanto fosse debole, non era del tutto irragionevole; giacché non può <strong>di</strong>rsi tale il supporre<br />
che un instituto conosca il proprio utile, e sia acconcio a fare ciò che si ricerca manifestamente alla sua<br />
salvezza». E ancora: «Perciò quando i Gesuiti, invece <strong>di</strong> ammollire l‘educazione, soffocare gli ingegni,<br />
infamare gli uomini benemeriti, attizzare le zuffe teologiche, scomunicare i veicoli, gli ospizi, gli atenei e<br />
le scuole del popolo, <strong>di</strong>stogliere dai buoni or<strong>di</strong>ni i capi delle nazioni, e muovere insomma al pubblico<br />
bene una guerra non so se piú stupida o piú scellerata, avessero battuto la via contraria, sarebbero oggi<br />
41
«Ora il migliorare a pro della mia Patria l‘Or<strong>di</strong>ne dei Gesuiti, mi pareva un bene cosí<br />
rilevato, che le ingiurie <strong>degli</strong> sciocchi e dei tristi non mi poteano <strong>di</strong>volgere dal tentarne il<br />
conseguimento… Anzi aggiungo, che se le mie parole avvalorate dai fatti (i quali sono assai piú<br />
eloquenti, non che del mio, <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>scorso), fossero riuscite a far tornare in cervello il celebre<br />
sodalizio e a rimetterlo sul buon cammino, esso non avrebbe trovato un amico piú sincero <strong>di</strong> me,<br />
né un <strong>di</strong>fensore piú caldo e risoluto. Lo <strong>di</strong>co francamente e senza paura perché io non ho due<br />
cuori né due pensieri, e de<strong>di</strong>cai da buon tempo tutte le facoltà del mio animo alla religione e<br />
all‘Italia, in<strong>di</strong>vise nel mio affetto e nella mia mente…» 137 .<br />
Ora però, afferma il Gioberti, il comportamento della Compagnia ha <strong>di</strong>ssipato le pur<br />
tenui speranze e reso inutili gli scrupoli 138 .<br />
Combattere la Compagnia <strong>di</strong> Gesú sarebbe perciò un debito verso la fede e la patria: «Io<br />
poi ho un obbligo speciale <strong>di</strong> non rifuggire da tale incarico, avendo parlato onorevolmente della<br />
Compagnia nel presente libro, e cosí rimosso da me ogni sospetto <strong>di</strong> rancore e <strong>di</strong> avversione;<br />
tanto che dee esser chiaro a ciascuno, che se oggi muto stile, i Gesuiti non hanno che a lagnarsi<br />
<strong>di</strong> lor medesimi» 139 .<br />
Il cambiamento <strong>di</strong> ―stile‖, con il quale Gioberti avviava una impegnativa lotta al<br />
Gesuitismo, rimanda ad una complessa e delicata questione storiografica, quella relativa alle<br />
trasformazioni ed ai mutamenti nelle teorie e nella prassi politica <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti.<br />
Antonio Anzilotti, in sostanziale accordo con Giovanni Gentile, riven<strong>di</strong>ca al filosofo<br />
torinese una profonda coerenza politico-religiosa che deriverebbe dalla sintesi tra i principi<br />
filosofici ed una realistica applicazione dei medesimi. I mutamenti sarebbero perciò da<br />
addebitare piú a delle variazioni tattiche, che a delle fratture e contrad<strong>di</strong>zioni nel pensiero e<br />
nell‘azione <strong>di</strong> Gioberti 140 . Di fronte alle evoluzioni politiche successive al Primato, da cui lo<br />
stesso Gioberti venne gradualmente <strong>di</strong>staccandosi, egli accetta la tesi proposta dallo stesso<br />
filosofo, <strong>di</strong> una consapevole assunzione dell‘elemento ―utopico‖ presente nel Primato da parte<br />
dell‘Autore, il cui reale pensiero sarebbe accessibile solo attraverso una intelligente critica del<br />
testo, liberato dagli espe<strong>di</strong>enti contingenti 141 .<br />
benedetti e levati alle stelle. Imperocché, lo ripeto, la patria nostra è cosí depressa, immiserita, avvilita,<br />
che la cooperazione <strong>di</strong> un Or<strong>di</strong>ne desto, attivo, faticante, non che dover essere sprezzata o non curata<br />
come inutile dagli amatori <strong>di</strong> quella, sarebbe da aversi cara e da reputarsi <strong>di</strong> non piccolo momento; e<br />
questa è l‘ultima considerazione, che m‘indusse a procedere come feci nella prima e<strong>di</strong>zione della mia<br />
scrittura».<br />
137 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 169.<br />
138 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 169: «Ma io non dovetti penar gran tempo a chiarirmi <strong>di</strong> ciò che<br />
altri per questi due rispetti può promettersi dai Gesuiti, e ad esser privo <strong>di</strong> quella lieve fidanza, che <strong>di</strong>anzi<br />
in me annidava, e che mi aveva prescritto <strong>di</strong> procedere con tanta riserva. Io li ringrazio <strong>di</strong> aver <strong>di</strong>ssipati in<br />
poco tempo tutti gli scrupoli che ancora mi trattenevano, e <strong>di</strong> aver eletta a tal fine non già la via rematica<br />
delle parole, ma quella dei fatti, che assai piú chiara, piú eloquente e piú spe<strong>di</strong>tivi. Imperocché da due<br />
anni in qua la Compagnia ebbe cura <strong>di</strong> accumular tante prove <strong>di</strong> ciò che il mondo e specialmente l‘Italia<br />
possono aspettarsene, che lo sperar ancora la <strong>di</strong> lei conversione non passerebbe senza nota <strong>di</strong> follia, e il<br />
<strong>di</strong>fferire a combattere le sue pestifere influenze sarebbe un prevaricare il proprio debito verso la fede e la<br />
patria. Se altro non fosse, quando in un secolo mansueto, come il nostro, una setta religiosa arma i fratelli<br />
contro i fratelli e desta l‘incen<strong>di</strong>o della rabbia civile in una nazione tranquilla e nobilissima, il tacere<br />
sarebbe un partecipare all‘infamia <strong>di</strong> tali opere, imperocché si può patteggiare con i pettegolezzi e colle<br />
opinioni; ma le stragi e le guerre non patiscono accor<strong>di</strong>».<br />
139 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 163-170.<br />
140 Cfr. A. ANZILOTTI, Gioberti, op. cit., 80 a proposito del Primato, scrive: «Quest‘uomo, che pur è<br />
vissuto finora <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tazioni, ha una perfetta intuizione storica, conosce i limiti entro i quali può<br />
muoversi, e sa <strong>di</strong>scernere il punto ove il ―desiderabile‖ - per usare una espressione <strong>di</strong> Manzoni –<br />
s‘incontra con il ―riuscibile‖ ».<br />
141 Cfr. V. GIOBERTI, Epistolario, IV, Firenze 1928, 303 - 308, Gioberti a Mamiani, 13 VIII 43: «... lo<br />
scopo che mi sono proposto ... è <strong>di</strong> far penetrare in Italia alcune verità che mi paiono utili a operare la<br />
concor<strong>di</strong>a della civiltà colla religione ... Io mi proposi adunque <strong>di</strong> scrivere per forma che il mio libro fosse<br />
almen tollerato dai governi italiani, e potesse giungere facilmente alle mani <strong>di</strong> tutti, e principalmente dei<br />
giovani <strong>stu<strong>di</strong></strong>osi e dei chierici ... Per rendere tollerabili le critiche in<strong>di</strong>rette che io feci dei governi italiani,<br />
lodai <strong>di</strong>rettamente alcuni <strong>di</strong> essi <strong>di</strong>ssimulando il male e commendando il bene che mi par <strong>di</strong> vedervi ... Per<br />
42
Adolfo Omodeo invece, mostra <strong>di</strong> non credere all‘interpretazione con la quale Gioberti<br />
ed i suoi <strong>di</strong>fensori tendono a ricostruirne ―post-eventum‖ la coerenza 142 .<br />
Nella ricostruzione dell‘evoluzione politica dell‘abate piemontese nega a questi quel<br />
sano realismo che vede, per esempio, in Camillo <strong>di</strong> Cavour. Ci sarebbe in Gioberti «una<br />
esuberanza fantastica <strong>di</strong> progetti, <strong>di</strong> escogitazioni» che lo porterebbero spesso a non valutare<br />
esattamente la realtà, o a suscitare forze <strong>di</strong> cui egli stesso non si mostrerebbe in grado <strong>di</strong><br />
controllare gli effetti. Per quanto riguarda il neo-guelfismo dell‘abate, egli lo considera «un<br />
espe<strong>di</strong>ente tattico, qualcosa come in guerra, il passaggio <strong>di</strong> un fiume o l‘aggiramento <strong>di</strong> una<br />
posizione, non un momento idealmente formativo ... » 143 . Lo stesso Gioberti non avrebbe<br />
pertanto aderito profondamente a quel progetto, che sarebbe stato una sorta <strong>di</strong> ―cavallo <strong>di</strong> Troia‖<br />
per introdurre in Italia la rivoluzione nazionale 144 .<br />
Del complesso <strong>di</strong>battito, che qui interessa solo superficialmente, meritano <strong>di</strong> essere<br />
ricordati i contributi <strong>di</strong> Ettore Passerin d‘Entrèves 145 e <strong>di</strong> Giorgio Candeloro 146 .<br />
Il primo, coerentemente con la sua visione del Risorgimento italiano, come particolare<br />
momento storico in cui le esigenze religiose e politiche, pur nella varietà delle posizioni,<br />
tendono a intersecarsi e completarsi reciprocamente, tende a rivalutare la ―sincerità‖<br />
dell‘ispirazione <strong>di</strong> Gioberti, anche con le ambiguità dei suoi miti, e con le evoluzioni suggerite<br />
dall‘incalzare <strong>degli</strong> avvenimenti.<br />
Il secondo fa notare che «il mito neo-guelfo non fu un‘invenzione <strong>di</strong> Gioberti, ma fu il<br />
punto d‘arrivo <strong>di</strong> una tendenza profondamente ra<strong>di</strong>cata in Italia, che il Gioberti seppe sfruttare<br />
politicamente aderendovi anche sinceramente, almeno per un certo tempo».<br />
In questo lavoro è necessario limitarsi alla domanda: che cosa spinse Gioberti ad<br />
avviare una lotta, che si prospettava sin dall‘inizio onerosa, con la Compagnia <strong>di</strong> Gesú? Era<br />
veramente necessaria?<br />
incarnare ... i miei pensieri ... esposi l‘utopia dell‘arbitrato pontificale e della confederazione Italiana.<br />
Intendo sotto il nome <strong>di</strong> utopia l‘effettuazione perfetta <strong>di</strong> un‘idea, giacché le idee non si possono mai<br />
mettere in atto compitamente in questa nostra povera e inferma natura ... L‘arbitrato del papa e l‘unione<br />
federativa della nostra penisola sono due utopie ... <strong>di</strong> cui non ... si vedranno che saggi molti lontani dalla<br />
loro perfezione ideale. Né alcun tempo fu meno propizio del nostro anco a tali saggi imperfettissimi: onde<br />
io vi confesso per questa parte <strong>di</strong> avere scritto senza speranza. Non v‘ha, credo, in Italia, o fuori alcuno ...<br />
che speri manco <strong>di</strong> me. Se <strong>di</strong>co <strong>di</strong> sperare nella conclusione dell‘opera, la mia fiducia si riferisce a un<br />
remoto e indeterminato avvenire, perché certo il risorgimento d‘Italia e del cattolicesimo appartiene agli<br />
or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>vini del mondo, e anche su questo articolo la mia persuasione è interissima». Ivi, 309 - 312,<br />
Gioberti a Gaspare Seggiaro, 18 VIII 43: «Ho dovuto ... <strong>di</strong>ssimular molte cose, accennare semplicemente<br />
alcune altre, e lasciar molto alla <strong>di</strong>screzione del lettore ... Non sono sí semplice da credere possibile<br />
l‘effettuazione presente o vicina dell‘arbitrato pontificio o della confederazione italiana».<br />
142<br />
Cfr. A. OMODEO, Gioberti e la sua evoluzione politica, in Difesa del Risorgimento,Torino 1951, 86 –<br />
155.<br />
143<br />
A. OMODEO, Gioberti, op. cít., 88. L‘Autore aggiunge: «La confusione, credo, nasce dall‘uso<br />
promiscuo del termine mito, una volta con il significato spiritualistico d‘ideale anche se ideale gravato <strong>di</strong><br />
una corpulenza necessaria ed inevitabile per operare nel mondo, l‘altra volta con il significato<br />
machiavellico-soreliano <strong>di</strong> espe<strong>di</strong>enti, <strong>di</strong> accoglimento, per catturare e padroneggiare l‘opinione e le<br />
moltitu<strong>di</strong>ni. Il neoguelfismo fu mito solo in questo secondo senso, non nel primo». Questa è anche la tesi<br />
<strong>di</strong> Salvatorelli si veda ―Pensiero e azione del Risorgimento‖.<br />
144<br />
Cfr. A. OMODEO, Gioberti, op. cit., 88: «In quanto alla questione in sé, io non ho levato pregiu<strong>di</strong>ziali<br />
d‘or<strong>di</strong>ne moralistico nei riguar<strong>di</strong> del neoguelfismo, che ho sempre considerato come una sapientissima<br />
macchina <strong>di</strong> guerra, una rete in cui il geniale abate prese mezza Italia moderata, per gettarla nella<br />
rivoluzione, e in cui si <strong>di</strong>batté <strong>di</strong>speratamente per tre anni lo stesso papa, il grande pescatore».<br />
145<br />
Cfr. E. PASSERIN D‘ENTREVES, Il Cattolicesimo Liberale in Europa ed il movimento neoguelfo in<br />
Italia, in Nuove Questioni <strong>di</strong> Storia del Risorgimento e dell‟Unità d‟Italia, Milano 1961, vol. I. 565 - 606;<br />
IDEM, Religione e Politica nell‟800 europeo, con introduzione <strong>di</strong> F. Traniello, Roma 1993.<br />
146<br />
Cfr. CANDELORO, Storia dell‟Italia moderna, vol. II Dalla Restaurazione alla Rivoluzione nazionale<br />
1815 - 1846, Milano 1978. A pag. 465 l‘Autore continua: «È necessario inoltre tener conto, piú <strong>di</strong> quanto<br />
l‘Omodeo non faccia nel suo lavoro, delle circostanze in cui si svolse l‘azione giobertiana. D‘altra parte il<br />
pensiero giobertiano ha uno sviluppo assai piú complesso e contrad<strong>di</strong>torio <strong>di</strong> quanto non appaia dal libro<br />
dell‘Anzilotti». Si vedano anche le osservazioni dello stesso Autore alle pagine 359 - 360 dell‘opera<br />
citata.<br />
43
«Nel ―Gesuitismo‖ - scrive Anzilotti - Gioberti raggruppa, per combatterle meglio, tutte<br />
le caratteristiche piú esose <strong>di</strong> quel cattolicismo gretto e conservatore, che gli appare come il<br />
primo grande ostacolo alla resurrezione morale e civile del nostro paese» 147 . Poco prima<br />
affermava: «Fatta coincidere la propria filosofia con il pensiero ortodosso, per inserirla nella<br />
tra<strong>di</strong>zione e darle un valore ed un‘efficacia che altrimenti non avrebbe mai ottenuto, il Gioberti<br />
doveva dunque porre in evidenza le fondamentali incompatibilità tra la sua ―religione civile‖ e il<br />
cattolicismo della Curia e dei Gesuiti» 148 .<br />
Tra l‘incarnazione del Cattolicesimo, quale concretamente la Compagnia <strong>di</strong> Gesú nel<br />
suo complesso andava realizzando, e l‘interpretazione dello stesso Cattolicesimo che Gioberti<br />
aveva elaborato, esistevano effettivamente delle <strong>di</strong>fferenze profonde e <strong>di</strong>fficilmente<br />
componibili 149 .<br />
La Compagnia <strong>di</strong> Gesú era stata ricostituita da Pio VII nel 1814 e si era rapidamente,<br />
pur non senza <strong>di</strong>fficoltà, riorganizzata in molti Stati europei. Nel 1846 l‘Or<strong>di</strong>ne contava oltre<br />
4.500 membri, destinati ad aumentare negli anni successivi. Per identità culturale e per le<br />
vicende storiche che portarono alla sua soppressione, la Compagnia si trovò quasi dovunque a<br />
combattere l‘Illuminismo e le correnti <strong>di</strong> pensiero che da esso in qualche modo derivavano: il<br />
razionalismo, il sensismo, il liberalismo, il giuris<strong>di</strong>zionalismo. Politicamente e culturalmente<br />
finí quasi sempre per sostenere le correnti piú tra<strong>di</strong>zionaliste e conservatrici, legate all‘Ancièn<br />
régime. Per il sostegno dato alla censura, l‘opposizione fatta ad alcune innovazioni educative,<br />
quali gli Asili infantili patrocinati da Ferrante Aporti, la lotta contro la laicizzazione<br />
dell‘Università, erano guardati da molti intellettuali europei come i campioni<br />
dell‘intransigentismo e della reazione.<br />
Tra il ‗40 ed il ‗43 i Gesuiti ingaggiarono una polemica, a tratti anche aspra, con<br />
Antonio Rosmini, nella quale alcuni esponenti dell‘Or<strong>di</strong>ne si espressero in termini offensivi<br />
verso la persona e l‘ortodossia <strong>di</strong> Rosmini 150 . Quasi contemporaneamente all‘uscita dei<br />
Prolegomeni, era in corso in Francia una vigorosa polemica antigesuitica guidata da Edgar<br />
Quinet e Jules Michelet, che aveva trovato risonanze letterarie nel <strong>roma</strong>nzo l‘Ebreo errante <strong>di</strong><br />
Eugène Sue, e politiche nei <strong>di</strong>scorsi alla Camera <strong>di</strong> Adolphe Thiers. Il Governo francese inviò in<br />
Vaticano come ambasciatore straor<strong>di</strong>nario l‘esule italiano Pellegrino Rossi, che dopo abili<br />
trattative con il Papa, tramite il Card. Luigi Lambruschini, ed il preposito generale della<br />
Compagnia <strong>di</strong> Gesú, Roothaan, ottenne che i Gesuiti si ritirassero dalle principali case religiose<br />
possedute dall‘Or<strong>di</strong>ne in Francia, pur mantenendone la proprietà.<br />
Nella Svizzera le tendenze verso l‘unificazione federale, sostenute da liberali e ra<strong>di</strong>cali,<br />
<strong>di</strong> estrazione prevalentemente borghese e <strong>di</strong> origini protestanti, venivano osteggiate dai cantoni<br />
meri<strong>di</strong>onali, tra<strong>di</strong>zionalmente cattolici, favorevoli alle ampie autonomie dei singoli stati<br />
cantonali all‘interno <strong>di</strong> una confederazione. I cantoni cattolici particolarmente quello <strong>di</strong><br />
Lucerna, chiamarono i Gesuiti a <strong>di</strong>rigere il seminario locale. La decisione, che seguiva una<br />
campagna propagan<strong>di</strong>stica antigesuita da parte dei liberali, fu considerata e probabilmente<br />
voleva essere un gesto <strong>di</strong> sfida: seguirono scontri, anche sanguinosi tra protestanti e liberali da<br />
un lato e cattolici dall‘altro, cui fecero seguito tra il ‗44 ed il ‗45 scontri tra le truppe <strong>di</strong> Lucerna<br />
ed i cosiddetti ―corpi franchi‖ liberali.<br />
147 A. ANZILOTTI, Gioberti, op. cit. 135 ss.<br />
148 A. ANZILOTTI, Gioberti, op. cit., 135.<br />
149 Si tenga presente a questo proposito il parere <strong>di</strong> G. Martina: «Gioberti intanto andava rendendosi conto<br />
che non poteva mancare, presto o tar<strong>di</strong>, uno scontro con la Compagnia <strong>di</strong> Gesú. Non sarebbero sfuggiti a<br />
lungo a pensatori come il Taparelli e a polemisti come il Curci pericoli insiti nel Primato, la<br />
strumentalizzazione della religione e la tendenza a ridurla ad una filosofia basata sui presupposti esposti<br />
dall‘abate nelle sue opere precedenti, incompatibili con il pensiero cattolico. Si trattava <strong>di</strong> due opposte<br />
interpretazioni del cattolicesimo, assai piú che <strong>di</strong> due visioni dello Stato».G. MARTINA, Pio IX, op. cit.,<br />
vol. I, 68.<br />
150 Ci riferiamo in particolare all‘episo<strong>di</strong>o in cui il Rozaven, assistente del Roothaan preposíto generale,<br />
paragonò Rosmini al Lamennais, lasciandone intuire la prossima apostasia, in un articolo all‘Ami de la<br />
Religion del 2 febbraio 1843. Su tutta la delicata questione riman<strong>di</strong>amo alla chiara e serena presentazione<br />
<strong>di</strong> G. MARTINA, Pio IX, op. cit., vol. I, 77 - 78.<br />
44
Questo clima politico europeo influí certamente nella decisione <strong>di</strong> Gioberti <strong>di</strong> dare<br />
finalmente voce ad una polemica che da tempo covava sotto la cenere 151 .<br />
L‘ideale <strong>di</strong> una conciliazione tra religione cristiana e civiltà moderna, tra i dogmi della<br />
Fede e le conquiste della Ragione, l‘autorità delle gerarchie religiose ed i <strong>di</strong>ritti politici dei<br />
citta<strong>di</strong>ni, i valori intramontabili del Vangelo ed il risveglio nazionale dei popoli, era patrimonio<br />
comune non solo dei cattolici liberali italiani, ma si può <strong>di</strong>re <strong>di</strong> tutto il Romanticismo europeo <strong>di</strong><br />
ispirazione cristiana.<br />
Gioberti, almeno nella fase neo - guelfa del suo pensiero, aderiva a questo ideale ―toto<br />
corde‖. Ma il modo determinato in cui realizzare questa sintesi, Gioberti se lo figurava in un<br />
modo personale, fortemente influenzato dall‘orientamento idealistico del proprio pensiero<br />
filosofico.<br />
Civiltà e religione, nel pensiero dell‘abate, non sono confuse, ma tendono a fondersi e<br />
ad unirsi: «Civiltà e religione importano egualmente la maggioranza e la vittoria dell‘anima sul<br />
corpo, della ragione sul senso, dell‘arbitrio sull‘istinto, della legge sulle forze brutali, dello<br />
spirito sulla natura, dell‘uomo sugli altri esseri terreni, e delle intelligenze finite sul corporeo e<br />
sull‘universo; cosicché si può <strong>di</strong>re che la religione è una civiltà assoluta e perfetta, come la<br />
cultura terrena è una religione iniziale, che ha verso l‘altra le attinenze <strong>di</strong> una parte con il tutto e<br />
del principio con il compimento» 152 .<br />
Il Cristianesimo pertanto è insieme una religione, una civiltà ed una filosofia che, agli<br />
occhi del Gioberti non debbono andare <strong>di</strong>sgiunte.<br />
Ne consegue che «il nimicare i progressi civili e le cognizioni (religiose, ndr) che li<br />
partoriscono, è un attentato ingiurioso a Dio, ripugnante agli or<strong>di</strong>ni ed allo scopo del mondo,<br />
funesto agli uomini e contrario agli spiriti, ai precetti, all‘intento del Cristianesimo. Offende Dio<br />
perché la civiltà è <strong>di</strong>vina, come la religione, e solo in tanto a questa inferiore, in quanto mira<br />
<strong>di</strong>rettamente al tempo e non all‘eterno; ma siccome l‘eternità, rispetto alle creature, presuppone<br />
la durata temporanea, e ne è per cosí <strong>di</strong>re la somma ed il cumulo; chi <strong>di</strong>sama e <strong>di</strong>sfavorisce i<br />
mondani interessi, pregiu<strong>di</strong>ca ai sopramondani, come contrasta al fine chi reca danno od<br />
inciampo ai sussi<strong>di</strong> che vi conducono» 153 .<br />
Nell‘interpretazione <strong>di</strong> Gioberti il Cattolicesimo è la religione civile e civilizzatrice per<br />
eccellenza, ed essa, come la filosofia del Piemontese, è conciliatrice, <strong>di</strong>alettica, universale.<br />
Secondo questa impostazione contrastare il progresso culturale e sociale, non è dunque<br />
solo uno sbaglio politico ma anche un errore teologico. Di qui la polemica accesa del torinese<br />
contro il ―misticismo male inteso‖, che condanna in blocco gli interessi temporali e deprezza<br />
l‘impegno per il miglioramento della società.<br />
Di qui la convinzione che un Cattolicesimo retrogrado, intransigente, intollerante, è una<br />
degenerazione del medesimo ... un‘eresia pratica.<br />
Per Gioberti il ―Risorgimento‖ politico e la ―Riforma‖ religiosa sono che due aspetti<br />
inscin<strong>di</strong>bili <strong>di</strong> un medesimo processo <strong>di</strong> attualizzazione dell‘Idea.<br />
Un confronto ideale tra il Cristianesimo secondo Gioberti e la concreta configurazione<br />
del Cattolicesimo ufficiale ai suoi tempi, particolarmente nell‘interpretazione gesuitica e/o<br />
intransigente, era perciò inevitabile. L‘abate, pur guardandosi bene dall‘esplicitare in termini <strong>di</strong><br />
polemica attiva il <strong>di</strong>vario delle concezioni (per considerazioni <strong>di</strong> opportunità politico-religiosa),<br />
è tuttavia convinto che il Primato, con i suoi ideali, sia una critica implicita alla concezione<br />
ideale che in cuor suo avversa.<br />
151 Soprattutto gli avvenimenti della Svizzera ebbero incidenza, ci sembra, nell‘animo <strong>di</strong> Gioberti, che<br />
anche nei Prolegomeni ha accenti d‘in<strong>di</strong>gnazione verso i Gesuiti per questo episo<strong>di</strong>o.<br />
152 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 98. L‘Autore continua: «Il che è tanto vero che a mano a mano che<br />
le loro potenze si vanno esplicando ed avvalorando, l‘una si trasforma nell‘altra e l‘effetto <strong>di</strong>mostra la<br />
loro medesimezza; cosí, poniamo, da un lato il nostro incivilimento non è altro che la deduzione logica e<br />
la pratica sociale dei principii racchiusi nell‘Evangelio; e dall‘altro lato l‘Evangelio è il postulato<br />
necessario per ispiegare razionalmente le varie parti <strong>di</strong> quello, per guisa, che se altri facendo una sottil<br />
<strong>di</strong>samina <strong>degli</strong> instituti e <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni propri dell‘età moderna, volesse trarne un sistema <strong>di</strong> religiose<br />
credenze, il suo lavoro tornerebbe intorno ai sommi capi sostanzialmente identico con il culto che<br />
professiamo».<br />
153 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 98 ss.<br />
45
Forse anche per questo afferma che il senso del ―Primato‖ deve essere ricercato<br />
criticamente al <strong>di</strong> là delle parole espresse.<br />
Se questo fosse vero non dovrebbe stupire che il filosofo torinese colga l‘occasione, che<br />
gli pare propizia, per esplicitare un <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o da tempo latente 154 .<br />
Ma a ben guardare si deve riconoscere che i Prolegomeni non sono un‘ampia ed<br />
organica esposizione teoretica, ancorché in chiave polemica, <strong>di</strong> un pensiero considerato nella<br />
sua generalità. Sono invece la giustificazione culturale delle posizioni assunte dal pensatore<br />
torinese nel corso <strong>di</strong> una lotta politica che continua, si evolve e richiede un intervallo militante.<br />
Il contesto in cui nacquero le pagine anti-gesuitiche dei Prolegomeni, e la stessa forma<br />
―pamphlettistica‖ della polemica rimandano a concrete preoccupazioni politico-culturali che<br />
varrebbe la pena <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare 155 .<br />
Il ―Giobertismo‖ non si limitò, come il pensiero <strong>di</strong> quasi tutti gli altri cattolici liberali,<br />
ad essere una interpretazione dei valori e <strong>degli</strong> avvenimenti, ma fu, come si è accennato, una<br />
corrente politica attivamente ingaggiata nella soluzione dei problemi morali e politici della<br />
penisola italiana. Dopo il successo del Primato, l‘Autore <strong>di</strong>venne l‘esponente <strong>di</strong> maggior rilievo<br />
del liberalismo cattolico moderato, e quin<strong>di</strong>, in qualche modo, colui dal quale potevano e<br />
dovevano partire le in<strong>di</strong>cazioni strategiche della ―corrente‖ aggregatasi intorno a lui.<br />
L‘abate aveva <strong>di</strong>nanzi a sé sostanzialmente due possibilità.<br />
La prima era quella <strong>di</strong> favorire un‘alleanza, in nome <strong>di</strong> un comune denominatore<br />
―cattolico‖ tra gruppi liberali e conservatori moderati, <strong>di</strong>sponibili a prudenti, parziali<br />
concessioni in senso nazionale e costituzionale. Lo stesso Primato lasciava intravvedere questa<br />
possibilità. Ma la <strong>di</strong>sponibilità quasi illimitata verso il fronte conservatore era stato uno<br />
stratagemma tattico.<br />
La seconda ipotesi era <strong>di</strong> ricompattare, possibilmente intorno a sé, i vari filoni del<br />
movimento liberale, e farne il ―partito vincente‖ contro gli estremi della democrazia <strong>di</strong><br />
estrazione mazziniana e del fronte anti - liberale tra<strong>di</strong>zionalista e clericale.<br />
Gioberti scelse questa seconda linea strategica 156 .<br />
Per riguadagnare cre<strong>di</strong>bilità tra i liberali <strong>di</strong> estrazione laica era necessario non solo<br />
precisare meglio i contorni costituzionali e laici del progetto giobertiano, ma anche prendere le<br />
<strong>di</strong>stanze in modo inequivocabile dalle forme <strong>di</strong> guelfismo <strong>di</strong> stampo ultra - mondano ed<br />
intransigente.<br />
La polemica antigesuita <strong>di</strong> Gioberti, inserita in un momento storico in cui la lotta alla<br />
Compagnia rappresentava una caratteristica abbastanza <strong>di</strong>ffusa dei ceti intellettuali borghesi<br />
liberali, <strong>di</strong>venta lo strumento tattico con cui egli cerca <strong>di</strong> riguadagnarsi una ―ortodossia‖<br />
liberale, emarginare politicamente i tra<strong>di</strong>zionalisti intransigenti, convincere i patrioti laici della<br />
positività <strong>di</strong> un accordo con il Cattolicesimo opportunamente rinnovato e scisso nelle<br />
responsabilità dal Gesuitismo, su cui si caricano tutte le colpe della reazione.<br />
L‘antagonista logico del Cattolicesimo filosofico e patriottico <strong>di</strong> Gioberti (conciliativo,<br />
<strong>di</strong>alettico, progressivo, tollerante) può avere adesso nome e cognome con il quale essere<br />
presentato all‘opinione pubblica per essere da essa riprovato: ―Il Gesuitismo moderno -<br />
154 V. GIOBERTI, Prolegomeni, op. cit., 168: «Chiunque si compiaccia <strong>di</strong> paragonare il mio libro colla<br />
presente Avvertenza, troverà che la seconda <strong>di</strong> questa scritture non è altro, che un‘applicazione<br />
particolare ed una esplicazione piú minuta delle cose già dette nella prima».<br />
155 Diversammente si era espresso Anzilotti: «Andare in cerca delle ragioni particolari, che poterono<br />
determinare il Gioberti a lottare con i Gesuiti, non ha molta importanza. Son due sistemi opposti, che<br />
quasi rappresentano due epoche <strong>di</strong>verse» A. ANZILOTTI, Gioberti, op. cit., 126.<br />
156 L‘interpretazione della lotta antigesuitica <strong>di</strong> Gioberti, nel senso <strong>di</strong> una consapevole scelta politico -<br />
culturale, è formulata chiaramente da G. Candeloro: «In realtà l‘azione giobertiana era riuscita già a<br />
guadagnare con il Primato una parte notevole del clero e <strong>degli</strong> ambienti cattolici meno retrivi all‘idea<br />
dell‘alleanza con il movimento nazionale liberale; impossibile sarebbe stato estendere ancor <strong>di</strong> piú verso<br />
destra lo schieramento nuovo che si andava formando; con la pubblicazione dei Prolegomeni invece<br />
Gioberti guadagnò forze al centro e a sinistra; superò le <strong>di</strong>fferenze che erano sorte nei suoi riguar<strong>di</strong>; <strong>di</strong>ede<br />
a tutto il movimento che si andava formando intorno a lui un impulso fortissimo e al tempo stesso<br />
<strong>di</strong>sorientò le forze reazionarie, in un momento in cui queste si trovavano non solo in Italia ma in tutta<br />
Europa in gravi <strong>di</strong>fficoltà». G. CANDELORO, Storia d‟Italia, op. cit., vol. II, 403-404.<br />
46
sintetizza l‘abate - è anti <strong>di</strong>alettico e sofistico per eccellenza, e questa qualificazione esprime<br />
con breve e limpida formula tutte le doti‖.<br />
L‘enormità delle accuse che egli riversa contro il Gesuitismo è perciò il frutto <strong>di</strong> uno<br />
schema ideale nel quale è riservato ad esso, quasi d‘ufficio, il ruolo dell‘anti-eroe.<br />
I toni cupi e le tinte forti con i quali Gioberti <strong>di</strong>pinge i gesuiti moderni, abbandonando il<br />
lungo esercizio <strong>di</strong> moderazione delle opere precedenti, si spiegano principalmente come il<br />
prodotto <strong>di</strong> una scelta politica.<br />
Probabilmente Gioberti riteneva fosse venuto il momento <strong>di</strong> forzare la resistenza dei<br />
gruppi <strong>di</strong> potere anti - liberali, già indeboliti dal crescere del movimento nazionale e in parte<br />
<strong>di</strong>sorientati dalla stessa politica ―soffice‖ <strong>di</strong> Gioberti.<br />
Uno scontro con i Gesuiti, che in molti Stati italiani svolgevano un importante ruolo <strong>di</strong><br />
sostegno ideologico - culturale <strong>degli</strong> assetti socio - politici emersi nel periodo della<br />
Restaurazione, <strong>di</strong>ventava quasi inevitabile.<br />
Approfittando del crescere <strong>di</strong> un‘opinione pubblica antigesuitica e sperando <strong>di</strong> poter<br />
isolare la Compagnia anche all‘interno delle posizioni conservatrici, decise <strong>di</strong> passare<br />
all‘attacco. Cosí facendo era convinto, inoltre, <strong>di</strong> guadagnare consensi tra le file dei liberali piú<br />
insofferenti delle tendenze papaline del neo - guelfismo.<br />
Questi ci sembrano - molto schematicamente - i motivi che indussero il filosofo torinese<br />
a cambiare profondamente ―stile‖ nel trattare la Compagnia <strong>di</strong> Gesú.<br />
L‘accoglienza dei Prolegomeni da parte dell‘ala ―ortodossa‖ del liberalismo fu<br />
generalmente positiva. Alcuni cattolici liberali, come Tommaseo, Cantú, Manzoni, non<br />
apprezzarono la polemica contro i Gesuiti. Cesare Balbo, pur con<strong>di</strong>videndo la <strong>di</strong>sapprovazione<br />
dell‘operato politico dei conservatori piemontesi, amici dei Gesuiti, avanzava il timore che la<br />
polemica contro la Compagnia ostacolasse la possibilità <strong>di</strong> un accordo tra Cattolicesimo e<br />
Liberalismo 157 .<br />
I Gesuiti rimasero stupiti ed in<strong>di</strong>gnati delle pagine che li riguardavano. Direttamente<br />
non c‘era stato nessun atto <strong>di</strong> ostilità verso l‘abate; qua e là, piuttosto, simpatia ed interesse per<br />
le proposte del Primato 158 . Ai loro occhi, pertanto, l‘attacco <strong>di</strong> Gioberti alla Compagnia si<br />
presentava privo <strong>di</strong> qualsiasi motivazione plausibile.<br />
Qualcuno provò a ricomporre amichevolmente la vicenda, sollecitando per via<br />
epistolare una qualche ritrattazione dell‘abate.<br />
Di fronte ad un atteggiamento negativo <strong>di</strong> Gioberti si decise <strong>di</strong> formalizzare la risposta.<br />
Il Francesco Pellico, fratello del noto patriota Silvio, compose allora lo scritto ―A Vincenzo<br />
Gioberti‖ 159 , pacato nel tono, ma preciso nel rintuzzare le accuse <strong>di</strong> Gioberti e nel <strong>di</strong>fendere il<br />
proprio Istituto religioso. Piú battagliero, anche nel titolo, il libro del Carlo <strong>Maria</strong> Curci: ―Fatti<br />
ed argomenti in risposta alle molte parole <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti intorno ai Gesuiti nei<br />
Prolegomeni del Primato‖ 160 , scritto con pungente ironia.<br />
Argomento centrale della polemica dei Gesuiti era il rifiuto <strong>di</strong> equiparare i valori<br />
religiosi e quelli culturali, o ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong> strumentalizzare il Cristianesimo per il successo dei<br />
nuovi ideali politici: «Noi vogliamo e dobbiamo pre<strong>di</strong>care la redenzione <strong>di</strong> Cristo: se si vuole<br />
che noi, per acconciarci alle tendenze del secolo, togliamo a pre<strong>di</strong>care la redenzione d‘Italia, ci<br />
protestiamo solennemente: non possiamo e non vogliamo, perché non ad hoc missi sumus» 161 .<br />
I Gesuiti inoltre accusavano Gioberti <strong>di</strong> non aver provato nulla delle sue accuse e dal<br />
canto loro portavano concreti elementi a confutazione delle affermazioni <strong>di</strong> Gioberti.<br />
Per quel che riguarda la soppressione della Compagnia <strong>di</strong> Gesú, decretata da Clemente<br />
XIV nel 1773, i due Gesuiti l‘attribuiscono alle pressioni ed alle vessazioni <strong>di</strong> alcune corti<br />
europee sul pontefice.<br />
157 Cfr. «Cesare Balbo a Gioberti», R. VII. 1845 V. GIOBERTI, Epistolario 1, 292 -295.<br />
158 I Padri Taparelli, Curci e Píccirillo, con alcuni altri, curarono - ad esempio - una e<strong>di</strong>zione dell‘opera a<br />
Benevento, sebbene senza il permesso dell‘Autore.<br />
159 F. PELLICO, A Vincenzo Gioberti, Genova 1845.<br />
160 C.M. CURCI, Fatti ed argomenti in risposta alle molte parole <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti intorno ai<br />
Gesuiti,nei Prolegomeni del Primato, Napoli 1845.<br />
161 C.M. CURCI, Fatti ed argomenti, op. cit., C. IX, n. 4, e<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> Modena 1846, 173.<br />
47
Nella bolla <strong>di</strong> soppressione non si farebbe accenno a dottrine o costumi devianti da parte<br />
dei seguaci del Loyola, né la regola del fondatore fu mai condannata dalla Chiesa. L‘obbe<strong>di</strong>enza<br />
con la quale i religiosi accettarono la soppressione della loro Compagnia, viene mostrato come<br />
prova della loro sottomissione alla <strong>Santa</strong> Sede.<br />
Oltre alle <strong>di</strong>fese ―ufficiose‖ del Pellico e del Curci, si aggiungono a favore dei Gesuiti<br />
alcune pubblicazioni minori, composte generalmente da ecclesiastici, che attaccano in vario<br />
modo Gioberti.<br />
Si inserisce qui la presa <strong>di</strong> posizione <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti che nello scritto Saggio<br />
sulla <strong>di</strong>alettica e la religione <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti 162 si preoccupava <strong>di</strong> contrastare l‘influenza<br />
delle idee giobertiane tra la popolazione genovese, anche <strong>di</strong> estrazione culturale piú modesta<br />
(Poiché l‘argomento viene sviluppato piú ampiamente nel corso della trattazione monografica<br />
seguente, riman<strong>di</strong>amo ad essa il lettore).<br />
Vanno inoltre ricordate le opere ―I Gesuiti dei secoli XVIII e XIX‖ <strong>di</strong> Agostino Peruzzi,<br />
arciprete della metropolitana <strong>di</strong> Ferrara, e gli ―Errori nei Prolegomeni del Primato <strong>di</strong> V.<br />
Gioberti‖ <strong>di</strong> Giuseppe Montegran<strong>di</strong>, oblato <strong>di</strong> S. Carlo, stampati entrambi nel 1846, il primo a<br />
Bologna, il secondo a Genova.<br />
«Carattere impulsivo, natura esuberante desiderosa <strong>di</strong> cimenti, sospinta da un grande e<br />
suscettibilissimo amor proprio, mentalità capace della rigidezza logica ma anche immaginosa e<br />
squisitamente sensibile alle bellezze formali ... » cosí Anzilotti, uno dei piú qualificati <strong>stu<strong>di</strong></strong>osi<br />
del Gioberti, descrive l‘abate: «Il suo temperamento battagliero, che ama smontare e annullare<br />
con la critica incalzante le affermazioni altrui, che mostra tutta la sua fecon<strong>di</strong>tà spirituale<br />
specialmente nel respingere con smisurato sfoggio <strong>di</strong> argomenti anche le piú modeste obiezioni,<br />
sotto l‘aculeo del risentimento, lo trasporta alla polemica e l‘obbliga a prendere un<br />
atteggiamento <strong>di</strong> lotta <strong>di</strong> fronte alle piú vive e <strong>di</strong>battute questioni del momento» 163 .<br />
Vincenzo Gioberti insomma non era uno <strong>di</strong>sposto ad accettare passivamente le<br />
iniziative <strong>degli</strong> avversari. Decise <strong>di</strong> affrontare <strong>di</strong> petto la polemica e ―scaraventò‖ sui Gesuiti i<br />
cinque tomi del Gesuita Moderno 164 . L‘opera non rappresenta un‘evoluzione nel pensiero<br />
dell‘abate torinese, ma è una conferma ed una giustificazione della lotta avviata in forma<br />
generica nei Prolegomeni.<br />
L‘Autore riaffronta il problema dalle <strong>di</strong>spute teologiche sulla Grazia e presenta il<br />
Giansenismo ed il Gesuitismo come due deviazioni opposte dall‘equilibrio cattolico che<br />
armonizza la Grazia <strong>di</strong>vina con la libertà umana (il Giansenismo tenderebbe a svalutare la<br />
seconda, il Gesuitismo la prima). Anche sul piano filosofico i due opposti estremi misconoscono<br />
il concetto vero <strong>di</strong> Atto Creatore, da cui prende le mosse la filosofia giobertiana, opponendo il<br />
Creatore e la Creazione, anziché relazionarli <strong>di</strong>aletticamente. Da qui <strong>di</strong>scenderebbero i numerosi<br />
errori ascetici e morali delle due ―sette‖, che Gioberti <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> condannare egualmente.<br />
Sul piano personale però l‘abate considera piú apprezzabile il contegno austero e<br />
rigoroso dei Giansenisti, <strong>di</strong> cui apprezza l‘eru<strong>di</strong>zione e l‘impegno culturale. Di essi con<strong>di</strong>vide<br />
non il sistema dogmatico, ma gran parte delle critiche concrete rivolte alla morale dei Gesuiti,<br />
fondata sulla <strong>di</strong>latazione dell‘arbitrio umano oltre l‘ambito assegnatogli dalla Legge <strong>di</strong>vina, e<br />
giustificata dal Probabilismo. L‘Autore insomma riespone in forma piú organica e documentata<br />
quasi tutti gli argomenti che aveva accennato nei Prolegomeni.<br />
Il terzo libro è de<strong>di</strong>cato prevalentemente alla presentazione positiva dell‘ideale<br />
giobertiano, <strong>di</strong> conciliazione tra Cattolicesimo e civiltà, interpretati alla luce della filosofia<br />
idealistica dell‘abate. L‘Autore riba<strong>di</strong>sce e motiva le tesi politiche del federalismo moderato <strong>di</strong><br />
ispirazione neo - guelfa, in un momento in cui l‘elezione al soglio pontificio <strong>di</strong> Pio IX sembrava<br />
dar ragione alle proposte avanzate da Gioberti. Viene affrontato anche il problema dello Stato<br />
Pontificio. Pur affermando che esso non è essenziale all‘esistenza del papato, l‘Autore ne<br />
162 G. FRASSINETTI, Saggio sulla <strong>di</strong>alettica e la religione <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti, Genova 1846.<br />
163 A. ANZILOTTI, Gioberti, op. cit., 76. La descrizione dell‘Anzilotti è posta nella parte del libro che<br />
riguarda le sue polemiche con i rosminiani, ma coglie validamente il carattere dell‘abate come si<br />
manifesterà anche successivamente.<br />
164 A. OMODEO, L‟evoluzione politica <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti, in ―Difesa del Risorgimento‖, cit., 125. Cfr.<br />
V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, Losanna, 1846 - 475, voll. 5.<br />
48
accetta realisticamente l‘esistenza e l‘utilità, a <strong>di</strong>fesa dell‘autonomia del Papa, ed a vantaggio<br />
del processo <strong>di</strong> unificazione italiana, purché sia riformato in senso costituzionale e purché<br />
accanto al clero siano chiamati anche i laici a svolgere funzioni <strong>di</strong> responsabilità politica. Con il<br />
crescere della sicurezza civile del Pontefice, nei confronti <strong>di</strong> attacchi politici e giuri<strong>di</strong>ci verso la<br />
sua Persona, come Capo della Cattolicità, prospetta inoltre, in un futuro remoto, una<br />
<strong>di</strong>ssoluzione del potere temporale, a vantaggio <strong>di</strong> un arbitrato morale e civile del Papa<br />
sull‘umanità.<br />
Per quanto riguarda la storia della Compagnia, Gioberti conferma il suo apprezzamento<br />
positivo <strong>di</strong> Sant‘Ignazio, <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>pinge un ritratto ideale <strong>di</strong> mistico - guerriero, contemplativo e<br />
organizzatore religioso e civile. L‘esaltazione del fondatore e dei primi tempi eroici dell‘Istituto<br />
servono però da pietra <strong>di</strong> paragone per misurare la progressiva degenerazione dei Gesuiti.<br />
L‘abate contesta l‘interpretazione data dal Pellico sull‘abolizione della Compagnia,<br />
afferma che nella Bolla Pontificia <strong>di</strong> Clemente XIV si fa accenno agli abusi dei Gesuiti, e<br />
ricorda le intemperanze <strong>di</strong> alcuni religiosi ribelli all‘or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> soppressione.<br />
Rifacendosi all‘opera recentemente pubblicata dal conte <strong>di</strong> Saint-Priest: Histoire de la<br />
chute des Jésuites au XVIII siècle (Paris, 1846), Gioberti accusa l‘Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> aver settariamente<br />
intrigato nell‘ombra contro Clemente XIV, fino a contribuire al suo avvelenamento.<br />
Porta poi prove dell‘atteggiamento intollerante dell‘Or<strong>di</strong>ne nei tempi presenti, come la<br />
lotta condotta a Torino contro il Dettori, professore universitario allontanato dall‘insegnamento<br />
sotto l‘accusa <strong>di</strong> Giansenismo, l‘ostilità contro Rosmini, il comportamento dei Gesuiti in<br />
Francia (avevano attaccato l‘insegnamento laico dell‘Università).<br />
Sul piano pratico Gioberti conferma il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> irrecuperabilità della Compagnia e<br />
ra<strong>di</strong>calizza la necessità <strong>di</strong> una lotta politica contro tutta la setta ―austro - gesuitica‖, cioè verso la<br />
Compagnia e tutta la sua ampia ―clientela‖, il ―Gesuitismo esterno‖, soprattutto se organizzato<br />
in congregazioni e associazioni.<br />
Tra <strong>di</strong> esse viene espressamente nominata, come espressione tipica <strong>di</strong> ―gesuitismo‖ una<br />
Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici genovesi comunemente denominata sotto il titolo del ―Beato<br />
Leonardo da Porto Maurizio‖ 165 .<br />
Scritto dall‘Autore con notevole impegno culturale, nella speranza <strong>di</strong> <strong>di</strong>re una parola<br />
definitiva nella polemica contro la Compagnia, il libro risulta pesantemente con<strong>di</strong>zionato<br />
proprio da questo carattere polemico, che fa <strong>di</strong>menticare all‘autore gli stessi inviti alla<br />
moderazione rivolti agli scrittori anti - gesuiti nei Prolegomeni.<br />
La pubblicazione del Gesuita moderno <strong>di</strong> Gioberti segnò una tappa importante non tanto<br />
nella formulazione <strong>di</strong> un‘analisi e <strong>di</strong> un programma ―anti - gesuitico‖, quanto nella sua<br />
assunzione come in<strong>di</strong>spensabile ―corollario‖ della battaglia per l‘unificazione ed il<br />
―Risorgimento‖ d‘Italia, da parte della corrente giobertiana.<br />
La sua <strong>di</strong>ffusione creò le premesse ideologiche per il passaggio dall‘ambito delle<br />
<strong>di</strong>scussioni semplicemente intellettuali all‘azione politica organizzata.<br />
Nella prima metà del ‘48 si ebbero in varie parti d‘Italia rimostranze e agitazioni <strong>di</strong><br />
carattere anti - gesuitico: nel Regno <strong>di</strong> Sardegna, nel Regno <strong>di</strong> Napoli e nello Stato Pontificio. Il<br />
carattere talvolta violento delle manifestazioni fu attribuito da parte dei suoi avversari proprio<br />
all‘influsso <strong>di</strong> Gioberti.<br />
Dopo la pubblicazione del Gesuita moderno, vi erano state forti pressioni su Pio IX, da<br />
parte della Compagnia e <strong>di</strong> alcuni sovrani, tra cui lo stesso Carlo Alberto, affinché la<br />
Congregazione dell‘In<strong>di</strong>ce condannasse lo scritto.<br />
In un primo momento il Pontefice preferí dare fiducia alla posizione del Card. Angelo<br />
Mai, prefetto, per il quale l‘opera non conteneva dei veri e propri errori dogmatici 166 .<br />
Con il successivo svolgersi <strong>degli</strong> avvenimenti (le manifestazioni anti - gesuitiche) la<br />
Curia <strong>roma</strong>na ritenne opportuna una qualche forma <strong>di</strong> censura, che si determinò, considerata<br />
anche la fama <strong>di</strong> cui godeva in quel momento Gioberti e anche alcuni pregi delle sue opere,<br />
nella forma <strong>di</strong> una correzione fatta dall‘Autore nei punti che gli sarebbero stati in<strong>di</strong>cati.<br />
165 È appunto tale Congregazione l‘argomento della presente ricerca.<br />
166 Cfr. G. MARTINA, Pio IX, op. cit., vol. I, 180-189, 220-224.<br />
49
Nel maggio ‗48, dopo quasi 15 anni d‘esilio, il filosofo torinese tornava in Italia, e vi<br />
riceveva quasi dovunque trionfali accoglienze.<br />
Durante la visita a Roma fu accolto in u<strong>di</strong>enza da Pio IX e si parlò anche del Gesuita<br />
moderno. Il Papa gli comunicò gli appunti mossi al libro e ne ottenne l‘assicurazione <strong>di</strong> una<br />
ritrattazione scritta dei punti compromettenti. Il mancato adempimento della promessa ed ancor<br />
piú le vicende della Repubblica Romana e la fuga del Papa a Gaeta compromisero in modo<br />
definitivo la fortuna <strong>di</strong> Gioberti presso la <strong>Santa</strong> Sede.<br />
La pubblicazione <strong>di</strong> un nuovo scritto del Carlo <strong>Maria</strong> Curci: Una <strong>di</strong>vinazione sulle tre<br />
ultime opere <strong>di</strong> V. Gioberti, i Prolegomeni, il Gesuita moderno, e l‟Apologia, e<strong>di</strong>to a Parigi nel<br />
1849, affrettò i tempi <strong>di</strong> una condanna che era ormai nell‘aria.<br />
Il Curci prende d‘assalto la stessa costruzione politico - religiosa del Gioberti,<br />
mostrandone, con quella agilità polemica che gli è propria, le intime e sostanziali <strong>di</strong>vergenze<br />
dalla dottrina cattolica tra<strong>di</strong>zionale 167 . Pur facendosi campione del Cattolicesimo ortodosso,<br />
Gioberti avrebbe sotto questo titolo introdotto la sua personale filosofia per piú aspetti deviante.<br />
Con decreto del 30 maggio 1849 tutte le opere <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti furono messe all‘In<strong>di</strong>ce dei<br />
libri proibiti.<br />
Dopo questa panoramica, riguardante il contesto italiano, nel capitolo seguente si<br />
cercherà <strong>di</strong> mostrare come la polemica antigesuitica <strong>di</strong> Gioberti abbia inciso nello sviluppo <strong>degli</strong><br />
avvenimenti a Genova, in riferimento alla Congregazione del Beato Leonardo.<br />
167 A. ANZILOTTI, Gioberti, op. cit., 190.<br />
50
CAPITOLO TERZO<br />
LA CONGREGAZIONE DEL BEATO LEONARDO<br />
DALLE REAZIONI A GIOBERTI ALLA SOPPRESSIONE<br />
1. LA POLEMICA SUL GESUITISMO A GENOVA<br />
Genova, da secoli fiorente centro commerciale e principale porto italiano del Tirreno<br />
settentrionale, perdette con il Congresso <strong>di</strong> Vienna l‘autonomia politica garantitagli da una<br />
lunga tra<strong>di</strong>zione repubblicana, e fu annessa nel 12 <strong>di</strong>cembre 1814 al Regno <strong>di</strong> Sardegna.<br />
I ceti <strong>di</strong>rigenti e impren<strong>di</strong>toriali della città, malgrado le mai sopite nostalgie<br />
dell‘autonomismo municipale, si orientarono per una politica <strong>di</strong> integrazione nello Stato<br />
sabaudo che valorizzasse le caratteristiche economiche della città, primariamente il porto. Esso<br />
poteva <strong>di</strong>ventare infatti lo sbocco ―naturale‖ non solo del commercio ligure e piemontese, ma<br />
anche <strong>di</strong> quello milanese e <strong>di</strong> tutta la pianura padana centro-occidentale. Per realizzare questo<br />
<strong>di</strong>segno, che avrebbe proiettato Genova su un livello commerciale internazionale, era necessario<br />
liberare la Lombar<strong>di</strong>a dalla dominazione austriaca. Gli ideali del Risorgimento <strong>di</strong> unità d‘Italia e<br />
d‘in<strong>di</strong>pendenza dallo straniero ebbero in Genova una singolare risonanza non solo per motivi<br />
culturali e storici, ma anche per i concreti interessi economici della città, o almeno delle sue<br />
classi <strong>di</strong>rigenti 168 . La città fu uno dei centri piú attivi della propaganda e dell‘attività<br />
risorgimentale, volta non solo alla lotta contro gli Austriaci ed all‘unificazione dell‘Italia, ma<br />
anche al conseguimento <strong>di</strong> istituzioni politiche e civili, <strong>di</strong> una qualche forma <strong>di</strong> rappresentazione<br />
elettorale.<br />
Il processo politico che andava maturando non ebbe uno sviluppo né facile né lineare, e<br />
vide momenti <strong>di</strong> lotta anche aspra. Genova, patria <strong>di</strong> Giuseppe Mazzini, capo della corrente<br />
repubblicana e democratica del Risorgimento, fu una delle basi del movimento repubblicano e<br />
rivoluzionario in Italia.<br />
Molto attiva fu anche la corrente liberale - moderata, che accettava la Monarchia,<br />
prevedeva un conseguimento dell‘unità attraverso accor<strong>di</strong> <strong>di</strong>plomatici (mentre i repubblicani <strong>di</strong><br />
Mazzini volevano basarsi sull‘iniziativa del popolo, attraverso delle insurrezioni) ma aderiva<br />
con entusiasmo alla lotta contro lo straniero e propugnava istituzioni liberali ed anti -<br />
assolutiste. Sebbene la propaganda repubblicana in Genova, alimentata anche dall‘antica<br />
tra<strong>di</strong>zione repubblicana della città raggiungesse un gran numero <strong>di</strong> studenti e fasce <strong>di</strong> borghesi<br />
ed artigiani, non ebbe quasi seguaci nel clero, anche tenuto conto del carattere non cattolico<br />
dell‘ideologia religiosa <strong>di</strong> Mazzini, la quale prescindeva infatti dalla Rivelazione biblica.<br />
Non cosí fu per le idee liberali moderate e particolarmente per quelle, cosiddette,<br />
―neoguelfe‖, <strong>di</strong> Gioberti in cui prospettava la possibilità <strong>di</strong> giungere all‘unificazione dell‘Italia<br />
me<strong>di</strong>ante una confederazione <strong>di</strong> Stati, alla cui presidenza stesse il Pontefice Romano. La<br />
proposta, che sembrava conciliare l‘adesione agli ideali unitari e risorgimentali, con la fedeltà al<br />
cattolicesimo ed al Papa, ebbe vari consensi negli ambienti cattolici e suscitò da piú parti gran<strong>di</strong><br />
entusiasmi.<br />
Vi era tuttavia nell‘agire politico <strong>di</strong> Gioberti un‘ambiguità che, sebbene solo piú tar<strong>di</strong><br />
venisse messa chiaramente in luce, lo rendeva inviso soprattutto ai gruppi piú legati alle<br />
tra<strong>di</strong>zioni. Un posto <strong>di</strong> rilievo nella lotta al Gioberti ebbero i Gesuiti, i quali sostenevano il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>vino dei re e perciò rigettavano il principio della sovranità popolare e guardavano con<br />
<strong>di</strong>ffidenza le correnti <strong>di</strong> pensiero moderne, quali venivano propagandate allora dai movimenti ad<br />
esse legate. Il Gioberti con il passare del tempo, fece della lotta ai Gesuiti uno dei punti<br />
qualificanti del suo programma politico, considerandoli uno dei piú gran<strong>di</strong> pericoli per il<br />
conseguimento dell'unità d‘Italia.<br />
Il Frassinetti, che da tempo era amico dei Gesuiti e vedeva con preoccupazione il largo<br />
<strong>di</strong>ffondersi delle idee giobertiane tra la popolazione, compresi i ceti piú poveri meno istruiti,<br />
ritenne <strong>di</strong> dover scrivere anche lui qualcosa a <strong>di</strong>fesa della Compagnia <strong>di</strong> Gesú. Conforme ad una<br />
168 Cfr. NURRA, Genova nel Risorgimento, Mílano 1948; G. ORESTE, Genova nel Risorgimento italiano<br />
1797-1861, in Quaderni Ligustici, n° 105, 2-16.<br />
51
sua costante attenzione per la <strong>di</strong>ffusione dei ―buoni libri‖ fra tutte le categorie <strong>di</strong> persone, anche<br />
le piú semplici, riteneva importante la pubblicazione <strong>di</strong> un qualche libretto <strong>di</strong> facile e gradevole<br />
lettura che potesse essere <strong>di</strong>vulgato per arginare, in parte, la sormontante corrente giobertiana.<br />
Provò a scriverlo e, sebbene consapevole <strong>di</strong> mettersi contro un personaggio piú famoso e<br />
agguerrito, dopo qualche esitazione, <strong>di</strong>ede alle stampe nel maggio 1846, anonimo, il suo<br />
―Saggio intorno alla <strong>di</strong>alettica e religione <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti‖ 169 .<br />
Lo scritto ha un tono vivace ed ironico e si esprime con valutazioni decisamente<br />
polemiche verso quelle <strong>di</strong> Gioberti. Quest‘ultimo vedeva nella storia della Compagnia <strong>di</strong> Gesú<br />
due momenti, il primo, quello iniziale, positivo cioè animato da autentico fervore evangelico,<br />
l‘altro invece <strong>di</strong> corruzione ed involuzione nel quale la Compagnia, mettendo se stessa al centro<br />
dell‘universo (egoismo <strong>di</strong> gruppo), era <strong>di</strong>venuta nella società causa <strong>di</strong> molti mali. Per questo<br />
motivo il Papa Clemente XIV l‘avrebbe meritatamente abolita. Piú tar<strong>di</strong> Papa Pio VII,<br />
considerando i molti mali da cui era afflitta la società e la stessa cristianità, avrebbe ripristinato<br />
la Compagnia <strong>di</strong> Gesú, ma con l‘intenzione <strong>di</strong> richiamare in vita quella <strong>degli</strong> inizi e non quella<br />
corrotta. Purtroppo la Compagnia non avrebbe risposto positivamente a queste attese, ed<br />
avrebbe ripreso a camminare su una strada <strong>di</strong> degradazione morale, religiosa e politica,<br />
propagando ad esempio: una morale rilassata, il casuismo, numerose pratiche devozionali <strong>di</strong><br />
nessun valore, ed aspirando a <strong>di</strong>rigere gli affari politici <strong>degli</strong> Stati.<br />
Il Frassinetti contesta questa impostazione della storia della Compagnia, ed asserisce<br />
che essa ha dato nel corso <strong>di</strong> tutti i tempi della sua esistenza uomini vali<strong>di</strong>, santi e dotti. Essa<br />
inoltre fin dall‘inizio ebbe sostenitori e demolitori cosí come nei tempi allora correnti. Gioberti,<br />
riprendendo argomenti già usati dai detrattori della Compagnia, avrebbero lodato invece i tempi<br />
<strong>di</strong> S. Ignazio perché essi non davano fasti<strong>di</strong>o per il presente. Egli inoltre rimprovera al Gioberti<br />
<strong>di</strong> accusare i Gesuiti <strong>di</strong> molte colpe, senza prendersi la briga <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare nessuna <strong>di</strong> queste<br />
accuse.<br />
Nel suo ―Saggio‖ il Frassinetti, segue a gran<strong>di</strong> linee lo sviluppo delle affermazioni del<br />
Gioberti e, riportandone ampi passi, cerca <strong>di</strong> metterne in luce le supposte contrad<strong>di</strong>zioni, lacune<br />
o falsità. Benché l‘oggetto del <strong>di</strong>scorso siano sempre i Gesuiti, Frassinetti vuole mostrare in<br />
concreto come siano carenti sia ―la <strong>di</strong>alettica‖ che ―la religione‖ dell‘abate torinese. Anche<br />
questo scritto del Frassinetti suscitò un certo scalpore, tanto piú che l‘autore non riuscí a<br />
mantenere l‘incognito.<br />
Dal fronte avversario non tardò ad arrivare una risposta: nel luglio 1846 fu pubblicato lo<br />
scritto ―I Gesuiti - risposta al M. R. D. Frassinetto, per C. B.‖ 170 , stampato alla macchia in<br />
quanto non aveva l‘approvazione della censura. Secondo gli ecclesiastici 171 che hanno <strong>stu<strong>di</strong></strong>ato<br />
questo periodo storico, ne fu estensore Cristoforo Bonavino, noto anche per i suoi scritti sotto lo<br />
pseudonimo <strong>di</strong> Ausonio Franchi 172 . Scopo dello scritto era ―smascherare‖ l‘autore dello<br />
―schifoso libello‖ il quale ―non dubitò <strong>di</strong> vilipendere il primo filosofo e teologo d‘Italia‖ 173 ,<br />
169<br />
Saggio sulla <strong>di</strong>alettica e religione <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti, pubblicato anonimo, Tip. Fazíola, Genova<br />
1846, 66. L‘opuscolo preparato per la seconda e<strong>di</strong>zione non fu stampato. Conforme ad essa è il testo e<strong>di</strong>to<br />
in Opera Omnia, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1912, vol. XIII, del quale testo ci serviamo stampato<br />
anche, come stralcio, in un volumetto a sé.<br />
170<br />
G. BONAVINO, I Gesuiti, op. cit. L‘errore del nome, certamente voluto, denota una vena polemica<br />
Frassinetto = piccolo albero.<br />
171<br />
Cosí Angelo Remon<strong>di</strong>ni e soprattutto Arturo Colletti nei suoi Manoscritti.<br />
172<br />
Il Bonavino, nato a Pegli Genova il 27 febbraio 1821, iniziò gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> ecclesiastici nel Seminario <strong>di</strong><br />
Genova e li concluse a Bobbio, dove fu or<strong>di</strong>nato presbitero dal Vescovo A. M. Gianelli, allora suo amico<br />
e protettore. Dopo aver rotto le relazioni con il Gianelli ritornò a Genova, dove ebbe <strong>di</strong>fficoltà<br />
economiche. Aderí alle idee giobertiane e successivamente mazziniane. in campo filosofico si fece<br />
assertore del razionalismo, e scrisse, sotto lo pseudonimo <strong>di</strong> AUSONIO FRANCHI: ―La Filosofia delle<br />
Scuole Italiane‖. Ritornò alla Chiesa Cattolica negli ultimi anni della vita e scrisse l‘―Ultima critica‖,<br />
ritrattazione autobiografica <strong>degli</strong> errori passati. Morí il 12 settembre 1895, confortato dai sacramenti. Cfr.<br />
G. DELLA VOLPE, Ausonio Franchi pseudonimo <strong>di</strong> Cristoforo Bonavino, in Enciclope<strong>di</strong>a Italiana, Roma<br />
1932, vol. XV, 875.<br />
173<br />
G. BONAVINO, I Gesuiti, op. cit., Introduzione al lettore italiano.<br />
52
autore che identifica senz‘altro nel Frassinetto (sic!), Priore <strong>di</strong> S. Sabina, che perciò non manca<br />
<strong>di</strong> oltraggiare nel corso del suo scritto 174 .<br />
Riguardo al contenuto vero e proprio, esso è una <strong>di</strong>fesa delle idee <strong>di</strong> Gioberti sui<br />
Gesuiti, idee che il Frassinetti avrebbe <strong>di</strong>storto interpretando i Prolegomeni «a spiluzzico,<br />
saltandone una parte, travisandone un‘altra e interpretando a capriccio le intenzioni dello<br />
scrittore» 175 . Per il resto lo stesso Bonavino segue un metodo analogo a quello del Frassinetti,<br />
riportandone vari brani, con interpolazioni, e dando una risposta che tende o a chiarificare il<br />
supposto autentico pensiero <strong>di</strong> Gioberti, o a portare prove storiche <strong>di</strong> queste affermazioni. Viene<br />
cosí a determinare il periodo della degenerazione della Compagnia <strong>di</strong> Gesú intorno al 1700,<br />
dopo che, raggiunto il massimo del successo mondano, si sarebbe lasciata da questo traviare 176 .<br />
Per quanto riguarda i Gesuiti moderni l‘autore afferma che essi si opponevano agli asili infantili,<br />
alle casse <strong>di</strong> risparmio, ai ricoveri <strong>di</strong> men<strong>di</strong>cità, alle stesse ferrovie, e questo avrebbero fatto per<br />
non vedere limitato il loro predominio spirituale e politico con il progresso della società civile.<br />
Essi sarebbero i sostenitori <strong>di</strong> una ―chiesa falsa‖, che si era insinuata nella Chiesa vera e la<br />
deturpava. Questo sarebbe stato il motivo per cui i Gesuiti andavano combattuti 177 .<br />
Tralasciando i singoli punti della polemica riportiamo la conclusione: «Per concludere,<br />
sa il mondo e particolarmente l‘Italia, quali siano i Gesuiti: essi sono i veri nemici del<br />
cristianesimo, della sede <strong>roma</strong>na e dei popoli. Nessun‘opera potrebbe farsi piú grata a Dio<br />
Padre, <strong>di</strong> cui hanno negato l‘eterna paternità, a Dio <strong>Figli</strong>olo, <strong>di</strong> cui non ammettono la<br />
generazione ab aeterno dal Padre, a Dio Spirito Santo, <strong>di</strong> cui negano l‘eternità negando quella<br />
delle altre due persone, che quella <strong>di</strong> liberar l‘Europa ed il mondo da quest‘Or<strong>di</strong>ne, che<br />
cominciò a tralignare ne suoi <strong>di</strong>spotici generali subito dopo la morte d‘Ignazio, loro santo<br />
fondatore» 178 . Allo scritto del Bonavino il Frassinetti rispose con il silenzio, conforme ai suoi<br />
principi, manifestati anche in altre occasioni 179 . A sua <strong>di</strong>fesa fu stampata e <strong>di</strong>ffusa una<br />
―Osservazione al libello <strong>di</strong> C. B.‖, <strong>di</strong> sole quattro pagine, firmata da P.G. (Prete Gaetano<br />
identificato dai piú con Gaetano Alimonda) che scrive «... se in lui (Frassinetti, ndr) calunniato<br />
<strong>di</strong>venta bello il silenzio, egli è come un dovere che altri parli e scriva, quando frammiste alle<br />
ipocrite accuse personali s‘incontrano <strong>di</strong> quegli errori e <strong>di</strong>sorbitanze che offendono la santità<br />
della religione» 180 . L‘Autore dell‘Osservazione riferisce che C. B. fece circolare per la città due<br />
mesi prima del suo scritto, la voce che ―si apparecchiava una fierissima confutazione del Balbo<br />
(Cesare, ndr) contro il Frassinetti‖, giocando poi sulla coincidenza delle iniziali al momento<br />
della stampa 181 .<br />
Secondo l‘Osservazione, C. B. parla risoluto ―il linguaggio dei protestanti‖ ed è questo<br />
soprattutto che ferisce la religione. Per provare questa affermazione si porta il fatto che «Nella<br />
definizione che fa della sua chiesa, non altro capo le assegna che l‘invisibile, cioè il Salvatore,<br />
non facendo conto del visibile 182 , cioè del Sommo Pontefice... » Altra prova sarebbe la simpatia<br />
manifestata verso i Calvinisti contro i Cattolici, nelle guerre <strong>di</strong> religione. L‘Osservazione inoltre<br />
rifiuta e ri<strong>di</strong>colizza l‘idea delle ―due Chiese‖ una vera ed una falsa, coesistenti nel<br />
Cattolicesimo. Nella finale P. G. porta l‘esempio dello scritto <strong>di</strong> C. B. per mostrare i pericoli<br />
della libertà <strong>di</strong> stampa. La <strong>di</strong>ffusione del foglio <strong>di</strong> P.G. forní lo spunto per la pubblicazione <strong>di</strong> un<br />
174<br />
Ibid. «Ma noi sappiamo chi l‘ha scritto, e come la legge sa trarre <strong>di</strong> mezzo ai citta<strong>di</strong>ni buoni i<br />
colpevoli, per esporre loro soli alla berlina, e colpirli con la dovuta pena; cosí noi non lanceremo i nostri<br />
colpi alla cieca, ma pel suo proprio nome appelleremo il calunniatore: non ignoriamo i doveri<br />
dell‘urbanità, ma ad uomini <strong>di</strong> tal crusca qual riguardo è dovuto? Dell‘onta che s'è cercata è compenso<br />
bastante l‘amicizia del Gesuitismo: perciò gli risponderemo come si debbe ai monelli ed ai commettimale,<br />
dei quali ha imitato i mo<strong>di</strong>».<br />
175<br />
Ibid., 2.<br />
176<br />
Ibid., 42 - 43.<br />
177<br />
Ibid., 6 s.<br />
178<br />
Ibid., 64.<br />
179<br />
Egli cercò tuttavia <strong>di</strong> far sequestrare dalle autorità dello Stato lo scritto, ma queste, prendendo tempo,<br />
resero inefficace il provve<strong>di</strong>mento poi adottato.<br />
180<br />
P. G., Osservazioni al libello <strong>di</strong> C.B., Genova 1846.<br />
181<br />
Ibid.<br />
182<br />
G., Osservazioni al libello <strong>di</strong> C.B., Genova 1846.<br />
53
nuovo scritto a <strong>di</strong>fesa del Gioberti e dell‘operetta <strong>di</strong> C. B. sui Gesuiti, il cui titolo era<br />
―Autentiche prove contro i Gesuiti moderni e loro affiliati" 183 ; l‘Autore si celava sotto la sigla B.<br />
C. Gli <strong>stu<strong>di</strong></strong>osi ecclesiastici <strong>di</strong> questi avvenimenti attribuiscono anche questo scritto a Cristoforo<br />
Bonavino, il quale avrebbe perciò semplicemente invertito l‘or<strong>di</strong>ne delle sue iniziali 184 . L‘autore<br />
che fa mostra <strong>di</strong> non conoscere C. B., usa un tono piú pacato ed apparentemente piú <strong>di</strong>staccato<br />
ed obiettivo <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> C. B. che comunque <strong>di</strong>fende e loda.<br />
L‘inizio è un atto <strong>di</strong> omaggio al Gioberti: «Non v‘ha nessuno che ignori il nome <strong>di</strong><br />
Vincenzo Gioberti; nessuno, anche me<strong>di</strong>ocremente letterato, che non ne conosca le opere, piene<br />
<strong>di</strong> filosofia, <strong>di</strong> patriottismo, <strong>di</strong> religione; e se la civiltà conta oggi buon numero <strong>di</strong> promotori fra<br />
i dotti, non ultimo certamente riconosce il filosofo torinese» 185 . L‘Autore presentava poi, dal suo<br />
punto <strong>di</strong> vista, lo ―status quaestionis‖: elogiava i meriti patriottici <strong>di</strong> Gioberti, ricordava e<br />
<strong>di</strong>fendeva le sue accuse alla Società <strong>di</strong> Gesú, menzionava i P. Pellico e Curci, «a quali ragione<br />
vuole che sia resa giustizia; l‘uno e l‘altro hanno benissimo propugnato la loro causa, e il<br />
secondo particolarmente <strong>di</strong>ede saggio <strong>di</strong> buone lettere, <strong>di</strong> accorta strategia, <strong>di</strong> valente <strong>di</strong>alettica,<br />
e fece piú <strong>di</strong> quello che in quelle circostanze si potesse aspettare» 186 . Prendeva poi in esame il<br />
Saggio, definendolo «libro <strong>di</strong> piccolissima mole, piú fertile <strong>di</strong> spropositi che <strong>di</strong> concetti, e<br />
spirante lo sprezzo e l‘o<strong>di</strong>o per il Gioberti. Ivi non eru<strong>di</strong>zione, non lingua, non gravità, non<br />
filosofia, non carità... » 187 . Mostrava quin<strong>di</strong> stupore che Frassinetti non avesse smentito<br />
pubblicamente <strong>di</strong> essere l‘autore del Saggio «<strong>di</strong>chiarandosi monde le mani da quel sacrilegio;<br />
giacché chiunque al vero progresso si oppone, chiunque combatte l‘incivilmento, e a‘ mezzi de‘<br />
popolari miglioramenti si attraversa, appunta le armi contro alla religione, e si fa reo <strong>di</strong> lesa<br />
umanità e <strong>di</strong>vinità» 188 . Riferiva infine della Risposta <strong>di</strong> C. B., libro che «se era piú ragionato e<br />
meglio scritto, era tuttavia alquanto acerbo e risentito; e quanto il primo era contumelioso a<br />
Gioberti e alla civiltà, tanto fu il secondo pungentissimo e inesorabile contro il reverendo<br />
Frassinetto; e la <strong>di</strong>sputa s‘avvicinò alla personalità» 189 . L‘autore prosegue respingendo l‘accusa<br />
al Gioberti <strong>di</strong> essere irreligioso, ed ancora piú <strong>di</strong> mancare <strong>di</strong> <strong>di</strong>alettica 190 . Passa quin<strong>di</strong><br />
all‘attacco e taccia il Frassinetti <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zione, <strong>di</strong> ignoranza e <strong>di</strong> calunnia 191 . Giu<strong>di</strong>ca perciò<br />
che «meritatamente gli fu dato addosso dal signor C. B., il quale, chiunque sia, mostrossi<br />
acutissimo e sagacissimo ragionatore, e il nostro paese gli è obbligato <strong>di</strong> aver <strong>di</strong>feso Gioberti da<br />
un impertinente aggressore» 192 . Notevole, per la nostra narrazione, ci sembra la <strong>di</strong>fesa che viene<br />
fatta all‘interpretazione della Rivoluzione francese fatta da C. B. come conseguenza <strong>degli</strong><br />
eccessi dell‘Assolutismo, e la <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> questi dall‘accusa <strong>di</strong> ―protestantesimo‖, mossagli da P.<br />
G. Nella definizione <strong>di</strong> Chiesa non si parlerebbe del Capo visibile (Papa) per necessaria brevità,<br />
allo stesso modo che fanno i Simboli della Chiesa Antica 193 . La <strong>di</strong>fesa dei Protestanti contro i<br />
Cattolici nelle guerre <strong>di</strong> religione riguarderebbe il loro comportamento morale e «la vita civile<br />
pura ed austera», contro «ai <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni, alla cupi<strong>di</strong>tà, alla rapacità, alle libi<strong>di</strong>ni della cattolica<br />
nobiltà» 194 e non i dogmi e le proposizioni della Fede. L‘autore vuole inoltre giustificare C. B.,<br />
non solo <strong>di</strong> aver <strong>di</strong>feso Gioberti ritorcendo l‘accusa <strong>di</strong> calunniatore sul Frassinetti, ma anche <strong>di</strong><br />
183<br />
G. BONAVINO, Autentiche prove, op. cit., 1846.<br />
184<br />
Cosí Remon<strong>di</strong>ni, Colletti e tutti i biografi del Frassinetti. Anche qui viene accolta questa ipotesi.<br />
185<br />
Cfr. Ibid., 7.<br />
186<br />
Ibid., 11.<br />
187<br />
Ibid., 12.<br />
188<br />
Ibid., 12.<br />
189<br />
Ibíd., 13.<br />
190<br />
«Si contesta la bontà della sua <strong>di</strong>alettica, la <strong>di</strong>alettica <strong>di</strong> Gioberti, quella che non contestarono prima<br />
d‘ora né i Zantedeschi, né i Tar<strong>di</strong>ti, né Rosmini; i quali, se quell‘accusa avesse avuto un fondamento al<br />
mondo, non avrebbero certo mancato nelle loro dotte <strong>di</strong>scussioni <strong>di</strong> palesarlo e <strong>di</strong> darne le prove. Ora ciò<br />
che non osarono i soprallodati filosofi, come osò <strong>di</strong>rlo con tanta impudenza colui che, a tutti ignoto, e <strong>di</strong><br />
nessuna dottrina corredato, in molte ciancie fidandosi, imbaldanziva fino a chiamare ignorante un savio a<br />
cui tutti i dotti d‘Italia portan rispetto? ». G. BONAVINO, Autentiche prove, op. cit., 14.<br />
191<br />
Ibid., 14 ss.<br />
192 Ibid., 16.<br />
193 Ibid., 64.<br />
194 Ibid., 55.<br />
54
averlo fatto «in termine <strong>di</strong> ri<strong>di</strong>colo, e talvolta ancora <strong>di</strong> sprezzo» 195 . Dopo aver paragonato<br />
Frassinetti ad una bertuccia, ed a Tersite, sostiene che la satira può oltrepassare i limiti<br />
dell‘urbanità quando serve: a) per respingere le impertinenti aggressioni; b) per ven<strong>di</strong>care i<br />
<strong>di</strong>ritti della «ragione contro gli attentati <strong>di</strong> uno stolto o d‘un impostore‖; c) per ven<strong>di</strong>care i <strong>di</strong>ritti<br />
del giusto, dell‘onesto, della patria, dagli attentati dei malvagi... » 196 . Il Frassinetti si sarebbe<br />
macchiato <strong>di</strong> tutt‘e tre le colpe e perciò «lo sdegno <strong>di</strong> C. B. era giustissimo» 197 . L‘ultima parte<br />
dello scritto è una duplice esortazione a C. B. ed al Gíoberti perché proseguano nella loro<br />
attività. Il primo viene incoraggiato, al pari <strong>di</strong> Gesú Cristo, a proseguire la sua lotta contro il<br />
―Fariseismo‖, <strong>di</strong> cui considera rappresentanti i Gesuiti 198 .<br />
Del secondo si esaltano i tentativi <strong>di</strong> liberare il «maestoso albero della Religione<br />
santissima dalle ―male piante‖» 199 , per i quali ha dovuto soffrire persecuzione. Cosí la<br />
conclusione: «L‘Italia, o Gioberti, vi deve molto, e vorrebbe rimunerarvi, se in qualche modo ne<br />
avesse facoltà; non potendo altro, vi ringrazia, e afferma che in voi vede e riverisce il piú grande<br />
suo amico, il piú ardente dei suoi <strong>di</strong>fensori. Il guiderdone principale delle vostre fatiche,<br />
l‘immortalità, vi è già assicurata, né può fallirvi: continuate nella gloriosa intrapresa, e,<br />
favorendovi Id<strong>di</strong>o, ne avrete intera la palma» 200 .<br />
Vincenzo Gioberti intervenne nuovamente nella polemica con cinque volumi del suo ―Il<br />
Gesuita moderno‖ 201 . La voluminosa opera ebbe un enorme successo, e se ne vendettero in tutta<br />
la penisola, in breve tempo, circa quattor<strong>di</strong>cimila copie. Nello scritto l‘abate torinese<br />
raccoglieva tutti i documenti e le testimonianze che gli sembravano atti a suffragare i motivi<br />
della sua opposizione ai Gesuiti, motivi che riesponeva con piú veemenza. Dopo la<br />
pubblicazione <strong>di</strong> quest‘opera la lotta al ―gesuitismo‖ <strong>di</strong>venne uno dei punti qualificanti del<br />
―neoguelfismo‖. In esso il Gioberti nomina personalmente Frassinetti: «Egli è chiaro che con<br />
questi canoni l‘abate Giuseppe Frassinetti, prevosto <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina, dovette scoprire nelle varie<br />
mie opere e soprattutto nei miei Prolegomeni l‘orma scolpita <strong>di</strong> un nemico della Chiesa,<br />
ond‘egli stimò bene <strong>di</strong> avvertire i suoi popolani con un‘operetta a proposito, nella quale però<br />
volle per modestia, tacere il proprio nome. Egli si contenta <strong>di</strong> chiamarmi filosofo pervertitore,<br />
oppressore della verità, autore <strong>di</strong> innumerevoli calunnie <strong>di</strong> cento pagine <strong>di</strong> vituperio, <strong>di</strong> un<br />
attentato nefando, <strong>di</strong> <strong>di</strong>cerie gonfie, capziose, seducenti ... che io sono il campione dei nemici<br />
della Chiesa» 202 .<br />
L‘abate torinese mostrava dunque <strong>di</strong> essere a conoscenza del Saggio <strong>di</strong> Frassinetti, ed<br />
anche <strong>di</strong> aver preso visione delle Riflessioni; attesta inoltre <strong>di</strong> aver letto i libretti <strong>di</strong> risposta del<br />
Bonavino.<br />
Il Gesuita moderno ospitava inoltre una relazione dal titolo Del Gesuitismo in Liguria,<br />
che non era opera del Gioberti, ma <strong>di</strong> altra persona che egli presenta cosí: «La seguente notizia<br />
fu <strong>di</strong>stesa da un personaggio <strong>di</strong> lealtà e pietà specchiatissime e bene informato della materia».<br />
Ma chi scrisse Il Gesuitismo in Liguria?<br />
Secondo Paolo Negri 203 «l‘informatore del Gioberti intorno al gesuitismo in Liguria ora<br />
ci si svela da autentici e inconfutabili documenti: ed è il futuro ministro <strong>degli</strong> interni del primo<br />
gabinetto costituzionale <strong>di</strong> Carlo Alberto, e futuro collega del Gioberti, poi segretario <strong>di</strong> Stato<br />
alle finanze nel ministero presieduto dal Gioberti stesso: il Marchese Vincenzo Ricci <strong>di</strong><br />
195 Ibid., 66.<br />
196 Ibid., 68.<br />
197 Ibid., 69.<br />
198 Ibid., 69 ss.<br />
199 Ibid., 71.<br />
200 Ibid., 73.<br />
201 V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, 5 voll., Losanna, 1846 - 47. E<strong>di</strong>zione nazionale a cura <strong>di</strong> : F.<br />
SCIACCA, Milano, 1940 - 42, 6 voll. Le citazioni sono tratte da quest‘ultima e<strong>di</strong>zione.<br />
202 V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., Discorso preliminare, vol. I, CCCXXXVIII ss.<br />
203 NEGRI, V. Ricci e il “Gesuita moderno”, in Rassegna storica del Risorgimento italiano, a. VII, 1921,<br />
244-275.<br />
55
Genova» 204 . Il gesuita Rinieri ritiene che il medesimo marchese ne sia l‘autore e vede ―la mano<br />
e la farina del Ricci‖ nell‘opera <strong>di</strong> cui parliamo 205 .<br />
Ricci trasmise a Gioberti questa relazione, come risulta anche dalla lettera che inviò a<br />
Gioberti il 6 giugno 1846: «Rispondo alla vostra del 7 e del 15 maggio sí tar<strong>di</strong>, non per<br />
trascuranza, ma per ottenere notizie precise. Non fui per altro neghittoso, e fin dal 20 maggio,<br />
feci pervenire all‘avv. Pinchia una lunga memoria, contenente la storia municipale del<br />
Gesuitismo. Essa è scritta <strong>di</strong> primo getto, e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nata e incolta nella forma, ma esatta e<br />
frutto <strong>di</strong> accurate indagini. Lettala, se vi occorrono delucidazioni su qualche punto non avete<br />
che a in<strong>di</strong>carmelo, ma, ripeto, quanto ai fatti sono precisi» 206 . Ricci dunque fece pervenire a<br />
Gioberti questa relazione, ma fu lui a comporla? Arturo Colletti, sacerdote genovese esperto <strong>di</strong><br />
storia <strong>di</strong>ocesana, sostiene che lo scritto suppone la mano <strong>di</strong> un sacerdote, sia per le informazioni<br />
particolareggiate <strong>di</strong> fatti ecclesiastici, sia per le osservazioni teologiche e morali inframesse 207 .<br />
Fa notare inoltre che Ricci, pur essendo agli occhi <strong>di</strong> Gíoberti pienamente ―leale‖, <strong>di</strong>fficilmente<br />
si potrebbe definire personaggio <strong>di</strong> ―pietà specchiatissima‖ e neppure ―ben informato nella<br />
materia 208 .<br />
Propone perciò il nome <strong>di</strong> Cristoforo Bonavino, il quale non aveva ancora letto il<br />
Saggio, <strong>di</strong> Frassinetti, ma sarebbe già stato interessato alla polemica, come poi avrebbe<br />
<strong>di</strong>mostrato con i due opuscoli, sopra esaminati 209 . Pur non potendo dare una risposta completa e<br />
definitiva al problema della ―paternità‖ della relazione, vogliamo qui sottolineare il ruolo <strong>di</strong><br />
primo piano svolto da Vincenzo Ricci nella preparazione delle informazioni e <strong>degli</strong> scritti che<br />
potevano essere utili a Gioberti nella compilazione del suo Gesuita moderno, e la adesione<br />
stessa del Ricci alle analisi ed alle proposte del ―Gesuitismo in Liguria‖ 210 .<br />
Premessa generale era che «l'influenza dei RR. Padri (Gesuiti ndr) si era sviluppata ed<br />
estesa in Genova con il mezzo <strong>di</strong> società subalterne» 211 . Si ricordava la fondazione delle Pie<br />
Opere <strong>di</strong> S. Raffaele e <strong>di</strong> S. Dorotea che si consideravano come opere controllate dai gesuiti in<br />
quanto gestite da preti devoti alla Compagnia 212 .<br />
204<br />
Ibid., 250.<br />
205<br />
I. RINIERI, Il Gesuita moderno, op. cit., 319.<br />
206<br />
Cfr NEGRI, V. Ricci, art. cit., 244.<br />
207<br />
A. COLETTI, Manoscritti, cap. XVI, 24-36.<br />
208<br />
Scrive infatti Ricci a Gioberti: «Io vado raccogliendo i fatti principali, e vi renderò informato. Devo<br />
procurarmeli con l‘interrogare molti». Cfr NEGRI, V. Ricci, art. cit., 265 S. Sulla base <strong>di</strong> questa<br />
affermazione Colletti sostiene che Ricci poteva essere ―ben informato della materia‖ e cerca perciò un<br />
altro autore, per il quale propone il nome <strong>di</strong> C. Bonavino. Colletti de<strong>di</strong>ca varie pagine a sostenere la sua<br />
tesi. Riteniamo che addentrarsi in questi problemi ―tecnici‖ non sia produttivo per lo sviluppo del nostro<br />
<strong>di</strong>scorso. Il problema dell‘attribuzione dello scritto sul ―Gesuitismo in Liguria‖ può benissimo restare<br />
aperto, rimanendo l‘augurio che altri possano risolverlo in maniera sod<strong>di</strong>sfacente e definitiva.<br />
209<br />
La relazione fu spe<strong>di</strong>ta da V. Ricci a Gioberti il 20 maggio, era perciò già composta, quando, proprio<br />
in quei giorni, uscí il Saggio del Frassinetti.<br />
210<br />
Vincenzo Ricci, come si vedrà nel paragrafo seguente, ebbe un ruolo rilevante nelle vicende politiche<br />
del tempo, prima come uno dei capi del Movimento Costituzionale genovese, poi come ministro del<br />
Regno <strong>di</strong> Sardegna.<br />
211<br />
V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., vol. VI, doc. XXIII, 183.<br />
212<br />
«Nell‘anno 1829 venne a pre<strong>di</strong>care in Genova, durante la quaresima, nella chiesa <strong>di</strong> N.S. del Carmine,<br />
il bergamasco d. Luca Bussi Passi, ndr: questi fatta riunione <strong>di</strong> alcuni ecclesiastici, giovani piú bigotti che<br />
istruiti, li fanatizzò con l‘idea <strong>di</strong> mettere i ragazzi del popolo nella necessità <strong>di</strong> apprendere la dottrina<br />
cristiana senza che, per alcun pretesto potessero sottrarsi ad un dovere cosí sacro. Questo principio, per se<br />
stesso commendevole senza offendere la massima che la religione si persuade e non s‘impone generò<br />
l‘istituzione, da lui pre<strong>di</strong>cata, <strong>di</strong> due Congregazioni, l‘una per i ragazzi sotto il nome <strong>di</strong> S. Raffaele<br />
Arcangelo, l‘altra per le ragazze sotto il nome <strong>di</strong> S. Dorotea. Quella <strong>di</strong> S. Raffaele non è quasi curata, ma<br />
quella <strong>di</strong> S. Dorotea esercita ed attrae tutto lo zelo dei cooperatori. In essa si trovano delle matrone, che,<br />
sotto l‘egida del loro nome, tutelano la società; delle anziane, ciascuna delle quali sovrasta ad un numero<br />
<strong>di</strong> ragazze; delle allieve che <strong>di</strong>pendono imme<strong>di</strong>atamente dalle anziane: tutte poi si confessano dai<br />
sacerdoti addetti alla Congregazione medesima o dai Gesuiti... » Cfr. V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno,<br />
op. cit., vol. VI, doc. XXIII, 183.<br />
56
Si faceva cenno all‘istituto delle Suore Dorotee ed al Convitto (Conservatorio <strong>di</strong> S.<br />
Dorotea) da esso pre<strong>di</strong>sposto per le ragazze 213 . Si parlava poi della situazione nel Seminario, e<br />
del controllo che la fazione filo - gesuitica avrebbe esercitato sulle or<strong>di</strong>nazioni sacerdotali,<br />
estromettendo gli elementi considerati avversi 214 .<br />
Si parla poi della Congregazione del Beato Leonardo: «Si riunirono in una casa alcuni<br />
<strong>di</strong> questi preti, e fondarono una società presso a cui invitavano i chierici a leggere e <strong>di</strong>scutere<br />
sopra a materie <strong>di</strong> teologia e <strong>di</strong> morale (facendo cioè quello che il Concilio <strong>di</strong> Trento affida ai<br />
parrochi per le conferenze) e sopratutto <strong>di</strong> ascetizzare in preghiere, soliloqui, orazioni mentali,<br />
me<strong>di</strong>tazioni, confessioni pubbliche ecc ... In queste congreghe si <strong>di</strong>scutono casi <strong>di</strong> coscienza,<br />
che tutti hanno uno scioglimento talmente lasso da essere in opposizione <strong>di</strong>retta con i principi<br />
elementari della giustizia, invocando a sostegno dottrine erronee o falsamente applicate» 215 .<br />
«Questa società avendo a membro zelantissimo certo prete Sturla, capro emissario <strong>di</strong><br />
tutte le parti o<strong>di</strong>ose (mentre gli altri guadagnano cure d‘anime, canonicati, abbazie, vescovati)<br />
prese il nome popolare <strong>di</strong> Sturlismo. Lo Sturlismo, presentatosi sotto l‘aspetto <strong>di</strong> un corpo <strong>di</strong><br />
ecclesiastici, che <strong>di</strong>rettamente <strong>di</strong>pendenti dall‘Arcivescovo, si prestassero, in ubbi<strong>di</strong>enza ai suoi<br />
or<strong>di</strong>ni, al soccorso ai parrochi ... annoverò, a principio, alcuni preti istruiti e <strong>di</strong> sani principi, ed<br />
ottenne un Regolamento approvato dall‘Arcivescovo sotto il nome <strong>di</strong> Congregazione del Beato<br />
Leonardo da Portomaurizio.<br />
Appena ebbero un‘esistenza legale, il presidente delegato dall‘Arcivescovo, fu<br />
convertito in fantasma e nulla potea: agenti, piú audaci e non cosí retti, istillavano le dottrine e<br />
maneggiavano gli affari, ed estendendo le loro viste fondarono tra loro una segreta, in cui, non<br />
piú sui soli chierici, ma su tutto il clero, si estendeva la pulizia loro» 216 .<br />
«Da questa Congrega uscirono i libri Riflessioni agli Ecclesiastici del prevosto<br />
Frassinetti e l‘opuscolo <strong>di</strong> Storace L‟in<strong>di</strong>fferenza in materia politica trae seco l‟in<strong>di</strong>fferenza in<br />
materia religiosa. La pubblicazione <strong>di</strong> questi due scritti fantastici e menzogneri <strong>di</strong>ede luogo al<br />
ritiro <strong>di</strong> quei preti che <strong>di</strong> buona fede erano entrati nella Congregazione, e per necessaria<br />
conseguenza, motivò la persecuzione cui andarono e vanno sottoposti» 217 . L‘autore mostra<br />
dunque una <strong>di</strong>screta conoscenza della Congregazione, che valuta in senso opposto a quello dei<br />
suoi fondatori. Interessante il fatto che l‘autore, certamente fonte non sospettabile <strong>di</strong> indulgenza<br />
verso la Congregazione, parli <strong>di</strong> ―persecuzione‖ riferendola sia al tempo della pubblicazione<br />
delle Riflessioni del Frassinetti (1837), sia al presente (1846), considerandola del resto<br />
pienamente giustificata.<br />
Lo scritto non ignora la vicenda dei parroci accusati <strong>di</strong> Giansenismo: «Siffatti maneggi,<br />
nei quali troppo aperta era l‘influenza dei Gesuiti, nauseavano la parte sana del clero ed allora i<br />
RR. P. s‘appigliarono ad assalire nominativamente i piú rispettabili parrochi e sacerdoti <strong>di</strong><br />
213 V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., vol. VI, doc. XXIII, 183 ss.<br />
214 «Ma come le idee gesuitiche non sono limitate ad un solo mezzo, oltre a questo vasto sistema <strong>di</strong><br />
d‘istruzione nei ragazzi, da cui hanno esor<strong>di</strong>to per raggiungere uno scopo molto piú esteso, <strong>stu<strong>di</strong></strong>arono il<br />
modo <strong>di</strong> influire su tutto il clero, onde piegarlo poco a poco alle proprie viste; e si cominciò dal<br />
chiericato, presentandone mezzo opportunissimo le <strong>di</strong>sposizioni del rettore del Seminario canonico<br />
Cattaneo e del professore <strong>di</strong> dogmatica canonico Bolasco ... Fu creata una commissione sui chierici e<br />
s‘ebbe la precauzione d‘annoverare il Vicario Generale e l‘Arci<strong>di</strong>acono, la quale ha pienamente<br />
annichilate le canoniche attribuzioni <strong>di</strong> queste due <strong>di</strong>gnità, giacché il maggior numero <strong>degli</strong> altri e la loro<br />
operosità rendono illusoria e puramente nominale la loro autorità. Si apersero allora registri, ove si<br />
notavano a merito <strong>di</strong> alcuni certe, cosí chiamate, opere <strong>di</strong> supererogazione concernenti il culto esterno,<br />
come il prestarsi d‘un chierico a servire all‘altare in piú chiese, il fare la dottrina alle Dorotee, ai<br />
prigionieri ecc.; e si notavano a grave carico <strong>degli</strong> altri l‘applicare allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o tanto da non servire che<br />
raramente all‘altare, l‘argomentare in iscuola con maggior copia <strong>di</strong> argomenti che non portavano i dettati<br />
del maestro, il vestirsi con pulizia, il trovarsi, anche <strong>di</strong> rado, al pubblico passeggio: e si conchiudeva che<br />
questi non avevano spirito ecclesiastico; giacché la massima, stabilita in Seminario è che lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o preme<br />
poco, ma molto, anzitutto, lo spirito; quasi che lo spirito ecclesiastico non dovesse fondarsi sulla sapienza<br />
<strong>di</strong> chi deve essere maestro agli altri». Cfr. V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., vol. VI, doc. XXIII,<br />
184 s.<br />
215 Cfr V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., vol. VI , doc. XXIII, 185 s.<br />
216 Ibid., 186.<br />
217 Ibid., 186 ss.<br />
57
Giansenismo, <strong>di</strong>ffondendo con i numerosissimi loro agenti anche laici, siffatte accuse in tutte le<br />
conversazioni». «Nel tempo stesso cominciarono a far proclamare pubblicamente anche nel<br />
catechismo al popolo, la dottrina dell‘obbligo della rivelazione del complice. Universale e<br />
compiuto era lo scandalo sicché il Collegio dei parroci, dopo molte adunanze e ricorsi verbali<br />
all‘Arcivescovo, deliberò una formale e scritta rappresentanza da presentarsegli dai delegati,<br />
imperocché il governo lo aveva obbligato a deporre dall‘ufficio <strong>di</strong> Vicario Generale il canonico<br />
Cogorno e sostituirvi l‘abate Gualco, furioso propagatore del Gesuitismo. Egli non poté far<br />
altro che assicurare i parrochi, con una circolare stampata, della sua stima, facendo fede della<br />
loro dottrina, ecc. Le Congregazioni <strong>di</strong> S. Dorotea e del Beato Leonardo sono sempre in fiore e<br />
formidabili» 218 .<br />
L‘autore parla inoltre dell‘influenza del Gesuitismo nel Seminario, ed in alcune<br />
congregazioni religiose e cioè: i Fratelli delle Scuole Cristiane, i Passionisti, i Benedettini<br />
riformati (S. Giuliano d‘Albaro), le Dame del Sacro Cuore, le Dorotee conviventi e non<br />
conviventi, le suore del Buon Pastore, le suore <strong>di</strong> Carità, ed anche, parzialmente, i Cappuccini.<br />
Cosí la sintesi e la conclusione:<br />
«Da tutti questi fatti accennati nascono le seguenti pratiche conseguenze:<br />
1) Una <strong>di</strong>visione scandalosa in tutto il clero, per cui le mormorazioni sono continue, gli<br />
uni accusano <strong>di</strong> gravi mancanze ed anche <strong>di</strong> delitti gli altri. Entrambe le parti, invece che <strong>di</strong><br />
<strong>stu<strong>di</strong></strong> profon<strong>di</strong> non si occupano che <strong>di</strong> polemiche e <strong>di</strong> contumelie.<br />
2) Un sospetto e una <strong>di</strong>ffidenza nei laici, i quali non si fidano <strong>di</strong> alcuno e s‘astengono<br />
dai sacramenti.<br />
3) Una rilassatezza grande ne‘ costumi, coperta da una vernice d‘ipocrisia, che abbaglia<br />
tutti gli spiriti deboli.<br />
Ma tutti questi mali sono assolutamente irrime<strong>di</strong>abili senza la volontà risoluta ed<br />
invincibile dell‘autorità civile colla fermezza dei Vescovi. Con questa unione i RR. P.<br />
potrebbero essere tolti dalle scuole, dai pulpiti, dai confessionali insieme ai loro settari,<br />
riducendoli alla Messa ed al Breviario. Dovrebbero allontanarsi dagli alti impieghi tutti i tinti <strong>di</strong><br />
questa pece. Ma questi rime<strong>di</strong> non si vogliono, ed ogni altro qualunque è inefficace» 219 .<br />
L‘autore del ―Gesuitismo in Liguria‖ concludeva la sua ―<strong>di</strong>agnosi‖ proponendosi come<br />
―terapia‖ <strong>di</strong> confinare, per cosí <strong>di</strong>re, i Gesuiti ed i loro sostenitori in una ―riserva in<strong>di</strong>ana dello<br />
spirito‖ cioè la Messa ed il Breviario, estromettendoli da tutte le funzioni nelle quali avrebbero<br />
potuto incidere sulla formazione culturale o religiosa delle popolazioni.<br />
Gioberti, oltre ad ospitare lo scritto sul ―Gesuitismo in Liguria‖, ne accoglie<br />
sostanzialmente le analisi. Riprende a parlare delle opere <strong>di</strong> S. Raffaele e S. Dorotea<br />
considerandole associazioni ―gesuitiche‖ e riportando ampi brani dello scritto <strong>di</strong> cui sopra.<br />
Viene poi ad accorgersi del clero e della Congregazione del Beato Leonardo: «Gli influssi<br />
gesuitici non sarebbero senza rime<strong>di</strong>o se il clero secolare non ne fosse infetto e serbasse<br />
quell‘autorità <strong>di</strong> costumi e quella copia <strong>di</strong> dottrina, che ne fecero in ad<strong>di</strong>etro uno splendore della<br />
Liguria. Il buon seme si mantiene ancora in alcuni vecchi parrochi, ma va mancando nei<br />
giovani, che loro succedono. Imperocché la setta or<strong>di</strong>nò una consulta censoria sopra i chierici<br />
novelli, la quale ascrive loro a colpa l‘applicarsi allo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o, l‘argomentare con maggior copia<br />
che assolutamente non si richiegga, il vestirsi con politezza, il mostrarsi sul pubblico passeggio:<br />
sentenziando che tutte queste cose sono contrarie allo spirito ecclesiastico 220 . E per allargare e<br />
ra<strong>di</strong>care questo lauto in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> galateo e <strong>di</strong> sapienza, fondò la Congregazione del Beato<br />
Leonardo ... ».<br />
218 V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., vol. VI, doc. XXIII, 187 S. In questa ricostruzione, che qui<br />
non <strong>di</strong>scutiamo, ci sono però alcune imprecisioni storiche. Degno <strong>di</strong> segnalazione è il fatto che l‘abate<br />
Gualco <strong>di</strong>venne Vicario Generale soltanto nel novembre 1838, cioè circa sei mesi dopo la rappresentanza<br />
dei parroci, che avvenne nel maggio del 1838. Se pertanto l‘Arcivescovo avesse avuto le ―mani legate‖,<br />
bisognerebbe trovare altri responsabili. Di un certo rilievo per la nostra ricerca è la testimonianza che ―la<br />
Congregazione del Beato Leonardo è sempre in fiore e formidabile‖.<br />
219 V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., vol. VI, doc. XXIII, 193.<br />
220 Le parole sottolineate sono citazioni dal ―Gesuitismo in Liguria‖ V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op.<br />
cit., vol. V, ca XIX, 278.<br />
58
«Questa Congrega, oltre ad instillare nei soci l‘o<strong>di</strong>o consueto alle lettere, l‘abuso delle<br />
devozioni minute, la consuetu<strong>di</strong>ne perversa <strong>di</strong> spiare e riferire, si occupa <strong>di</strong> questioni morali,<br />
governandosi nelle decisioni con i principi <strong>di</strong> un lassismo spaventevole e <strong>di</strong>struggitivo <strong>di</strong> ogni<br />
giustizia; il quale su certi punti riesce a conclusioni poco <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> quelle (bisogna pur <strong>di</strong>rlo)<br />
che si usano nei conventicoli dei malandrini» 221 .<br />
Poco oltre continua «Come ciò fosse ancor poco, oltre la Congregazione or<strong>di</strong>naria, vi ha<br />
una consulta segreta, a cui intervengono solo gli eletti, la quale esercita una specie <strong>di</strong> censura e<br />
<strong>di</strong> vigilanza clandestina su tutta la chieresia in tutta la <strong>di</strong>ocesi. Da questa nera officina escono <strong>di</strong><br />
tempo in tempo dei libri come quelli del Gualco, del Frassinetti e simili: nei quali libri non sai<br />
talvolta se sia maggiore la temerarietà, il fanatismo o l‘ignoranza. Ivi ancora si or<strong>di</strong>scono le<br />
infami calunnie, le scellerate persecuzioni ... come l‘accusa <strong>di</strong> Giansenismo, che testé venne<br />
mossa ai parroci della città, e che fu ripulsata dal car<strong>di</strong>nale (Arcivescovo). Di qui finalmente<br />
non è gran tempo che si mandò intorno, sino a proclamarla pubblicamente anche nei catechismi<br />
al popolo, la dottrina della rivelazione del complice; dottrina falsa, scandalosa, abominevole,<br />
contraria ai primi principi della ragione, alle leggi della Chiesa, e ai dettati del cristianesimo ...<br />
Tali sono le trame e le dottrine perverse, che si praticano e s‘insegnano in quella congrega, che<br />
osa contaminare appropriandoselo il puro e santo nome del Beato Leonardo, ma che il popolo<br />
piú savio artefice <strong>di</strong> vocaboli, suol chiamare Sturlismo. E ciò che è peggio, esse s‘instillano nei<br />
teneri animi, e si educa con il loro aiuto una generazione <strong>di</strong> chierici bigotti, ignoranti,<br />
superstiziosi, abituati alla simulazione e all‘ipocrisia, che corrompono tutta la loro vita» 222 . La<br />
descrizione <strong>di</strong> Gioberti sul Gesuitismo prosegue toccando il Seminario e gli altri or<strong>di</strong>ni religiosi<br />
infetti dal ―morbo gesuitico‖ 223 . Noi passiamo <strong>di</strong>rettamente alla perorazione finale ed ai rime<strong>di</strong><br />
proposti: «Glorioso è a Genova l‘obbe<strong>di</strong>re ad un re colto e potente, ma ignobile sarebbe il<br />
sottentrare al giogo fratesco del generale della Compagnia ... dunque i genovesi avranno<br />
scacciato i tedeschi per ricevere gli Ignorantelli? E coloro che non stettero pazienti al giogo<br />
dell‘imperatore, sopporteranno quello dei Gesuiti? Ma che <strong>di</strong>co dei Gesuiti? La clientela loro<br />
piú infima fe‘ strazio in Genova <strong>degli</strong> intelletti e delle coscienze: un Frassinetti si arroga sugli<br />
animi quell‘imperio che Andrea Doria non esercitava sui corpi; e prete Sturla ignorantissimo<br />
vuol dare la legge ai citta<strong>di</strong>ni del Colombo ...» 224 . «Se il male durasse, Genova saria ben tosto<br />
<strong>di</strong>visa tra una plebe immersa nella piú crassa superstizione e un popolo <strong>di</strong> miscredenti 225 ...<br />
Tolgasi ai creati dalla setta ogni parte nell‘amministrazione e nell‘in<strong>di</strong>rizzo <strong>degli</strong> istituti<br />
caritatevoli ed ecclesiastici: chiudansi le congreghe corrompitrici, rendasi alle scienze sacre il<br />
loro lustro al tirocinio clericale la sua bontà, alla <strong>di</strong>stribuzione dei gra<strong>di</strong> e dei benefizi<br />
ecclesiastici il libero concorso, formisi un clero moderno, sapiente, civile. Spogliansi i Padri e i<br />
loro creati <strong>di</strong> ogni ingerenza nell‘educazione ... e il Gesuitismo si spegnerà da sé» 226 .<br />
La pubblicazione del ―Gesuita moderno‖ <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti segnò una tappa<br />
importante non tanto nella formulazione <strong>di</strong> un‘analisi e <strong>di</strong> un programma ―antigesuitico‖ quanto<br />
nella sua assunzione come in<strong>di</strong>spensabile ―corollario‖ della battaglia per l‘unificazione ed il<br />
―Risorgimento‖ dell‘Italia da parte della corrente liberale, almeno <strong>di</strong> quella giobertiana.<br />
La sua <strong>di</strong>ffusione creò le premesse per passare dall‘ambito delle <strong>di</strong>scussioni<br />
semplicemente intellettuali, all‘azione politica organizzata. È questo il periodo <strong>di</strong> maggior<br />
prestigio dell‘abate torinese, quello nel quale il progetto neo - guelfo raccoglieva non solo<br />
l‘appassionata adesione <strong>di</strong> vasti settori dell‘opinione pubblica <strong>di</strong> religione cattolica, ma<br />
sembrava poter contare su un‘accoglienza e collaborazione da parte dello stesso Pio IX.<br />
221 V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., vol. V, ca XIX, 278.<br />
222 V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., vol. V, ca XIX, 279.<br />
223 V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., vol. V, ca XIX, 280.<br />
224 V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, op. cit., vol. V, ca XIX, 281-282.<br />
225 Ibid., 283.<br />
226 Ibid., 283 ss.<br />
59
2. CHIUSURA DELLA CONGREGAZIONE.<br />
La <strong>di</strong>ffusione <strong>degli</strong> ideali politici in<strong>di</strong>pendentistici ed unitari ebbe in Genova una forte<br />
accelerazione a partire dal 1846. Proprio in quell‘anno si tenne, tra l‘altro, nella città <strong>di</strong><br />
Cristoforo Colombo l‘VIII Congresso <strong>degli</strong> Scienziati: congressi «dal 1838 (Toscana) si<br />
susseguivano come parlamenti della cultura nazionale ancor prima che esistesse una<br />
rappresentazione nazionale» 227 .<br />
Il Congresso ebbe una risonanza nazionale <strong>di</strong> valore politico 228 , che esorbitava<br />
largamente dal puro interesse scientifico, e trovò nei genovesi una calorosa ospitalità.<br />
Nella città operavano numerose società segrete (Società della Maddalena, Società dei<br />
14, Società <strong>di</strong> Apollo, Entelema) tra le quali il Comitato dell‘Or<strong>di</strong>ne, <strong>di</strong> orientamento liberale -<br />
moderato, ed i circoli mazziniani.<br />
Appartenevano al Comitato dell‘or<strong>di</strong>ne il marchese Giorgio Doria (presidente) e gli<br />
intellettuali Rosellini Pellegrini, Canale, Celesia, Gabella, Lorigiola, Accame.<br />
Queste società si sciolsero ed unificarono poi, nel gennaio 1848, nel Circolo Nazionale,<br />
dove le tendenze mazziniane risultarono prevalenti. Altri personaggi <strong>di</strong> spicco dei circoli<br />
patriottici erano i marchesi Lorenzo Pareto e Vincenzo Ricci. A questi ultimi si rivolse l‘avv.<br />
Cesare Cabella, per proporre un campagna <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrazioni popolari contro i Gesuiti, che<br />
avessero il carattere dell‘universalità e della simultaneità 229 . Ne dà notizia lo stesso Cabella in<br />
una lettera del 25 novembre a Lorenzo Valerio, amico <strong>di</strong> Gioberti e <strong>di</strong>rettore del giornale<br />
liberale ―La Concor<strong>di</strong>a‖ <strong>di</strong> Torino: «Il soggetto della lettera è il seguente. Ho concepito il<br />
pensiero <strong>di</strong> una grande <strong>di</strong>mostrazione che potesse provocare l‘abolizione della Compagnia <strong>di</strong><br />
Gesú. E questo mio pensiero non l‘ho confidato che a sole due persone <strong>di</strong> Genova, il sig.<br />
227 G. ORESTE, Genova nel Risorgimento italiano, art. cit., 11 s.<br />
228 I Congressi <strong>degli</strong> scienziati italiani si svolsero, a partire dal 1839, su iniziativa <strong>di</strong> Carlo Luciano<br />
Bonaparte, principe <strong>di</strong> Musignano e poi principe <strong>di</strong> Canino, naturalista <strong>di</strong> fama europea, che aveva<br />
partecipato con entusiasmo ad analoghe manifestazioni in altre nazioni. I nove congressi si tennero a Pisa<br />
1839, Torino 1840, Firenze 1841, Padova 1842, Lucca 1843, Milano 1844, Napoli 1845, Genova 1846,<br />
Venezia 1847. Sebbene la motivazione ufficiale, e la sorveglianza puntigliosa dei governi limitassero le<br />
<strong>di</strong>scussione nell‘ambito puramente scientifico, il contesto storico politico italiano, le convinzioni politiche<br />
personali dei partecipanti, e le molte espressioni allusive <strong>di</strong> circostanza fecero sí che tali assemblee<br />
facilitassero, insieme alle comunicazione scientifiche, la <strong>di</strong>ffusione <strong>degli</strong> ideali dell‘Unità italiana, dando<br />
ad essi prestigio culturale. Oltre all‘aspetto ufficiale occorre considerare inoltre l‘opportunità <strong>di</strong> contatti<br />
privati che queste assisi fornirono a numerosi esponenti <strong>di</strong> quella che fu poi la classe <strong>di</strong>rigente del<br />
Risorgimento italiano. Non deve perciò stupire che questo substrato politico tendesse costantemente a<br />
riaffiorare, malgrado il controllo delle autorità. Il Congresso <strong>di</strong> Genova, che cadeva intorno al centenario<br />
della cacciata <strong>degli</strong> austriaci da Genova, fu uno <strong>di</strong> quelli che maggiormente videro risuonare le parole <strong>di</strong><br />
fratellanza, unità e in<strong>di</strong>pendenza <strong>degli</strong> italiani. Nelle stesse commissioni <strong>di</strong> lavoro si parlò <strong>di</strong> una lega<br />
doganale italica, <strong>di</strong> una rete ferroviaria unitaria e <strong>di</strong> istruzione pubblica uniformata nei <strong>di</strong>versi Stati della<br />
penisola. Nelle parole e nei gesti si respirava un clima <strong>di</strong> fiduciosa attesa <strong>di</strong> nuove decisive trasformazioni<br />
della situazione italiana. Il contributo dei Congressi allo sviluppo <strong>degli</strong> ideali risorgimentali, se rimane<br />
imponderabile da un punto <strong>di</strong> vista organizzativo per il carattere clandestino delle intese tra i patrioti,<br />
risulta <strong>di</strong> considerevole importanza sotto il profilo culturale, sia come affermazione morale <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>pendenza della cultura italiana, sia come esperienza pubblica <strong>di</strong> libero scambio intellettuale e civile<br />
tra <strong>stu<strong>di</strong></strong>osi italiani al <strong>di</strong> là <strong>degli</strong> angusti confini dei <strong>di</strong>versi stati della comune patria. Sul piano<br />
bibliografico, oltre a C. SPELLANZON, Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia, Milano 1933, vol. II,<br />
libro II, 809; libro IV, 56; si possono consultare, tra le altre, le seguenti monografie: G. CERVETTO, Le<br />
riunioni <strong>degli</strong> scienziati Italiani. Memoria <strong>di</strong> Giuseppe Cervetto letta all'Accademia delle Scienze<br />
dell'Istituto <strong>di</strong> Bologna il 20.XII 1860, Bologna 1861; A. LINAKER, I congressi <strong>degli</strong> scienziati e i<br />
congressi pedagogici italiani, in Rassegna Nazionale 1880, vol. II, fasc. 3, 490; A. HORTIS, Le riunioni<br />
<strong>degli</strong> scienziati italiani, prima delle guerre <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza 1839-47, estratto dagli ―Atti della Società<br />
Italiana per il progresso delle scienze XI riunione‖ Trieste 1921, Città <strong>di</strong> Castello 1922; F. BARTOCCHINI<br />
–S. VERDINI, Sui Congressi <strong>degli</strong> scienziati, Roma 1952. Interamente de<strong>di</strong>cato al Congresso <strong>di</strong> Genova è<br />
A. CODIGNOLA, Risorgimento ed antirisorgimento all‟VIII Riunione <strong>degli</strong> scienziati italiani Genova<br />
settembre 1846, Genova 1946.<br />
229 Cfr. A. CUSTODERO, Il Piemonte negli albori della Libertà secondo il carteggio Gioberti-Valerio, in Il<br />
Risorgimento italiano, 1927, 25 s.<br />
60
Lorenzo Pareto e il sig. Vincenzo Ricci, che l‘approvarono, e son pronti a cooperarvi quando<br />
sarà tempo. E sarebbe che tutte le città d‘Italia ad un tempo <strong>di</strong>mandassero al Papa l‘abolizione<br />
della Compagnia. Dissi ad un tempo, perché tutta l‘importanza del movimento starebbe nella<br />
universalità, non solo, ma nella simultaneità. Sono i due caratteri che dovrebbe aver e in modo<br />
eminente. Se Ganganelli abolí i Gesuiti sulla domanda dei Re, perchè Mastai non li abolirebbe<br />
sulla domanda dei popoli? È vero che Mastai non è Ganganelli, ed ora piú che mai fa temere <strong>di</strong><br />
sé; ma pure potrebbe cedere ad un consentimento universale. Certo la Compagnia è il maggiore<br />
e piú abominevole nemico dell‘Italia e dell‘umanità ... Se ella approva il mio pensiero, se ella<br />
consente a porvi mano, faccia allora quello che io ho già fatto fin d‘ora, e che altri faranno in<br />
altre città. Scelga nelle <strong>di</strong>verse città del Piemonte (le principali) una persona a cui confidare il<br />
secreto, che dovrà essere gelosamente custo<strong>di</strong>to fino al giorno in cui si aprano le sottoscrizioni.<br />
Quando Genova, Torino, Firenze, Napoli, Roma, Milano, Venezia, Parma, Palermo, saranno<br />
d‘accordo e sarà in esse fissato il giorno della levata, si <strong>di</strong>ramino gli avvisi per le città<br />
secondarie. E nello stesso giorno si aprano le sottoscrizioni in ogni parte d‘Italia. Non aspetto<br />
pronta risposta ... M‘inchino profondamente».<br />
Lorenzo Valerio rispose affermativamente all‘appello (11 <strong>di</strong>cembre 1847), <strong>di</strong>sse <strong>di</strong> aver<br />
comunicato il segreto all‘amico Riccardo Sineo, e promise una campagna contro i Gesuiti nelle<br />
pagine del giornale La Concor<strong>di</strong>a, da lui <strong>di</strong>retto. La proposta si inseriva in un clima politico in<br />
cui la propaganda anti - gesuitica era <strong>di</strong>ventata molto estesa e vigorosa, e fungeva anche da<br />
copertura per una pressione popolare anti - governativa, volta ad ottenere le riforme politiche<br />
desiderate, e già concesse da Pio IX a Roma e dal granduca Leopoldo in Toscana. Alcuni<br />
provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> Carlo Alberto in <strong>di</strong>rezione delle riforme tramutarono la visita <strong>di</strong> Carlo Alberto<br />
alla città <strong>di</strong> Genova (4 novembre 1847) in un momento <strong>di</strong> gloria. Ad accogliere il re vi erano<br />
vari drappelli, secondo le <strong>di</strong>verse categorie, primo dei quali quello della nobiltà, guidato dai<br />
marchesi Giorgio Doria e Balbi Piovera, che portavano la ban<strong>di</strong>era del 1746. Un gruppo <strong>di</strong><br />
sacerdoti era guidato da Mons. Pio Nepomuceno Doria, abate <strong>di</strong> S. Matteo ed elemento <strong>di</strong><br />
spicco del clero liberale, il quale portava una ban<strong>di</strong>era con la scritta: ―Viva Gioberti‖. Durante il<br />
periodo <strong>di</strong> permanenza del sovrano in Genova, si formò una guar<strong>di</strong>a nazionale clandestina, (ma<br />
tollerata dal governo), che tra l‘altro faceva sorveglianza alle case dei gesuiti. Veramente<br />
imponente poi fu la manifestazione popolare in ricordo della cacciata <strong>degli</strong> austriaci per opera<br />
del Balilla nel 1746, che si svolse il 10 <strong>di</strong>cembre 1847, con una sorta <strong>di</strong> processione al santuario<br />
<strong>di</strong> Oregina. Quasi tutta la città fu illuminata a festa ed i <strong>di</strong>mostranti procedevano cantando;<br />
osservarono però un significativo silenzio passando davanti al palazzo Tursi, sede <strong>di</strong> un collegio<br />
<strong>di</strong> Gesuiti per i giovani della nobiltà, i quali giovani tuttavia applau<strong>di</strong>rono ai manifestanti.<br />
Particolarmente numeroso fu, nell‘occasione, il gruppo <strong>degli</strong> studenti, preceduti dal conte<br />
Terenzio Mamiani, che allora insegnava all‘<strong>università</strong> <strong>di</strong> Genova.<br />
Con i primi <strong>di</strong> gennaio del 1848 le manifestazioni <strong>di</strong>rettamente anti - gesuitiche presero<br />
un carattere violento. Il 3 gennaio una folla <strong>di</strong> varie centinaia <strong>di</strong> persone percorse la città<br />
gridando ―armi!‖e ―morte ai Gesuiti!‖ Si radunò poi un certo numero davanti alla residenza dei<br />
Padri in S. Ambrogio e cercò <strong>di</strong> forzare il portone, ma senza successo 230 .<br />
Il giorno successivo iniziò la raccolta <strong>di</strong> firme per una petizione popolare che<br />
domandava l‘espulsione dei Gesuiti e la creazione <strong>di</strong> una guar<strong>di</strong>a nazionale o civica: «Sire, i<br />
nostri popoli sono unanimi nell‘avviso che l‘esistenza dei Gesuiti negli Stati Sar<strong>di</strong>, sia<br />
inconciliabile con il civile e politico progresso del quale voi siete generoso promotore, ed a cui<br />
eglino, provocando ogni sorta <strong>di</strong> <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni, costantemente si oppongono. Egualmente<br />
concordano nel sentimento della necessità della istituzione della Guar<strong>di</strong>a civica ... Tanto<br />
sperando, reverentemente s‘inchinano» 231 . La raccolta <strong>di</strong> firme durò probabilmente due<br />
giorni 232 , ed il numero dei sottoscrittori è, come spesso, controverso.<br />
230 Cfr. I. RINIERI, Il Gesuita moderno, op. cit., 334 ss.<br />
231 I. RINIERI, Il Gesuita moderno, op. cit., 338, alla nota 3 scrive: ―Il testo leggevasi nell‘Alba <strong>di</strong> Firenze,<br />
13 gennaio 1848‖. Il RIDELLA in ―La vita e i tempi <strong>di</strong> C. Gabella‖, 115, ne lamentava la per<strong>di</strong>ta. A.<br />
CODIGNOLA lo riproduce nel ―G. Mameli‖, cit., I, 161.<br />
232 Il giorno 5 gennaio 1848, a sera, si tenne infatti una riunione per decidere chi sarebbe andato a portare<br />
le firme al Re.<br />
61
Si tenne poi un‘assemblea nella quale furono eletti i rappresentanti incaricati <strong>di</strong> portare<br />
la petizione al re.<br />
Carlo Alberto però non volle neppure ricevere la delegazione e <strong>di</strong>ede or<strong>di</strong>ne al ministro<br />
Borelli <strong>di</strong> rimandare in<strong>di</strong>etro i delegati con una rimostranza sull‘illegalità dell'iniziativa.<br />
L‘8 febbraio il Re <strong>di</strong> Sardegna promise la Costituzione, e la promulgò concretamente il<br />
4 marzo 1848. Sul finire <strong>di</strong> febbraio intanto la rivoluzione scoppiava a Parigi e da qui si sarebbe<br />
<strong>di</strong>ffusa in molti stati europei, compreso l‘impero asburgico. In quel frattempo, agli ultimi del<br />
mese <strong>di</strong> febbraio, in seguito a <strong>di</strong>mostrazioni popolari <strong>di</strong>rette allo scopo, a Cagliari e a Sassari i<br />
Gesuiti furono costretti ad abbandonare le loro se<strong>di</strong>, e a riparare in campagna fino ad una<br />
decisione governativa sul loro conto. La notizia, poi risultata mal fondata, dell‘arrivo in Genova<br />
<strong>di</strong> un primo gruppo <strong>di</strong> 30 gesuiti, forní il pretesto per un assalto alla loro casa, presso la chiesa<br />
<strong>di</strong> S. Ambrogio. La Gazzetta <strong>di</strong> Genova del 2 marzo 1848 riferiva cosí l‘episo<strong>di</strong>o: «Avant‘ieri<br />
mattina (29 febbraio, ndr.) fattasi correre la voce essere sbarcati i gesuiti fuggiaschi dalla<br />
Sardegna, questa nuova benché erronea involgatasi, per tal modo concitò l‘animo della<br />
popolazione, che la sera una affollata moltitu<strong>di</strong>ne traeva a furia al Collegio (nel palazzo Tursi in<br />
via Novissima, ndr.) ed al Convento <strong>di</strong> questi (presso S. Ambrogio, ndr.); e quivi tra un<br />
assordante schiamazzo <strong>di</strong> mille grida, <strong>di</strong> mille fischi, tra un proferirsi incessante <strong>di</strong> esacerbate<br />
parole, si dava opera con quegli ingegni che si credevan migliori ad atterrare le porte. Ciottoli si<br />
lanciavano contro le invetriate, e queste in pezzi.<br />
S‘invocava con ogni sforzo <strong>di</strong> gola l‘uscita de‘ gesuiti, la folla aumentava la calca,<br />
raddoppiava il trambusto, quando comparvero squadriglie <strong>di</strong> truppe <strong>di</strong> linea, i <strong>di</strong> cui capi con<br />
ogni bel garbo tentavano <strong>di</strong> richiamare la serrata ed aizzata popolazione a piú miti consigli.<br />
Furore <strong>di</strong> popolo è sordo a ragioni; l‘affare volgeva alla peggio, se non che S. E. il nostro<br />
Governatore, messosi reiteratamente tra la folla con ogni affettuosa maniera e con quelle<br />
promesse che tornavano all‘uopo, riuscí a trattenere quella foga irrompente, e chetare quel<br />
rumoroso entronare <strong>di</strong> grida, cui successero le replicate voci <strong>di</strong> Viva il vostro Governatore! Viva<br />
la Linea! Il sollevamento a gra<strong>di</strong> a gra<strong>di</strong> volgeva a quieta, la truppa vigilò l‘intera notte. La<br />
mattina del I° marzo leggevasi affissa la seguente Notificazione emanata dal Governo generale<br />
della Divisione <strong>di</strong> Genova: ―I Padri gesuiti hanno sgombrato dagli stabilimenti che occupavano<br />
in questa Città. Il Governo <strong>di</strong> S. M. il nostro augusto Sovrano, provvederà ulteriormente in<br />
modo definitivo. Genovesi, non mentite alla fama che vi proclama saggi, temperanti, amanti<br />
dell‘or<strong>di</strong>ne, ossequienti alla legge.<br />
IL GOVERNATORE, MARCHESE DELLA PLANARGIA‖.<br />
Appena avuto sentore che i gesuiti avevano sgombrati i loro stabilimenti, il popolo per<br />
farsene certo vi si trasse, e in quel momento <strong>di</strong> esasperazione, del mobiliare nulla vi rimasse <strong>di</strong><br />
incolume; al dopo pranzo le truppe <strong>di</strong> linea per or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> S. E. il Governatore s‘acquartieravano<br />
in quel convento sulla cui soglia quasi d‘improvviso leggevasi: Caserma militare» 233 .<br />
Il Governatore, messo in sostanza tra l‘alternativa <strong>di</strong> lasciare fare, (e permettere un<br />
probabile massacro dei gesuiti ivi residenti), o caricare la folla (con possibile spargimento <strong>di</strong><br />
sangue, e comunque con la sicura per<strong>di</strong>ta della popolarità), trovò il modo <strong>di</strong> fermare gli<br />
assalitori promettendo che nel corso della notte i gesuiti avrebbero sgombrato la casa; e cosí<br />
fu 234 . Il giorno appresso gli stessi assalitori poterono manifestare i loro sentimenti antigesuitici<br />
sugli oggetti del convento, <strong>di</strong>struggendo mobili, libri (una ricca biblioteca) e quadri sacri 235 . La<br />
tensione politica era giunta al punto che la sera del 2 marzo 1848 si riuní il Consiglio dei<br />
Ministri ed oltre a mettere a punto lo Statuto, ormai vicino alla promulgazione, si affrontò il<br />
problema dei Gesuiti.<br />
Nella medesima seduta la proposta <strong>di</strong> allontanare i Gesuiti da Torino raccolse<br />
l‘approvazione <strong>di</strong> tutti i ministri, ed infine fu ratificata dallo stesso Carlo Felice, il quale stimava<br />
233 Cfr. ―Gazzetta <strong>di</strong> Genova‖, Giovedí 2 marzo 1848, n° 27, a. LI 2.<br />
234 I gesuiti furono scortati durante la notte fino al palazzo ducale, e <strong>di</strong> qui imbarcati sulla fregata ―S.<br />
―Michele‖. Cfr. I. RINIERI, Il Gesuita moderno, op. cit., 419 - 424.<br />
235 Tralasciando i particolari dell‘episo<strong>di</strong>o, giova però ricordare che il ritrovamento <strong>di</strong> pannolini per<br />
bambino, che realmente furono fatti volare dalle finestre del convento gesuitico, sulla folla stupita, fu<br />
soltanto una messa in scena organizzata da qualche malintenzionato.<br />
62
i Gesuiti, ma considerò la decisione come il male minore. Se non che, formatosi il primo<br />
ministero costituzionale sotto la guida <strong>di</strong> Cesare Balbo, fu chiamato a far parte dello stesso<br />
ministero il marchese genovese Lorenzo Pareto, e probabilmente per la sua me<strong>di</strong>azione il<br />
ministero <strong>degli</strong> interni fu affidato al marchese Vincenzo Ricci. La notizia si seppe in Genova il<br />
giorno 10, e Ricci entrò nella sua funzione ministeriale il 16 marzo 1848. Ora Pareto e Ricci<br />
erano le persone che avevano approvato la proposta segreta <strong>di</strong> Cesare Gabella, per una<br />
sollevazione coor<strong>di</strong>nata in funzione anti - gesuitica, allo scopo <strong>di</strong> procurare la soppressione della<br />
Compagnia <strong>di</strong> Gesú. In ogni caso Vincenzo Ricci era il corrispondente fidato <strong>di</strong> Gioberti, il<br />
quale fece pervenire al filosofo torinese il materiale che poteva essere utile per la stesura del<br />
Gesuita moderno, tra il quale merita <strong>di</strong> essere ricordato qui lo scritto sul ―Gesuitismo in<br />
Liguria‖, <strong>di</strong> cui abbiamo già preso visione nell'analisi della Congregazione del Beato Leonardo,<br />
e delle altre opere ―gesuitate‖ <strong>di</strong> Genova.<br />
Con la nomina <strong>di</strong> Vincenzo Ricci al Ministero dell‘Interno il progetto giobertiano <strong>di</strong><br />
lotta alla Compagnia <strong>di</strong> Gesú ed ai suoi collaboratori o affiliati, poteva contare su un punto<br />
chiave <strong>di</strong> valore straor<strong>di</strong>nario. Quattro giorni dopo, cioè il 20 marzo, il ministero spe<strong>di</strong>va<br />
l‘or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> espulsione generale dei Gesuiti ai governatori <strong>di</strong> Torino, Cuneo, Alessandria,<br />
Novara, Genova: «È precisa intenzione del governo <strong>di</strong> S. Maestà, che tutti i Gesuiti escano<br />
senza ulteriore ritardo da questi regii Stati, eccettuati soltanto i nazionali che vorranno<br />
rimanervi, purché si ritirino presso li rispettivi parenti, e vestano l‘abito <strong>di</strong> prete secolare» 236 .<br />
Con questa espulsione il programma anti - gesuitico <strong>di</strong> Gioberti segnava una consistente, anche<br />
se temporanea e parziale, vittoria.<br />
Attraverso le vicende che abbiamo sommariamente delineato, maturò e si compí la<br />
chiusura della Congregazione del Beato Leonardo. Il nostro racconto l‘aveva lasciata mentre<br />
sembrava riprendersi da un lungo periodo <strong>di</strong> crisi interna, che la travagliò, con vicende alterne,<br />
negli anni ‗44, ‗45, ‗46, mentre nella prima metà del 1847 le <strong>di</strong>fficoltà interne sembravano<br />
superate. Manca, nelle nostre fonti, un accenno <strong>di</strong>retto alle ripercussioni che la nuova situazione<br />
politica, la propaganda liberale e democratica, la pubblicazione del Saggio <strong>di</strong> Frassinetti, <strong>degli</strong><br />
scritti <strong>di</strong> C. B. e B. C. e poi la <strong>di</strong>ffusione del Gesuita moderno <strong>di</strong> Gioberti ebbero sulla<br />
Congregazione. Ci si può domandare se nella preoccupazione del Superiore G. B. Cattaneo per<br />
una riforma ―che facesse cessare tutte le <strong>di</strong>cerie‖, espressa sul finire del 1846, dopo l‘uscita del<br />
Saggio del Frassinetti e delle polemiche connesse (compresi gli scritti <strong>di</strong> Bonavino), ci fosse<br />
anche la preoccupazione per la crescente emarginazione cui la Congregazione andava incontro<br />
per la sua attività filo - gesuitica e filo - temporalista ed ora, attraverso le opere <strong>di</strong> uno dei suoi<br />
membri piú in vista, anti - giobertiana.<br />
Ci si può anche chiedere se il resoconto steso dal Frassinetti nell‘estate del 1847 sulla<br />
Congregazione del Beato Leonardo 237 , volesse <strong>di</strong>fendere la Congregazione dagli attacchi cui<br />
era soggetta e fosse ad<strong>di</strong>rittura una sorta <strong>di</strong> contestazione morale dello scritto sul Gesuitismo in<br />
Liguria. Non possiamo andare oltre le semplici congetture, allo stato attuale delle nostre<br />
ricerche. Di positivo sappiamo che nell‘estate del ‗46 gli u<strong>di</strong>tori per le Accademie erano tanto<br />
pochi che quasi non si fecero 238 . Forse il nuovo clima politico - culturale influí in questa<br />
<strong>di</strong>serzione delle Accademie, le quali in quello stesso anno furono trasferite dall‘Oratorio in via<br />
della Lepre a casa <strong>di</strong> Luigi Sturla, ipotizziamo in un clima sociale in cui manifestarsi<br />
pubblicamente membri <strong>di</strong> una Congregazione ―gesuitata‖ cominciava a <strong>di</strong>ventare pericoloso.<br />
Occorre inoltre tener sempre presente che la Congregazione del Beato Leonardo si prefiggeva<br />
dei fini esclusivamente religiosi, sebbene con forti interessi culturali ed educativi, ed è<br />
236<br />
Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Torino, Gabinetto <strong>di</strong> polizia, 1848, Cartella I. Cfr.I. RINIERI, Il Gesuita moderno,<br />
op. cit., 447.<br />
237<br />
È la ―Notizia della Congregazione‖, <strong>di</strong> cui ci siamo ampiamente serviti per attingere notizie sulla<br />
Congregazione del Beato Leonardo. Il manoscritto è del 1847 l‘ultima data segnata è del 24 agosto,<br />
mentre la pubblicazione anonima, a cura del rev. Luigi Bottaro, con omissioni, avvenne ad Oneglia nel<br />
1857.<br />
238<br />
G. FRASSINETTI, Notizia, op. cít., 556 scrive: «Cosí passò tutto l‘anno 1846, ndr, e la freddezza era<br />
tanta che nella state non si fecero quasi le Accademie, per mancanza <strong>di</strong> chi v'intervenisse... ».<br />
63
comprensibile che, nel momento in cui la polemica si faceva prettamente politica, non trovasse<br />
altra possibilità che mantenersi nel silenzio e proseguire, per quanto possibile, nelle sue attività.<br />
Ma il programma giobertiano, formulato sulla base della relazione sul Gesuitismo in<br />
Liguria, prevedeva la sua liquidazione. Cosí imme<strong>di</strong>atamente dopo la cacciata dei Gesuiti da<br />
Genova (I° marzo), coloro che avevano <strong>di</strong>retto quest‘azione, rivolsero il loro impegno ad<br />
espellere gli elementi e le comunità ai loro occhi piú compromesse con la Compagnia <strong>di</strong> Gesú.<br />
Nei giorni seguenti, in seguito a manifestazioni <strong>di</strong> piazza, furono <strong>di</strong>sperse le Suore Dorotee<br />
(fondate da Paola Frassinetti), poi le Medee, e le figlie del S. Cuore <strong>di</strong> Gesú. Sorte analoga<br />
toccò alle suore del Buon Pastore, sebbene per esse i motivi politici non fossero quelli<br />
prevalenti, o almeno l‘accusa <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendere dai Gesuiti fosse meno chiara che per le altre<br />
religiose. Tra i religiosi furono estromessi dalle loro case i Fratelli delle scuole cristiane, i<br />
Passionisti, che avevano il convento in Granarolo, i Somaschi.<br />
Il ―Comitato Nazionale‖, fece sapere il 7 marzo 1848 a don Luigi Sturla che la sua<br />
presenza in Genova non era gra<strong>di</strong>ta, e non sarebbe stata tollerata. Mentre l‘attività delle Pie<br />
Opere <strong>di</strong> S. Raffaele e S. Dorotea e della Congregazione del Beato Leonardo, era ormai da<br />
qualche tempo bloccata, si voleva con il provve<strong>di</strong>mento decapitare queste organizzazioni,<br />
allontanandone il membro piú attivo ed in vista. Sturla, dopo essersi nascosto per qualche<br />
giorno, si imbarcò per Civitavecchia, e poi raggiunse Roma. Giuseppe Frassinetti, intanto, non<br />
sentendosi sicuro, si rese irreperibile ed andò, in una sorta <strong>di</strong> ―esilio volontario‖, prima<br />
dall‘amico sac. Angelo Remon<strong>di</strong>ni, parroco <strong>di</strong> S. Antonio <strong>di</strong> Casamavari, poi nella villetta del<br />
priore Gerolamo Campanella (parroco del Carmine, da cui per prudenza s‘era allontanato e<br />
anche egli collaboratore delle Accademie del Beato Leonardo), a S. Cipriano in val Polcevera.<br />
Quivi rimase circa 13 mesi, de<strong>di</strong>candosi agli <strong>stu<strong>di</strong></strong> ed alla preghiera, tenendosi in contatto<br />
epistolare con i sacerdoti <strong>di</strong> S. Sabina, tra cui i fratelli Giovanni e Raffaele Frassinetti. In questo<br />
periodo Frassinetti scrisse numerosi capitoli della Teologia Morale. La ventata antigesuitica si<br />
fece sentire anche nel Seminario: il 15 marzo, il Vicario Capitolare, Can. Ferrari (che reggeva la<br />
<strong>di</strong>ocesi genovese nella vacanza seguita alla morte del Card. Placido <strong>Maria</strong> Ta<strong>di</strong>ni avvenuta il 22<br />
novembre 1847) era indotto, dalla pressione dell‘opinione pubblica, a <strong>di</strong>mettere dalla carica <strong>di</strong><br />
Rettore il can. Giovanni Battista Cattaneo, a lungo vice Superiore della Congregazione del<br />
Beato Leonardo. La Congregazione del Beato Leonardo, presa <strong>di</strong> mira dalla corrente giobertiana<br />
genovese, cadeva cosí, sotto i colpi <strong>di</strong> una insistente e ben orchestrata campagna anti - gesuitica;<br />
né si riuscí in seguito a rimetterla in pie<strong>di</strong>.<br />
3. EREDITÀ DELLA CONGREGAZIONE<br />
Frassinetti tornò in città nella tarda primavera del 1849, dopo che l‘estrema fiammata<br />
rivoluzionaria, che aveva dato vita alla breve Repubblica <strong>di</strong> Genova, fu spenta dall‘esercito del<br />
generale Lamarmora. Riprese il suo ufficio <strong>di</strong> parroco, si <strong>di</strong>ede a scrivere operette <strong>di</strong> carattere<br />
ascetico, tra cui, <strong>di</strong> maggior rilievo, ―Il conforto dell‘anima <strong>di</strong>vota‖ 239 , rivolto a tutti i cattolici,<br />
e ―Gesú Cristo, regola del sacerdote‖ per gli ecclesiastici 240 .<br />
Piú tar<strong>di</strong>, ripercorrendo le tappe salienti della sua attività in uno scritto, ine<strong>di</strong>to,<br />
―Rischiarimento sul mio passato‖, steso nel 1856, scrisse: «Ritornato, non ho creduto dover piú<br />
dare un pensiero alla cessata Congregazione, non parendomi che sia volontà <strong>di</strong> Dio che per ora<br />
riviva. Ho procurato <strong>di</strong> fare qualche altro bene, che secondo i tempi che corrono si poteva<br />
fare» 241 .<br />
239 G. FRASSINETTI, Il conforto dell'anima <strong>di</strong>vota, Típ. Festa, nella Collezione Buoni Libri, n. XXV,<br />
Napoli 1852, 174. Ebbe 11 ristampe vivente l‘Autore. L‘un<strong>di</strong>cesima, Tip. della Gioventú, Genova 1865,<br />
uscí corretta e accresciuta. Ora in Opera Omnia, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1908, Opere Ascetiche<br />
vol. I. Fu tradotto in francese 1885, in spagnolo 1852, in tedesco 1909 ed in inglese.<br />
240 Gesú Cristo regola del Sacerdote, Firenze 1852, 84, pubblicato anonimo. Si conoscono 32 e<strong>di</strong>zioni<br />
dello scritto. Anche in Opera Omnia, Roma 1910, nel vol. III delle Opere Ascetiche. Fu tradotto in<br />
tedesco 1876 e 1878, in francese 1885 e spagnolo 1889 e 1901.<br />
241 G. FRASSINETTI, Rischiarimenti sul mio passato, manoscritto ine<strong>di</strong>to del 1856 con note <strong>di</strong> A.<br />
REMONDINI, dattiloscritto in: Archivio Frassinettiano vol. II, R. MORELLI e R. REGOLI a cura <strong>di</strong>, Centro<br />
vocazionale ―G. Frassinetti‖, Roma 1969, 34.<br />
64
Tra queste attività è da segnalare il suo contributo alla costituzione della ―Pia<br />
Associazione per la conservazione ed incremento della santa Fede‖.<br />
Lascio descrivere al Frassinetti il nuovo progetto: «Nell‘anno 1852, radunatisi alcuni<br />
ecclesiastici, già membri della Congregazione del Beato Leonardo da Porto Maurizio, cessata<br />
per le vicende dei tempi, per consultarsi in qual modo avrebbero potuto opporre un qualche<br />
argine ai mali religiosi e morali che già da alcuni anni tra noi <strong>di</strong>lagavano, <strong>di</strong>visarono <strong>di</strong> formare<br />
una Associazione Cattolica, ad imitazione <strong>di</strong> quelle che si costituivano in Germania. Cotale<br />
<strong>di</strong>visamento per allora non poterono mandare ad effetto, ed invece si dovettero contentare <strong>di</strong> una<br />
Pia Associazione da fondarsi nelle parrocchie, in onore <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. ma per la conservazione ed<br />
incremento della Fede Cattolica, come si vede nella pagella, approvata da Mons. Vicario<br />
capitolare addí 30 – IX- 1852. Tuttavia, non deponendo essi il pensiero <strong>di</strong> fondare in qualche<br />
modo l‘Associazione Cattolica formarono una Conferenza dei Promotori della detta Pia<br />
Associazione già approvata, conferenza organizzata in modo che potesse formare un principio<br />
<strong>di</strong> quella Associazione che avevano <strong>di</strong>visato» 242 .<br />
La nuova Associazione, che nasceva sulle ceneri, ma in continuità ideale con la<br />
Congregazione del Beato Leonardo, può ben considerarsi un embrione <strong>di</strong> Azione Cattolica,<br />
secondo le stesse parole <strong>di</strong> uno dei suoi fondatori. Si trattava infatti <strong>di</strong> una organizzazione aperta<br />
a tutti i ―buoni cattolici‖, ecclesiastici e laici, ma la presidenza era riservata a questi ultimi, ed in<br />
generale l‘Associazione aveva un preminente carattere secolare.<br />
Tre erano i principali campi <strong>di</strong> intervento, cioè i mezzi per promuovere la Fede: la<br />
preghiera, la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> buoni libri, la <strong>di</strong>ffusione della Parola <strong>di</strong> Dio. S‘iniziò creando una<br />
commissione per la <strong>di</strong>ffusione dei buoni libri, cui si aggiunsero via via quelle per l‘Adorazione<br />
<strong>di</strong>urna del ss. Sacramento, per la frequenza dei fanciulli alla Dottrina Cristiana, per<br />
l‘Adorazione notturna, per sorvegliare il movimento del Protestantesimo in città e promuovere<br />
le scuole serali 243 .<br />
Le commissioni erano coor<strong>di</strong>nate da una consulta centrale, e tutta l‘Associazione stava<br />
sotto il controllo e le <strong>di</strong>rettive dell‘Arcivescovo. I <strong>di</strong>rigenti si proponevano <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere tale<br />
Associazione in tutte le città dello Stato Sabaudo, ed in generale in tutte le <strong>di</strong>ocesi d‘Italia. Tra i<br />
<strong>di</strong>rigenti figura in primo piano il Frassinetti, che scrisse il ―Regolamento per la Conferenza dei<br />
Promotori‖, il ―Regolamento per il ramo femminile‖, ed alcuni appelli ai ―buoni cattolici‖ 244 .<br />
All‘interno <strong>di</strong> questa attività nella Pia Associazione va collocato il progetto <strong>di</strong> un<br />
settimanale cattolico, che il Frassinetti avrebbe voluto intitolare ―La Carità‖, per <strong>di</strong>ffondere il<br />
Cattolicesimo e far concorrenza alla ―cattiva stampa‖.<br />
Tale progetto il Frassinetti non riuscí a tradurlo in atto. Nel 1870, due anni dopo la sua<br />
morte, uscí a Genova una pubblicazione ebdomadaria, ―La Settimana Religiosa‖, a cura della<br />
medesima Pia Associazione, che per molti tratti ricalca il progetto frassinettiano.<br />
Di singolare interesse è anche la fondazione della prima Società operaia cattolica<br />
italiana, intitolata a ―N.S. del Soccorso e S. Giovanni Battista‖, alla quale Frassinetti <strong>di</strong>ede un<br />
importante contributo, assieme al can. Magnasco, che ne <strong>di</strong>venne primo <strong>di</strong>rettore spirituale. Il<br />
clima politico inaugurato dalla concessione e poi continuato con il mantenimento dello Statuto<br />
Albertino, aveva reso possibile, nel Regno <strong>di</strong> Sardegna prima che altrove, la nascita e la<br />
<strong>di</strong>ffusione delle prime forme <strong>di</strong> organizzazione operaia, tra cui particolarmente le Società <strong>di</strong><br />
Mutuo Soccorso.<br />
Prendendo esempio da Torino, anche in Liguria sorsero, a partire dal 1850, alcune<br />
Società <strong>di</strong> questo tipo 245 .<br />
242 G. FRASSINETTI, Altro cenno sulla Pia Associazione per la Conservazione ed incremento della Fede<br />
Cattolica in Genova, stampato da manoscritto ine<strong>di</strong>to nel vol. XIII dell‘Opera Omnia, 97 s.<br />
243 I protestanti si servivano spesso <strong>di</strong> questo mezzo per trovare aderenze nel tessuto sociale.<br />
244 Cfr. G. FRASSINETTI, Opera Omnia, vol. XIII, Roma 1912, 101-143.<br />
245 Notizie particolareggiate sul fenomeno si trovano in: G. PERILLO, Gli albori dell‟organizzazione<br />
operaia nel Genovesato, in Movimento operaio e socialista 1959, 169-188; 197-206; 1960, 51-81. Si<br />
possono consultare anche: ID., La prima società <strong>di</strong> Mutuo Soccorso fondata in Liguria: la Società “Dio e<br />
Umanità” <strong>di</strong> Voltri, in Movimento operaio e socialista in Liguria 1955, n. 2, 90-94; ID., Attività<br />
economica e con<strong>di</strong>zione dei lavoratori nel genovesato intorno alla metà del secolo XIX, in Movimento<br />
operaio e socialista in Liguria, 1958, 63 - 82.<br />
65
Esse erano generalmente sostenute e propagandate dai liberali e dai democratici,<br />
particolarmente dai mazziniani, ed avversate dai conservatori. Il giornale ―Il Cattolico‖ si<br />
espresse negativamente su <strong>di</strong> esse, temendole uno strumento nelle mani della ―Rivoluzione‖ 246 .<br />
A questa posizione nettamente ostile fece seguito però, a partire dal principio del 1854, un<br />
atteggiamento piú articolato, che riconosceva alcuni meriti alle Società <strong>di</strong> Mutuo Soccorso, ma<br />
ne combatteva la <strong>di</strong>rezione laica o anticlericale, e suggeriva l‘utilità <strong>di</strong> costituire delle Società<br />
operaie composte da lavoratori cattolici, fedeli alle <strong>di</strong>rettive della Chiesa, sia nel campo<br />
religioso che in quello politico 247 . Certamente non fu estranea a questa ―svolta‖ la persona del<br />
nuovo Arcivescovo <strong>di</strong> Genova, Andrea Charvaz 248 , uomo <strong>di</strong> vasta cultura e <strong>di</strong> idee aperte, tenuto<br />
in concetto <strong>di</strong> ―liberale‖. In questo clima culturale cre<strong>di</strong>amo vada inserito il sorgere della<br />
Società Operaia Cattolica <strong>di</strong> cui si è parlato, comunemente denominata con il solo titolo <strong>di</strong> ―S.<br />
Giovanni Battista‖ ed al principio appellata ―Compagnia‖. La fondarono il 23 luglio 1854, nella<br />
canonica <strong>di</strong> S. Torpete, 13 lavoratori (3 commercianti, 4 operai, 4 artigiani, 2 intellettuali)<br />
radunati intorno ai sacerdoti Salvatore Magnasco, Giuseppe Frassinetti e Luigi Ra<strong>di</strong>f 249 ,<br />
me<strong>di</strong>ante la lettura e l‘approvazione sottoscritta dello Statuto Sociale. Presidente fu eletto allora<br />
Giovan Luigi Ghiglione, maestro elementare, cui successe nel 1857 il sig. Gaetano Lordano,<br />
merciaio, e nel 1860 il sig. Giuseppe Canale che rimase in carica per 29 anni.<br />
Si trattava <strong>di</strong> una Società <strong>di</strong> Mutuo Soccorso, interessata anche all‘elevazione religiosa e<br />
culturale dei suoi membri 250 . Dopo un primo momento <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà, dovuto al sopraggiungere<br />
dell‘epidemia colerica, a partire dal I° gennaio 1855 la Società ebbe un andamento regolare ed<br />
un <strong>di</strong>screto sviluppo, tanto da <strong>di</strong>venire modello e guida <strong>di</strong> altre società consorelle, che<br />
formarono il primo nucleo della futura Federazione Operaia Cattolica Ligure. Alla fine del 1855<br />
gli associati erano 52, nel 1864 oltre 180, nel 1877 erano 619, fino a raggiungere nel 1880 la<br />
quota <strong>di</strong> 934 soci 251 .<br />
La società aderí nel 1855 (2 <strong>di</strong>cembre) alla ―Società <strong>di</strong> S. Vincenzo de‘ Paoli‖ 252 , e dal<br />
1875 mandò rappresentanti e partecipò al sorgere ed allo sviluppo dell‘Opera dei Congressi 253 .<br />
Sturla rimase fuori Genova vari anni. Subito dopo la sua fuga da Genova si recò a<br />
Roma; qui ebbe la sorpresa <strong>di</strong> vedere che il suo nome era già conosciuto e condannato come<br />
―gesuitante‖ da scritte sui muri, probabilmente <strong>di</strong> origine massonica. Si rivolse perciò al<br />
<strong>di</strong>castero missionario della S. Sede, la Congregazione ―De Propaganda Fide‖, per avere titolo,<br />
lettere <strong>di</strong> raccomandazione e documenti, onde partire come missionario. Il prefetto <strong>di</strong><br />
―Propaganda‖, il card. Franzoni, gli <strong>di</strong>ede la ―pagella‖ come missionario per la costa arabica,<br />
con due possibili ―obbe<strong>di</strong>enze‖, una per Aden, l‘altra per l‘Etiopia.<br />
Dopo numerose peripezie 254 raggiunse effettivamente quelle terre e collaborò dapprima<br />
con Mons. Massaia nelle missioni sulla costa Eritrea, poi fu nominato responsabile della<br />
246 Cfr. ―Il Cattolico”, giornale quoti<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> Genova, art. del 2 febbraio 1851, n° 456, 1821 s.<br />
247 Cfr. ―Il Cattolico‖, giornale quoti<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> Genova, art. del 17 maggio 1854, anno VI, n° 1407; del 26<br />
maggio 1854, anno VI, n° 1414; del 31 maggio 1854, anno VI, n° 1418.<br />
248 Cfr. A. CODIGNOLA, Andrea Charvaz, in Enciclope<strong>di</strong>a Italiana, Roma 1931, vol. IX, 944.<br />
249 Cfr. M. CECCALDI – C. FERRARI, Società operaia cattolica <strong>di</strong> N.S. del Soccorso e S. Giovanni Battista<br />
nel 75° anniversario <strong>di</strong> fondazione. Cenni storico - statistici 1854-1929, Tip. Capurro, Genova 1929.<br />
Ve<strong>di</strong> anche: G. CONTI, La società operaia cattolica N.S. del Soccorso e S. Giovanni Battista nel suo 125°<br />
anno <strong>di</strong> fondazione, Rapallo 1979. Ci permettiamo <strong>di</strong> notare che secondo queste fonti, tra i fondatori della<br />
Società è da annoverarsi anche il sacerdote Luigi Sturla. Poiché, come si vedrà anche nelle pagine<br />
successive, nel 1854 Sturla si trovava come missionario in Aden, e ritornò a Genova solo nel 1857,<br />
dobbiamo pensare che si tratti <strong>di</strong> una retro - datazione, dovuta al fatto che al suo ritorno in Genova Sturla<br />
collaborò allo sviluppo della Società, uno dei cui primi membri, Paolo Sturla, scultore in legno, era suo<br />
parente.<br />
250 Cfr. Regolamento, cap. I, art. I.<br />
251 Cfr. M. CECCALDI – C. FERRARI, La società operaia cattolica, op. cit., 39 - 65.<br />
252 Sul significato politico culturale <strong>di</strong> questa adesione si veda: F. FONZI, Correnti <strong>di</strong> opposizione alla<br />
politica piemontese tra i cattolici liguri negli anni 1849-1856, in Rassegna storica del Risorgimento, a.<br />
XXXIX, fasc. IV, ottobre-<strong>di</strong>cembre 1952, 542-552.<br />
253 Cfr. C. CAVELLI, Le istituzioni economiche del movimento sociale cattolico in Liguria, Tesi <strong>di</strong> Laurea<br />
in Scienze Politiche all‘Università <strong>di</strong> Genova, Anno Accademico 1975-76, relatore prof. G. Ancarani.<br />
254 Cfr. G. FRASSINETTI, Memorie intorno alla vita del sac. Luigi Sturla, op. cit., 57 ss.<br />
66
missione <strong>di</strong> Aden. Vestito l‘abito <strong>di</strong> terziario cappuccino, si trattenne fino al 1857 in Aden, dove<br />
fu nominato anche dal governo inglese cappellano della guarnigione locale, formata<br />
prevalentemente da cattolici irlandesi. Sturla che conosceva già <strong>di</strong>scretamente l‘inglese, si <strong>di</strong>ede<br />
in quel frattempo a <strong>stu<strong>di</strong></strong>are le lingue ivi parlate, sopratutto il Tamil 255 , prezioso per la presenza<br />
<strong>di</strong> molti soldati in<strong>di</strong>ani dell‘esercito inglese.<br />
Malgrado la sua operosa presenza in missione fosse apprezzata dal responsabile, card.<br />
Massaia, Sturla finí per accogliere le pressanti insistenze <strong>di</strong> Frassinetti, con il quale manteneva<br />
rapporti epistolari, il quale lo invitava ripetutamente a tornare a Genova 256 . Cosí chiese ed<br />
ottenne il ritorno in patria, che avvenne, presumibilmente nel 1857 257 . Qui fu accolto con affetto<br />
dai suoi amici, e Frassinetti lo volle con sé nella canonica, per riprendere la collaborazione che<br />
li aveva strettamente uniti nella giovinezza. Anche Sturla però dovette rassegnarsi a constatare<br />
che non esistevano le con<strong>di</strong>zioni per far risorgere la Congregazione del Beato Leonardo. Con<br />
coraggio ed ostinazione si <strong>di</strong>ede a rimettere in pie<strong>di</strong> la Pia Opera <strong>di</strong> S. Raffaele e S. Dorotea, e<br />
vi riuscí, sebbene l‘organizzazione conseguisse un‘estensione piú modesta che nel passato; egli<br />
ne affidò la <strong>di</strong>rezione prima al can. Storace, e poi al can. Magnasco. Sturla partecipò anche alle<br />
attività della Società operaia ―S. Giovanni Battista‖, da cui fu considerato alla stregua <strong>di</strong> uno dei<br />
fondatori. Trascorse gli ultimi anni della sua vita de<strong>di</strong>candosi principalmente alla cura della<br />
gioventú. Fondò due circoli giovanili chiamati anch‘essi ―Congregazioni‖, uno presso la chiesa<br />
<strong>di</strong> N.S. della Consolazione e <strong>di</strong> S. Vincenzo, l‘altro nella chiesa <strong>di</strong> S. Bartolomeo del Carmine,<br />
chiesa che si doveva vendere e <strong>di</strong> cui egli pagò il prezzo del riscatto, con offerte da lui stesso<br />
raccolte 258 . Dirigeva o collaborava con <strong>di</strong>verse associazioni cattoliche, tra cui la ―Pia Unione<br />
delle <strong>Figli</strong>e dell‘<strong>Immacolata</strong>‖, che ebbe inizio in Mornese sotto gli auspici <strong>di</strong> don Pestarino e del<br />
priore Frassinetti, e nella quale si formò <strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello, fondatrice delle suore<br />
Salesiane. Il ramo maschile <strong>di</strong> questa associazione, che promuoveva la vita religiosa e<br />
l‘osservanza dei voti <strong>di</strong> povertà, castità e obbe<strong>di</strong>enza anche da parte <strong>di</strong> persone impegnate nel<br />
―secolo‖, cioè nella comune attività sociale, la ―Pia Unione dei <strong>Figli</strong> dell‘<strong>Immacolata</strong>‖ fu da lui<br />
impiantata a Mornese nel 1862. Queste due associazioni sono da considerarsi come<br />
un‘anticipazione dei moderni ―Istituti secolari‖. Luigi Sturla, singolare figura <strong>di</strong> sacerdotemissionario<br />
genovese, terminava la sua esistenza terrena il 19 aprile 1865. Giuseppe Frassinetti,<br />
a <strong>di</strong>stanza circa <strong>di</strong> un anno dalla sua morte scrisse le ―Memorie‖ dell‘amico, senza intenti<br />
scientifici, ma in forma familiare <strong>di</strong> ricordo e cronaca <strong>di</strong> avvenimenti <strong>di</strong> cui l‘autore fu<br />
contemporaneo e partecipe 259 . Per l‘ultima volta Frassinetti ripercorre le principali tappe<br />
dell‘attività della Congregazione del Beato Leonardo, confermando la sua visione <strong>degli</strong><br />
avvenimenti, già espressa in altre occasioni.<br />
Nelle ―Memorie‖ viene <strong>di</strong>fesa l‘immagine <strong>di</strong> don Sturla come promotore <strong>di</strong> ―novità‖: «E<br />
certamente avevano ragione a <strong>di</strong>re che lo Sturla era promotore <strong>di</strong> molte novità, delle quali prima<br />
<strong>di</strong> lui non si aveva idea. La Pia Opera <strong>di</strong> S. Raffaele e <strong>di</strong> S. Dorotea era una novità, e origine <strong>di</strong><br />
tante novità; queste erano che i primari signori e signore della città si occupassero<br />
dell‘istruzione religiosa dei figli del popolo, che pii uomini e zitelle li raccogliessero alle feste<br />
perché intervenissero alle Dottrine, e poi si adoperassero perché non istessero lontani dai<br />
sacramenti, ed anche perché fossero messi a scuole e mestieri i piú trascurati dai genitori ... La<br />
sua Congregazione (del Beato Leonardo, ndr) era pure una novità, causa anch‘essa <strong>di</strong> altre<br />
novità, ... ed era pure una novità l‘accademia che coltivava il giovane clero in tutti gli <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
ecclesiastici, e lo coltivò con buon successo dall‘anno 1834 fino al terminare dell‘anno 1847 ...<br />
Ed erano pure novità le tante pie pratiche che promuoveva lo Sturla con i suoi intimi, per es. il<br />
Culto perpetuo al ss. Sacramento ... la Pia Unione delle amanti della santa modestia ..., la<br />
255 Lingua parlata a Ceylon e nel sud est dell‘In<strong>di</strong>a.<br />
256 G. FRASSINETTI, Memorie, op. cit., 74 ss.<br />
257 Cosí G. FRASSINETTI, Memorie, op. cit., 75. Diversamente Mons. Feliciano Massaia, che nel suo ―I<br />
miei trentacinque anni <strong>di</strong> Missione nell‟Alta Etiopia‖ in<strong>di</strong>ca un altro anno, probabilmente con qualche<br />
imprecisione nella memoria.<br />
258 G. FRASSINETTI, Memorie, op. cit., 82.<br />
259 G. FRASSINETTI, Memorie intorno alla vita del sac. Luigi Sturla, Tip. della Gioventú, Genova 1871,<br />
95, pubblicato postumo. La 2° e<strong>di</strong>zione, a cura <strong>di</strong> A. MONTI, contiene numerose lettere ine<strong>di</strong>te dello<br />
Sturla. Anche in Opera Omnia, Roma 1913, vol. XIII.<br />
67
pre<strong>di</strong>cazione e le confessioni settimanali e il mese <strong>Maria</strong>no alla Darsena ed al Cantiere della<br />
Foce ai 1000 circa condannati che vi erano detenuti; e gli esercizi spirituali ai fanciulli ecc., cose<br />
che prima non si conoscevano ed erano perciò novità in Genova» 260 .<br />
Venendo poi a raccontare gli avvenimenti del ‗48 e l‘esilio <strong>di</strong> Sturla, Frassinetti<br />
premette questa osservazione: «La storia finora raccontata si può <strong>di</strong>re storia antica: gli attori <strong>di</strong><br />
quel tempo per la massima parte sono morti, e pochi superstiti hanno avuto luogo a<br />
<strong>di</strong>singannarsi, e a demettere pregiu<strong>di</strong>zi dai quali erano illusi. Quella storia si può raccontare da<br />
presso a poco come si racconta la storia Greca e Romana: non si ha da temere che susciti<br />
passioni, che offenda suscettività. La storia invece che viene dopo, si dee <strong>di</strong>re storia moderna, e<br />
non può raccontarsi con uguale fidanza. Non <strong>di</strong>rò dunque tutto quello che si potrebbe <strong>di</strong>re delle<br />
cose che toccano le vicende dello Sturla» 261 .<br />
Forse per questo non pubblicò imme<strong>di</strong>atamente le Memorie dello Sturla, che videro la<br />
luce solo dopo la morte del Frassinetti: i moti rivoluzionari del ‗48 portarono al potere le<br />
correnti liberali, che erano ancora alla guida dell‘ormai Regno d‘Italia nel 1866, quando<br />
Frassinetti scrive.<br />
Fatto piú cauto dagli anni, Frassinetti non rinuncia comunque a <strong>di</strong>fendere insieme<br />
all‘amico, verso cui nutre un stima sincera, anche il loro comune operato e gli ideali <strong>degli</strong> anni<br />
piú ver<strong>di</strong> 262 .<br />
260<br />
G. FRASSINETTI, Memorie, op. cit., 49 ss.<br />
261<br />
Ibid., 224.<br />
262<br />
Giuseppe Frassinetti, morí il 2 gennaio 1868. Da un‘opera da lui fondata per l‘avviamento dei<br />
giovanetti poveri agli <strong>stu<strong>di</strong></strong> ecclesiastici, trasformata sotto la guida <strong>di</strong> don Antonio Piccardo in ―Pia Opera<br />
<strong>di</strong>ocesana dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>‖, prese l‘avvio nel 1903 la ―Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>‖, attualmente attiva in varie nazioni, che considera Giuseppe Frassinetti come suo fondatore e<br />
punto <strong>di</strong> riferimento spirituale.<br />
68
CONCLUSIONI 263<br />
1 . La Congregazione del Beato Leonardo nacque dall‘entusiasmo giovanile <strong>di</strong> alcuni<br />
ecclesiastici genovesi, educati nel clima culturale del Primo Ottocento. Ebbe come scopo<br />
principale la formazione ascetica, teologica e morale del giovane clero. I suoi valori formativi si<br />
ricollegavano ai fondamenti dell‘educazione seminaristica propugnati da S. Carlo Borromeo:<br />
pietà, formazione intellettuale, <strong>di</strong>sciplina ecclesiastica. Ad essi occorre aggiungere un interesse<br />
per l‘apostolato esterno (catechesi ai fanciulli, ai carcerati) che è da considerarsi un<br />
cambiamento portato dai tempi nuovi.<br />
L‘organizzazione tuttavia non si limitò soltanto a questi aspetti, ma si fece promotrice <strong>di</strong><br />
iniziative spirituali e pratiche devozionali, che ne fecero un centro <strong>di</strong> aggregazione rilevante<br />
nella <strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> Genova, spesso non allineato con gli orientamenti pastorali del clero genovese<br />
della precedente generazione.<br />
Sebbene Genova non fosse nuova ad aggregazioni <strong>di</strong> ecclesiastici con scopi catechetici<br />
e culturali (Missionari urbani e rurali, Operai evangelici), il nuovo sodalizio si <strong>di</strong>stinse presto<br />
per la <strong>di</strong>namicità organizzativa, e raggiunse un importante risultato culturale con la creazione <strong>di</strong><br />
un‘Accademia <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> teologici.<br />
L‘associazione presentava alcune caratteristiche, come la sottolineatura del ruolo del<br />
Pontefice <strong>roma</strong>no, la lotta al giansenismo, la <strong>di</strong>ffusione del pensiero <strong>di</strong> S. Alfonso de‘ Liguori,<br />
la valutazione della cultura del tempo come complessivamente avversa al Cattolicesimo,<br />
l‘impegno per la <strong>di</strong>ffusione della cultura e della stampa cattolica, che l‘avvicinano ad altre<br />
associazioni (quali ad esempio le ―Amicizie cattoliche‖), portatrici <strong>di</strong> una mentalità che sta<br />
all‘origine del Movimento Cattolico organizzato.<br />
La Congregazione sviluppò su queste basi un rapporto <strong>di</strong> collaborazione con la<br />
Compagnia <strong>di</strong> Gesú, che si può considerare intenso.<br />
La Congregazione del Beato Leonardo, in seguito alla polemica antigiansenista <strong>di</strong> alcuni<br />
suoi <strong>di</strong>rigenti, fu al centro <strong>di</strong> vivaci polemiche nel clero <strong>di</strong> Genova, nelle quali confluirono,<br />
insieme ad accuse infondate, anche i malumori per il nuovo in<strong>di</strong>rizzo pastorale e morale da essa<br />
propagato, ed il fasti<strong>di</strong>o per il progressivo avvicinamento della Congregazione ai Gesuiti.<br />
Nell‘occasione l‘associazione rimase isolata e fu ad un passo dalla chiusura, ma <strong>di</strong>mostrò una<br />
buona compattezza interna, cosa che facilitò la sua successiva ripresa.<br />
Mentre la Congregazione recuperava la propria attività con impegno (ma ad un certo<br />
punto piú fiaccamente per sopraggiunte <strong>di</strong>varicazioni nelle prospettive dei suoi <strong>di</strong>rigenti)<br />
venivano intanto maturando nella società italiana nuove esigenze e nuove concezioni politiche.<br />
2. La questione dell‘Unità e dell‘In<strong>di</strong>pendenza italiana, da tempo agitata da minoranze<br />
rivoluzionarie, <strong>di</strong>venne un tema largamente sentito da vasti strati dell‘opinione pubblica, anche<br />
nel clero.<br />
Un contributo rilevante in questa <strong>di</strong>rezione fu dato da Vincenzo Gioberti, che<br />
desiderava presentarsi come pala<strong>di</strong>no del Cattolicesimo, e insieme mostrarne la compatibilità<br />
con gli ideali liberali e costituzionali allora in ascesa.<br />
La sua proposta politica <strong>di</strong> una federazione tra gli Stati italiani, moderata dal Papa,<br />
innestandosi su una corrente filo - <strong>roma</strong>na già viva tra molti intellettuali cattolici, venne<br />
denominata ―neo - guelfismo‖.<br />
Gioberti inizialmente presentò le sue idee in modo generico ed ovattato, per facilitarne<br />
la <strong>di</strong>ffusione e far presa anche in settori tra<strong>di</strong>zionalmente ostili od estranei all‘ideale nazionale.<br />
Forse anche per questo il neo - guelfismo raccolse numerosi consensi e <strong>di</strong>venne una corrente <strong>di</strong><br />
opinione rilevante nel quadro delle forze politiche contemporanee. Con il passare del tempo<br />
però ritenne opportuno non solo precisare i contorni costituzionali e filo liberali del suo<br />
progetto, ma anche tentare <strong>di</strong> emarginare culturalmente e politicamente quei settori del<br />
Cattolicesimo legati all‘assolutismo o comunque avversi alla cultura liberale. Egli cercò<br />
pertanto <strong>di</strong> dar vita ad un movimento tendenzialmente <strong>di</strong> massa che fosse cattolico, liberale e<br />
263 Le conclusioni sono state riviste e mo<strong>di</strong>ficate dall‘autore.<br />
69
anti - conservatore. All‘interno <strong>di</strong> questa operazione politica si inserisce la polemica <strong>di</strong> Gioberti<br />
con i Gesuiti.<br />
Approfittando <strong>di</strong> una ondata <strong>di</strong> avversione alla Compagnia <strong>di</strong> Gesú nella borghesia<br />
intellettuale europea, il filosofo torinese addossò sui Gesuiti la responsabilità del <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o tra il<br />
Cattolicesimo e il progresso sociale e culturale del tempo.<br />
Nel corso della polemica, con l‘inasprirsi del tono, Gioberti giunse ad in<strong>di</strong>care nei<br />
Gesuiti i principali alleati dell‘Austria e perciò un ostacolo fondamentale al conseguimento del<br />
riscatto nazionale. I moti patriottici del ‘47 - ‘49 <strong>di</strong>edero nel Regno <strong>di</strong> Sardegna ed in alcune<br />
parti d‘Italia la possibilità ai giobertiani <strong>di</strong> mettere in pratica iniziative politiche volte alla<br />
cacciata dei Gesuiti ed alla liquidazione delle organizzazioni ―gesuitanti‖.<br />
Tra <strong>di</strong> esse, si era segnalata la Congregazione del Beato Leonardo, che da tempo<br />
collaborava con i Gesuiti, e recentemente, attraverso la penna del Frassinetti, uno dei membri<br />
piú qualificati, li aveva <strong>di</strong>fesi in polemica con Gioberti.<br />
Costretta dapprima all‘inattività, la Congregazione fu poi atterrata me<strong>di</strong>ante la<br />
<strong>di</strong>spersione dei suoi <strong>di</strong>rigenti, quando nel marzo del ‗48 i giobertiani giunsero al potere in<br />
Genova.<br />
3. Il ‗48, inteso in senso politico, rappresentò un anno <strong>di</strong> svolta determinante.<br />
L‘introduzione e il mantenimento dello Statuto Albertino nel Regno <strong>di</strong> Sardegna consentirono lo<br />
sviluppo del primo Stato costituzionale in Italia, che fu retto da una maggioranza <strong>di</strong><br />
orientamento liberale.<br />
L‘importanza della novità, che cambiava le ―regole del gioco‖ e cioè le con<strong>di</strong>zioni del<br />
confronto o dello scontro culturale e politico, fu avvertita anche dal gruppo <strong>di</strong>rigente della<br />
Congregazione del Beato Leonardo, il quale si <strong>di</strong>ede a cercare nuove forme <strong>di</strong> presenza cattolica<br />
nella società.<br />
Ci fu certamente un impiego personale dei singoli <strong>di</strong>rigenti in cui è possibile rintracciare<br />
un influsso dell‘orientamento acquisito attraverso la partecipazione alla Congregazione 264 , ma<br />
l‘ere<strong>di</strong>tà culturale della Congregazione fu raccolta particolarmente da una nuova associazione,<br />
<strong>di</strong> carattere laicale, la Pia Associazione per la conservazione ed incremento della fede, che<br />
corrispose al consapevole <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> affidare alla mobilitazione delle masse cattoliche quelle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> tutela dei valori, <strong>degli</strong> interessi e dei privilegi del Cattolicesimo, che la tendenziale<br />
laicizzazione dello Stato incominciava a negare come fondamento istituzionale acquisito del<br />
vivere sociale.<br />
La prima esperienza <strong>di</strong> Azione cattolica, nella città <strong>di</strong> Genova, nasceva come risposta<br />
insieme coraggiosa e polemica alle con<strong>di</strong>zioni culturali e istituzionali che lo Stato liberale<br />
andava imponendo alla Chiesa cattolica.<br />
Se sul piano organizzativo si trattava certamente <strong>di</strong> una novità (ma il riferimento ideale<br />
era alle associazioni cattoliche nella Germania protestante), sul piano <strong>degli</strong> orientamenti teorici<br />
essa continuava ed attualizzava un progetto <strong>di</strong> rinnovamento e riconquista in senso cattolico<br />
della società, il quale ebbe una viva espressione anche nella Congregazione del Beato Leonardo.<br />
4. Il sorgere in Italia <strong>di</strong> uno Stato costituzionale egemonizzato dai liberali portò ad un<br />
cambiamento nella presenza dei cattolici nella vita politica italiana. E ciò in duplice senso.<br />
Primo perché l‘organizzarsi dei citta<strong>di</strong>ni in libere associazioni politiche e culturali <strong>di</strong>ventava<br />
determinante per orientare in un senso o in un altro l‘andamento della res pubblica. Secondo,<br />
poiché lo Stato liberale tende a superare le concezioni e i fondamenti teorici della societas<br />
chrístiana e ad introdurne nuovi, in qualche modo svincolati da una concezione confessionale<br />
della società.<br />
264 Gaetano Alimonda, ad esempio, si impegnò nel giornalismo e fu <strong>di</strong>rettore del giornale genovese ―Il<br />
cattolico‖, <strong>di</strong> orientamento anti-liberale. Salvatore Magnasco si impegnò nell‘organizzazione delle<br />
―Società <strong>di</strong> S. Vincenzo‖ e poi con il Frassinetti <strong>di</strong>ede inizio alla Società <strong>di</strong> Mutuo Soccorso cattolica <strong>di</strong><br />
―S. Giovanni Battista‖. Lo stesso Magnasco, <strong>di</strong>venuto poi Arcivescovo <strong>di</strong> Genova, sostenne al Concilio<br />
Vaticano Primo la posizione infallibilista.<br />
70
Il fallimento del tentativo neoguelfo <strong>di</strong> dar vita ad un movimento cattolico patriottico e<br />
liberale, il carattere tendenzialmente laicistico dato dalla classe <strong>di</strong>rigente liberale al movimento<br />
risorgimentale e le posizioni da essa assunte nella soluzione della Questione Romana, la politica<br />
ecclesiastica del Regno <strong>di</strong> Sardegna, con le leggi eversive e la soppressione delle corporazioni<br />
religiose, l‘assestarsi del Pontefice <strong>roma</strong>no, dopo un periodo <strong>di</strong> incertezze e <strong>di</strong> cauti tentativi<br />
riformatori, su un fronte decisamente anti - liberale e conservatore, sono tutti elementi che<br />
concorrono a spiegare come mai, dopo l‘ Unità d‘ Italia, il Movimento Cattolico organizzato a<br />
livello <strong>di</strong> massa ha assunto un carattere ostile nei confronti dello Stato liberale 265<br />
(Intransigentismo).<br />
5. La presente ricerca ha messo in luce come all‘origine della Congregazione del Beato<br />
Leonardo, e piú in generale della mentalità <strong>di</strong> molti ecclesiastici <strong>di</strong> orientamento anti - liberale,<br />
vi fosse una viva istanza religiosa <strong>di</strong> risveglio e ―ricomposizione‖ cattolica del clero e della<br />
società. Questo ideale imponeva un‘adesione personale alla fede cattolica ma anche una<br />
conoscenza ed una <strong>di</strong>fesa delle tra<strong>di</strong>zioni e dei dogmi oltre che dell‘autorità ecclesiale ed una<br />
loro <strong>di</strong>ffusione nel popolo cristiano a tutti i livelli.<br />
Determinante era l‘assunzione delle conquiste e dei mezzi <strong>di</strong> propaganda propri della<br />
cultura moderna, ma non della filosofia e dei valori razionalistici e liberali, valutati in contrasto<br />
con la tra<strong>di</strong>zione cattolica.<br />
Paradossalmente un‘analoga ansia <strong>di</strong> riforma, non solo politica ma anche religiosa,<br />
sebbene con contenuti e <strong>di</strong>rezioni <strong>di</strong>fferenti, si ritrova anche in Gioberti ed in coloro che lo<br />
sostennero.<br />
Ci si permetta <strong>di</strong> congedarci dal presente lavoro richiamando all‘attenzione una<br />
convinzione, forse un po‘ paradossale, ma frutto <strong>di</strong> un‘acuta comprensione del Risorgimento<br />
italiano come momento <strong>di</strong> crisi religiosa 266 espressa da Ettore Passerin d‘Entreves, secondo il<br />
quale il Risorgimento vide «non tanto il crollo <strong>di</strong> un‘antica fede, quanto l‘urto fecondo <strong>di</strong> fe<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>verse: talora un reciso <strong>di</strong>stacco, ma spesso anche un ritorno alla tra<strong>di</strong>zione, che non è poi<br />
meno rivoluzionario della critica ra<strong>di</strong>cale, poiché investe il passato <strong>di</strong> una nuova vita» 267 .<br />
265<br />
Cfr., F. FONZI, Correnti <strong>di</strong> opposizione alla politica piemontese tra i cattolici liguri negli anni 1849-<br />
1859, in Rassegna Storica del Risorgimento, a. XXXIX 1952 542-552.<br />
266<br />
Il termine è mutuato da S. JACINI, La crisi religiosa del risorgimento. La politica ecclesiastica italiana<br />
da Villafranca a Porta Pia, Bari, 1938.<br />
267<br />
E. PASSERIN D‘ENTREVES, in ID., Religione e politica nell‟Ottocento europeo, op. cit., 5.<br />
71
D. GUALCO, Giansenío d‟Ipri, Genova 1844.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
C. BONAVINO, I Gesuiti. Risposte al M. R. D. Frassinetto per C. B. (Anonimo), Italia 1846.<br />
ID., Autentiche prove contro i Gesuiti e í loro affiliati e il celebre <strong>di</strong>alettico M. R. Frassinetto<br />
per B. C. in risposta a P.G. (Anonimo), Italia 1846.<br />
F. PELLICO, A Vincenzo Gioberti, Napoli 1846.<br />
C. M. CURCI, Fatti ed argomenti in risposta alle molte parole <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti intorno ai<br />
Gesuiti nei Prolegomeni del Primato, Napoli 1846.<br />
ID., Una <strong>di</strong>vinazione sulle tre ultime opere <strong>di</strong> Vincenzo Gíoberti: I Prolegomeni, il Gesuita<br />
moderno e l‟Apologia, Parigi 1849.<br />
G. MASSARI, V. Gioberti: Ricor<strong>di</strong> biografici e carteggio, Torino 1860 - 1869, 3 voll.<br />
D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vita del sac. Giuseppe Frassinetti, Priore <strong>di</strong> S.<br />
Sabina in Genova, Genova 1879.<br />
A CAPECELATRO, Vita della serva <strong>di</strong> Dio Paola Frassinetti, fondatrice delle suore <strong>di</strong> S.<br />
Dorotea, Roma 1900.<br />
G. FRASSINETTI, Riflessioni proposte agli ecclesiastici, Genova 1837; Ora in: Opera Omnia,<br />
Opere Ascetiche, vol. III, Roma 1910, 59-93.<br />
ID., Osservazioni sopra gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> ecclesiastici proposte ai chierici, Genova 1839. Ora in: Opera<br />
Omnia, vol. XIII, Roma 1912, 215-290.<br />
ID., Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. , dei ss. Apostoli e del Beato<br />
Leonardo da Porto Maurizio, (Anonimo), Genova 1835, 12. Ora in: Opera Omnia, vol. XIII,<br />
586592, con il titolo Idea della Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. ,<br />
Roma 1912.<br />
ID., Saggio intorno alla <strong>di</strong>alettica ed alla religione <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti (Anonimo), Genova<br />
1846. Ora in: Opera Omnia, vol. XIII, Roma 1912, 149-214.<br />
ID., Regolamento per la Conferenza dei promotori della Pia Associazione per la conservazione<br />
ed incremento della fede cattolica, Genova 1853. Ora in: Opera Omnia, vol. XIII, Roma 1912,<br />
105-112.<br />
ID., Ai buoni cattolici la Consulta della Pia associazione per la conservazione ed incremento<br />
della santa Fede, Genova 1855. Ora in: Opera Omnia, vol. XIII, Roma 1912, 115-126.<br />
ID., Regolamento della Pia Associazione delle Signore per la conservazione ed incremento della<br />
fede cattolica, Genova 1856 (Anonimo). Ora in: Opera Omnia, vol. XIII, Roma 1912, 126-136.<br />
ID., Notizia della Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. Regina <strong>degli</strong><br />
Apostoli, dei ss. Apostoli e del Beato Leonardo da Porto Maurizio, (pubblicato anonimo, a cura<br />
<strong>di</strong> L. Bottaro), Oneglia 1857. Ora in: Opera Omnia, vol. XIII, Roma 1912, 521-611.<br />
ID., Memorie intorno alla vita del sac. Luigi Sturla, Genova 1871. In: Opera Omnia, vol. XIII,<br />
Roma 1912, 405-455.<br />
72
A. LUZIO, La madre <strong>di</strong> Giuseppe Mazzini: carteggio ine<strong>di</strong>to dal 1834 al 1839, Torino 1919.<br />
NEGRI, Vincenzo Ricci e il Gesuita moderno, in: Rassegna storica del Risorgimento italiano, a.<br />
VIII (1921), 244-275.<br />
A. ANZILOTTI, Gioberti, Firenze 1922.<br />
A. COLLETTI, Ausonio Franchi ed i suoi tempi (apostasia e conversione), Torino - Roma 1925.<br />
V. GIOBERTI, Epistolario, E<strong>di</strong>zione nazionale a cura <strong>di</strong> G. Gentile e G. Balsamo - Crivelli,<br />
Firenze 1927-1930, 11 voll.<br />
C. OLIVARI, Della vita e delle opere del servo <strong>di</strong> Dio sac. Giuseppe Frassinetti, Priore a S.<br />
Sabina in Genova, Fondatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Roma 1928.<br />
M. CECCARDI – C. FERRARI, Società operaia cattolica <strong>di</strong> N.S. del Soccorso e <strong>di</strong> S. Giovanni<br />
Battista (nel 75° Anniversario <strong>di</strong> fondazione. Cenni storico - statistici 1854 - 1929), Genova<br />
1929.<br />
I. RINIERI, Il Gesuita moderno, Genova 1932.<br />
V. GIOBERTI, Prolegomeni del Primato morale e civile <strong>degli</strong> Italiani, Capolago 1846.<br />
Nell‘e<strong>di</strong>zione nazionale delle Opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti è a cura <strong>di</strong> E. Castelli,<br />
Milano 1938.<br />
ID., Del Primato morale e civile <strong>degli</strong> italiani, Bruxelles 1843. Nell‘e<strong>di</strong>zione nazionale delle<br />
opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te <strong>di</strong> V. Gioberti è a cura <strong>di</strong> V. Rodano, Milano 1938 - 39, 2 voll.<br />
E. GUGLIELMINO, Genova dal 1814 al 1848. Gli sviluppi economici e l‟opinione pubblica (Atti<br />
della Regia Deputazione <strong>di</strong> Storia Patria per la Liguria. Serie Risorgimento, vol. IV), Genova<br />
1939.<br />
V. GIOBERTI, Il Gesuita moderno, Losanna 1846 - 47, 5 voll. Nell‘e<strong>di</strong>zione nazionale delle<br />
Opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti è a cura <strong>di</strong> M. F. Sciacca, Milano 1940 - 1942, 6<br />
voll.<br />
D. DE CAMMILLIS, Un grande <strong>di</strong>fensore del Vangelo: il Car<strong>di</strong>nale Gaetano Alimonda (1818 -<br />
1891), Tivoli 1941.<br />
A. DURANTE, Mons. Salvatore Magnasco, Arcivescovo <strong>di</strong> Genova, Milano 1942.<br />
F. FONZI, Per una storia del movimento cattolico italiano (1861-1919). Relazione presentata al<br />
XXVIII Congresso <strong>di</strong> Storia del Risorgimento (Roma 12-14 ottobre 1949), in: Rassegna Storica<br />
del Risorgimento, a.XXXV11 (1950), 140-150.<br />
A. OMODEO, V. Gioberti e la sua evoluzione politica, in: Difesa del Risorgimento, Torino 1951.<br />
F. FONZI, Correnti <strong>di</strong> opposizione alla politica piemontese tra i cattolici liguri negli anni 1849 -<br />
1859, in: Rivista storica del Risorgimento, a. XXX1X (1952), 542-552.<br />
G. B. TRAGELLA, Un “Gesuitante” missionario d‟occasione, in: Stu<strong>di</strong>a Missionalia, a. VII<br />
(1953) 349 - 368.<br />
G. DE ROSA, Storia politica dell‟Azione Cattolica in Italia, Bari 1953-54, 2 voll.<br />
73
AA. VV., Atti dell‟XXXIII Congresso <strong>di</strong> Storia del Risorgimento (Messina 1-2 settembre 1954)<br />
de<strong>di</strong>cato a Il problema religioso nel Risorgimento, Messina 1954.<br />
ANONIMO, ―Cronaca della celebrazione del Primo Centenario della Società Operaia Cattolica<br />
<strong>di</strong> N.S. del Soccorso e <strong>di</strong> S. Giovanni Battista e delle Società Operaie Cattoliche Liguri‖,<br />
Giugno 1955.<br />
V. VITALE, Breviario della Storia <strong>di</strong> Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici,<br />
Genova 1955, 2 voll., (con bibliografia completata da T. O. De Negri).<br />
A. C. JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino 1955.<br />
G. PERILLO, Attività economica e con<strong>di</strong>zione dei lavoratori nel genovesato intorno alla metà del<br />
sec. XIX, in Movimento operaio e socialista in Liguria, a. IV (1958), 63-82.<br />
A. GAMBASIN, Il movimento sociale nell‟Opera dei Congressi (1874-1904). Contributo per la<br />
storia del Cattolicesimo sociale in Italia, Roma 1958.<br />
G. PERILLO, Gli albori dell‟organizzazione operaia nel Genovesato, in: Movimento operaio<br />
socialista in Liguria, a. V (1959) 169-188; 197-206; a. VI (1960), 51-81.<br />
E. PASSERIN D‘ENTREVES, Il cattolicesimo liberale in Europa ed il movimento neoguelfo in<br />
Italia in: Nuove questioni <strong>di</strong> storia del Risorgimento e dell‟Unità d‟Italia, Milano 1961, vol. I,<br />
565- 606.<br />
G. ORESTE, Note per uno <strong>stu<strong>di</strong></strong>o dell‟opinione pubblica a Genova (1853-60) in: AA.VV.,<br />
Genova e l‟impresa dei Mille, Roma 1961.<br />
G. DE ROSA, Storia del movimento cattolico in Italia, dalla Restaurazione all‟età giolittiana,<br />
Bari 1966, 2 voll.<br />
E. F. FALDI, Il Priore <strong>di</strong> S. Sabina, il Servo <strong>di</strong> Dio Don Giuseppe Frassinetti, Genova<br />
Sampierdarena 1967.<br />
T. O. DE NEGRI, Storia <strong>di</strong> Genova, Milano 1968.<br />
C. VERUCCI, I cattolici e il liberalismo dalle “amicizie cristiane” al modernismo, Padova 1968.<br />
TEODOSIO DA VOLTRI, Un prete rinnovatore, ritratto <strong>di</strong> Giuseppe Frassínetti, Genova 1969.<br />
R. AUBERT, Il pontificato <strong>di</strong> Pio IX, in: Storia della Chiesa, (<strong>di</strong>retta da A. Fliche, a V. Martin,<br />
J.B. Duroselle ed E. Jarry), Torino 1970, vol. XXI 1/2.<br />
G. CANDELORO, Il movimento cattolico in Italia, Roma 1972.<br />
F. TRANIELLO, Cattolicesimo e società moderna (dal 1848 alla “Rerum Novarum”), in: Storia<br />
delle idee politiche, economiche e sociali (<strong>di</strong>retta da L. Firpo), Torino 1972, vol. V, 551-652.<br />
G. MARTINA, Pio IX, Roma 1974-1986, 2 voll.<br />
F. FONZI, I cattolici e la società italiana dopo l‟unità, Roma 1972.<br />
BARTOLO GARICLIO - ETTORE PASSERIN D‘ENTREVES (a cura <strong>di</strong>), Introduzione alla storia del<br />
movimento cattolico in Italia, Bologna 1979.<br />
74
G. RENZI, Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche, Roma 1979.<br />
GIORGIO CHITTOLINI E GIOVANNI MICCOLI (a cura <strong>di</strong>), Storia d‟Italia. Annali 9: La chiesa e il<br />
potere politico dal me<strong>di</strong>oevo all‟età contemporanea, Torino 1986.<br />
M. E. POSADA, Storia e santità. Influsso del teologo Giuseppe Frassinetti sulla spiritualità <strong>di</strong> S.<br />
<strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello, Roma 1992.<br />
M. ROSA, Clero e società nell‟Italia contemporanea, Bari 1992.<br />
E. PASSERIN D‘ENTREVES, Religione e politica nell‟Ottocento Europeo (a cura <strong>di</strong> F. Tranello),<br />
Roma 1993.<br />
Francesco Puddu<br />
75
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE<br />
PER GLI ADOLESCENTI E GIOVANI SECONDO LA SPIRITUALITÀ<br />
DEL SACERDOTE GIUSEPPE FRASSINETTI 268<br />
INTRODUZIONE<br />
«Dio vuole che tutti nel loro stato si facciano santi» 269 . Ogni cristiano è chiamato alla<br />
santità. È una vocazione che manifesta la <strong>di</strong>gnità e responsabilità <strong>di</strong> ogni uomo creato ad<br />
immagine e somiglianza <strong>di</strong> Dio. L‘intera esistenza dell‘uomo è un continuo peregrinare nello<br />
sforzo <strong>di</strong> realizzare questa vocazione: la chiamata a <strong>di</strong>ventare figli <strong>di</strong> Dio. La santità è il vero<br />
significato dell‘esistenza dell‘uomo in questo mondo 270 . La vocazione alla santità ci rivela anche<br />
un‘altra verità: questa chiamata è un‘alleanza tra l‘uomo e il suo Creatore, 271 è un patto<br />
d‘amicizia che dona all‘uomo l‘onore <strong>di</strong> collaborare con Dio nel suo grande progetto <strong>di</strong> salvezza<br />
dell‘umanità.<br />
La santità cristiana è un cammino. È uno stile <strong>di</strong> vita che richiede la conversione e<br />
trasformazione in Cristo, suo maestro e modello 272 . La scelta <strong>di</strong> seguire Cristo è un impresa<br />
molto impegnativa che richiede coraggio e perseveranza; ma la testimonianza dei santi ci<br />
conferma che non è impossibile. La via della santità è possibile per tutti, anzi è per tutti. È un<br />
cammino da percorre con Dio (Emanuele), Dio cammina con noi e ci accompagna con il suo<br />
grande amore e un‘infinita misericor<strong>di</strong>a.<br />
La strada da percorrere nella tensione alla santità è un percorso da fare con ―Qualcuno‖.<br />
Nella storia della salvezza Dio ha sempre fornito guide al suo popolo: i profeti, i re, i pastori, e<br />
in generale i santi. Essi sono gli inviati che parlano a nome <strong>di</strong> Dio ma nello stesso tempo anche<br />
guide o accompagnatori spirituali.<br />
Giuseppe Frassinetti è uno <strong>di</strong> questi uomini, chiamato da Dio ad essere strumento per la<br />
cura e guida del suo gregge.<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale è nel cuore del piano della salvezza. «Lo scopo della <strong>di</strong>rezione<br />
spirituale è <strong>di</strong> aiutarci a compiere la nostra missione in questo mondo, portare avanti il<br />
significato della nostra esistenza, vivere la nostra vocazione, salvare le nostre anime e <strong>di</strong>ventare<br />
santi» 273 . È un strumento in<strong>di</strong>spensabile per la vita spirituale <strong>di</strong> ogni cristiano soprattutto per i<br />
giovani 274 . «La <strong>di</strong>rezione spirituale è necessaria per la nostra crescita e maturità spirituale, ma è<br />
estremamente importante nei momenti piú delicati della vita come nell‘adolescenza e<br />
268 Dissertazione per la Licenza in Teologia, con la specializzazione in Teologia Spirituale presso la<br />
―Pontificia Facultas Theologica Teresianum‖ Pontificio Istituto <strong>di</strong> Spiritualità, Roma, studente Dominic<br />
Tabal N° matr.:9250/S, Anno Accademico 2005-2006, Moderatore: Prof. Benito Goya.<br />
Padre Dominic Tabal, <strong>di</strong> oirgine filippina, sacerdote della Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, è impegnato nel lavoro pastorale tra i giovani e adolescenti, che con impegno e zelo<br />
prospetta la via della santità, servendosi particolarmente della <strong>di</strong>rezione spirituale.<br />
269 Il conforto dell‟anima, O.A., I, 17.<br />
270 «L‘accoglienza e la risposta del credente è anche essa dono e opera del potere <strong>di</strong>vino. Questo è il modo<br />
in cui la parola <strong>di</strong> Dio giunge a compimento e <strong>di</strong>spiega le sue virtualità. Quanto piú l‘uomo agisce, tanto<br />
piú si rivela il potere <strong>di</strong>vino» F. RUIZ, Le vie dello Spirito Santo, EDB, Bologna 1999, 19.<br />
271 «Dio ha stretto con l‘uomo un rapporto <strong>di</strong> alleanza. Considerata secondo il suo aspetto personale,<br />
questa alleanza si manifesta quale vocazione: Dio chiama ogni uomo a realizzare un progetto <strong>di</strong> santità<br />
che sfocia nella vita eterna, ed è proprio <strong>di</strong>vino e cerca adeguare ad esso la propria esistenza, che realizza<br />
la sua vocazione» C.A. BERNARD, Teologia spirituale, E<strong>di</strong>zioni Paoline, Roma 1983, 41.<br />
272 «Ogni cristiano è chiamato da Dio a essere conforme a Cristo compiendo perfettamente il suo stato <strong>di</strong><br />
vita. Egli ha la responsabilità primaria <strong>di</strong> <strong>di</strong>re sí alla chiamata che ha sentito e <strong>di</strong> accettare, con tutte le<br />
conseguenze, tale risposta, la quale non è tanto <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne intellettuale ma vitale» B. GOYA, Luce e guida<br />
nel cammino, EDB, Bologna 2004, 59.<br />
273 C.P. MICHAEL, An introduction to spiritual <strong>di</strong>rection, Paulist Press, U.S.A. 2004, 7.<br />
274 «La <strong>di</strong>rezione spirituale è <strong>di</strong> somma importanza nel cammino verso la santità quando si vuole vivere<br />
intensamente il progresso spirituale» L.M. MENDIZÁBAL, La <strong>di</strong>rezione spirituale. Teoria e pratica, EDB,<br />
Bologna 1999, 12.<br />
76
giovinezza, specialmente quando si devono prendere decisioni importanti e applicare il<br />
<strong>di</strong>scernimento» 275 .<br />
Lo scopo <strong>di</strong> questo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o è <strong>di</strong> presentare i meto<strong>di</strong> della <strong>di</strong>rezione spirituale del<br />
sacerdote Giuseppe Frassinetti, che aveva fama <strong>di</strong> buon <strong>di</strong>rettore spirituale dei giovani e <strong>di</strong><br />
esaminare l‘attualità del suo insegnamento oggi per orientare e aiutare tanti <strong>di</strong>rettori spirituali<br />
nel loro ministero <strong>di</strong> guida ed accompagnamento delle nuove generazioni.<br />
I meto<strong>di</strong> applicati nell‘elaborato sono: descrittivo, analitico e sintetico. Il lavoro<br />
presenterà l‘insegnamento del sacerdote Giuseppe Frassinetti con chiarezza e in modo conciso e<br />
fedele al suo carisma e alla sua spiritualità.<br />
Come suggerisce il titolo <strong>di</strong> questo lavoro, sarà presa in considerazione solo e<br />
fedelmente la dottrina <strong>di</strong> questo sacerdote <strong>di</strong> Genova riguardo all‘accompagnamento spirituale<br />
dei giovani, frutto dal suo impegno pastorale. Questo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o non pretende <strong>di</strong> presentare delle<br />
novità, anzi la sua originalità sta nel suo impegno e desiderio <strong>di</strong> esplicitare e attualizzare la<br />
<strong>di</strong>rezione spirituale del sacerdote Giuseppe Frassinetti nella nostra situazione o<strong>di</strong>erna, <strong>stu<strong>di</strong></strong>o che<br />
ancora non era stato intrapreso.<br />
La ricerca si basa su fonti <strong>di</strong> prima mano: L‟Opere ascetiche <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti con<br />
l‘introduzione e note <strong>di</strong> Giordano Renzi, Le Memorie storiche intorno alla vita del Sac.<br />
Giuseppe Frassinetti raccolte da Domenico Fassiolo, Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote Giuseppe<br />
Frassinetti <strong>di</strong> Carlo Olivari, e la Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti <strong>di</strong> Manfredo Paolo<br />
Falasca. Per le altre fonti, l‘autore ha consultato libri e <strong>stu<strong>di</strong></strong> sulla la vita e spiritualità del<br />
sacerdote Giuseppe Frassinetti, libri sulla <strong>di</strong>rezione spirituale e libri sulla pastorale dei giovani e<br />
adolescenti.<br />
Il lavoro è <strong>di</strong>viso in quattro capitoli. Il primo presenterà un breve profilo storico sulla<br />
vita del sacerdote Giuseppe Frassinetti e la situazione religiosa - sociale dei giovani durante il<br />
suo tempo. Vengono presentate anche in questo capitolo gli elementi portanti della sua<br />
spiritualità.<br />
Il secondo capitolo elaborerà la dottrina della <strong>di</strong>rezione spirituale del Frassinetti. La<br />
ricerca mette in luce lo scopo e l‘importanza dell‘accompagnamento spirituale. In questo<br />
capitolo, saranno illustrati i tre elementi fondamentali in ogni processo <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale. In<br />
modo sintetico questo capitolo cercherà <strong>di</strong> presentare i maestri che hanno influenzato ed hanno<br />
contribuito alla personalità, poi alla dottrina e spiritualità del Frassinetti.<br />
Il terzo si può considerare il cuore <strong>di</strong> questo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o. Si presenterà la dottrina<br />
dell‘accompagnamento spirituale del sacerdote Giuseppe Frassinetti per gli adolescenti e per i<br />
giovani. In questo capitolo, cercheremo <strong>di</strong> conoscere la sua figura come <strong>di</strong>rettore spirituale,<br />
esamineremo i <strong>di</strong>versi elementi del suo metodo <strong>di</strong> accompagnamento, e finalmente cercheremo<br />
<strong>di</strong> elencare i <strong>di</strong>versi mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> guidare l‘anima cristiana esaminando le sue opere e scritti, che<br />
testimoniano la ricchezza ed efficacia della sua dottrina. Ci si potrà rendere conto che è<br />
appropriata la definizione che gli è stata attribuita <strong>di</strong> fautore dei santi.<br />
L‘ultimo capitolo <strong>di</strong> questo lavoro presenterà la situazione attuale dei giovani nel nostro<br />
tempo, ed analizzerà gli elementi essenziali della <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti per<br />
aiutare gli accompagnatori spirituali dei giovani <strong>di</strong> oggi nel loro ministero pastorale giovanile.<br />
Infine, nel presente <strong>stu<strong>di</strong></strong>o si tenterà una sintesi della dottrina dell‘accompagnamento<br />
spirituale del sacerdote Giuseppe Frassinetti e la sua rilevanza attuale al nostro tempo.<br />
Questo lavoro vuole contribuire a trovare possibili soluzioni alle <strong>di</strong>verse sfide e<br />
<strong>di</strong>fficoltà in questo delicato campo della missione della Chiesa: la cura delle anime soprattutto<br />
dei giovani e adolescenti.<br />
275 S. DE PIERI, Orientamento educativo e accompagnamento vocazionale, ELLEDICI, Leumann To<br />
2000, 74.<br />
77
CAPITOLO PRIMO<br />
GIUSEPPE FRASSINETTI E IL SUO TEMPO<br />
A. Panorama storico<br />
Il <strong>di</strong>ciannovesimo fu un secolo <strong>di</strong> lotte interminabili per l‘in<strong>di</strong>pendenza nazionale. Il<br />
<strong>di</strong>ffuso spirito rivoluzionario aveva tratto origine dall‘Illuminismo. La nascita <strong>di</strong> tale filosofia<br />
aveva messo in risalto l‘idea della superiorità della ragione umana nei confronti della fede e<br />
aveva avallato in molti casi l'uso della forza per <strong>di</strong>ffondere e incarnare a tutti i costi i suoi<br />
principi nel mondo moderno. Fu davvero un'era <strong>di</strong> rivoluzioni 276 . Un obbiettivo era il <strong>di</strong>vorzio<br />
tra chiesa e stato e la strategia principale per raggiungerlo fu quella <strong>di</strong> sban<strong>di</strong>erare l‘idea <strong>di</strong><br />
progresso nella sfera politica, sociale, culturale e religiosa, proponedo una società laica. Con<br />
queste premesse, due forti tendenze si scontrarono: la prima era quella <strong>di</strong> proteggere la<br />
tra<strong>di</strong>zione, la seconda la lotta ra<strong>di</strong>cale per adottare la mentalità <strong>di</strong> un mondo in trasformazione.<br />
Non c'è da stupirsi se quest'era fu chiamata «...il periodo dello Sturm und Drang. Fu il<br />
periodo del desiderio conclamato per gli ideali <strong>di</strong> libertà, propagati dalla rivoluzione francese,<br />
ma che avevano bisogno <strong>di</strong> maturità nella coscienza sociale in ogni suo passo» 277 .<br />
Sotto il peso dalla loro situazione miserevole e desiderosa <strong>di</strong> liberarsi ad ogni costo da<br />
questa con<strong>di</strong>zione, la maggioranza della popolazione iniziò ad essere meno attaccata ai valori e<br />
agli insegnamenti della Chiesa, che veniva in<strong>di</strong>cata come il principale ostacolo al progresso 278 .<br />
«È il periodo <strong>di</strong> vari laicismi, <strong>degli</strong> assalti rivoluzionari contro il clero e la predominanza delle<br />
autocrazie, al fine <strong>di</strong> laicizzare la struttura stessa della Chiesa che, d‘altra parte, con il<br />
rinforzarsi del papato riconquistò la sua propria libertà <strong>di</strong> azione» 279 .<br />
È chiaro che la Chiesa soffrí per questa persecuzione, e gli effetti furono sentiti non solo<br />
tra i membri della gerarchia della Chiesa, ma avevano conseguenze in tutti i suoi membri.<br />
Comunque, questo <strong>di</strong>fficile periodo era servito per trasformare e purificare la Chiesa stessa. «La<br />
fede dei Cristiani riemerse purificata da ciò che avevano subito. La Chiesa dovette ritornare alla<br />
sua missione essenziale. Aveva un clero che era meritevole e solidamente strutturato, e che<br />
<strong>di</strong>pendeva strettamente dall‘amministrazione centrale» 280 . Questo secolo infatti, tra tutte le sue<br />
luci ed ombre, aveva lasciato una ricca ere<strong>di</strong>tà spirituale per la Chiesa Universale 281 . «A fronte<br />
276<br />
«A parte gli atteggiamenti assunti <strong>di</strong> fronte alla cultura del settecento, l‘ottocento appare originalmente<br />
innovatore: inaugura l‘inizio <strong>di</strong> un‘epoca nuova. Lo testimoniano gli sconvolgenti moti rivoluzionari che<br />
l‘hanno preceduto al suo affacciarsi» T. GOFFI, La spiritualità dell‟ottocento, EDB, Bologna 1989, 18.<br />
277<br />
L. BORRIELO – G.. DELLA CROCE – B. SECONDIN, Storia della spiritualità. La spiritualità cristiana<br />
nell‟età contemporanea, Borla, Roma 1985, 13.<br />
278<br />
«In forma innovativa sull‘epoca antecedente l‘ottocento ha una propria ideologia politico-razionalista,<br />
un nuovo vissuto democratico, una vita civica slegata dalla struttura ecclesiastica, la chiesa privata dai<br />
suoi tra<strong>di</strong>zionali privilegi e assoggettata alla comune legislazione statale, una vita comunitaria ecclesiale<br />
asserragliata per custo<strong>di</strong>rsi dai moti cultuali laicisti liberali e socialisti» T. Goffi, La Spiritualità<br />
dell‟ottocento, 18.<br />
279<br />
L. BORRIELO – G.. DELLA CROCE – B. SECONDIN, Storia della spiritualità. La spiritualità cristiana<br />
nell‟età contemporanea, Borla, Roma 1985, 14.<br />
280<br />
J. COMBY, How to read the Church history. From the Reformation to the present day, SCM Press,<br />
London 1998, 121.<br />
281<br />
«… la vita spirituale acquista nuove <strong>di</strong>mensioni nella <strong>di</strong>namica dei settori apostolicamente piú<br />
impegnati; e nel contempo la spiritualità <strong>di</strong>venta piú comunitaria, sociale ed ecclesiale, perdendo un certo<br />
tono elitario. Di fatto, pur non riscontrando novità ra<strong>di</strong>cali nella vita cristiana, si possono osservare<br />
manifestazioni particolari che acquistano notevole risalto: ciò accade per alcune forme <strong>di</strong> vita religiosa e<br />
con la nuova azione apostolica dei laici, per alcune manifestazioni <strong>di</strong> vita cristiana impegnate in quella<br />
che viene definita azione sociale e per il contributo dato dall‘attività missionaria, particolarmente<br />
78
della situazione ostile fomentata durante la confusione delle rivoluzioni, la spiritualità realizzò<br />
un momento <strong>di</strong> reazione, segnato dalla restaurazione. Fu il risvegliarsi e la rinascita della<br />
responsabilità <strong>di</strong> ciascuno al fine <strong>di</strong> salvare i valori fondamentali della fede Cristiana» 282 .<br />
Questo aveva contribuito alla nascita <strong>di</strong> molte congregazioni religiose, la rinascita del ruolo<br />
importante dei laici nella Chiesa, il risveglio dell'importanza dell‘Eucarestia nella vita <strong>di</strong> ogni<br />
cristiano, la partecipazione attiva e purificata alla <strong>di</strong>vina liturgia ed altre devozioni mariane.<br />
Senza dubbio il sacerdote Giuseppe Frassinetti fu uno dei molti protagonisti <strong>di</strong> questa<br />
rivoluzione spirituale.<br />
«Il <strong>di</strong>ciannovesimo secolo in Europa rappresenta il periodo dei contrasti tra<br />
restaurazione e rivoluzione, tra<strong>di</strong>zionalismo, <strong>roma</strong>nticismo ed illuminismo» 283 . Nel contesto<br />
italiano, può essere osservata la stessa panoramica. È nostro intento mettere a fuoco in<br />
particolare durante questo periodo la situazione <strong>di</strong> Genova, luogo in cui nacque Giuseppe<br />
Frassinetti 284 . Possiamo affermare imme<strong>di</strong>atamente che la situazione globale aveva una forte<br />
influenza sui genovesi. Troviamo anche qui le due tendenze opposte sopramenzionate 285 . «Era,<br />
infatti, un secolo <strong>di</strong> eventi tormentati e <strong>di</strong>battuti; un esempio sono le vicissitu<strong>di</strong>ni napoleoniche<br />
riguardanti Genova, che aveva perso la sua libertà e la plurisecolare pace interna a causa dello<br />
scoppio <strong>di</strong> violente passioni in contrasto tra loro» 286 . Di conseguenza, una nuova sfida ribollí nel<br />
sangue <strong>di</strong> ogni genovese. Non si trattava solamente della lotta per l'in<strong>di</strong>pendenza dai francesi,<br />
c‘era anche la nascita del conflitto tra la popolazione 287 . «Il Servo <strong>di</strong> Dio (Frassinetti) viveva e<br />
lavorava mentre l‘opposizione tra vecchie e nuove tendenze era in crescita. Non venne mai<br />
ingannato da quelle facili illusioni, osservava con attenzione quelle con<strong>di</strong>zioni umane alla luce<br />
dell‘eternità. Non fu mai un politico <strong>di</strong> professione, ne piú o meno un <strong>di</strong>scepolo della politica;<br />
era un prete e la sua politica era unicamente il Vangelo» 288 .<br />
In questo <strong>di</strong>fficile momento, la Divina Provvidenza dette prova ancora una volta che<br />
Dio camminava tra coloro che hanno fede e che Egli presta sempre attenzione ai loro bisogni<br />
spirituali. E un Padre che usa sempre strumenti umani per proteggere i suoi figli amati. La<br />
sviluppata in questo periodo storico, al rinnovamento cristiano‖ M. RAGAZZONI, Storia della spiritualità<br />
moderna, Teresianum, Roma 2005, 190.<br />
282 E. PACHO, Storia della spiritualità moderna, Teresianum, Roma 1984, 275.<br />
283 S. DE FIORES, <strong>Maria</strong> sintesi <strong>di</strong> valori. Storia culturale della mariologia, E<strong>di</strong>zioni San Paolo, Milano<br />
2005, 284.<br />
284 «Nel secolo XVIII la città del Servo <strong>di</strong> Dio era profondamente combattuta da una sorda guerra <strong>di</strong><br />
principi e <strong>di</strong> dottrine, le quali, tuttoché allora restassero in gran parte allo stato <strong>di</strong> teorie e <strong>di</strong> idee,<br />
formentarono in seguito quella terribile lotta <strong>di</strong> opere esteriori contro la chiesa nel secolo seguente» G.<br />
CAPURRO, Giuseppe Frassinetti e l‟opera sua. Tipografia della Gioventú, Genova 1908, 5.<br />
285 «… periodo fortunoso, in cui opposte tendenze si contrastarono il campo. Da una parte, il piú come<br />
suole avvenire, quelli che si lasciano andare all‘onda del tempo, o per manco <strong>di</strong> coraggio, o per una cotale<br />
in<strong>di</strong>fferenza, o per un certo amore <strong>di</strong> novità. A questi, che nella massima parte credevano in tutta buona<br />
fede doversi navigare a seconda del vento, si aggiungevano uomini astuti, che con fini artifizi <strong>di</strong> accorti<br />
infingimenti, <strong>di</strong> falsi lo<strong>di</strong>, <strong>di</strong> mascherato zelo cercavano addormentare in una fatale sicurezza quanti<br />
avrebbero dovuto stare a guar<strong>di</strong>a dell‘insi<strong>di</strong>ato gregge e gridare al lupo. Dall‘altra uomini <strong>di</strong> antico<br />
stampo, <strong>di</strong> pietra soda, <strong>di</strong> zelo, pochi <strong>di</strong> numero, ma energici, risoluti, cercavano col far vivere nel clero<br />
l‘antica <strong>di</strong>sciplina, col ridestare nel popolo la pietà, ristorare la chiesa genovese dai gravi danni che<br />
l‘eresia giansenista dapprima, e poi le dottrine rivoluzionarie avevano arrecati» C. OLIVARI, Il Servo <strong>di</strong><br />
Dio sacerdote Giuseppe Frassinetti, Tipografia Pologlotta Vaticana, Roma 1928, 7.<br />
286 A. DE ANGELIS, The prior Joseph Frassinetti and the spirituality of Genoa in the 19th century, Don<br />
Bosco Press, Makati City 2000, 17.<br />
287 «Il 1804, anno della nascita del Frassinetti, fu anche l‘anno in cui Napoleone Bonaparte si proclamò<br />
imperatore dei francesi e re d‘Italia. Nel 1805 l‘imperatore entrò trionfalmente in Genova. Per circa <strong>di</strong>eci<br />
anni la vita genovese graviterà attorno a Parigi, centro dello stato. Durante il periodo francese l‘antica,<br />
potente Repubblica marinara vedeva ormai tracciata la sua sorte a venire: l‘annessione al Regno <strong>di</strong><br />
Sardegna, <strong>di</strong>ventando cosí un porto del Piemonte. Effettivamente Genova veniva definitivamente annessa<br />
al Regno Sardo il 3 giugno 1815» M. E. POSADA, Storia e santità. Influsso del teologo Giuseppe<br />
Frassinetti sulla spiritualità <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello, Las, Roma 1992, 32.<br />
288 E. F. FALDI, Il priore <strong>di</strong> S. Sabina. Il Servo <strong>di</strong> Dio don Giuseppe Frassinetti, Scuola Tipografica Don<br />
Bosco, Genova 1964, 39.<br />
79
testimonianza <strong>di</strong> Pio IX fu uno dei suoi molti segni. «In relazione al <strong>di</strong>segno della Provvidenza,<br />
che governa i gran<strong>di</strong> eventi, che mettono alla prova la Chiesa, ma dalla quale essa riemerge<br />
sempre trionfante, si sviluppa in Italia, in concomitanza con il Moto Unitario e con le sofferenze<br />
personali <strong>di</strong> Pio IX per la per<strong>di</strong>ta del potere temporale, una devozione per il Papa tanto da<br />
considerarlo l‘oracolo <strong>di</strong> Dio sulla terra. La Voluntas Dei è ricercata in ogni cosa, come una<br />
prova della fede e della ragione, come una garanzia <strong>di</strong> trovarsi sempre sul giusto cammino verso<br />
la verità. Sotto questo profilo, ogni sforzo era orientato verso un preciso punto <strong>di</strong> riferimento: il<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale, l‘autorità religiosa, il vescovo, il papa e la Divina Provvidenza... » 289 .<br />
La Direzione Spirituale in questo periodo era considerata un aiuto importante e una<br />
assicurazione della realizzazione della volontà <strong>di</strong> Dio nella vita <strong>di</strong> ciascuno. Il <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale era considerato l‘immagine visibile <strong>di</strong> Dio. Egli è infatti, una guida nel viaggio verso<br />
la vita spirituale, 290 e il sacerdote Giuseppe Frassinetti fu uno <strong>di</strong> quei <strong>di</strong>rettori spirituali mandati<br />
da Dio per la cura del suo gregge.<br />
B. Giuseppe Frassinetti<br />
1. Giuseppe Frassinetti: un dono <strong>di</strong> Dio<br />
Paolo Giuseppe <strong>Maria</strong> Frassinetti fu un dono <strong>di</strong> Dio al <strong>di</strong>ciannovesimo secolo. Nacque<br />
il 15 Dicembre 1804 in un umile quartiere <strong>di</strong> Genova nei pressi della parrocchia <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
delle Vigne. Fu il primo <strong>degli</strong> un<strong>di</strong>ci figli <strong>di</strong> Giovanni Battista e Angela Viale. Solo cinque <strong>di</strong><br />
questi sopravvissero: insieme a lui c‘erano Francesco, Giovanni, Raffaele: tutti i suoi fratelli<br />
abbracciarono il sacerdozio come lui. La loro unica sorella, <strong>Santa</strong> Paola, <strong>di</strong>venne la fondatrice<br />
delle Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea 291 .<br />
Durante l‘infanzia e la preadolescenza Giuseppe Frassinetti aveva già dato prova <strong>di</strong> una<br />
vita straor<strong>di</strong>nariamente virtuosa. «Sin dalla fanciullezza, il nostro Giuseppe aveva mostrato<br />
segni che non lasciavano dubbi sulla sua futura bontà. La prima virtú che lo contrad<strong>di</strong>stingueva<br />
dagli altri ragazzi della sua età era la sua obbe<strong>di</strong>enza, che è la base <strong>di</strong> tutte le altre virtú. In<br />
questo era quasi irreprensibile. Era sempre pronto ad accettare le osservazioni dai suo genitori e<br />
non si permetteva mai alcun innocente <strong>di</strong>vertimento senza chiedere il loro permesso» 292 .<br />
Giuseppe coltivò la sua vita spirituale. La sua intimità con Dio ebbe origine all‘età <strong>di</strong> sei<br />
anni quando mamma Angela lo consacrò alla Beata Vergine in uno dei santuari piú amati dai<br />
genovesi, la Madonnetta 293 . Portò con sé questa speciale devozione per la Beata <strong>Maria</strong> durante<br />
tutta la sua esistenza ed essa <strong>di</strong>venne l‘ispirazione del suo ministero pastorale. Possiamo inoltre<br />
riscontrare la docilità del suo spirito quando ricevette per la prima volta la <strong>Santa</strong> Comunione.<br />
«La memoria della sua prima comunione rimase profondamente impressa in lui. In quel giorno<br />
lo videro esultante per la tanta gioia e, toccato dalla santità, non si stancava mai <strong>di</strong> raccontare<br />
289<br />
ZOVATTO, ed., Storia della spiritualità italiana, Città Nuova, Roma 2002, 479.<br />
290<br />
«Nel contesto ecclesiale spirituale dell‘ottocento, impegnato <strong>di</strong> ossequio e sud<strong>di</strong>tanza, la <strong>di</strong>rezione<br />
spirituale appariva desiderabile giacché offriva la gioia <strong>di</strong> essere affidati ad una persona <strong>di</strong> Dio, la<br />
sicurezza <strong>di</strong> un buon cammino spirituale, la percezione <strong>di</strong> essere ascoltato nelle proprie confidenze e,<br />
quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> essere amati» T. GOFFI, La spiritualità dell‟ottocento, 183.<br />
291<br />
«Nella primavera del 1831 il Frassinetti assumeva a Quinto la Parrocchia <strong>di</strong> San Giuseppe. Ebbe<br />
l‘ispirazione <strong>di</strong> chiamare con sé la sorella Paola ed il padre – dopo alcune titubanze – lo concesse<br />
pensando anche all‘aria <strong>di</strong> Quinto che avrebbe giovato alla <strong>Figli</strong>a. Nacque cosí la piccola scuola <strong>di</strong> carità<br />
per ragazze povere e il piccolo gruppo <strong>di</strong>ventò nucleo fecondo <strong>di</strong> nuova vita nella Chiesa: oggi è la<br />
Congregazione delle Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea fondata da <strong>Santa</strong> Paola Frassinetti» M. E. POSADA, Storia e<br />
santità, op. cit., 74.<br />
292<br />
D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vita del sac. Giuseppe Frassinetti, Tipografia della<br />
Gioventú, Genova 1879, 9.<br />
293<br />
«Non aveva ancora compiuti i sei anni, che fu condotto dai genitori, la vigilia dell‘Assunta al santuario<br />
detto popolarmente della Madonnetta a fare l‘offerta del cuore come è costume in questa chiesa con<br />
grande affluenza <strong>di</strong> fanciulli. Non lo <strong>di</strong>menticò mai piú, e quando era già parroco <strong>di</strong> santa Sabina, in un<br />
<strong>di</strong>scorsetto che tenne nello stesso santuario per una simile cerimonia, ricorda con sua consolazione quel<br />
giorno per lui tanto lieto» Ibid..<br />
80
della sua fortuna. Si prendeva gran cura del rosario che gli era stato dato come se fosse una<br />
reliquia <strong>di</strong> quell‘evento memorabile. Certamente, possiamo credere che in quel giorno Dio<br />
l‘abbia abbracciato con tale fermezza con la Sua speciale grazia che accompagnò Giuseppe<br />
durante tutta la sua vita» 294 . Da quel momento in poi, alimentò la sua vita quoti<strong>di</strong>ana<br />
partecipando quoti<strong>di</strong>anamente alla <strong>Santa</strong> Messa 295 . Non c‘è da meravigliarsi che questa intimità<br />
lo condusse al sacerdozio. Infaticabilmente, <strong>di</strong>venne un apostolo della <strong>Santa</strong> Eucarestia e<br />
Comunione quoti<strong>di</strong>ana.<br />
Un‘altra rimarcabile qualità <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti fu la de<strong>di</strong>zione alla sua formazione<br />
intellettuale e culturale. Eccelse sempre nei suoi <strong>stu<strong>di</strong></strong> 296 . Non sprecava mai tempo sapendo che<br />
una preparazione dettagliata era un bene per il suo futuro apostolato. «Mentre procedeva in virtú<br />
e devozione, si impose una rigida regola per se stesso in modo tale da spendere tutto il suo<br />
tempo <strong>stu<strong>di</strong></strong>ando o nella loro casa o nella biblioteca della città, accompagnando la sua <strong>di</strong>sciplina<br />
con devozione mattutina e serale» 297 . Visse con questa de<strong>di</strong>zione tutta la sua vita, specialmente<br />
nella preparazione al sacerdozio e anche dopo la sua or<strong>di</strong>nazione 298 . Questa fu la ragione per la<br />
quale <strong>di</strong>venne in seguito un importante riferimento nella cultura teologica. Esercitò questo<br />
ministero tanto nello scrivere quanto nella pre<strong>di</strong>cazione.<br />
«Frassinetti è considerato come un evidente e preciso autore ascetico dotato <strong>di</strong> una<br />
notevole capacità <strong>di</strong>dattica nel rendere comprensibili anche problemi complicati, mettendo in<br />
evidenza gli elementi essenziali. Dava sempre ai suoi lavori fondamenti la base <strong>di</strong> solida<br />
dottrina dogmatica e li rendeva concreti con la sua assidua esperienza personale» 299 . Questo lo<br />
rese famoso non solo a Genova ma anche in <strong>di</strong>verse parti del mondo. Molti dei suoi lavori<br />
furono tradotti in numerose lingue, a riprova della sua salda dottrina e utilità per la fede<br />
cristiana. «Giuseppe Frassinetti fu un uomo genovese della Genova del <strong>di</strong>ciannovesimo secolo<br />
con qualcosa in piú che lo rese un uomo <strong>di</strong> Dio» 300 .<br />
Ecco alcuni tratti della personalità <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti che lo resero un dono alla sua<br />
epoca, in particolar modo ai giovani. Ciò che è stato sottolineato nella descrizione precedente è<br />
la sua solida formazione in giovane età, che lo trasformò con il maturare del tempo un apostolo<br />
per i giovani. Queste considerazioni ci aiuteranno a capire un‘altra importante <strong>di</strong>mensione del<br />
suo apostolato, vale a <strong>di</strong>re la sua <strong>di</strong>rezione spirituale - che è l‘argomento principale <strong>di</strong> questo<br />
lavoro.<br />
2. La famiglia Frassinetti: una scuola <strong>di</strong> santità<br />
La santità <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti fu tanto il frutto <strong>di</strong> una giovane formazione datagli dai<br />
suoi genitori 301 quanto delle esperienze <strong>di</strong> vita che con<strong>di</strong>vise con i suoi fratelli e sua sorella. La<br />
294 Ibid., 10.<br />
295 «Il sottoscritto può attestare che una volta in un <strong>di</strong>scorso famigliare con due o tre giovani studenti,<br />
<strong>di</strong>sse francamente che egli da giovane non tralasciò mai un giorno <strong>di</strong> assistere al santo Sacrificio della<br />
Messa‖ ibid., 11.<br />
296 «Endowed with a bright intelligence, Joseph probably learnt the first elements of the Latin language<br />
from Fr. Angelico, an Observant Friar. Frassinetti attended the classes in the seminary as extern, excelling<br />
and stan<strong>di</strong>ng out from his fellow seminarians, especially in the humanitieS. Likewise, he excelled in the<br />
fields of Philosophy and Theology, thus deserving praises and awards» A. DE ANGELIS, The prior Joseph<br />
Frassinetti and the spirituality of Genoa in the 19th century, op. cit. 12.<br />
297 Ibid.,<br />
298 «Basti <strong>di</strong>re che egli non si contentò delle semplici lezioni a cui giornalmente partecipava, ma<br />
frequentava le biblioteca, e sopra i gran<strong>di</strong> volumi dei teologi e dei Padri spendeva lunghe ore, pensando e<br />
me<strong>di</strong>tando senza risparmiarsi fatica alcuna. Questa sua abituale occupazione lo assorbiva soprattutto nei<br />
giorni <strong>di</strong> vacanza, nei quali il suo riposo era una passeggiata insieme con un compagno <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o. Fu cosí<br />
che egli adornò la sua mente <strong>di</strong> cognizione profonde, …» D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla<br />
vita del sac. Giuseppe Frassinetti, 14.<br />
299 ZOVATTO, ed., Storia della spiritualità italiana, 564.<br />
300 M. FALASCA, Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, Cantagalli, Siena 2004, 3.<br />
301 «Dai genitori aveva appreso ad amare Dio ed il prossimo, da loro aveva ere<strong>di</strong>tato uno sguardo<br />
ottimistico verso la vita e l‘attitu<strong>di</strong>ne a fare tesoro del tempo e del sacrificio» [L. FAIN BINDA,<br />
81
sua fu una famiglia che <strong>di</strong>venne per lui una scuola <strong>di</strong> santità 302 . Abbiamo appena descritto la<br />
con<strong>di</strong>zione politica e morale <strong>di</strong> questo periodo, ma questo non scoraggiò papà Giovanni Battista<br />
e mamma <strong>Maria</strong> Viale nell‘educare in modo appropriato i loro figli secondo gli insegnamenti<br />
della fede cristiana 303 .<br />
Angela Viale era una donna semplice ma dalla profonda spiritualità e umanità.<br />
Giuseppe ere<strong>di</strong>tò da lei devozione e generosità <strong>di</strong> cuore 304 . «È stato detto che nutriva i suoi figli<br />
sia con il latte che con la vocazione religiosa e provava una profonda devozione per la Beata<br />
Vergine <strong>Maria</strong>... » 305 . È stato anche detto che Angela ebbe un altro figlio <strong>di</strong> latte che <strong>di</strong>venne<br />
prete come i suoi altri quattro figli. Questo accadde quando un giorno Angela incontrò una<br />
donna che non aveva abbastanza latte per suo figlio. Mamma Angela offrí senza esitazioni il suo<br />
latte per aiutare questa madre; ma quello che l‘ha resa grande è stata la testimonianza della sua<br />
fede. Angela aveva perso cinque figli. Ha sempre offerto questo momento <strong>di</strong> dolore al <strong>di</strong>vino<br />
volere <strong>di</strong> Dio, educando Giuseppe e gli altri figli a fare la stessa cosa 306 .<br />
Anche il padre <strong>di</strong> Giuseppe fu una figura importante nella formazione della sua<br />
spiritualità. Giovanni Battista era un uomo umile e onesto. Non era ricco, ma fu sempre un<br />
padre operoso e responsabile 307 . «Di suo padre Giovanni Battista Giuseppe Frassinetti aveva<br />
detto: se ho mai fatto qualcosa <strong>di</strong> buono, dopo che a Dio, lo devo a mio padre» 308 . La fede <strong>di</strong> suo<br />
presentazione, in D. BRUZZONE – M. F. PORCELLA a cura <strong>di</strong>, La formazione alla santità nella Chiesa<br />
genovese dell‟ottocento. Il contributo <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, Las, Roma 2004, 7].<br />
302 «Quale aura <strong>di</strong> cristiana pietà spirasse tra quelle mura privilegiate dal cielo basterebbe a <strong>di</strong>mostrarlo il<br />
fatto <strong>di</strong> tutta intera la figliolanza consacrata a Dio, e in tempi in cui la pietà e l‘antico riserbo andava<br />
rapidamente scemando, col <strong>di</strong>ffondersi delle nuove idee, anche nella famiglia cristiana. Ci duole che<br />
come <strong>di</strong> un fitto velo sia per noi avvolta l‘infanzia del nostro Giuseppe, e che nessuna memoria ci sia<br />
pervenuta delle cure amorose della buona genitrice, la quale certo dovette infondere nel primogenito suo i<br />
germi preziosi <strong>di</strong> ogni piú bella virtú, germi <strong>di</strong> cui non poté ella vedere che i primi fiori appena sbocciati»<br />
C. OLIVARI, Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote Giuseppe Frassinetti, 16.<br />
303 «L‘humus familiare non poteva dunque essere piú ricco e splendente <strong>di</strong> vita cristiana, alimentato<br />
com‘era dalla robusta fede del padre Giovanni Battista e dalla delicatissima pietà della madre Angela<br />
Viale, che conduceva i suoi figli, ad uno ad uno, man mano che le giungevano, al santuario della<br />
Madonetta, per consacrarne il cuore a <strong>Maria</strong>» G. RENZI, Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche.<br />
Catalogo bibliografico generale delle Opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te del Servo <strong>di</strong> Dio, Tifografia Don Guanella,<br />
Roma 1979, 7.<br />
304 ―La mamma, Angela Viale, donna <strong>di</strong> squisita delicatezza <strong>di</strong> mente e <strong>di</strong> cuore e dalla fede veramente<br />
materna, lo avvia precocemente a fare il segno della croce e a comprendere il significato, lo accompagna<br />
<strong>di</strong> frequente alla chiesa <strong>di</strong> san Luca per insegnarli la via che porta a Gesú e, al compiersi del sesto anno <strong>di</strong><br />
età, si reca con lui sul colle <strong>di</strong> Carbonara, al santuario della Madonneta, per affidarlo alla Vergine<br />
Assunta‖ L. FAIN BINDA, presentazione, in D. BRUZZONE – M. F. PORCELLA a cura <strong>di</strong>, La formazione<br />
alla santità nella Chiesa genovese dell‟ottocento. Il contributo <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, Las, Roma 2004,<br />
7.<br />
305 M. FALASCA, Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, op. cit., 31.<br />
306 «Nel cuore della mamma erano vivi come quelli che le saltellavano attorno. D‘ognuno aveva qualcosa<br />
da <strong>di</strong>re, d‘ognuno portava un segno ed un ricordo nel suo corpo. Erano il suo calendario. Ogni fatto era<br />
situato prima o dopo o durante l‘attesa <strong>di</strong> questo o <strong>di</strong> quel figlio, mantenuti vivi e presenti anche nella<br />
memoria dei fratelli sopravvissuti: la gioia del primo vagito che ne annunciava l‘arrivo – all‘epoca si<br />
nasceva tutti in casa – il battesimo prima che fossero trascorse le ventiquattro ore per assicurare loro il<br />
para<strong>di</strong>so, venendone cosí a comprendere l‘importanza. Al loro ricordo restarono legati anche il primo<br />
incontro con il mistero della morte ed i primi atti <strong>di</strong> fede: perché battezzati, erano certamente in para<strong>di</strong>so<br />
con gli angeli e già vedono Dio, la Madonna e i santi. La loro morte, piú che timore, a quei piccoli<br />
ingenerava un senso <strong>di</strong> invi<strong>di</strong>a» Ibid., 30.<br />
307 «Il padre, nella modesta sua professione <strong>di</strong> merciaio, si adoperava a tutt‘uomo perché la famiglia<br />
venisse su onoratamente e cristianamente educata. Uomo per indole austero, e per vivo sentimento <strong>di</strong><br />
religione convinto dell‘alta idealità della vita, e della responsabilità che ai genitori incombe della buona<br />
riuscita del figli, li custo<strong>di</strong>va con gelosissima cura» C. OLIVARI, Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote Giuseppe<br />
Frassinetti, 17.<br />
308 L. FAIN BINDA, presentazione, La formazione alla santità nella Chiesa genovese dell‟ottocento. Il<br />
contributo <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, op. cit., 7.<br />
82
padre fu messa alla prova quando Angela morí, lasciandolo con sei figli. Bartolomeo, il piú<br />
giovane, morí pochi giorni dopo sua madre.<br />
Non fu mai facile per Giovanni, ma questi perseverò, accettando ogni cosa come volere<br />
<strong>di</strong> Dio. «Nel mentre, suo padre, uomo <strong>di</strong> devozione genuina, aveva de<strong>di</strong>cato sforzi premurosi<br />
nel prendersi buona cura dei suoi figli, come un vero imitatore <strong>di</strong> Tobia, instillò in Giuseppe<br />
principi religiosi, lo sottrasse all‘influenza <strong>di</strong> cattive compagnie e non lo iniziò mai al teatro o<br />
ad altri <strong>di</strong>vertimenti che fossero eccessivamente terreni. Portava sempre suo figlio con sé sia<br />
quando andava a passeggiare che quando si recava in chiesa per varie pie devozioni» 309 . Questa<br />
buona educazione contribuí in gran modo a formare lo spirito <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina e perfezione cristiana<br />
in Giuseppe. Durante tutta la sua vita, <strong>di</strong>venne la sua guida costante, la cosiddetta compagnia<br />
invisibile nel suo ministero apostolico.<br />
Tali erano i genitori <strong>di</strong> Giuseppe. Non c‘è da meravigliarsi quin<strong>di</strong> se, nelle loro anime<br />
innocenti, tutti i giovani Frassinetti aspiravano sempre a sod<strong>di</strong>sfare Dio e a fare il suo volere. P.<br />
Manfredo Paolo Falasca ha scritto un interessante articolo al riguardo, «Fratelli e sorelle che<br />
erano in costante competizione circa chi compiacesse <strong>di</strong> piú Dio» 310 . A questa cosí giovane età,<br />
erano in grado <strong>di</strong> comprendere cosa fosse la santità: non è altro che compiacere Dio. Per<br />
raggiungere imme<strong>di</strong>atamente il loro nobile obbiettivo, lottarono per <strong>stu<strong>di</strong></strong>are in che modo<br />
ottenerlo. «I giovani Frassinetti <strong>stu<strong>di</strong></strong>avano le cose <strong>di</strong> Dio cosí da conoscere il modo <strong>di</strong> vivere<br />
una vita che Lo compiacesse, ed il modo migliore per raggiungere questo obbiettivo era tramite<br />
il catechismo e gli esempi dei santi» 311 . Giuseppe <strong>di</strong>venne il loro primo catechista 312 ; trasformò<br />
la loro casa in una Chiesa <strong>di</strong> giovani santi 313 . «La mia descrizione <strong>di</strong> questa famiglia <strong>di</strong> santi<br />
<strong>di</strong>mostra quanto sia nobile vivere insieme; piú che dal legame del sangue, erano tenuti insieme<br />
dal legame del loro amore» 314 . Questo rese la famiglia <strong>di</strong> Frassinetti una scuola <strong>di</strong> santità.<br />
3. Giuseppe Frassinetti: un <strong>di</strong>rettore spirituale a quattor<strong>di</strong>ci anni<br />
Giuseppe Frassinetti, a seguito della morte <strong>di</strong> sua madre il 6 gennaio 1819, assunse un<br />
ruolo importante nei confronti della cura dei suoi fratelli e della sorella Paola. Essendo il<br />
maggiore tra loro, <strong>di</strong>venne la mano destra <strong>di</strong> Giovanni Battista nell‘educazione dei bambini.<br />
Praticamente a quattor<strong>di</strong>ci anni, cominciò ad esercitare guida e <strong>di</strong>rezione spirituale nell‘ambito<br />
della sua famiglia 315 . Tra i suoi quattro fratelli, de<strong>di</strong>cò particolare attenzione a Paola, poiché era<br />
l‘unica ragazza. Divenne il primo insegnante <strong>di</strong> Paola nella sua educazione giovanile e <strong>di</strong> base,<br />
e, in seguito, la accompagnò nella scelta della sua vocazione.<br />
Non fu una semplice coincidenza se chiamò Paola a stare con lui nella parrocchia <strong>di</strong><br />
Quinto con la scusa <strong>di</strong> collaborare con lui nel prendersi cura dei giovani. Fu uno dei suoi meto<strong>di</strong><br />
per guidare Paola verso il luogo in cui Dio la stava chiamando. Lo fece perché la conosceva<br />
molto bene. Dopotutto, era stato il suo <strong>di</strong>rettore spirituale dall‘inizio. <strong>Santa</strong> Paola commentò in<br />
309<br />
D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vVita del sac. Giuseppe Frassinetti, op. cit., 9.<br />
310<br />
Manfredo Falasca ha de<strong>di</strong>cato un intero capitolo su questo argomento, il capitolo XI del suo libro<br />
―Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti».<br />
311<br />
Ibid., 58.<br />
312<br />
«Perché sia tale Giuseppe s‘è fatto una ricchissima raccolta <strong>di</strong> belle storie <strong>di</strong> santi che mostrano come<br />
la dottrina vada vissuta, storie che infervoravano ad imitarli e a mettersi in gara con loro nel dar gusto a<br />
Dio» ibid., 64.<br />
313<br />
«La mamma avrebbe certo moderato quel desiderio <strong>di</strong> imitare i santi e la fretta <strong>di</strong> farsi anch‘essi presto<br />
santi, impedendo a Paola i molti e prolungati <strong>di</strong>giuni e proteggendo dal freddo le mani <strong>di</strong> Giuseppe. Casa<br />
e chiesa, quei ragazzi. Una casa trasformata in chiesa con altarini e sacre immagini, celebrazioni <strong>di</strong> messe,<br />
novene con tanto <strong>di</strong> latino comprensibile solo alle orecchie del Signore, e pre<strong>di</strong>che, e processioni <strong>di</strong><br />
stanza in stanza, cantando tutte le canoniche apprese in chiesa» Ibid., 67.<br />
314<br />
Ibid., 7.<br />
315<br />
«In tali famiglie l‘ascendente del primo è enorme. Credete ad uno nato un<strong>di</strong>cesimo. Si vide in lui un<br />
quasi padre, e tale si sente. Giuseppe primogenito, si trovò ad essere studente e maestro dei fratelli.<br />
Aggiungasi che era persona istruita <strong>di</strong> casa e per tale tenuto in considerazione dal padre» Ibid., 44.<br />
83
un‘occasione, «Ascoltando con piacere tutte le loro conversazioni, particolarmente quelle <strong>di</strong> mio<br />
padre e il mio fratello maggiore 316 , ho imparato molte cose che altrimenti non avrei saputo» 317 .<br />
La sua considerazione prudente a riguardo della fondazione <strong>di</strong> una nuova congregazione<br />
non è nient‘altro che una prova alla determinazione e fede <strong>di</strong> sua sorella. Era sua intenzione<br />
assicurarle fermezza e forza. E cosí, convinto del coraggio e della forte volontà <strong>di</strong> Paola nel<br />
seguire il piano <strong>di</strong> Dio nella sua vita, lui stesso preparò i passi iniziali per la costituzione <strong>di</strong> una<br />
nuova congregazione, ora chiamata “Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea”. Cosí, il rapporto tra fratello e<br />
sorella <strong>di</strong>venne un rapporto <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale. La sua esperienza nell‘educare e formare<br />
Paola verso la realizzazione della volontà <strong>di</strong> Dio nella sua vita aveva contribuito molto alla sua<br />
propria preparazione nel <strong>di</strong>ventare piú tar<strong>di</strong> uno strumento per molti giovani verso il corretto<br />
<strong>di</strong>scernimento nello stato della loro vita. «La sua esperienza con Paola gli fece scoprire in<br />
giovane età l‘importanza <strong>di</strong> una figura femminile e cosa questa sia capace <strong>di</strong> fare, se è<br />
innamorata <strong>di</strong> Dio» 318 .<br />
Giuseppe Frassinetti <strong>di</strong>venne un <strong>di</strong>rettore spirituale anche per i suoi fratelli minori. Lo<br />
fece cosí bene che tutti loro decisero <strong>di</strong> seguire il suo esempio ed abbracciare il sacerdozio:<br />
Francesco <strong>di</strong>venne Canonico Regolare Lateranense, parroco della Beata Vergine Incoronata;<br />
Raffaele e Giovanni, dal canto loro, <strong>di</strong>vennero attivi collaboratori <strong>di</strong> Giuseppe nel suo<br />
apostolato. Entrambi rimasero vicini al fratello maggiore fino alla sua morte. Tale attaccamento<br />
a Giuseppe era probabilmente il frutto <strong>di</strong> un <strong>di</strong>scernimento interno, che li portò a scoprire la loro<br />
umile ma importante vocazione.<br />
Giuseppe dovette aver spiegato ai fratelli come fosse piú importante obbe<strong>di</strong>re al volere<br />
<strong>di</strong> Dio che nutrire aspirazioni personali verso una posizione ecclesiastica piú elevata. Attraverso<br />
<strong>di</strong> lui, anche loro scoprirono la loro vocazione e il ruolo che ricoprivano nella Chiesa. Non si<br />
trovano altre informazioni importanti su <strong>di</strong> loro, eccetto le lettere che lui mandò ai fratelli<br />
durante il suo esilio in cui affidava loro la cura del suo gregge 319 . Queste lettere mostravano la<br />
preoccupazione paterna che Giuseppe provava per i suoi fratelli e per le anime affidate alla sua<br />
cura. In tal modo, ancora una volta, il rapporto <strong>di</strong> Giuseppe con i suoi fratelli <strong>di</strong>venne un<br />
rapporto <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale. Anche se non <strong>di</strong>vennero famosi, una cosa era certa: furono tutti<br />
preti santi e zelanti.<br />
4. Giuseppe Frassinetti: un apostolo per i giovani<br />
Giuseppe Frassinetti, grato per la formazione che ricevette dalla sua famiglia e dai suoi<br />
educatori, non indugiò mai a de<strong>di</strong>care tutti i suoi sforzi per educare e guidare i giovani. Come<br />
abbiamo visto precedentemente, il suo desiderio non era una semplice intuizione, ma una<br />
riflessione concreta sulla sua esperienza personale, quando, insieme a suo padre, guidò e formò i<br />
316 «… con Giuseppe che, a suo <strong>di</strong>re, aveva esercitato un influsso molto forte sulla famiglia per la sua<br />
virtú non or<strong>di</strong>naria, si sarebbe stretto un legame <strong>di</strong> amicizia reciproca, una profonda intesa, da una sorta <strong>di</strong><br />
fraternità spirituale, destinata a durare a lungo» R. ROSSETTO, Paola Frassinetti. In punta <strong>di</strong> pie<strong>di</strong>,<br />
E<strong>di</strong>zioni Messaggero, Padova 1984, 17.<br />
317 C. OLIVARI, Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote Giuseppe Frassinetti, 20.<br />
318 M. FALASCA, Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, 48.<br />
319 «Il mio allontanamento sono persuaso che fu in mio bene, se succederà il vostro lo sarà ugualmente.<br />
Però mi pare <strong>di</strong>fficile che debba venire chi vi scacci <strong>di</strong> casa e voglia tutto per sé. Fate bene a stare<br />
d‘intelligenza con quel prete che lo credo buon amico, consigliatevi sempre con lui. Nel caso che non si<br />
potesse evitare l‘economo mi pare che si potrebbe fare qualche parte per avere qualcuno che si potesse<br />
supporre <strong>di</strong>screto; ma quel prete vi consiglierà. Ciò che adesso voglio scrivervi è che non vi lasciate<br />
sopraffare dal timore, il quale potrebbe farvi <strong>di</strong>menticare il quaerite primum regnum Dei. Troppo chiaro<br />
si vede negli o<strong>di</strong>erni avvenimenti il <strong>di</strong>gitus Dei, e che non est alius qui pugnet pro nobis. Perciò sarà<br />
vanissima tutta l‘umana prudenza, anzi se sarà eccessiva avrà cattivi effetti. Vedete che nelle altre chiese,<br />
anche in S. Siro, si fa il mese mariano, come si fa in quelle avreste potuto farlo anche voi alla mattina; la<br />
Madonna avrebbe potuto aiutare; avete temuto una novena ai defunti; sono però contento che abbiate fatto<br />
il triduo. Io vi compatisco perché in tanta parte avete ragione <strong>di</strong> temere <strong>di</strong> tutto; ma d‘altronde non potete<br />
avere altro aiuto se non dalla fede in Dio: pregate dunque, fate pregare, che non c‘è altro mezzo» Lettere<br />
Spirituali, O.A., II, 625-626.<br />
84
suoi tre fratelli e sua sorella. Il suo entusiasmo era accompagnato da un ardente desiderio <strong>di</strong><br />
combattere la situazione morale <strong>di</strong> degrado del suo tempo, che fortemente influenzava la<br />
società.<br />
«Subito dopo la sua or<strong>di</strong>nazione, si consacrò completamente a Dio. Si premurò <strong>di</strong> essere<br />
libero da ogni cosa terrena, e si de<strong>di</strong>cò senza indugio all‘esercizio del ministero della<br />
santificazione delle anime. Si uní alla congregazione dei Missionari Urbani 320 e a quella<br />
Franzoniani 321 i quali ministeri includevano la pre<strong>di</strong>cazione, amministrare la confessione ed<br />
insegnare il catechismo ai giovani e ai fanciulli. Svolse queste attività con molto piacere, ed era<br />
sempre <strong>di</strong>sposto ad andare dove lo richiedeva il suo ministero sacerdotale» 322 .<br />
I frutti del suo zelo pastorale per i giovani erano meravigliosi. «L‘istruzione religiosa<br />
era molto povera e c‘erano pochi partecipanti... ignoravano le pre<strong>di</strong>che sia sul pulpito che<br />
sull‘altare. Nella parrocchia <strong>di</strong> S. Stefano, c‘erano all'incirca quin<strong>di</strong>cimila anime, solo quaranta<br />
giovani frequentavano il catechismo. Quando Frassinetti e Sturla 323 assunsero la <strong>di</strong>rezione, il<br />
numero salí a settecento» 324 . Era davvero una sorta <strong>di</strong> miracolo, conoscendo la situazione<br />
<strong>di</strong>fficile dell‘epoca.<br />
Il segreto <strong>di</strong> Giuseppe era la sua capacità <strong>di</strong> esporre le sue argomentazioni in modo<br />
semplice ed interessante. I giovani ammiravano la sua de<strong>di</strong>cazione e la sua autorità. Lo<br />
rispettavano e lo apprezzavano come un padre. Erano anche attratti dalla sua personalità<br />
semplice e umile 325 . Don De Gregori, il rettore del seminario, ammirava il suo talento e gli<br />
affidò la spiegazione delle Sacre Scritture ai giovani seminaristi.<br />
La sua popolarità si <strong>di</strong>ffuse per tutta Genova e le città confinanti, ed egli <strong>di</strong>venne il<br />
punto <strong>di</strong> riferimento per altri preti che gli chiedevano suggerimenti ed aiuto nella cura dei<br />
giovani. Fu questa la vera ragione per la quale Frassinetti scrisse molti opuscoli e libretti – in<br />
modo da aiutarli e rispondere ai loro bisogno apostolici. Questo entusiasmo e zelo già dall‘inizio<br />
dell‘esperienza del sacerdozio lo accompagnarono durante tutta la sua vita sacerdotale.<br />
Nel 1831 P. Giuseppe Frassinetti <strong>di</strong>venne parroco della parrocchia <strong>di</strong> San Pietro a<br />
Quinto, Genova. Una delle sue prime preoccupazioni fu la cura dei giovani. «Quello che era al<br />
centro dei suoi pensieri erano i giovani. Sapeva molto bene quanto fosse importante impiantare<br />
nei loro cuori innocenti le virtú cristiane, la conoscenza <strong>di</strong> Dio, le nostre responsabilità<br />
spirituali: sapeva che educare una gioventú onesta e cristiana era come preparare per la sua<br />
gente generazioni buone e forti per il futuro» 326 .<br />
320 La congregazione dei Missionari Urbani fu un efficiente istituzione, che mirava <strong>di</strong> sostenere i giovani<br />
sacerdoti nel loro apostolato. Fu fondata dal car<strong>di</strong>nale Stefano Durazzo nel 1643.<br />
321 Il nome è stato presso dal fondatore, Don Franzoni. Quest‘istituzione si concentra invece all‘apostolato<br />
nei luoghi <strong>di</strong> campagna.<br />
322 D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vita del sac. Giuseppe Frassinetti, 17.<br />
323 Luigi Sturla fu l‘amico – collaboratore del Frassinetti e che, come lui, con<strong>di</strong>vide la passione per la<br />
santificazione delle anime.<br />
324 M. FALASCA, Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, 68.<br />
325 «Egli si faceva tutto a tutti, e con bel modo e affabile giovialità ammoniva, correggeva gli erranti; ed<br />
era bello vederlo in mezzo ai giovani spezzare loro il pane della <strong>di</strong>vina parola, istruirli amorevolmente,<br />
sopportarne con una certa noncuranza i <strong>di</strong>fetti. Stavano attenti alle sue parole e quasi non gli si sapevano<br />
spiccicare <strong>di</strong> torno, attratti da quel suo fare lieto e festivo che mostrava verso <strong>di</strong> essi. È questa la ragione<br />
per cui gli riusciva facile tenerli in chiesa e farli accostare ai sacramenti; cosa che gli stava grandemente a<br />
cuore. Non si considerò sod<strong>di</strong>sfatto dal fatto che molti si andavano a confessare, ma ottenne che molti <strong>di</strong><br />
essi da lui stesso si confessassero; è perciò non credeva male spese lunghe ore che anche a sera tarda<br />
impiegava in quest‘opera <strong>di</strong> carità. È da notare che se egli era sempre affabile con i giovani, si asteneva<br />
tuttavia da ciò che potesse dare qualche sentore <strong>di</strong> eccessiva famigliarità, anzi si mostrava tutto acceso <strong>di</strong><br />
santa in<strong>di</strong>gnazione e adoperò anche la sferza nel castigarli quando <strong>di</strong>cevano o facevano qualche atto che<br />
potesse in qualche modo offendere la santa onestà. In questo modo riusciva a farsi conciliare quel rispetto<br />
che è dovuto al sacro carattere, e li abituava ad usare un contegno modesto e cosí silenzioso, che a mala<br />
pena e raramente si sentiva il cicalio <strong>di</strong> qualche giovane. Da questo si può dedurre quale sforzo fosse il<br />
suo, mentre si sa per esperienza come sia <strong>di</strong>fficile tenere in silenzio i gruppi dei ragazzi che si recano alla<br />
dottrina» D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vita del sac. Giuseppe Frassinetti, 18.<br />
326 C. OLIVARI, Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote Giuseppe Frassinetti, 45-46.<br />
85
Chiese l‘aiuto <strong>di</strong> sua sorella Paola perché si incaricasse dell‘istruzione della dottrina<br />
cristiana alle fanciulle. Era sicuro delle sue capacità perché era stato lui a prepararla. «Fratello e<br />
sorella si misero al lavoro. Frassinetti raccolse un po' <strong>di</strong> ragazze nel presbiterio in modo da<br />
istruirle alla devozione cristiana; ma sapeva anche che poteva affidare le loro giovani vite a sua<br />
sorella. Paola non fallí nel sod<strong>di</strong>sfare le aspettative <strong>di</strong> suo fratello e adoperò tutte le sue qualità e<br />
la sua bontà» 327 . La Divina Provvidenza <strong>di</strong>ede il suo consenso e, da questa esperienza, nacque<br />
una nuova congregazione per la Chiesa universale. In un modo o nell‘altro, possiamo<br />
considerare la maggior parte <strong>di</strong> queste giovani ragazze che si unirono a Paola come le figlie<br />
spirituali <strong>di</strong> Frassinetti, loro parroco.<br />
Egli lavorò duramente per elevare la con<strong>di</strong>zione morale <strong>di</strong> questi ragazzi e ragazze. In<br />
un breve periodo <strong>di</strong> tempo, riuscí ad sra<strong>di</strong>care tutte le abitu<strong>di</strong>ni rischiose e malsane per la loro<br />
formazione cristiana 328 . Riuscí a riportarli al grembo della Chiesa in modo da guidarli lungo il<br />
giusto cammino della fede cristiana.<br />
Il giorno 10 giugno 1839 il nostro Frassinetti fu nominato priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina dove<br />
rimase fino alla morte. Mise tutta la sua energia nella santificazione delle anime e portava nel<br />
cuore una speciale preoccupazione per i giovani 329 . Fece questo con le sue parole e i suoi<br />
esempi. Scrisse sull‘argomento libri e opuscoli. Anche don Bosco attinse dalla scienza del<br />
Frassinetti e lo chiese come collaboratore per la sua rivista: Letture Cattoliche. La maggior parte<br />
<strong>di</strong> questi lavori era in<strong>di</strong>rizzata ai giovani in modo da assicurare la loro giusta crescita secondo le<br />
virtú cristiane. Aveva inoltre fondato molte congregazioni e associazioni con questo stesso<br />
scopo 330 .<br />
Anche se non possiamo enumerare in questo lavoro tutte le attività del suo zelo<br />
infaticabile per la gioventú, è stato provato che il venerabile Giuseppe Frassinetti fu un apostolo<br />
indefesso durante tutta sua vita.<br />
5. La formazione <strong>di</strong> giovani sacerdoti per giovani<br />
Giuseppe Frassinetti conosceva per esperienza l‘importanza del ministero sacerdotale e<br />
il ruolo vitale che un prete ha nella vita <strong>di</strong> ogni cristiano. I preti non si limitano ad amministrare<br />
i sacramenti, sono i rappresentanti visibili <strong>di</strong> Cristo sulla terra, alter Christus. Come Lui, sono<br />
chiamati ad accu<strong>di</strong>re il suo gregge con una considerazione speciale per la pecorella smarrita. È<br />
tanto un onore quanto una responsabilità. Conosceva bene le gran<strong>di</strong> opere che un prete santo<br />
può compiere per l‘anima <strong>di</strong> ciascuno, specialmente per le anime innocenti che avevano piú<br />
bisogno della sua guida e <strong>di</strong>rezione spirituale.<br />
327 A. DE ANGELIS, The Venerable Joseph Frassinetti, 19-20.<br />
328 «… egli si era impegnato con forza ad estirpare dal suo gregge la pericolosa abitu<strong>di</strong>ni dei balli, che<br />
sono le piú terribili occasioni <strong>di</strong> peccato per la gioventú. Ora un altro male, che lo affliggeva assai, gli<br />
premeva <strong>di</strong> togliere. Era il costume che i ragazzi facessero il bagno al mare totalmente nu<strong>di</strong>: in estate se<br />
ne vedeva un gran numero tutti i giorni immancabilmente. Era tanto inveterata quell‘abitu<strong>di</strong>ne, che pareva<br />
<strong>di</strong>fficilissimo potervi porre rime<strong>di</strong>o. Egli cominciò a pre<strong>di</strong>care, ad esortare i genitori che impe<strong>di</strong>ssero<br />
quello scandalo. Rimproverò, promise, minacciò, nulla lasciò d‘intentato per correggere quella pessima<br />
consuetu<strong>di</strong>ne. Comandò ad alcuni giovani piú giu<strong>di</strong>ziosi che gli <strong>di</strong>cessero i nomi <strong>di</strong> coloro che avessero<br />
<strong>di</strong>subbi<strong>di</strong>to, e molte volte in estate andava sul mezzogiorno alla riva del mare, e se vedeva qualcuno nudo<br />
lo minacciava fin col bastone. In breve, tanto <strong>di</strong>sse tanto fece che riuscí a far cessare quello scandalo …»<br />
C. OLIVARI, Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote Giuseppe Frassinetti, 23.<br />
329 «Imitiamo pertanto il giar<strong>di</strong>niere, coltivando con speciale premura e zelo le buone novelle istituzioni.<br />
Tra queste siano prime quelle che riguardano l‘educazione morale e religiosa della gioventú, nella quale,<br />
come è chiaro, stanno riposte le migliori speranze e che d‘altra parte, è a i nostri giorni la porzione piú<br />
insi<strong>di</strong>ata della società» Brevi parole ai sacerdoti fratelli, O. A., II, 610.<br />
330 «Frassinetti ebbe a cuore la formazione dei giovani e dei fanciulli e per quest‘ultimi istituí la Pia<br />
Unione del Cuore Immacolato del <strong>Maria</strong>, con la stretta finalità <strong>di</strong> pregare per la conversione dei peccatori;<br />
benché non ignorasse che una tale associazione fosse già stata fondata in Francia, volle tuttavia<br />
esplicitamente <strong>di</strong>rigere questa fondazione alla formazione e all‘educazione della gioventú» GHEDA,<br />
Giuseppe Frassinetti. Testimone e formatore <strong>di</strong> santità, Postulazione Generale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, Litografia Alfredo Trudu e <strong>Figli</strong> SNC, Cagliari 2004, 121.<br />
86
Allo stesso tempo, comunque, conosceva anche i danni che un prete ignorante e<br />
impreparato può causare nelle anime. «Una forte preoccupazione per il giovane clero lo<br />
spingeva ad impegnarsi per assicurare una solida formazione per questo... Molto peggiore era la<br />
situazione tra i seminaristi che avevano ricevuto gli Or<strong>di</strong>ni Minori e che avrebbero costituito la<br />
nuova generazione <strong>di</strong> preti. Molti <strong>di</strong> loro erano sparsi nella città e vivevano con famiglie<br />
sconosciute. I pochi che erano al seminario vivevano in uno stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssipazione morale; il resto<br />
viveva con le loro famiglie. Per queste ed altre ragioni, non erano in grado <strong>di</strong> capire cosa lo stato<br />
ecclesiastico significasse davvero» 331 . «Il clero in particolar modo sentí gli effetti dello spirito<br />
razionalista e delle teorie rivoluzionarie <strong>di</strong> quel secolo. Non c‘era unità tra <strong>di</strong> loro e, a causa<br />
della loro passione politica, <strong>di</strong>vennero litigiosi e in<strong>di</strong>fferenti ai loro doveri pastorali. La loro<br />
formazione culturale e spirituale era povera e la <strong>di</strong>sciplina nel seminario era notevolmente<br />
permissiva» 332 .<br />
Conoscendo la situazione del clero a Genova, Frassinetti nutriva nel suo cuore il<br />
desiderio <strong>di</strong> fare qualcosa per la giusta formazione <strong>di</strong> preti nella sua <strong>di</strong>ocesi 333 . «Il nostro<br />
Frassinetti aveva questa intenzione e aveva <strong>stu<strong>di</strong></strong>ato il progetto <strong>di</strong> un‘associazione per il giovane<br />
clero. Aveva tutto il progetto pronto in mente: un‘associazione per il giovane clero che avrebbe<br />
offerto loro la formazione e li avrebbe animati, coltivato uno scambio culturale, e che si sarebbe<br />
de<strong>di</strong>cata in modo speciale alla coltivazione dei giovani» 334 .<br />
La Divina Provvidenza lo bene<strong>di</strong>sse in questa sua iniziativa e gli mandò don Luigi<br />
Sturla che con<strong>di</strong>videva con lui la stessa intenzione. Cosí nacque l‘associazione del giovane clero<br />
– conosciuta come la Congregazione del Beato Leonardo da Porto Maurizio 335 . In seguito,<br />
venne fondata l‘Accademia <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> Ecclesiastici. Queste associazioni contribuirono<br />
ampliamente alla preparazione culturale, intellettuale e spirituale del giovane clero e, <strong>di</strong><br />
conseguenza, anche l‘immagine e la con<strong>di</strong>zione del clero <strong>di</strong> Genova cambiò. Aiutò ad assicurare<br />
la giusta guida dei fedeli attraverso la formazione <strong>di</strong> pastori buoni e preparati per i giovani<br />
cristiani.<br />
Non si può negare che tale sforzo fosse sempre accompagnato da esperienze tristi e<br />
impegnative, specialmente connesse ad alcune figure importanti tanto nell‘ambito ecclesiastico<br />
che in quello politico. Dio però era con loro e tutte le loro sofferenze furono coronate dalla<br />
gloria <strong>di</strong> preparare pastori, buoni, fedeli e santi non solo nella chiesa <strong>di</strong> Genova ma anche per la<br />
Chiesa universale.<br />
C. I giovani durante l'epoca <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti<br />
Il genere <strong>di</strong> giovani generazioni prodotte <strong>di</strong>pende dal tipo <strong>di</strong> società alla quale<br />
appartengono. Come abbiamo descritto precedentemente, il <strong>di</strong>ciannovesimo secolo offriva una<br />
nuova prospettiva per la società. C‘era una forte tendenza al laicismo e ad una sete accentuata <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>pendenza. Vi era anche una <strong>di</strong>ffusa situazione <strong>di</strong> degrado morale tra la gente. Era ovvio che<br />
331 A. DE ANGELIS, The Venerable Joseph Frassinetti, 16.<br />
332 A. DE ANGELIS, The prior Joseph Frassinetti and the spirituality of Genoa in the 19th century, 19.<br />
333 «Il primo problema fu quello della formazione spirituale e culturale del clero ed in modo particolare<br />
del clero giovane, per il quale aveva nutrito ansia <strong>di</strong> apostolato fin dall‘alba del suo sacerdozio. In verità<br />
era questo un punto capitale per la vita della chiesa e <strong>di</strong> quella genovese in specie» G. RENZI, Giuseppe<br />
Frassinetti e le sue opere ascetiche, 11; «Ne ciò deve farci meraviglia, se pensiamo quanto gli stesse a<br />
cuore fin dai primi giorni del suo sacerdozio il portare anche lui il suo modesto contributo alla formazione<br />
<strong>di</strong> un clero, quale lui l‘intendeva, secondo il cuore <strong>di</strong> Dio» C. OLIVARI, Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote<br />
Giuseppe Frassinetti, 36.<br />
334 Ibid.<br />
335 «The Congregation of Blessed Leonardo throve more and more, and in 1834 received the canonical<br />
approval. But, with the numbers on the increase, the fervor was on the decrease. For this reason<br />
Frassinetti, together with Sturla, formed a restricted committee with the intention and purpose of keeping<br />
alive the spirit of the association. Later on, they planned to establish an Academy for Ecclesiastical<br />
Stu<strong>di</strong>eS. They began with enthusiasm and the academy subsequently gathered the best young clergy, new<br />
priests and minor clericS. The most famous minds of the Genoese were invited to teach» A. DE ANGELIS,<br />
The Venerable Joseph Frassinetti, 23.<br />
87
le prime vittime <strong>di</strong> questa mentalità velenosa fossero precisamente i giovani; questa mentalità<br />
influenzava le loro opinioni culturali, politiche e religiose. Non è <strong>di</strong>fficile immaginare come il<br />
Frassinetti si batté con tutte le sue forze per salvarli. «Osservando la mappa dell‘Europa, quasi<br />
in ogni momento, il <strong>di</strong>ciannovesimo secolo presenta un‘immagine chiara ma complicata delle<br />
giovani generazioni, senza pace, ribelli...» 336 .<br />
A Genova, durante l‘epoca <strong>di</strong> Frassinetti, esisteva una generazione <strong>di</strong> giovani confusi 337 .<br />
La tendenza contemporanea al laicismo li affascinava e seduceva. Nonostante i valori morali<br />
che avevano ere<strong>di</strong>tato ed a cui erano stati avviati dalle famiglie e dalla Chiesa fossero forti,<br />
molti avevano paura <strong>di</strong> non essere considerati al passo con i tempi.<br />
1. Con<strong>di</strong>zioni culturali e morali<br />
Nell‘ambito culturale e morale, molti dei ragazzi e delle ragazze <strong>di</strong> quest‘epoca erano<br />
analfabeti. Alcuni si accontentavano dell‘istruzione elementare <strong>di</strong> base che ricevevano e non si<br />
preoccupavano <strong>di</strong> continuare 338 . Questa fu la ragione per quale Frassinetti usava parole semplici<br />
ed esempi concreti nello spiegare le proprie omelie e la dottrina cristiana. Questa caratteristica<br />
era anche palese nel tipo <strong>di</strong> linguaggio che usava in molti dei suoi scritti.<br />
Andare a scuola era un privilegio per pochi 339 . Era quin<strong>di</strong> logico che la maggior parte <strong>di</strong><br />
questi giovani passasse il proprio tempo per strada ed in altri luoghi pubblici, non facendo nulla<br />
e frequentando qualsiasi <strong>di</strong>vertimento capitasse loro <strong>di</strong> trovare. Frassinetti sperimentò tutte le<br />
strategie possibili per salvarli. Si concentrò su due tentazioni principali dei giovani: cattive<br />
compagnie e cattive letture.<br />
Riguardo alla malsana influenza delle cattive compagnie, abbiamo osservato come<br />
Frassinetti, allora parroco <strong>di</strong> Quinto, fu in grado <strong>di</strong> sra<strong>di</strong>care i fasti carnevaleschi che<br />
includevano danze sensuali. Fu in grado inoltre <strong>di</strong> eliminare la moda tra i giovani <strong>di</strong> andare nu<strong>di</strong><br />
al mare durante l‘estate. Per il problema delle cattive letture, scrisse molti opuscoli e libricini<br />
per risvegliare un certo interesse e per assicurare un orientamento sano che era necessario alla<br />
loro crescita.<br />
Un‘altra forma <strong>di</strong> intrattenimento <strong>di</strong> questa generazione <strong>di</strong> giovani era passare il tempo<br />
ad ascoltare i <strong>di</strong>scorsi e le argomentazioni filosofiche dei piú vecchi. Amavano ascoltare i loro<br />
<strong>di</strong>battiti e <strong>di</strong>scussioni. «Ma Frassinetti aveva intuito il grande male che ne derivava, e lo aveva<br />
avvertito come un fardello pesante. Le nuove idee <strong>di</strong> libertà, l‘indebolimento della fede nelle<br />
persone, avevano portato ad un flagello <strong>di</strong> pratiche malevole» 340 . La maggior parte delle volte<br />
queste argomentazioni contenevano tendenze razionalistiche e rivoluzionarie. Molti dei giovani<br />
336<br />
S. LUZZATO, Giovani e rivoluzionari. L‟età contemporanea, in Storia dei Giovani, a cura <strong>di</strong> G. LEVI –<br />
J. C. SCHMITT, E<strong>di</strong>tori La<strong>terza</strong>, Roma 1994, 232.<br />
337<br />
«Nell‘Ottocento la congiura era ormai chiara: <strong>di</strong>struggere alle ra<strong>di</strong>ci quanto sapeva <strong>di</strong> Cattolico. Anche<br />
per i figli <strong>di</strong> genitori ignari <strong>di</strong> crisi religiosa – ed è il caso del nostro servo <strong>di</strong> Dio – la religione aveva<br />
cessato <strong>di</strong> essere ciò che era stata per i loro padri: bene ere<strong>di</strong>tato da vivere nella tra<strong>di</strong>zione. L‘ansia<br />
religiosa si era ora fatta problema da risolvere, un problema personale, che esigeva ricerca, ripensamento<br />
e conquista. Sono loro, e tra i primi il Frassinetti, quei che fanno scoprire che si può vivere la pienezza<br />
della vita cristiana senza essere influenzato dall‘ambiente, e persino meglio <strong>di</strong> quei che ne furono<br />
custo<strong>di</strong>ti come fiori in serra» M. Falasca, Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, 151.<br />
338<br />
«Negli anni venti dell‘ottocento Genova si aggirava sugli ottantamila abitanti. Quasi tutti i ragazzi,<br />
dopo qualche anno <strong>di</strong> elementari, o erano imbarcati come mozzi o posti a bottega ad imparare un‘arte.<br />
Relativamente pochi, e da potersi contare, quelli che intraprendevano gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> umanistici per poi accedere<br />
all‘<strong>università</strong>. Chi non poteva permettersi il lusso <strong>di</strong> precettori privati, per lo piú sacerdoti, frequentava le<br />
scuole tenute da religiosi: gesuiti, somaschi e scolopi, o quelle del seminario, anche se non aspirava al<br />
sacerdozio. Questi giovani, ai quali non si può negare la presenza d‘una forte religiosità ed un anelito <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>vino, pur germogliati in uno stesso campo, si riveleranno parte grano buono e parte loglio» Ibid., p.97.<br />
339<br />
«Le scelte dell‘adolescenza sono strettamente legate alle prime lezioni <strong>di</strong> storia che si recepirono<br />
attorno al focolare» Ibid., 14.<br />
340<br />
C. OLIVARI, Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote Giuseppe Frassinetti, 95.<br />
88
erano facilmente persuasi da tali belle parole ed erano attirati dal tranello del nemico, poiché<br />
erano convinti che le tendenze filosofiche li avrebbero condotti alla verità 341 .<br />
Il Giansenismo 342 era una delle tendenze religiose che avevano causato gravi danni<br />
morali. La rigidezza, che lo caratterizzava fece sentire la religione non un fatto <strong>di</strong> amore ma una<br />
religione <strong>di</strong> punizione e terrore. Trasformava il Dio della pietà e dell‘amore da Abba o padre a<br />
giu<strong>di</strong>ce severo 343 . Altra causa del degrado morale tra i giovani fu il bisogno esagerato <strong>di</strong> piaceri<br />
mondani. «I giovani <strong>di</strong> quel secolo sembravano amanti ciechi <strong>di</strong> questo mondo: queste figlie e<br />
questi figli devono <strong>di</strong>ventare amanti <strong>di</strong> Dio» 344 . Il Frassinetti aveva anche combattuto le<br />
conseguenze morali <strong>di</strong> ogni forma <strong>di</strong> moda, specialmente nel modo <strong>di</strong> vestirsi. «Poveri giovani!<br />
Vanno a passeggio, conversando con i loro amici, e oh, come lottano con la loro innocenza<br />
contro questa prova per tale nuova moda! Ci sono quelli che sono molto deboli e, anche se non<br />
indulgono in alcun vizio, provano tentazioni cosí forti, stimolate dalla passione <strong>di</strong> avere sempre<br />
davanti agli occhi oggetti <strong>di</strong> seduzione, anche dentro la chiesa, e quante battaglie devono<br />
sostenere!» 345 . Frassinetti non si stancò mai <strong>di</strong> combattere e spiegare i mali <strong>di</strong> questo<br />
atteggiamento sociale.<br />
2. Con<strong>di</strong>zioni politiche e religiose<br />
Sotto l‘aspetto politico e religioso, si riscontra la stessa posizione. «Si può osservare la<br />
mancanza <strong>di</strong> interesse per quel che riguarda la religione, il <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne e la negligenza dei principi<br />
ecclesiastici nelle famiglie, le letture maliziose e altri mali nella popolazione cristiana» 346 .<br />
Questa posizione ambigua verso la fede indusse molti giovani ad abbracciare i principi del<br />
laicismo. Divennero seguaci <strong>di</strong> quei personaggi che, in un modo o nell‘altro, erano iniziatori <strong>di</strong><br />
tali dottrine politiche. La maggior parte <strong>di</strong> queste figure politiche accusavano la Chiesa <strong>di</strong> essere<br />
la causa principale della sofferenza della gente.<br />
Dobbiamo citare due protagonisti che accompagnarono costantemente la vita apostolica<br />
<strong>di</strong> Frassinetti: Mazzini e Gioberti. Essi consideravano la religione come il principale intralcio al<br />
progresso e uno <strong>degli</strong> ostacoli da eliminare in modo da perseguire la desiderata libertà per il<br />
bene della nazione 347 . I giovani furono schierati in prima linea in questa battaglia contro la<br />
341 «Ciò che faceva <strong>di</strong>fferenza non era la scuola o il metodo d‘insegnamento, l‘uno non <strong>di</strong>fferendo gran<br />
che dall‘altro, ma la famiglia e, forse ancor piú, il professore che era riuscito a guadagnarsi la loro fiducia.<br />
Altra cosa prendere dalla parola <strong>di</strong> un Granelli, altra cosa dalla parola <strong>di</strong> un De Gregari, prete giansenista<br />
e liberale; altra cosa lasciare i banchi con l‘impressione che la religione dell‘infanzia era inconciliabile<br />
con la religione della libertà e del progresso» M. FALASCA, Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, 98.<br />
342 «Jansenism originated with the bishop of Ypres, Cornelius Jansen, a professor at Louvain University.<br />
He appealed to the authority of St. Augustine in expoun<strong>di</strong>ng theories on the nature of the original sin,<br />
human freedom, and the nature and efficacy of God‘s grace. At the root of his system was a belief in the<br />
ra<strong>di</strong>cal corruption of human nature» T. BOKENKOTTER, A concise history of the catholic Church, Image<br />
Books Doubleday, U.S.A. 1990, 239;«The moral teachings of giansenism is very rigid and severe. It<br />
refused all forms of lax morality» G. BEDOUELLE, Giansenismo, in Dizionario <strong>di</strong> storia della Chiesa,<br />
E<strong>di</strong>zioni Stu<strong>di</strong>o Domenicano, Bologna 1997, 106-108.<br />
343 «Per non pochi <strong>di</strong> quei giovani il primo incontro con Cristo s‘era riassunto in minacce d‘inferno. Un<br />
Dio terribilmente giusto e rigido esattore che non condona uno spicciolo, che non ammette nel suo regno<br />
se non chi abbia gareggiato con gli angeli in purità <strong>di</strong> cuore, e, per un privilegiato che si salva, mille sono<br />
precipitati senza pietà nel fuoco eterno. Si aggiungano le confessioni tortura, le assoluzioni negate,<br />
l‘eucaristia rimorso d‘averla profanata ricevendola le rare volte non abbastanza degnamente… Cosí, in<br />
nome d‘una religione pura, il giansenismo alienava gli animi da Dio e per tanti <strong>di</strong>venne anticamera <strong>di</strong><br />
miscredenza» M. FALASCA, Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, 98.<br />
344 Sull‟impiego del denaro, O.A., II, 298.<br />
345 Due parole alle gentile signore, O.A., I, 666.<br />
346 C. Olivari, Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote Giuseppe Frassinetti, 51.<br />
347 «Bastava porre in <strong>di</strong>menticanza l‘essenza della religione. A questa missione si preparava un<br />
seminarista torinese, Vincenzo Gioberti. C‘era poi da ridare spirito e lena ai tanti <strong>di</strong> fede cristiana rimasti<br />
sbandati, anche se colti a volte da un vago senso religioso. Grave errore aver creduto poterlo estirpare dal<br />
cuore dell‘uomo. Andava invece or<strong>di</strong>nato a colmare il vuoto prodotto dall‘apostasia, convertendolo in<br />
forme <strong>di</strong> vaga religiosità quali il culto della Patria, dell‘Umanità, del Progresso, del Dovere fino a se<br />
89
eligione e la Chiesa. Il Frassinetti fu anche vittima dello stesso destino. Soffrí il dolore <strong>di</strong> tale<br />
tremenda strumentalizzazione in tenera età 348 e questo lo accompagnò durante tutta la sua<br />
gioventú.<br />
Vi erano due gruppi a cui gli adolescenti e i giovani potevano associarsi: il primo era<br />
pro-religione e il secondo era contro la religione. I due <strong>di</strong>versi gruppi erano rappresentati da due<br />
<strong>di</strong>versi capi: Mazzini con i suoi compagni della Giovine Italia e Frassinetti e la fazione con i<br />
suoi compagni chiamati i ragazzi del Gianelli 349 . «Alcuni giovani trovarono in Mazzini un<br />
linguaggio simile al linguaggio <strong>di</strong> fede. Nelle loro scritture, facevano riferimento a Dio e alla<br />
religione, ma quando <strong>di</strong>cevano Dio, si riferivano a Nazione, Progresso, Umanità, Ragione,<br />
Filosofia, Scienza, Libertà, e altro ancora. Era a volte un insieme <strong>di</strong> tutto, ma non del vero Dio,<br />
e ancor meno del Dio celebrato dai preti Cattolici nella Chiesa: era un Dio che stava per essere<br />
cancellato dalla memoria <strong>di</strong> tutti» 350 .<br />
Questa battaglia accompagnò Frassinetti durante tutta la sua vita <strong>di</strong> prete. Lui e Mazzini<br />
aspiravano entrambi ad un cambiamento ed al progresso per la gente, ma mentre Frassinetti<br />
preferiva lavorare sotto la guida della Divina Provvidenza, Mazzini preferiva affidarsi solo alla<br />
forza delle risorse umane. Era una scelta che causò la violenza organizzata.<br />
Un‘altra figura politica che in questo periodo influenzò grandemente la generazione <strong>di</strong><br />
giovani fu Vincenzo Gioberti. Questi era stato membro della Giovane Italia <strong>di</strong> Mazzini, si era<br />
separato dal gruppo e ne aveva formato uno nuovo. Avevano lo stesso obbiettivo, quello <strong>di</strong> far<br />
crollare la religione e la Chiesa. Gioberti preferiva i mezzi <strong>di</strong>plomatici, fingeva <strong>di</strong> essere amico<br />
e sostenitore tanto della nazione quanto della Chiesa. Fu in grado conquistare la loro fiducia e,<br />
poco a poco, procedere verso il suo interesse principale. 351 La Divina Provvidenza comunque<br />
accompagnava e si prendeva cura della sua Chiesa. In questa situazione, il Frassinetti fu uno<br />
<strong>degli</strong> strumenti usati per rivelare alle persone le intenzioni malvagie <strong>di</strong> Gioberti. Egli scrisse con<br />
tempismo un saggio in modo da richiamare l‘attenzione della popolazione. L‘operetta era<br />
intitolata Il Saggio sulla <strong>di</strong>alettica e religione <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti. Nonostante fosse un‘opera<br />
che causò l‘esilio <strong>di</strong> Frassinetti, riuscí a salvare molti cristiani dal cadere definitivamente nei<br />
lacci tesi dal Gioberti. Questa fu la principale ragione per la quale il Frassinetti si batté<br />
infaticabilmente per illuminare ragazzi e ragazze circa il significato e l‘importanza della<br />
stesso… Nessuna verità rivelata e definita, nessun precetto, nessun rito, nessun sacerdozio. A questo<br />
seconda missione pensa un adolescente genovese, Giuseppe Mazzini, ma non in <strong>di</strong>saccordo con Gioberti.<br />
Avrebbero marciato separati e colpito uniti, come parve avverarsi negli anni 1848 e 1849. Ma a Torino<br />
c‘erano don Lanteri, don Guala con i giovani del Convitto Ecclesiastico; a Genova un professore <strong>di</strong><br />
retorica, Antonio <strong>Maria</strong> Gianelli, ed i ragazzi del Gianelli; uno il Frassinetti» Ibid., 24.<br />
348 «Gli occhi <strong>di</strong> chi aveva narrato a lui bambino quei tempi cosí cattivi erano pieni <strong>di</strong> visioni <strong>di</strong> sangue ed<br />
esprimevano l‘orrore per le <strong>di</strong>ssacrazioni delle cose piú sante: chiese mutate in stalle, le campane<br />
ammutolite o condannate a sonare per celebrare i fasti della Rivoluzione, quando non erano abbattute per<br />
farne cannoni. Frati e monache cacciati <strong>di</strong> convento» Ibid..<br />
349 «… il gruppo Mazzini nella Giovine Italia, <strong>di</strong> cui era fondatore ed anima lo stesso Mazzini, luglio<br />
1831; i Ragazzi del Gianelli nella Congregazione del Beato Leonardo da Porto Maurizio, <strong>di</strong> cui era<br />
fondatore – confondatore stando alla sua relazione in cui pone se stesso in ombra per far rifulgere<br />
l‘operato dell‘amico Sturla – ed anima il Frassinetti… Programma antitetico, ma uguale la persuasione:<br />
bisognava fare tentando vie nuove per riuscire dove altri avevano fallito o per neghittosità o per<br />
<strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> energie o per assenza d‘un chiaro programma e d‘inventiva. L‘uno e l‘altro puntano sui<br />
giovani: studenti e professionisti il Mazzini; teologi e giovani sacerdoti il Frassinetti. Uguale il<br />
destinatario ultimo, il popolo, ma, mentre per il Mazzini, prigioniero del suo ceto borghese e vissuto<br />
sempre all‘estero, ―popolo‖ è parola vuota, per il Frassinetti, figlio del popolo, ―popolo‖ è la gente umile<br />
del suo stesso ceto con cui ogni giorno si rimescola in chiesa e fuori chiesa. L‘uno e l‘altro faranno della<br />
penna, della stampa le loro armi, precedendo in questo il Mazzini al Frassinetti. Uguale la parola<br />
d‘or<strong>di</strong>ne: l‘unione è forza, convincimento che resterà consacrato nel nostro inno nazionale» Ibid., 102-<br />
103.<br />
350 Ibid., 100.<br />
351 «… scriveva che egli voleva fare un passo alla volta, e che non voleva spaventare nessuno, e che<br />
quelle lo<strong>di</strong> bisognava sciorinarle per ottenere il passaporto. Gioberti aveva ottenuto cosí che una forte<br />
corrente <strong>di</strong> entusiasmo pervadesse e riscotesse in pro dell‘Italia ogni cuore italiano: gli bastava questo; al<br />
resto avrebbe pensato poi» C. OLIVARI, Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote Giuseppe Frassinetti, 101.<br />
90
eligione, in modo da salvarli e portarli via da ogni tipo <strong>di</strong> cattiva influenza che avrebbe<br />
rovinato le loro giovani vite.<br />
D. La Spiritualità del sacerdote Giuseppe Frassinetti<br />
La cura instancabile del sacerdote Giuseppe Frassinetti per i giovani non fu frutto <strong>di</strong> una<br />
intuizione spontanea. Era saggiamente e prudentemente <strong>stu<strong>di</strong></strong>ata. Non era solo un metodo<br />
pedagogico, ma l‘applicazione <strong>di</strong> un certo progetto <strong>di</strong> vita, ossia <strong>di</strong> spiritualità. Non è facile<br />
elaborare la spiritualità <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti nel suo intero, e non è il punto principale <strong>di</strong><br />
questo lavoro. Cercheremo <strong>di</strong> proporre una breve panoramica <strong>di</strong> essa seguendo fedelmente<br />
l‘esposizione <strong>di</strong> P. Giordano Renzi 352 .<br />
«Dio vuole che chiunque, in qualsiasi stato si trovi, <strong>di</strong>venga santo» 353 . Santità – questo è<br />
il cuore della spiritualità <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti. Credeva che questa è la vocazione universale<br />
<strong>di</strong> ogni cristiano battezzato, dal momento che appartenie allo stesso Padre che è in Cielo che è<br />
santo. La missione <strong>di</strong> ogni prete non è altra che scuotere i figli <strong>di</strong> Dio e in<strong>di</strong>rizzarli a questa<br />
chiamata, guidandoli sulla via verso la santità. Lo zelo pastorale <strong>di</strong> Frassinetti e i suoi scritti<br />
erano in<strong>di</strong>rizzati a questo preciso fine. Era convinto che il momento migliore e piú appropriato<br />
<strong>di</strong> accompagnare i figli <strong>di</strong> Dio verso il loro Padre in cielo fosse durante la loro giovane ed<br />
innocente età.<br />
Giuseppe Frassinetti aveva sempre pre<strong>di</strong>cato che la santità era facile, semplice e<br />
possibile per tutti. Per <strong>di</strong>mostrare questa affermazione, elaborò con cura dei mezzi in modo da<br />
proporre e facilitare tale cammino verso la perfezione. Il primo passo importante è il desiderio<br />
della santità; senza questo, niente potrebbe accadere. Il secondo è la purificazione dell‟ anima.<br />
Insisteva che per incontrare Dio fosse necessario essere liberi da ogni peccato e da tutto ciò che<br />
non appartiene a Dio. Il cuore dell‘uomo deve essere libero affinché Dio possa entrare. Offrirsi<br />
a Dio è il passo successivo. Questo passo prepara l‘anima ad essere completamente <strong>di</strong> Dio. Il<br />
quarto passo importante è la <strong>di</strong>rezione spirituale, l‘argomento <strong>di</strong> questo lavoro. Concentreremo<br />
la nostra attenzione su questo strumento importante nel prossimo capitolo. La preghiera è il<br />
passo successivo. Seguono la comunione frequente e giornaliera. Il settimo passo è la devozione<br />
alla Beata Vergine. Questo è seguito dalla considerazione che il modello e il formatore della<br />
santità è Cristo. Infine, verginità e celibato sono considerati un‘altra guida importante verso la<br />
santità.<br />
Anche se la Direzione Spirituale è il quarto punto della lista, potrebbe essere<br />
considerato il primo nella pratica <strong>di</strong> accompagnamento spirituale, specialmente quando riguarda<br />
ragazzi e ragazze, poiché questi non sanno nulla della vita spirituale. È responsabilità del<br />
<strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> introdurre le giovani anime a questo progetto per la santità, ed è proprio ciò che<br />
Giuseppe Frassinetti cercò <strong>di</strong> realizzare fino al suo ultimo attimo <strong>di</strong> vita.<br />
352 Padre Giordano Renzi ha curato la raccolta delle Opere Ascetiche del venerabile Giuseppe Frassinetti<br />
in due volumi. Egli ha de<strong>di</strong>cato la sua vita nello <strong>stu<strong>di</strong></strong>o delle opere del Frassinetti per far conoscere la<br />
santità e il suo contributo per il bene della chiesa universale.<br />
353 Il Conforto dell‟anima <strong>di</strong>vota, O.A., I, 625-626.<br />
91
CAPITOLO SECONDO<br />
LA DIREZIONE SPIRITUALE IN GIUSEPPE FRASSINETTI<br />
A. Significato ed importanza della <strong>di</strong>rezione spirituale<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale, nel senso piú ampio del termine, è un‘attività che ogni uomo<br />
compie abitualmente nei momenti <strong>di</strong>fficili della vita: infatti, in tali situazioni gli uomini hanno<br />
da sempre fatto ricorso ad in<strong>di</strong>vidui ritenuti saggi e competenti, chiedendo loro illuminazione e<br />
consigli 354 . La <strong>di</strong>rezione spirituale è dunque insita nella natura dell‘uomo ed, interpretando<br />
l‘aggettivo ―spirituale‖ alla luce della fede cristiana, essa si inserisce nel piano <strong>di</strong>vino della<br />
salvezza in<strong>di</strong>viduale.<br />
Nella storia della salvezza Dio è sempre stato vicino agli uomini ed ha fornito loro <strong>degli</strong><br />
―strumenti umani‖ che Lo rappresentassero 355 . Tali strumenti si trovano sia nel Vecchio che nel<br />
Nuovo Testamento e sono la <strong>di</strong>mostrazione che Dio si prende cura del suo popolo.<br />
Tuttavia nel piano <strong>di</strong>vino c‘è un solo protagonista: lo Spirito Santo 356 . È Lui il primo<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale <strong>di</strong> ogni cristiano. «La <strong>di</strong>rezione spirituale non è questione dell‘autorità <strong>di</strong> una<br />
persona su un‘altra (il <strong>di</strong>rettore e il credente), ma piuttosto la <strong>di</strong>sposizione con cui entrambi si<br />
pongono attentamente all‘ascolto dello Spirito Santo che parla ad ogni uomo o donna<br />
in<strong>di</strong>pendentemente che loro ne siano consapevoli o meno» 357 .<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale è stata praticata dai padri nella fede fin nelle prime comunità<br />
cristiane ed è stata trasmessa attraverso le generazioni fino ad oggi 358 . Sebbene nel corso del<br />
tempo sia stata soggetta a molte crisi, rimane una pratica importantissima nella vita <strong>di</strong> ogni<br />
cristiano.<br />
Nel trattare la materia seguiremo l‘interpretazione <strong>di</strong> P. Benito Goya, visto che essa è<br />
strettamente connessa alla dottrina del Frassinetti sulla <strong>di</strong>rezione spirituale stessa. Secondo P.<br />
Benito Goya essa consiste nella scienza e nell‘arte <strong>di</strong> portare le anime alla perfezione in modo<br />
conforme alla propria vocazione personale 359 . P. Giuseppe Frassinetti ha descritto il ruolo del<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale usando la metafora <strong>di</strong> una nave e del suo capitano. Per garantire un viaggio<br />
sicuro ai naviganti, il capitano deve essere sia un esperto conoscitore del mare che un artista.<br />
354<br />
E. ANCILLI, Direzione spirituale, in A.A.V.V., Dizionario <strong>di</strong> spiritualità dei laici, E<strong>di</strong>zioni O. R.,<br />
Milano 1981, 233; «L‘accompagnamento vicendevole appare, fin dagli inizi, come un bisogno che si<br />
ra<strong>di</strong>ca nella stessa natura sociale della persona. Questa, da sempre, ha fatto ricorso a maestri ritenuti saggi<br />
e competenti, cercando in loro luce e consiglio, specialmente nelle situazioni problematiche della sua<br />
esistenza» B. GOYA, Luce e guida nel cammino. Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione, EDB, Bologna 2004, 15.<br />
355<br />
«Christianity developed from the relationship of a community of <strong>di</strong>sciples with their itinerant rabbiteacher<br />
Jesus who preached both in<strong>di</strong>vidual and communal spiritual <strong>di</strong>rection together with his preaching<br />
and healing ministries» J. K. RUFFING, Spiritual <strong>di</strong>rection, in A.A. V.V., The new SCM Dictionary of<br />
christian spirituality, SCM Press, London 2005, 243.<br />
356<br />
«La guida principale resta lo Spirito Santo: il <strong>di</strong>rettore accompagna le anime per aiutarle a conoscere<br />
se stesse e il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> Dio su <strong>di</strong> loro, senza imporre il suo modo <strong>di</strong> agire o <strong>di</strong> vedere le cose per<br />
spronarle a camminare con libertà ed equilibrato impegno, per sostenerle e incoraggiarle soprattutto nei<br />
perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> prova» U. OCCHIALINI, Direzione spirituale, in A.A. V.V., Dizionario <strong>di</strong> mistica, Libreria<br />
E<strong>di</strong>trice Vaticana, Città del Vaticano 1998, 423.<br />
357<br />
C. GRATTON, Spiritual <strong>di</strong>rection, in A.A. V.V., The new Dictionary of catholic spirituality, The<br />
Liturgical Press, Minnesota 1993, 913.<br />
358<br />
«Oggi si afferma che la <strong>di</strong>rezione spirituale è esistita sempre: fin dalle origine del cristianesimo erano<br />
presenti i padri spirituali. Essa è stata e rimane un fatto costante nella storia della Chiesa e deriva, prima<br />
<strong>di</strong> tutto, dalla concezione sociale della vita cristiana, la quale non isola l‘in<strong>di</strong>viduo ma lo riferisce e lo<br />
lega al destino <strong>degli</strong> altri» B. GOYA, Luce e guida nel cammino. Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione, 15.<br />
359<br />
Ibid., 33.<br />
92
Allo stesso modo il <strong>di</strong>rettore spirituale ha la missione <strong>di</strong> guidare le anime verso la chiamata<br />
universale alla santità.<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale è una scienza in quanto deve fondarsi su una solida dottrina 360 : le<br />
riflessioni stesse <strong>di</strong> Frassinetti sono state il frutto <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> sulle Sacre Scritture, i Padri della<br />
Chiesa, il Magistero e gli insegnamenti <strong>di</strong> alcuni teologi e santi come S. Tommaso d‘Aquino, S.<br />
Alfonso <strong>Maria</strong> de‘ Liguori, S. Teresa d‘Avila, S. Giovanni della Croce, S. Francesco <strong>di</strong> Sales e<br />
San Filippo Neri.<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale è un‘arte in quanto richiede al <strong>di</strong>rettore spirituale l‘abilità <strong>di</strong><br />
compiere pienamente il suo ministero. Egli <strong>di</strong>venta me<strong>di</strong>atore tra lo Spirito Santo e la persona<br />
che deve essere guidata. Il <strong>di</strong>rettore deve essere creativo e sensibile ai segni che sia lo Spirito<br />
che il credente inviano per il bene del credente stesso e deve capire quando è giunto il momento<br />
<strong>di</strong> ―allontanarsi dalla scena‖ per lasciare che il credente proceda liberamente.<br />
Non c‘è alcun dubbio che Frassinetti abbia eccelso in quest‘arte che è stata il frutto del<br />
suo instancabile zelo pastorale come confessore e pastore, come è comprovato da molti dei suoi<br />
figli e figlie spirituali che sono poi stati proclamati uomini e donne santi per la Chiesa Cattolica.<br />
B. Finalità della Direzione Spirituale<br />
Il fine ultimo della <strong>di</strong>rezione spirituale è la santità. Essa ha l‘obiettivo <strong>di</strong> condurre il<br />
credente alla consapevolezza profonda della propria identità come figlio <strong>di</strong> Dio, chiamato a<br />
vivere in comunione con Lui 361 . «Lo scopo fondamentale dell‘accompagnamento spirituale è <strong>di</strong><br />
aiutare le persone ad avere un rapporto personale con Dio» 362 .<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale è necessaria ma non in<strong>di</strong>spensabile in assoluto 363 . La santità è<br />
sempre un dono e Dio, come sorgente della santità, è libero <strong>di</strong> donarla a coloro che Egli ritiene<br />
meritevoli. Nella storia della salvezza ci sono state persone che sono <strong>di</strong>venute sante senza<br />
l‘aiuto della <strong>di</strong>rezione spirituale. Tuttavia, Giuseppe Frassinetti ha insistito che, poiché tale<br />
privilegio non è per tutti, è saggio accogliere l‘aiuto del <strong>di</strong>rettore spirituale per assicurarsi un<br />
cammino spirituale sereno nel corso della vita. «Per l‘esercizio della santa umiltà la Divina<br />
Provvidenza ha voluto che nessuno governi se stesso autonomamente, ma piuttosto, che ognuno<br />
abbia bisogno <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rettore spirituale che lo gui<strong>di</strong> verso lo Spirito Santo, a cominciare<br />
dall‘ultimo dei credenti fino al Papa. Tutti devono avere un <strong>di</strong>rettore spirituale e devono<br />
consultarlo per le questioni dell‘anima e obbe<strong>di</strong>rgli» 364 . La figura del <strong>di</strong>rettore spirituale svolge,<br />
dunque, un ruolo molto importante nel cammino dei credenti verso la santità.<br />
C. Il rapporto nella <strong>di</strong>rezione spirituale<br />
Il cuore <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>rezione spirituale è il rapporto fra i due protagonisti principali: lo<br />
Spirito Santo, il vero <strong>di</strong>rettore spirituale, e il credente che deve essere guidato. Il <strong>di</strong>rettore<br />
360 «Innanzitutto è una scienza, fondata su principi teorici, dottrinali, teologici e psicologici, relativi alla<br />
natura della perfezione e ai con<strong>di</strong>zionamenti in<strong>di</strong>viduali. In quanto scienza, è strettamente imparentata<br />
con la teologia pastorale e con la teologia spirituale, <strong>di</strong> cui può essere considerata parte integrante, e<br />
anche con le scienze umane come la pedagogia e la psicologia che illuminano questo itinerario<br />
inter<strong>di</strong>sciplinare» Ibid.<br />
361 «Il fine ultimo della <strong>di</strong>rezione spirituale, la meta finale che vuole raggiungere, è la conquista piena<br />
dell‘unione con Dio, sorgente <strong>di</strong> ogni santità. Essa vuole condurre il credente alla pienezza del suo<br />
battesimo e quin<strong>di</strong> alla maturazione integrale della grazia battesimale e dell‘esperienza trinitaria, in<br />
armonia con la vocazione personale» Ibid.<br />
362 J. K. RUFFING, Spiritual <strong>di</strong>rection: beyond the beginnings, Paulist Press, Mah Wah NJ 2000, 5.<br />
363 «È solo una necessità relativa, non assoluta quella della <strong>di</strong>rezione spirituale del sacerdote perché<br />
l‘unico <strong>di</strong>rettore delle anime è sempre e solo lo Spirito Santo. Ma è una vera necessità morale perché,<br />
normalmente senza il suo aiuto né incipienti imboccano con facilità la strada della perfezione, né i<br />
proficienti <strong>di</strong> per sé verranno con costanza <strong>di</strong>fesi dalle illusioni, né i perfetti conservano la necessaria<br />
umiltà» A. SAPA, Direzione spirituale a <strong>di</strong>stanza: criteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale per tutte le categorie <strong>di</strong><br />
persone d‟ogni età, E<strong>di</strong>trice La Tipografia, San Curi 1996, 41.<br />
364 Il Religioso al secolo, O.A., II, 132.<br />
93
spirituale è me<strong>di</strong>atore fra i due protagonisti. Tale ruolo non è certamente facile. Non solo egli<br />
deve essere un esperto sulla natura della <strong>di</strong>rezione spirituale, ma anche un profondo conoscitore<br />
delle ―cose <strong>di</strong> Dio‖. Il successo della <strong>di</strong>rezione spirituale sta nell‘armonia fra i tre elementi <strong>di</strong><br />
questo delicato processo: lo Spirito Santo, il credente e lo strumento umano, il ―<strong>di</strong>rettore<br />
spirituale‖.<br />
1. Lo Spirito Santo: il <strong>di</strong>rettore spirituale <strong>di</strong> ogni cristiano<br />
La <strong>terza</strong> persona della santissima Trinità realizza il progetto d‘amore <strong>di</strong> Dio per<br />
l‘umanità. «Lo Spirito Santo è al lavoro insieme al Padre e al <strong>Figli</strong>o fin dall‘inizio dei tempi per<br />
portare a compimento il piano della salvezza dell‘uomo» 365 . Dio vuole dare all‘uomo la sua vera<br />
identità e la ragione della sua esistenza, e ha affidato allo Spirito Santo questo compito 366 . Egli è<br />
dono <strong>di</strong> Dio, anzi è Dio stesso che offre all‘uomo ancora una volta la possibilità <strong>di</strong> guadagnare<br />
la vita eterna. L‘uomo deve solo rispondere a questo invito con l‘impegno <strong>di</strong> collaborare e farsi<br />
guidare dallo Spirito Santo. Ma occorre prima <strong>di</strong> tutto riceverlo nella propria vita, e lo riceviamo<br />
e veniamo nutriti dalla sua presenza nei sacramenti 367 e ogni volta che lo invochiamo sia<br />
personalmente come anche nelle celebrazioni liturgiche 368 . Egli guida ogni battezzato a scoprire<br />
la <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> essere figli <strong>di</strong> Dio. Ed accompagna ognuno nel cammino verso la santità.<br />
L‘immagine e il ruolo dello Spirito Santo nella <strong>di</strong>rezione spirituale sono molto chiari.<br />
Lui è il primo vero <strong>di</strong>rettore spirituale che illumina allo stesso tempo sia ―lo strumento umano‖,<br />
il <strong>di</strong>rettore spirituale che il ―credente guidato‖ 369 . In ogni caso, è importante sottolineare che i tre<br />
elementi della <strong>di</strong>rezione spirituale collaborano vicendevolmente l‘uno con l‘altro.<br />
Giuseppe Frassinetti ha fortemente riconosciuto questo importante ruolo dello Spirito<br />
Santo come fonte delle grazie <strong>di</strong> Dio necessarie per tendere alla santità. Egli ha de<strong>di</strong>cato molti<br />
dei suoi scritti nella elaborazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni sul comportamento richiesto sia al <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale che al credente in modo che entrambi facilitino il lavoro dello Spirito in loro. Ad<br />
esempio, egli invitava i suoi figli e figlie spirituali ad invocare lo Spirito prima <strong>di</strong> scegliere il<br />
proprio <strong>di</strong>rettore spirituale: «In primo luogo affida a Dio questa scelta e stai certo che Lui si<br />
prenderà cura <strong>di</strong> tutto ciò <strong>di</strong> cui tu non sei capace. Sarebbe saggio se facessi una novena allo<br />
365 CCC, n. 686, p.197.<br />
366 «Ma l‘aspetto particolare, che spicca <strong>di</strong> piú nella vita cristiana, nella <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> comunione, è quello<br />
esperienziale dell‘immanenza, della presenza dello Spirito, come forza che unifica tutte le potenze<br />
dell‘uomo e le orienta verso una attività <strong>di</strong> conoscenza e <strong>di</strong> amore che è dono <strong>di</strong> Dio, fatto all‘uomo<br />
concreto. Perciò l‘attività dello Spirito Santo è finalizzata a un‘attuazione dell‘uomo che lavora, che<br />
gioisce, che soffre, nel quadro <strong>di</strong> una concentrazione cosciente <strong>di</strong> tutte le proprie forze verso Dio e verso<br />
Cristo» C. LAUDAZI, Azione dello Spirito nella crescita del cristiano, in A.A V.V., Lo Spirito Santo nella<br />
vita spirituale, E<strong>di</strong>zioni del Teresianum, Roma 1981, 180.<br />
367 «I sacramenti sono gli spazi privilegiati in cui si opera il <strong>di</strong>spiegamento del dono dello Spirito in ogni<br />
credente… I sacramenti non solo sono un‘opera dello Spirito Santo, ma sono una pentecoste permanente.<br />
Lo Spirito Santo non ha esaurito i suoi interventi nel mondo con la Pentecoste; al contrario, le meraviglie<br />
sacramentali della salvezza sono avvenimenti che ci fanno partecipare alla vita dello stesso Spirito e ai<br />
doni salvifici che Egli apporta» C. ROCCHETTA, Lo Spirito e le meraviglie <strong>di</strong> Dio, in A.A. V.V., Lo Spirito<br />
Santo nella vita spirituale, 96.<br />
368 «La celebrazione si aprirà logicamente verso la vita per una continuità con gli impegni assunti, per una<br />
logica espansione della grazia ricevuta, e cioè delle presenze e dell‘azione dello Spirito nel mondo<br />
attraverso i cristiani <strong>di</strong>ventati pneumatori, portatori dello Spirito nel mondo» J. CASTELLANO, Presenza<br />
ed azione dello Spirito Santo nella Liturgia, in A.A. V.V., Lo Spirito Santo nella vita spirituale, 141.<br />
369 «Lo Spirito, tuttavia, si <strong>di</strong>mostra profondamente rispettoso della libertà dell‘in<strong>di</strong>viduo. Lunghi dal<br />
forzarlo a camminare per i suoi sentieri, lo Spirito si limita a presentare alternative o scelte. Aspetta, poi,<br />
che ciascuno scelga <strong>di</strong> rispondere liberamente alle opportunità e alle grazie che gli sta offrendo. Nello<br />
stesso, tempo lo Spirito conta in modo assoluto sul lavoro insostituibile dell‘accompagnatore spirituale. In<br />
un certo senso subor<strong>di</strong>na le sue aspirazioni e le sue proposte all‘intervento <strong>di</strong> questi: lo assume quasi<br />
come suo ambasciatore plenipotenzario. Vuole che lui, l‘accompagnatore, gli presti la sua presenza fisica,<br />
la sua voce, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, il suo comportamento e, soprattutto, la sua sensibilità<br />
spirituale» L. GONZÁLEZ, Guidati dallo Spirito. Accompagnamento spirituale <strong>di</strong> stile integrativo, Libreria<br />
E<strong>di</strong>trice Vaticana, Città del Vaticano 1998, 10-11.<br />
94
Spirito Santo e chiedessi l‘intercessione della Vergine <strong>Maria</strong> (…). Vedrai che in questo modo<br />
non sbaglierai» 370 .<br />
2. Il <strong>di</strong>rettore spirituale come ambasciatore dello Spirito Santo<br />
Visto che il protagonista della <strong>di</strong>rezione spirituale è lo Spirito Santo, il <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale può essere considerato l‘ambasciatore dello Spirito 371 , Giuseppe Frassinetti ha<br />
de<strong>di</strong>cato un importante contributo alla figura della guida spirituale, perché la scelta dello<br />
―strumento giusto‖ è estremamente importante per la tensione verso la perfezione cristiana 372 .<br />
«È utile che ogni credente che vuole <strong>di</strong>ventare santo abbia un <strong>di</strong>rettore spirituale. In caso non<br />
l‘abbia, è bene che preghi Dio affinché lo aiuti a trovare una guida sicura per la propria anima<br />
(…) e che continui a pregare affinché Dio li illumini entrambi in questo ministero» 373 .<br />
a. Qualità <strong>di</strong> un buon <strong>di</strong>rettore spirituale<br />
«Il <strong>di</strong>rettore spirituale è il capitano della nave dell‘anima <strong>di</strong> ogni credente che naviga<br />
nell‘oceano tempestoso del secolo corrente fino al raggiungimento del porto della vita eterna. È<br />
evidente che la nave deve essere in con<strong>di</strong>zione eccellente ed equipaggiata <strong>di</strong> tutto il necessario,<br />
ma se il capitano non è ben preparato e prudente nella sua arte la nave rischierà <strong>di</strong><br />
naufragare» 374 . Questa metafora esprime l‘identità e il ruolo del <strong>di</strong>rettore spirituale che deve<br />
essere sia un artista che un esperto nella guida delle anime.<br />
Questa breve descrizione esprime tre importanti requisiti che debbono avere coloro che<br />
sono chiamati a tale ministero: devono essere sufficientemente preparati, avere zelo e prudenza.<br />
Esaminiamoli brevemente.<br />
Un buon <strong>di</strong>rettore spirituale deve essere sufficientemente preparato. A tale proposito S.<br />
Teresa d‘Avila e S. Giovanni della Croce suggerivano ai loro figli/e spirituali <strong>di</strong> scegliere un<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale che fosse sufficientemente colto. In particolare, la posizione <strong>di</strong> S. Teresa<br />
d‘Avila era dovuta all‘esperienza negativa che lei stessa aveva avuto nella <strong>di</strong>rezione spirituale.<br />
«La <strong>Santa</strong> ha piú volte espresso la sua meraviglia nei confronti <strong>di</strong> un sacerdote che, pur avendo<br />
<strong>stu<strong>di</strong></strong>ato Teologia non era in grado <strong>di</strong> dare adeguati giu<strong>di</strong>zi morali, evento questo che si ripeté<br />
piú volte» 375 . Secondo la <strong>Santa</strong> un buon <strong>di</strong>rettore spirituale è colui che ha un solido fondamento<br />
nelle Sacre Scritture, in Teologia dogmatica, morale e spirituale.<br />
S. Giovanni della Croce con<strong>di</strong>videva le stesse idee. «Quando S. Giovanni della Croce<br />
insegna che il <strong>di</strong>rettore spirituale deve essere saggio, egli sta esprimendo un concetto dai molti<br />
significati. Intende <strong>di</strong>re che il <strong>di</strong>rettore spirituale deve essere istruito, saper comprendere, essere<br />
illuminato, informato e consapevole» 376 .<br />
370 Il Conforto dell‟anima <strong>di</strong>vota, O.A., II, 51.<br />
371 «Il <strong>di</strong>rettore spirituale è maestro <strong>di</strong> fede, <strong>di</strong> sapienza, <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza; è colui che, <strong>di</strong>sponibile e fedele<br />
ascoltatore della Parola <strong>di</strong> Dio, può aiutare gli altri ad aprirsi alle esigenze <strong>di</strong> quella Parola, e scoprire il<br />
senso profondo, a gustare tutta la bellezza e a operare in conformità ad essa» G. FINUTTI, Il Maestro del<br />
cuore: la <strong>di</strong>rezione spirituale in San Filippo Neri, Morcelliana, Brescia 1997, 15.<br />
372 «Non volendo dunque deviare dallo scopo che dal principio mi proponeva, due soli mezzi vi assegnerò<br />
dai quali vogliono <strong>di</strong>pendere tutti gli altri. Il primo, è quello che vi metterà sulla strada della perfezione<br />
cristiana; il secondo, è quello che vi servirà da guida sicura, affinché camminiate bene e facciate gran<strong>di</strong><br />
passi sulla strada medesima… Il secondo mezzo ch‘io vi propongo, è quello che vi accompagnerà sulla<br />
vera strada della perfezione cristiana, sicché non decliniate né da una parte né dall‘altra, e farà che usiate<br />
bene tutti i restanti mezzi necessari, ovvero opportuni al conseguimento delle perfezione dei quali non vi<br />
parlo. Questo mezzo è buon <strong>di</strong>rettore che vi dovette scegliere e a cui dovete in tutto ubbi<strong>di</strong>re» Ibid., 44.<br />
373 L‟Arte <strong>di</strong> farsi santi, O.A., II, 89.<br />
374 Il Religioso al secolo, O.A., II, 132.<br />
375 C. DI RIENZO, Vivi nello Spirito. La <strong>di</strong>rezione spirituale in S. Teresa d‟Avila, E<strong>di</strong>zioni Dehoniane,<br />
Napoli 1992, 88.<br />
376 D. GRAVISS, Portrait of the spiritual <strong>di</strong>rector in the writings of St. John of the Cross, Istitutum<br />
Carmelitanum, Roma 1983, 161.<br />
95
Frassinetti suggeriva lo stesso ai suoi figli spirituali, ma poiché sapeva che<br />
realisticamente era raro trovare persone <strong>di</strong> tale preparazione, suggeriva che almeno si scegliesse<br />
un <strong>di</strong>rettore spirituale con una buona preparazione <strong>di</strong> base, nella convinzione che comunque è<br />
sempre Dio che parla attraverso <strong>di</strong> lui. «Abbia almeno un‘opportuna preparazione, perché un<br />
uomo ignorante è come un cieco che ha bisogno lui stesso <strong>di</strong> una guida e che porterebbe<br />
entrambi a cadere» 377 .<br />
Un buon <strong>di</strong>rettore spirituale deve lavorare in modo zelante per la santificazione delle<br />
anime, cosí come lo stesso Frassinetti ha fatto in pratica. Se egli non provasse amore per la sua<br />
missione, come potrebbe essere una buona guida per gli altri? «È importante che il <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale abbia zelo per la santificazione delle anime. Chi non è interessato ai progressi<br />
spirituali e alla crescita <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>vidui che si affidano alla propria cura non li può stimolare,<br />
perché egli è fra i primi ad essere stanco e demotivato nel compiere un percorso <strong>di</strong> per sé molto<br />
<strong>di</strong>fficile» 378 . Lo zelo e l‘entusiasmo del <strong>di</strong>rettore spirituale sono necessari per svolgere l‘intero<br />
processo. Egli deve sempre essere la fonte della forza <strong>di</strong> colui che è <strong>di</strong>retto ed essere per lui un<br />
testimone perseverante.<br />
Infine, un <strong>di</strong>rettore spirituale deve essere prudente, caratteristica questa che è richiesta<br />
da tutti i maestri <strong>di</strong> spiritualità. «La prudenza è necessaria, perché senza <strong>di</strong> essa lo zelo non<br />
sarebbe sufficiente a stimolare il credente, piuttosto lo porterebbe a cadere. Ci sono talvolta<br />
strani e severi <strong>di</strong>rettori spirituali che pretendono e consentono cose inaccettabili: questi devono<br />
essere decisamente evitati. Un buon <strong>di</strong>rettore, illuminato e ricco <strong>di</strong> esperienza, deve avere<br />
prudenza ed essere cauto in modo che il credente si abbandoni con sicurezza alla sua guida» 379 .<br />
b. Il ruolo <strong>di</strong> un buon <strong>di</strong>rettore spirituale<br />
Il <strong>di</strong>rettore spirituale « è illuminato da Dio ed è questa la ragione principale per cui tu<br />
devi obbe<strong>di</strong>rgli sulle cose che egli ritiene importanti per te ed evitare quelle che lui ti sconsiglia,<br />
perché non utili alla tua crescita spirituale. Dio lo illuminerà affinché egli conosca e scopra la<br />
tua coscienza. Se ti suggerisce qualcosa significa che ti conosce, comprende la tua situazione e<br />
sa che è per il tuo bene» 380 .<br />
Quin<strong>di</strong>, il ruolo chiave <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rettore spirituale consiste nella sua capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernere<br />
lo stato della coscienza del credente. Egli chiede continuamente a Dio l‘aiuto adatto alla<br />
personalità <strong>di</strong> ogni credente. Una volta trasmesso questo aiuto, egli rimane vicino al credente e<br />
lo ―supervisiona‖. È proprio questa la fase in cui la sua presenza è piú importante, poiché il<br />
credente potrebbe scoraggiarsi perché i risultati tardano a venire o, al contrario, infervorarsi<br />
troppo per le sensazioni positive.<br />
Questo è certo un compito molto <strong>di</strong>fficile e, dunque, non c‘è da meravigliarsi che<br />
Frassinetti abbia paragonato il <strong>di</strong>rettore spirituale ad un angelo. «Per guidare una persona che<br />
intraprende una vita angelica c‘è bisogno <strong>di</strong> un angelo dal para<strong>di</strong>so, ma Dio, per risparmiare agli<br />
angeli questo compito, ha assegnato questa missione ai <strong>di</strong>rettori suoi ministri. Anche se il tuo<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale è un esser umano con le sue debolezze, prova a cercare tra quelli che siano<br />
piú angelici. Egli deve mostrare <strong>di</strong> essere non un <strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> questo mondo, ma un uomo<br />
totalmente devoto a Dio. Cosí sarai ben guidato e certamente entrerai nel giar<strong>di</strong>no dei gigli che<br />
<strong>di</strong>ffondono la loro dolce fragranza per tutta la Gerusalemme del Cielo» 381 .<br />
Il <strong>di</strong>rettore spirituale ha l‘obiettivo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare la via giusta che un in<strong>di</strong>viduo deve<br />
percorrere per la sua crescita spirituale. «Devi comprendere che ci sono <strong>di</strong>versi mo<strong>di</strong> per<br />
arrivare alla perfezione e non tutti sono necessari per ognuno. È il <strong>di</strong>rettore spirituale che dà<br />
in<strong>di</strong>cazioni concrete ed istruzioni appropriate senza cui la norma generale rimarrebbe priva <strong>di</strong><br />
377<br />
Il Religioso al secolo, O.A., II, 132-133.<br />
378<br />
Ibid.<br />
379<br />
Ibid.<br />
380<br />
Il conforto dell‟anima <strong>di</strong>vota, O.A., I, 48-49.<br />
381<br />
La gemma delle fanciulle cristiane, O.A., II, 541.<br />
96
isultati o ad<strong>di</strong>rittura dannosa se fosse applicata senza prudenza. Quin<strong>di</strong>, nella ricerca della<br />
santità, procurati tutto il necessario, ma soprattutto scegli bene il tuo <strong>di</strong>rettore spirituale» 382 .<br />
c. Scegliere il <strong>di</strong>rettore spirituale giusto<br />
Frassinetti era consapevole della <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> scegliere il <strong>di</strong>rettore spirituale giusto e<br />
temeva che ciò potesse in qualche modo ostacolare il conseguimento della santità. Per questo<br />
<strong>di</strong>ede importanti suggerimenti in merito.<br />
Innanzitutto raccomandava <strong>di</strong> affidarsi alla volontà <strong>di</strong> Dio e <strong>di</strong> pregare affinché Egli<br />
inviasse la persona giusta per accompagnare il cristiano nel cammino verso la santità, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong><br />
fare la scelta giusta, selezionando il proprio <strong>di</strong>rettore spirituale in modo attento e saggio, senza<br />
fretta. «Se è possibile scegliere fra tanti <strong>di</strong>rettori spirituali, è necessario scegliere il migliore e<br />
non il primo che si incontra. Tutti i confessori possono potenzialmente essere vali<strong>di</strong>, ma non<br />
tutti alla stessa maniera» 383 . Frassinetti ha insistito molto nella scelta del <strong>di</strong>rettore spirituale<br />
giusto affinché il percorso verso la santità non si trasformi in un grave peso. «I <strong>di</strong>rettori sono un<br />
po‘ come i dottori che noi supponiamo siano in grado <strong>di</strong> guarire le malattie, ma non tutti sono<br />
esperti <strong>di</strong> una specifica malattia. Se quin<strong>di</strong> siamo convinti <strong>di</strong> dover scegliere il miglior me<strong>di</strong>co<br />
per le malattie fisiche, tanto piú dobbiamo scegliere il miglior confessore per la cura delle<br />
malattie spirituali» 384 .<br />
Scegliere il migliore fra tanti <strong>di</strong>rettori qualificati potrebbe essere non semplice. Tuttavia<br />
il Frassinetti ha una soluzione a tal proposito. Egli fa riferimento alla saggezza del Vangelo:<br />
«Un buon albero si riconosce dai suoi frutti» (Mt 7,18). Un buon <strong>di</strong>rettore spirituale si può<br />
in<strong>di</strong>viduare dai frutti del suo ministero. «Tra i confessori fra cui puoi scegliere il tuo <strong>di</strong>rettore,<br />
devi scegliere quello i cui buoni frutti possono considerarsi fra i migliori» 385 .<br />
Non si è fermato a questa descrizione, ma è andato oltre elaborando dettagli concreti.<br />
«Per la tua scelta pren<strong>di</strong> quelli che celebrano la <strong>Santa</strong> Messa con fervore, che hanno lo spirito<br />
della preghiera, che sono colti e quando gli si chiede <strong>di</strong> fare una pre<strong>di</strong>ca <strong>di</strong>mostrano il maggior<br />
impegno e zelo per la salvezza delle anime; quando sono occupati nella pratica dei loro<br />
ministeri non siano interessati ad alcun tipo <strong>di</strong> attrazione e piacere mondano. Quando avrai<br />
scelto questo tipo <strong>di</strong> persona, avrai certamente fatto la scelta migliore» 386 .<br />
Tuttavia se l‘occasione non permette <strong>di</strong> scegliere fra <strong>di</strong>versi <strong>di</strong>rettori spirituali,<br />
suggerisce <strong>di</strong> scegliere quell‘unico sacerdote che si trova. «Quell‘unico confessore sarà quello<br />
giusto, perché Dio, che guarda alle tue buone intenzioni, conosce il tuo desiderio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare<br />
santo e farà sí che quella persona sia per te il giusto <strong>di</strong>rettore nonostante egli non sia del tutto<br />
buono <strong>di</strong> per sé» 387 .<br />
d. Considerazioni sulla <strong>di</strong>rezione spirituale non desiderata<br />
Non tutte le <strong>di</strong>rezioni spirituali hanno sempre successo, a volte possono rivelarsi come<br />
esperienze dolorose e spiacevoli. In alcuni casi ciò <strong>di</strong>pende dal fatto che il <strong>di</strong>rettore spirituale<br />
non è ben preparato e quin<strong>di</strong> perde le anime che sono <strong>di</strong>sposte ad intraprendere la strada verso la<br />
santità. Frassinetti ha affermato che un cieco non potrà mai essere una buona guida per un altro<br />
cieco: entrambi non possono far altro che cadere. Egli ha preparato una serie <strong>di</strong> riflessioni in<br />
merito alle esperienze <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale deludenti. «Molte volte il Signore consente alle<br />
anime buone <strong>di</strong> imbattersi in cattive esperienze affinché esse beneficino poi <strong>di</strong> un piú grande<br />
bene. Quin<strong>di</strong> Egli fa sí che le gran<strong>di</strong> anime incontrino <strong>di</strong>rettori spirituali inadeguati, in modo che<br />
da tale inadeguatezza si possa ottenere qualche buon risultato, tenuto conto che se fossero<br />
guidati da <strong>di</strong>rettori colti ed istruiti avrebbero comunque i migliori risultati. Le gran<strong>di</strong> anime<br />
382 Il conforto dell‟anima <strong>di</strong>vota, O.A., I, 45.<br />
383 Ibid., 50.<br />
384 Ibid.<br />
385 Ibid., 51.<br />
386 Ibid., 52.<br />
387 Ibid.<br />
97
sono invitate ad offrire questo sacrificio alla luce della fede, per il bene <strong>di</strong> altri le cui necessità<br />
sono piú gran<strong>di</strong> in confronto alle loro» 388 .<br />
D‘altra parte Frassinetti ricorda che il vero <strong>di</strong>rettore è lo Spirito Santo, l‘unico che<br />
garantisce ad un‘anima tutti i benefici che le sono necessari. A tal proposito si riferisce<br />
all‘esperienza <strong>di</strong> S. Teresa d‘Avila e S. Giovanni della Croce. «Ciò che S. Teresa d‘Avila ha<br />
fatto, lo stesso ha in<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> fare agli altri, cioè <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre con il proprio <strong>di</strong>rettore spirituale<br />
le esperienze che lei aveva con il Signore. Era consapevole che lui era incompetente ma lei,<br />
come anche S. Giovanni della Croce, lo considerava come se parlasse in nome <strong>di</strong> Dio» 389 .<br />
Tuttavia, ci sono delle circostanze in cui l‘errore è compiuto dal credente che è guidato:<br />
è il caso in cui egli non è sincero a sufficienza o non compie tutti gli sforzi necessari per<br />
collaborare con il <strong>di</strong>rettore spirituale e lo Spirito Santo. Infatti, come si è affermato in<br />
precedenza, la buona riuscita della <strong>di</strong>rezione spirituale sta nell‘armoniosa relazione tra i tre<br />
elementi, ognuno dei quali deve impegnarsi a sod<strong>di</strong>sfare pienamente il proprio ruolo.<br />
3. Atteggiamento e comportamento del credente guidato<br />
Il secondo protagonista della <strong>di</strong>rezione spirituale è il credente che chiede al <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong><br />
aiutarlo ad intraprendere la strada per la santità. Secondo Frassinetti <strong>di</strong>pende in gran parte da lui<br />
la buona riuscita della <strong>di</strong>rezione spirituale, poiché è lui il soggetto principale <strong>di</strong> questa<br />
―impresa‖. Dal credente ci si attendono intenzioni sincere che siano <strong>di</strong>mostrate da sforzi<br />
concreti nell‘utilizzare gli aiuti ricevuti con la consapevolezza che sono tutti per il suo bene.<br />
Egli deve avere il cuore aperto ad accettare e mettere in pratica le in<strong>di</strong>cazioni dello Spirito Santo<br />
che lavora in lui e i suggerimenti dello strumento umano, il <strong>di</strong>rettore spirituale. «Da questo<br />
punto <strong>di</strong> vista, devi manifestare al tuo <strong>di</strong>rettore spirituale le tue buone intenzioni ed aspirazioni,<br />
che vengono dal Signore, le tue inclinazioni e tentazioni, in modo che egli conosca il tuo intimo,<br />
ti doni l‘aiuto <strong>di</strong> cui hai bisogno e comprenda ciò che Dio vuole da te. Chie<strong>di</strong>gli <strong>di</strong> fare un<br />
progetto per la tua vita fatto <strong>di</strong> mortificazioni, preghiere, sacramenti, ecc. e sii preciso<br />
nell‘obbe<strong>di</strong>re alle sue in<strong>di</strong>cazioni. In questo modo, sicuramente sarai sulla strada giusta e<br />
conforme alla volontà <strong>di</strong> Dio, obiettivo che deve essere il tuo unico desiderio» 390 .<br />
Inoltre, Frassinetti ha fortemente raccomandato che il credente obbe<strong>di</strong>sca al suo<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale. «Un buon <strong>di</strong>rettore è colui che assegna ad ogni anima gli esercizi <strong>di</strong> cui<br />
questa ha bisogno per arrivare alla perfezione, e poter <strong>di</strong>scernere la propria vocazione» 391 . Il<br />
<strong>di</strong>rettore è responsabile <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care al credente tutte le tappe per la sua crescita spirituale: se lui<br />
non gli obbe<strong>di</strong>sce, nulla <strong>di</strong> buono può accadere.<br />
Per il Frassinetti, infatti, l‘obbe<strong>di</strong>enza è la prima virtú che il credente deve possedere nel<br />
corso del suo cammino spirituale se vuole essere certo <strong>di</strong> raggiungere ciò che desidera. «Se c‘è<br />
qualcuno tra voi che aspira alla perfezione cristiana, ma non obbe<strong>di</strong>sce al proprio <strong>di</strong>rettore, guai<br />
a lui! Invece <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare perfetto, <strong>di</strong>venterà peggiore giorno per giorno. Sii obbe<strong>di</strong>ente! Non<br />
pretendere <strong>di</strong> arrivare ad una vita santa attraverso la <strong>di</strong>sobbe<strong>di</strong>enza» 392 .<br />
Frassinetti raccomanda <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>re al proprio <strong>di</strong>rettore spirituale, poiché egli è uno<br />
strumento <strong>di</strong> Dio. «Quando una persona si presenta con tutte le buone intenzioni ad un ministro<br />
<strong>di</strong> Dio per la confessione, quel ministro non parla per se stesso: è Dio che gli suggerisce cosa<br />
<strong>di</strong>re, in modo saggio e santo, anche se, nella vita reale, non lo è. Quin<strong>di</strong>, se non hai altra scelta,<br />
sii contento e stai tranquillo che lui non nuocerà alla tua anima. Dio, infatti, non permette che tu<br />
sia guidato per un cammino sbagliato» 393 .<br />
L‘obbe<strong>di</strong>enza, dunque, è la chiave per la buona riuscita <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>rezione spirituale.<br />
Secondo Frassinetti «l‘obbe<strong>di</strong>enza è la prima figlia della santa umiltà. È colei che guida l‘uomo<br />
verso tutte le altre virtú e, senza <strong>di</strong> lei, qualsiasi buona intenzione non dà alcun valido<br />
388<br />
Ibid., 50.<br />
389<br />
J. M. DOUGLAS, Handbook for spiritual <strong>di</strong>rectors, Paulist Press, Mah Wah NJ 1998, 8.<br />
390<br />
Il religioso al secolo, O.A., II, 133.<br />
391<br />
Il conforto dell‟anima <strong>di</strong>vota, O.A., I, 48.<br />
392 Ibid.<br />
393 Ibid., 50.<br />
98
isultato» 394 . L‘obbe<strong>di</strong>enza deve essere imme<strong>di</strong>ata, cieca e perfetta 395 : solo cosí si potranno<br />
ottenere i frutti imme<strong>di</strong>ati che si desiderano per la propria anima 396 . «Devi obbe<strong>di</strong>re<br />
prontamente, senza riflettere, senza rinvii o tentazioni. Obbe<strong>di</strong>sci ciecamente, con l‘in<strong>di</strong>fferenza<br />
<strong>di</strong> un pezzo <strong>di</strong> legno, <strong>di</strong> una pietra, lasciando che le cose vadano liberamente. Infine, obbe<strong>di</strong>sci<br />
perfettamente, anche nelle piccole cose, tenendo presente che a volte il <strong>di</strong>rettore spirituale può<br />
suggerirti cose o azioni che sembrano <strong>di</strong> scarsa importanza, ma invece sono <strong>di</strong> grande valore per<br />
un‘anima» 397 .<br />
Al credente è dunque chiesta la piena obbe<strong>di</strong>enza, una fede genuina per abbandonarsi<br />
nelle mani del <strong>di</strong>rettore spirituale che lavora sotto l‘ispirazione dello Spirito Santo. Tuttavia, ciò<br />
non vuol <strong>di</strong>re che egli non debba piú usare la propria intelligenza: deve obbe<strong>di</strong>re solo a ciò che<br />
lo conduce alla salvezza e non alla dannazione eterna 398 . A tal fine, Frassinetti ha invitato i suoi<br />
figli e figlie spirituali ad essere sempre in guar<strong>di</strong>a. «C‘è un solo caso in cui non si deve obbe<strong>di</strong>re<br />
al <strong>di</strong>rettore spirituale: quando egli ti <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> fare cose peccaminose, come ad esempio rinunciare<br />
alla fede o bestemmiare Dio e i santi, cose che Dio non permetterebbe mai» 399 .<br />
D. Le fonti <strong>di</strong> ispirazione della dottrina <strong>di</strong> Frassinetti sulla <strong>di</strong>rezione spirituale<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale del Frassinetti ha il suo solido fondamento nelle Sacre Scritture,<br />
nelle dottrine dei Padri della Chiesa, nel Magistero della Chiesa del suo tempo e in alcune<br />
importanti figure della Chiesa Cattolica che sono stati suoi insegnanti ideali e hanno avuto<br />
grande influenza sulla sua spiritualità. Ne citiamo alcuni che hanno arricchito fortemente il<br />
Frassinetti nella pratica della <strong>di</strong>rezione spirituale.<br />
1. S. Alfonso <strong>Maria</strong> de’ Liguori<br />
Ai tempi <strong>di</strong> Frassinetti non c‘era una chiara <strong>di</strong>stinzione fra la confessione e la <strong>di</strong>rezione<br />
spirituale. Le persone che confessavano i loro peccati chiedevano allo stesso tempo in<strong>di</strong>cazioni<br />
su questioni <strong>di</strong> morale cristiana. Al riguardo, Frassinetti ha conquistato la fiducia <strong>di</strong> altri<br />
sacerdoti per le sue convinzioni morali che erano principalmente volte alla salvezza delle anime.<br />
Questa formazione è dovuta ad un grande santo che ha accompagnato il suo ministero pastorale.<br />
Infatti, la provvidenza <strong>di</strong> Dio ha voluto che Frassinetti fosse formato sotto l‘ispirazione <strong>di</strong><br />
Alfonso <strong>Maria</strong> de‘ Liguori. «Egli si opponeva fortemente al rigore dei Giansenisti che hanno<br />
trasformato il sacramento della confessione in un momento <strong>di</strong> condanna. La sua dottrina si<br />
collocava a metà fra il rigore dei Giansenisti e il lassismo dei Gesuiti – associato con il<br />
Probabilismo a cui egli contrappose l‘Equiprobabilismo nel <strong>di</strong>scernere il corso <strong>degli</strong> eventi: ciò<br />
significa che una legge dubbiosa non deve essere obbligatoriamente seguita e che un‘opinione<br />
394 Il religioso al secolo, O.A., II, 132.<br />
395 «Nelle cose riguardanti lo spirito dovete ubbi<strong>di</strong>re al vostro <strong>di</strong>rettore spirituale… Quin<strong>di</strong>, per la<br />
Confessione, per la Comunione, e per gli esercizi <strong>di</strong> pietà, nei dubbi, nella perplessità, nelle ansietà, negli<br />
scrupoli, non badate mai a ciò che pare a voi, non osservate mai altro, se non ad ubbi<strong>di</strong>re puntualmente,<br />
perfettamente e ciecamente» La monaca in casa, O.A., II, 16.<br />
396 «… memore della parola <strong>di</strong> Gesú Cristo <strong>di</strong>sse ai suoi ministri, chi ascolta voi ascolta me, lasciatevi<br />
guidare da lui e ubbi<strong>di</strong>telo con perfezione. Se voi vi lasciate mai dominare dalla superbia <strong>di</strong> fare da voi,<br />
fareste poco o nulla <strong>di</strong> bene e cadrete facilmente in qualche inganno: le vostre buone intenzioni, non<br />
benedette da Dio, riuscirebbero infruttuose; e il bene da voi operato potrebbe cangiare in male» Il<br />
religioso al secolo, O.A., II, 133.<br />
397 Ibid., 134.<br />
398 «Se però il <strong>di</strong>rettore spirituale vi comandasse cose strane che dessero ammirazione, o potessero<br />
cagionare qualche danno, sia al corpo, sia dallo spirito, non gli dovreste ubbi<strong>di</strong>re ciecamente: poiché vi<br />
potrebbe essere un <strong>di</strong>rettore che vi paresse buono e molto, ma non avesse la necessaria prudenza. In questi<br />
casi dovreste consultare qualche altro soggetto dotto ed illuminato, per conoscere veramente se<br />
convenisse ubbi<strong>di</strong>re al <strong>di</strong>rettore, piuttosto lasciar quello e cercarne un altro» La monaca in casa, O.A., II,<br />
16.<br />
399 Ibid.<br />
99
probabile può essere eseguita, ma che una legge è dubbiosa solo quando le opinioni a favore e<br />
contro <strong>di</strong> essa sono ugualmente bilanciate» 400 .<br />
L‘incontro del Frassinetti con questo Dottore della Chiesa durante la sua gioventú, in<br />
particolare durante gli anni <strong>di</strong> preparazione al sacerdozio, è stato molto significativo nella sua<br />
formazione personale. S. Alfonso <strong>Maria</strong> de‘ Liguori <strong>di</strong>venne il modello del suo apostolato e il<br />
primo maestro della sua vita spirituale. Il suo <strong>di</strong>scepolato è stato provato durante la <strong>di</strong>fficile lotta<br />
contro il Giansenismo. «Frassinetti lo considerava un maestro <strong>di</strong> spiritualità sopra tutti gli altri,<br />
che lo aveva preservato dal ridurre la moralità nella scienza del peccato…» 401 .<br />
2. S. Teresa d’Avila e S. Giovanni della Croce<br />
Come è stato precedentemente affermato, Frassinetti è stato un pio <strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> S.<br />
Teresa d‘Avila e S. Giovanni della Croce che hanno fortemente influenzato la sua spiritualità 402 .<br />
La sua dottrina sull‘importanza della <strong>di</strong>rezione spirituale è il risultato dello <strong>stu<strong>di</strong></strong>o della<br />
vita e delle opere <strong>di</strong> S. Teresa d‘Avila. «Le osservazioni e i consigli <strong>di</strong> S. Teresa sulla <strong>di</strong>rezione<br />
spirituale sono il frutto della sua esperienza personale» 403 . La <strong>di</strong>rezione spirituale che Frassinetti<br />
ha tratto dai suoi esempi ha ispirato tutti i suoi lavori e accompagnato tutta la sua vita spirituale<br />
fino alla morte. In particolare, la sua insistenza sulla personalità del <strong>di</strong>rettore spirituale proviene<br />
chiaramente dalla dottrina della santa. L‘analogia del <strong>di</strong>rettore spirituale come capitano della<br />
nave è l‘applicazione delle qualità che lei ha elencato. «Non è necessario solo che un <strong>di</strong>rettore<br />
sia saggio, santo e ricco <strong>di</strong> esperienza, ma che possegga la capacità <strong>di</strong> guidare le anime verso la<br />
perfezione cristiana, tenendo in considerazione la vocazione specifica <strong>di</strong> ognuno» 404 .<br />
Giuseppe Frassinetti con<strong>di</strong>videva l‘idea della santa secondo cui la <strong>di</strong>rezione spirituale è<br />
necessaria, ma non in assoluto. «È certo che S. Teresa parli della <strong>di</strong>rezione spirituale come un<br />
mezzo necessario alla crescita spirituale, specialmente in giovane età. Tuttavia, non si deve<br />
credere che il progresso nella vita spirituale non possa avvenire senza la <strong>di</strong>rezione: in tal caso<br />
sarebbe come privare Dio del suo potere e si minerebbe tutta la dottrina <strong>di</strong> S. Teresa» 405 .<br />
La ricca elaborazione del Frassinetti sul valore della <strong>di</strong>rezione spirituale è stata anche<br />
ispirata da S. Giovanni della Croce. «S. Giovanni della Croce ha dato tre ragioni per cui<br />
l‘apertura verso il proprio <strong>di</strong>rettore spirituale è essenziale: primo, per confermare l‘effetto, la<br />
luce, la forza e la sicurezza <strong>di</strong> molte comunicazioni <strong>di</strong>vine; secondo, perché un‘anima ha<br />
bisogno or<strong>di</strong>nariamente <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni pertinenti alle sue esperienze, deve essere guidata<br />
attraverso la buia notte della povertà spirituale e, terzo, per umiltà, sottomissione e<br />
mortificazione» 406 . Come S. Giovanni della Croce, Frassinetti ha sempre insistito sul prezioso<br />
ruolo del <strong>di</strong>rettore. «L‘efficacia del ministero della <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong>pende non solo, ma in<br />
misura significante, dall‘impegno del <strong>di</strong>rettore alla crescita della vita spirituale. La realizzazione<br />
<strong>di</strong> questo impegno è vincolata alla convinzione che solo Dio è il Signore e la guida della vita <strong>di</strong><br />
ogni cristiano; quin<strong>di</strong>, si deve dare al <strong>di</strong>rettore la libertà <strong>di</strong> scoprire la volontà <strong>di</strong> Dio nella vita<br />
del credente» 407 .<br />
400<br />
J. BOWKER, St. Alphonsus Liguori, in A..A. V.V., The Oxford <strong>di</strong>ctionary of religions, Oxford University<br />
Press, China 1999, 579.<br />
401<br />
M. FALASCA, Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, Cantagalli, Siena, 144-145.<br />
402<br />
«La scuola ascetica carmelitana definisce la <strong>di</strong>rezione spirituale come arte e scienza: come è l‘abilità<br />
del <strong>di</strong>rettore nella guida delle anime verso la perfezione; come scienza comprende i principi e le<br />
conclusioni riguardanti i rapporti tra il <strong>di</strong>rettore e il fedele che gli chiede d‘essere guidato, e fornisce i<br />
principi teoretici a cui deve ispirarsi l‘azione pratica del <strong>di</strong>rettore stesso» S. RIVA, La <strong>di</strong>rezione spirituale<br />
nell‟età dello sviluppo, Queriniana, Brescia 1967, 22.<br />
403<br />
K. G. CULLIGAN, Spiritual <strong>di</strong>rection. Contemporary rea<strong>di</strong>ngs, Living Flame Press, U.S.A. 1983, 61.<br />
404<br />
C. DI RIENZO, Vivi nello Spirito. La <strong>di</strong>rezione spirituale in S. Teresa d‟Avila, E<strong>di</strong>zioni Dehoniane,<br />
Napoli 1982, 96.<br />
405<br />
K. G. CULLIGAN, Spiritual <strong>di</strong>rection. Contemporary rea<strong>di</strong>ngs, 202.<br />
406<br />
T. GREEN, The friend of the bridegroom: spiritual <strong>di</strong>rection and the encounter with Christ, Ave <strong>Maria</strong><br />
Press, Notre Dame IN 2000, 74.<br />
407<br />
K. G. CULLIGAN, Spiritual <strong>di</strong>rection. Contemporary rea<strong>di</strong>ngs, 202.<br />
100
3. S. Francesco <strong>di</strong> Sales<br />
La spiritualità <strong>di</strong> P. Frassinetti è stata influenzata anche da S. Francesco <strong>di</strong> Sales,<br />
soprattutto per quanto riguarda la chiamata universale alla santità. Entrambi hanno con<strong>di</strong>viso la<br />
convinzione che la santità è il fine <strong>di</strong> ogni cristiano. «Visitando paese dopo paese e lavorando<br />
dall‘alba al tramonto, S. Francesco <strong>di</strong> Sales è stato conosciuto come un sacerdote molto umile<br />
ed un pre<strong>di</strong>catore ricco <strong>di</strong> qualità. Egli ha scritto e <strong>di</strong>stribuito libretti che respingevano le<br />
posizioni e le dottrine dei Riformatori e offrivano istruzioni importanti per la vita spirituale» 408 .<br />
Tutti i suoi scritti erano <strong>di</strong>retti verso un unico fine: giungere ad una vita <strong>di</strong> perfezione e per<br />
questo egli ha tanto insistito sulla <strong>di</strong>rezione spirituale. «Il Servo <strong>di</strong> Dio Frassinetti ha affiancato<br />
la sua dottrina a quella <strong>di</strong> S. Francesco <strong>di</strong> Sales: entrambi concordavano sul fatto che sarebbe un<br />
errore, anzi un‘eresia, chiudersi nella propria vita seppur piena <strong>di</strong> zelo, stando lontano dai<br />
negozi <strong>degli</strong> artigiani, dalle coppie, dalle famiglie. Infatti, entrambi considerano la santità<br />
prerogativa <strong>di</strong> tutti gli in<strong>di</strong>vidui, in<strong>di</strong>pendentemente dagli stati e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita» 409 .<br />
4. S. Filippo Neri come prototipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore spirituale<br />
Secondo Giuseppe Frassinetti, S. Filippo Neri è il prototipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore spirituale e lui<br />
stesso lo sceglierebbe per se stesso. «Attraverso il suo ministero <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore spirituale S. Filippo<br />
Neri ha sottolineato l‘importanza dei doni personali come strumenti per proseguire verso il<br />
progresso spirituale» 410 . In particolare, Frassinetti è stato attratto dallo zelo <strong>di</strong> S. Filippo Neri<br />
per la salvezza delle anime. Egli è stato un uomo totalmente devoto a Dio e alla Vergine <strong>Maria</strong> a<br />
cui ha sempre affidato tutto ciò che aveva.<br />
La semplicità della dottrina <strong>di</strong> S. Filippo Neri ha ispirato il ministero pastorale del<br />
Frassinetti. Inoltre, egli è stato fortemente attratto dalla sua gioiosa ed entusiastica testimonianza<br />
nella <strong>di</strong>fficile missione della guida delle anime. «Il suo spirito si adatta a qualsiasi inclinazione,<br />
a tutte le con<strong>di</strong>zioni e tendenze in<strong>di</strong>viduali, cosicché egli riesce a conquistare le anime per il<br />
Signore senza alcuna violenza. S. Filippo Neri era saggio con i saggi, ignorante gli ignoranti, un<br />
bambino con i bambini: omnibus omnia factus, come S. Paolo» 411 . In altre parole, un <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale deve avere un cuore aperto, pronto ad accogliere le anime e sempre <strong>di</strong>sponibile per<br />
loro 412 . Nella sua vita deve essere visibile che lui è un uomo in cammino per la santità, una<br />
santità possibile! «S. Filippo Neri dava piú del massimo sempre e ovunque. Viveva la vita con<br />
gioia, organizzandola in funzione <strong>di</strong> questa gioia: cosí <strong>di</strong>venne un invincibile maestro, il<br />
principe <strong>di</strong> questa grande <strong>di</strong>sciplina» 413 .<br />
Giuseppe Frassinetti fu un fedele <strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> questi maestri delle anime. Il suo<br />
insegnamento dell‘accompagnamento spirituale è fondato non solo dai varie meto<strong>di</strong> imparati da<br />
loro ma soprattutto della testimonianza personale della santità <strong>di</strong> vita.<br />
408<br />
M. GLAZIER, St. Francis de Sales, in A.A. V.V., The modern Catholic Encyclope<strong>di</strong>a, Claretian<br />
Publications, In<strong>di</strong>a 1997, 325.<br />
409<br />
G RENZI, Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche. Catalogo bibliografico generale delle opere<br />
e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te del Servo <strong>di</strong> Dio, Tifografia Don Guanella, Roma 1979, 39.<br />
410<br />
G. FINUTTI, Il Maestro del cuore, 57.<br />
411<br />
Il conforto dell‟anima <strong>di</strong>vota, O.A., II, 54.<br />
412<br />
«Il <strong>di</strong>rettore spirituale si fa compagno <strong>di</strong> viaggio nel cammino spirituale non come un semplice<br />
catalizzatore <strong>di</strong> forze, uno che <strong>di</strong>rige <strong>di</strong>scretamente nel cammino, con<strong>di</strong>videndo esperienze e fatiche;<br />
suscita per sé e per gli altri sempre nuove attese, per sollecitare nuova fede e ulteriore speranza» G.<br />
FINUTTI, Il Maestro del cuore, 100.<br />
413<br />
G. DE LIBERO, San Filippo ride e gioca, Coletti E<strong>di</strong>tore, Roma 1962, 5.<br />
101
CAPITOLO TERZO<br />
DIREZIONE SPIRITUALE PER GLI ADOLESCENTI E GIOVANI<br />
A. L’Importanza della <strong>di</strong>rezione spirituale per gli adolescenti e giovani<br />
«La <strong>di</strong>rezione spirituale è un processo che mira a guidare una persona verso il cammino<br />
della perfezione» 414 . L‘uomo ha sempre bisogno dell‘altro per crescere e vivere. Le tappe che<br />
sono piú delicate nello sviluppo umano sono l‘età dell‘adolescenza e della giovinezza, ed è in<br />
questo periodo della vita che la <strong>di</strong>rezione spirituale svolge un ruolo fondamentale. «Nella<br />
gioventú sono le speranze dell‘avvenire» 415 . Guidarli ed accompagnarli nel cammino <strong>di</strong> vita è<br />
un investimento per il bene della chiesa e della società.<br />
La preoccupazione per la formazione dei giovani è stata sempre presente nell‘apostolato<br />
<strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti. Egli spiegava loro la bellezza <strong>di</strong> questo momento della loro esistenza.<br />
«Sapete che esistono anche <strong>di</strong>verse stagioni nella vita? Sí, la vita stessa ha le sue stagioni: la sua<br />
primavera è la vostra età. E se come la primavera è la stagione piú bella dell‘anno, la vostra è il<br />
periodo piú bello nella vita» 416 . È il momento <strong>di</strong> tante scoperte e curiosità. L‘età quando si<br />
scopre il dono meraviglioso della vita e in cui si inizia ad essere protagonista della propria storia<br />
nel mondo in cui si vive.<br />
Dio ha voluto creare l‘uomo in un processo <strong>di</strong> crescita secondo le <strong>di</strong>verse tappe per<br />
poter rivelare il suo volto <strong>di</strong> Padre. Ogni tappa <strong>di</strong>mostra la sua presenza provvidenziale. È<br />
proprio in questa età che gli adolescenti e giovani devono scoprire questa verità: esiste un Dio<br />
che li ama e che li accompagna lungo il cammino della vita.<br />
Ma è anche il periodo piú pericoloso in quanto è anche il momento in cui satana prova a<br />
spargere il suo seme per portare queste anime fragili lontano da Dio. «Lucifero desidera sempre<br />
<strong>di</strong>struggere tutto il piano <strong>di</strong> Dio: perciò si approfitta della vostra debolezza e <strong>di</strong>strazione, manda<br />
i suoi seguaci per sedurvi a compiere non il bene ma il male» 417 .<br />
Giuseppe Frassinetti trova nella <strong>di</strong>rezione spirituale un modo efficace per assicurare la<br />
formazione dei giovani. Il <strong>di</strong>rettore spirituale sarà per un giovane un punto <strong>di</strong> riferimento nella<br />
avventura della vita soprattutto nel suo cammino <strong>di</strong> vita spirituale. «Ora, intorno a questo<br />
argomento, prima cosa da notare si è che tra i mezzi assegnati dai maestri <strong>di</strong> spirito pel<br />
conseguimento della perfezione cristiana, è giu<strong>di</strong>cato importantissimo quello della scelta <strong>di</strong> un<br />
buon <strong>di</strong>rettore: verità da essere agevolmente intesa, se si consideri che <strong>di</strong>pende da lui la pratica,<br />
ossia l‘applicazione <strong>di</strong> tutti gli altri mezzi <strong>di</strong> perfezione» 418 .<br />
I giovani che percorrono un cammino <strong>di</strong> fede sotto la guida del <strong>di</strong>rettore spirituale<br />
possono <strong>di</strong>ventare essi stessi testimoni ed ispiratori per gli altri giovani. «Ognuno <strong>di</strong> noi può<br />
<strong>di</strong>ventare strumento dell‘opera <strong>di</strong> Dio. Egli spesso si fa incontrare dalle persone deboli e meno<br />
esperte, attraverso i nostri amici, i genitori e anche i giovani stessi» 419 . Perciò i giovani possono<br />
essere apostoli dei loro coetanei.<br />
B. Giuseppe Frassinetti: <strong>di</strong>rettore spirituale dei giovani<br />
414<br />
K. G. CULLIGAN, Spiritual <strong>di</strong>rection. Contemporary rea<strong>di</strong>ngs, Living Flames Press, U.S.A. 1983, 10.<br />
415<br />
Proposti fatti per sé e per alcuni amici, O.A., II, 619.<br />
416<br />
G. FRASSINETTI, Esercizi spirituali per i giovinetti d‟ambo i sessi, Tipografia della Gioventú, Genova<br />
1865, 8.<br />
417<br />
Ibid., 12.<br />
418<br />
Il religioso al secolo, O.A., II, 132.<br />
419<br />
G. FRASSINETTI, La missione delle fanciulle. Racconti contemporanei, Tipografia <strong>di</strong> Giovanni<br />
Ghianni, Oneglia 1863, 18.<br />
102
Giuseppe Frassinetti è stato un buon <strong>di</strong>rettore spirituale dei ragazzi e giovani del suo<br />
tempo. Egli ne ha accompagnato tanti sulla strada della santità. I suoi figli spirituali lo hanno<br />
considerato come un vero padre, sempre attento e pronto a <strong>di</strong>fenderli da ogni pericolo che<br />
potesse allontanarli dalla fede e da Dio. Possiamo menzionare due giovani a cui egli stesso<br />
de<strong>di</strong>cò due opuscoli importanti: Rosina Pedemonte e Rosa Cordone. Questi due figlie spirituali<br />
<strong>di</strong> Frassinetti sono <strong>di</strong>ventate modello per gli altri giovani del loro tempo.<br />
La prima: Rosina Pedemonte morí a vent‘anni a Genova dando testimonianza <strong>di</strong> santità.<br />
Rosina ha de<strong>di</strong>cato praticamente la sua vita alla cura dei bambini poveri. La sua, fu una vita<br />
totalmente al servizio dei piú piccoli e deboli. Frassinetti scrisse <strong>di</strong> lei, «Credo <strong>di</strong> aver fatto una<br />
cosa giusta scrivendo la sua memoria. Rosina ha lasciato una luce, un esempio per i suoi amici,<br />
perché possano imitarla non solo loro ma tutti i giovani che leggono questa opera» 420 .<br />
Un‘altra figlia spirituale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti fu Rosa Cordone. La grandezza <strong>di</strong><br />
questa giovane era proprio nella sua capacità <strong>di</strong> accettare la sofferenza come volontà <strong>di</strong> Dio.<br />
Rosa aveva sempre <strong>di</strong>mostrato fedeltà e amore per il Signore nonostante il dolore e la malattia<br />
che la condusse alla morte. Frassinetti scrisse una piccola opera sulla sua testimonianza. «I<br />
gran<strong>di</strong> maestri <strong>di</strong> spirito ci hanno insegnato che la santità non si misura nel fare gran<strong>di</strong> cose per<br />
Dio, ma nell‘accettare la sua volontà. Anche le cose semplici che facciamo possono <strong>di</strong>ventare<br />
via al para<strong>di</strong>so se le facciamo nel nome dell‘amore e per amore» 421 . E Rosa fu esempio <strong>di</strong> questa<br />
santità.<br />
Giuseppe Frassinetti fu considerato non solo un padre ma anche un amico dai suoi figli<br />
spirituali. Tra <strong>di</strong> loro c‘era anche Domenico Fassiolo. «È da notare che Frassinetti era molto<br />
amico dei ragazzi e giovani, ma non lasciava spazio per la famigliarità. Era sempre pronto a<br />
correggerli e dare punizione quando sbagliavano. In questa maniera egli ha guadagnato rispetto<br />
e amore» 422 . Frassinetti fu un amico – guida, ma un amico severo. L‘amicizia era il suo metodo<br />
nell‘accompagnamento spirituale.<br />
Egli guadagnava anime innocenti alla Chiesa. Ha svolto questo ministero efficacemente,<br />
e ciò <strong>di</strong>pese anche dalla sua testimonianza personale. Era veramente un uomo <strong>di</strong> Dio. «Infatti,<br />
per una buona riuscita <strong>di</strong> un processo <strong>di</strong> accompagnamento spirituale, il <strong>di</strong>rettore non deve<br />
essere solo esperto <strong>di</strong> teologia ma deve essere un uomo che vive nella grazia <strong>di</strong> Dio» 423 .<br />
Possiamo affermare dunque dal frutto del suo impegno <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore spirituale che Frassinetti era<br />
veramente un santo uomo.<br />
Esistono <strong>di</strong>versi stili che l‘accompagnatore spirituale può utilizzare: autoritario,<br />
democratico, empatico e integrativo. «È importante che tu, come accompagnatore, <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>verse alternative su quanto si riferisce allo stile <strong>di</strong> accompagnamento. Potrai cosí scegliere<br />
quello, secondo la tua intuizione e l‘ispirazione dello Spirito, sembra essere il piú adatto per la<br />
persona» 424 . Senza dubbio, il nostro Frassinetti era una guida autoritaria. Questo stile <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rezione spirituale era limpidamente manifestato nelle sue opere e scritti. Era il metodo piú<br />
adatto per i ragazzi e giovani <strong>di</strong> quel tempo. «Il <strong>di</strong>rettore spirituale è considerato uno che ha<br />
autorità sulla persona, perciò interpreta il Vangelo, gli insegnamenti della Chiesa, le mozioni e<br />
gli orientamenti dello Spirito, il significato del comportamento della persona e le sue possibilità<br />
future» 425 .<br />
È necessario sottolineare che nonostante che lo definiamo una guida autoritaria,<br />
Frassinetti non andò oltre il limite della sua influenza sulle persone che <strong>di</strong>rigeva. Diventò<br />
autoritario solo per assicurare che venissero introdotti sulla via rivelata da Dio, accogliendo ciò<br />
420 G. FRASSINETTI, Il modello della povera fanciulla Rosina Pedemonte, Tipografia <strong>di</strong> Gioventú Ghianni,<br />
Oneglia 1861, 104.<br />
421 G. FRASSINETTI, La rosa senza spine. Memorie sulla vita della pia zitella Rosa Cordone, Tipografia<br />
della Gioventú, Genova 1867, 67.<br />
422 D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vita del sac. Giuseppe Frassinetti, Tipografia della<br />
Gioventú, Genova 1879 .<br />
423 K.G. KULLIGAN, Spiritual <strong>di</strong>rection, 10.<br />
424 L. GONZÁLEZ, Guidati dallo Spirito. Accompagnamento spirituale <strong>di</strong> stile integrativo, Libreria<br />
E<strong>di</strong>trice Vaticana, Città del Vaticano 1998, 55.<br />
425 Ibid., 58.<br />
103
che viene insegnato dai padri della fede. Egli non si ritiene degno del titolo <strong>di</strong> padre della fede.<br />
Era un titolo dato dalle persone che erano curate attentamente e prudentemente dal loro<br />
<strong>di</strong>rettore- guida. Sappiamo per esperienza che l‘albero viene conosciuto dai frutti: Giuseppe<br />
Frassinetti fu un servo nella vigna del Signore carico <strong>di</strong> frutti.<br />
C. Direzione spirituale in<strong>di</strong>viduale<br />
L‘esercizio della <strong>di</strong>rezione spirituale nel senso proprio si riferisce al rapporto personale<br />
che esiste tra il <strong>di</strong>rettore e la singola persona, e questo senz‘altro sotto l‘ispirazione dello Spirito<br />
Santo. In<strong>di</strong>viduiamo ora il contenuto della <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti nella<br />
guida personale della singola anima.<br />
1. La formazione dell’anima del giovane<br />
Il primo ruolo importante della guida spirituale dei giovani è l‘amore e la passione per i<br />
giovani stessi, e ciò deve essere attualizzato con l‘impegno sincero e costante. Guidare un<br />
giovane verso il cammino alla santità è un‘impresa che richiede tempo e sacrifici. Questo<br />
compito è <strong>di</strong>fferente dalla istruzione della dottrina cristiana. Il ministero della <strong>di</strong>rezione<br />
spirituale è un passo in avanti nel cammino della fede, è il momento dell‘applicazione della<br />
dottrina per poter maturare il desiderio <strong>di</strong> conoscere piú vicino il Signore, amarlo e seguirlo.<br />
Giuseppe Frassinetti de<strong>di</strong>cò due opere importanti a questo riguardo: la prima opera fu<br />
in<strong>di</strong>rizzata alle ragazze Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú, l‘altra fu per i<br />
ragazzi, Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> un giovinetto cristiano. Cerchiamo <strong>di</strong> esaminarle per scoprire gli elementi<br />
fondamentali della sua <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong>retta alla persona.<br />
a. Ricor<strong>di</strong> per la coscienza<br />
«La coscienza è la regola prossima delle nostre azioni, perché ogni atto umano si<br />
giu<strong>di</strong>ca virtuoso, o vizioso, non secondo il suo obiettivo materiale, ma secondo l‘idea che<br />
abbiamo della sua bontà o della sua malizia» 426 . Questa definizione data dal Frassinetti in questi<br />
due opuscoli manifesta il bisogno <strong>di</strong> formare ed educare la coscienza umana. È necessaria tale<br />
educazione in particolar modo per i ragazzi e giovani che sono spesso inclinati a cedere<br />
all‘influenza seducente del male.<br />
La prima tappa è la purificazione della coscienza 427 . «Prima <strong>di</strong> tutto purificate bene la<br />
vostra coscienza da ogni peccato con una buona confessione, anche generale, se il vostro<br />
confessore ve la permette. Perciò se aveste alcuna cosa che vi desse qualche fasti<strong>di</strong>o e<br />
rimor<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> coscienza, e che non aveste ancora manifestata, anche a costo <strong>di</strong> qualunque<br />
rossore e rincrescimento, manifestatela; fatevi sforzo, vincetevi, non tenete occulta nessuna<br />
mancanza, quantunque il demonio o il vostro amor proprio ve la facesse parere piccola e <strong>di</strong> poca<br />
importanza» 428 . Il cammino da percorre insieme con il <strong>di</strong>rettore parte proprio con la grazia del<br />
sacramento della Riconciliazione.<br />
Il perdono dei peccati libera l‘anima da ogni forma <strong>di</strong> schiavitú, e prepara il cuore del<br />
credente ad accogliere Cristo nella sua vita. «Dio ci ha fatti liberi, e Dio non lavora nel nostro<br />
cuore se noi non vogliamo. Egli è pronto a farci tutti suoi, cioè santi; ma vuole che noi siamo<br />
pronti a tutto, e che ci offriamo a Lui con un‘offerta intera e irrevocabile» 429 .<br />
426<br />
G. FRASSINETTI,Compen<strong>di</strong>o della Teologia Morale <strong>di</strong> S. Alfonso M. de Liguori, I, Scuola Tipografica<br />
Salesiana, Torino 1948, 7.<br />
427<br />
«L‘educazione della coscienza è un compito <strong>di</strong> tutta la vita. Fin dai primi anni <strong>di</strong>schiude al bambino la<br />
conoscenza e la pratica della legge interiore, riconosciuta dalla coscienza morale. Un‘educazione<br />
prudente insegna la virtú; preserva o guarisce dalla paura, dall‘egoismo e dall‘orgoglio, dai risentimenti<br />
della colpevolezza e dai moti <strong>di</strong> compiacenza, che nascono dalla debolezza e dagli sbagli umani.<br />
L‘educazione della coscienza garantisce la libertà e genera la pace del cuore» CCC, n. 1784, 456.<br />
428<br />
Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú, O.A., I, 638.<br />
429 Offerta <strong>di</strong> noi a Dio, O.A., I, 321.<br />
104
Educare la propria coscienza significa ridare il posto a Dio nella propria vita. La<br />
persona deve desiderare nel cuore suo solo <strong>di</strong> piacere al Signore. «Beata l‘anima che spesso<br />
pensa che ha Dio nel cuore!» 430 . Cristo deve <strong>di</strong>ventare il centro della sua esistenza: il punto <strong>di</strong><br />
riferimento del suo essere ed agire.<br />
b. Ricor<strong>di</strong> per l’importanza della preghiera<br />
La preghiera è la forza che sostiene ogni uomo verso il cammino della perfezione. «La<br />
preghiera è la strada regale del Para<strong>di</strong>so. Percorrendo questa strada guadagniamo il tesoro piú<br />
prezioso della vita. Arriverà il momento in cui <strong>di</strong>remo che il prezzo che abbiamo pagato non è<br />
niente in paragone al premio guadagnato» 431 . Ed è fondamentale che i giovani si debbano<br />
equipaggiare con la piú importante arma nella battaglia della vita cristiana per la santità, quale è<br />
la preghiera.<br />
Giuseppe Frassinetti fu un <strong>di</strong>scepolo della santa carmelitana che era eccellente maestra<br />
<strong>di</strong> preghiera, ma ha cercato <strong>di</strong> formulare un metodo piú semplice adatto per i giovani. «Per<br />
pregare bene, pregate <strong>di</strong> cuore e col cuore, parlando col vostro Signore Id<strong>di</strong>o come la figlia parla<br />
col padre, al quale con tutta confidenza domanda il cibo e il vestito; come l‘inferma parla con il<br />
me<strong>di</strong>co, al quale chiede con tutto l‘impegno la me<strong>di</strong>cina del suo male, come la povera parla col<br />
ricco, al quale domanda con tanta umiltà la limosina; come la sposa parla collo sposo, al quale<br />
con tanta passione attesta il suo amore» 432 .<br />
Con questa descrizione semplice e concreta quale sia la preghiera, il Frassinetti provò <strong>di</strong><br />
spiegare ai giovani che la preghiera è facile e a portata <strong>di</strong> mano. Deve essere spontanea e non<br />
necessita <strong>di</strong> tante parole. È importante il fatto che sia costante, poiché è necessaria per le anime<br />
che bramano d‘essere unite a Dio. «Quando pregate, <strong>di</strong>tele piuttosto brevi (non pretendo che<br />
siano lunghe), ma <strong>di</strong>tele sempre. La preghiera è il cibo dell‘anima, come il pane è il cibo del<br />
corpo» 433 .<br />
c. Ricor<strong>di</strong> per i santi sacramenti<br />
I sacramenti sono la via piú efficace per ricevere la grazia <strong>di</strong> Dio. Ogni sacramento è<br />
una manifestazione del desiderio <strong>di</strong> Dio <strong>di</strong> provvedere tutte le bene<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui ognuno ha<br />
bisogno per essere in comunione con Lui. «Frequentate i santi sacramenti piú spesso che potete,<br />
secondo il consiglio del vostro confessore» 434 . Tali grazie sono essenziali specialmente per i<br />
giovani che appena iniziano il loro lungo cammino <strong>di</strong> fede, ed è questo il motivo in base al<br />
quale Frassinetti incluse l‘importanza della vita sacramentale nella sua <strong>di</strong>rezione spirituale.<br />
Egli comunque, aveva affidato alla cure dei confessori e delle guide spirituali un sano<br />
in<strong>di</strong>rizzo riguardo alla santa Comunione e alla santificazione delle <strong>di</strong>verse feste. «Non vi<br />
trattenete <strong>di</strong> <strong>di</strong>re al vostro confessore che voi siete risoluta <strong>di</strong> essere tutta <strong>di</strong> Gesú; quanto piú<br />
egli conoscerà chiara la vostra buona intenzione a farvi tutta <strong>di</strong> Gesú, vi aiuterà tanto meglio» 435 .<br />
I sacramenti degnamente ricevuti e celebrati spesse volte con il consenso dei confessori,<br />
ci trasformano <strong>di</strong> piú nell‘immagine e nella somiglianza <strong>di</strong> Dio. Questo succede perché si riceve<br />
ed si incontra Dio stesso in persona. «Se tutti i giovani frequentassero i santi sacramenti quando<br />
loro è prescritto dal confessore, vivrebbero tutti col santo timor <strong>di</strong> Dio, e sarebbero tutti buoni<br />
cristiani» 436 . Egli insegnava ai suoi figli spirituali che vivere la vita sacramentale è vivere in<br />
santità. È un modo <strong>di</strong> stare in comunione con Dio in terra.<br />
d. Ricor<strong>di</strong> per la famiglia<br />
430<br />
Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú, 638.<br />
431<br />
T. AVILA, The way of perfection, translated by E. A. PEERS, Image Books E<strong>di</strong>tion, U.S.A. 1964, 150.<br />
432<br />
Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú, 639.<br />
433<br />
Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> un giovinetto cristiano, O.A., I, 656.<br />
434<br />
Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú, 640.<br />
435<br />
Ibid.<br />
436<br />
Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> un giovinetto cristiano, O.A., I, 655.<br />
105
Il Frassinetti conobbe il grande vantaggio <strong>di</strong> avere una buona famiglia, sicché la sua<br />
famiglia <strong>di</strong>ventò per lui scuola <strong>di</strong> santità. Era il primo luogo dove aveva imparato la via del<br />
Signore, perciò invitava i giovani a dare valore e voler bene alla loro famiglia e a trasformarla in<br />
un ambiente dove esercitare la vita virtuosa a cui aspirano. «Colle persone <strong>di</strong> casa siate sempre<br />
umili e ubbi<strong>di</strong>te a tutti, anche a quelli che non vi devono comandare, purché non vi coman<strong>di</strong>no<br />
cose <strong>di</strong> male» 437 .<br />
L‘amore ed affetto nella famiglia deve essere uguale per tutti. Il comportamento verso<br />
ciascun membro della famiglia deve essere benevolo anche con coloro che trattano l‘altro<br />
componente come un peso e lo considerano antipatico. «Se vedete che in casa siete tenuta come<br />
la serva <strong>di</strong> tutti e si fa conto <strong>di</strong> voi come si farebbe <strong>di</strong> uno straccio, persuadevi che davanti a Dio<br />
non meritate <strong>di</strong> piú; quin<strong>di</strong> non ne fate lamenti con nessuno; contentatevi <strong>di</strong> essere trattata<br />
cosí» 438 . Ovviamente questo non è un compito facile, ma l‘intenzione principale del Frassinetti<br />
fu <strong>di</strong> introdurre i giovani nella via <strong>di</strong> Dio. L‘umiltà acquisita in famiglia servirà come base<br />
solida nel relazionarsi con la gente alla quale Dio li invia come testimoni.<br />
d. Ricor<strong>di</strong> per l’umiltà ed onestà<br />
Giuseppe Frassinetti insegnava ai suoi figli spirituali l‘importanza dell‘umiltà ed onestà<br />
per progre<strong>di</strong>re nella vita spirituale. È molto importante conoscere la nostra indegnità davanti<br />
agli occhi <strong>di</strong> Dio. Dobbiamo impegnarci ad essere umili non solo in ciò che riguarda Dio ma<br />
anche in ciò che concerne altre persone in quanto ciascuno è un‘immagine <strong>di</strong> Lui. I ragazzi e<br />
giovani hanno bisogno <strong>di</strong> questa virtú per poter mettere tutta la fiducia in Dio. La vera umiltà va<br />
accompagnata con la fiducia in se stessi. Umile è colui o colei che con l‘aiuto <strong>di</strong>vino si impegna<br />
con tutta l‘energia <strong>di</strong> fare il meglio nella sua vita. «Fondatevi bene nell‘umiltà, riconoscendo<br />
che da voi stessa non siete capace a far niente <strong>di</strong> bene. Ma fondatevi anche bene nella<br />
confidenza, riconoscendo che coll‘aiuto <strong>di</strong> Dio siete capace a far tutto il bene» 439 .<br />
Un‘altra virtú importante per la crescita spirituale dei giovani in cammino nella<br />
perfezione è l‘onestà. «La santa onestà è la virtú che sommamente vi deve importare <strong>di</strong><br />
custo<strong>di</strong>re nella vostra bellissima età. Se voi custo<strong>di</strong>te bene in questi anni la santa onestà, avete<br />
gran fondamento <strong>di</strong> sperare che la custo<strong>di</strong>rete per sempre. Infatti, generalmente parlando, gli<br />
uomini che si trovano privi <strong>di</strong> questa virtú non l‘hanno perduta da gran<strong>di</strong>, ma da piccoli, cioè da<br />
giovani» 440 . La virtú dell‘onestà aiuta nella conquista delle altre virtú, è un‘arma importante<br />
contro le tentazioni. Un giovane sincero e integro conserva la sua anima da ogni illusione e<br />
opera ingannatrice del <strong>di</strong>avolo. «I giovani che custo<strong>di</strong>scono questa virtú, che è la piú bella <strong>di</strong><br />
tutte le altre, sono i pre<strong>di</strong>letti <strong>di</strong> Dio, i devoti piú cari <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima, i meglio custo<strong>di</strong>ti<br />
dagli Angeli santi; perciò sono quelli che devono godere della maggior abbondanza delle grazie<br />
<strong>di</strong>vine» 441 .<br />
L‘umiltà e l‘onestà sono le virtú fondamentali che ogni giovane deve impegnarsi a<br />
conquistare sia per il successo <strong>di</strong> ogni accompagnamento spirituale, ma soprattutto per lo<br />
sviluppo maturo della propria personalità.<br />
f. Ricor<strong>di</strong> per il timore <strong>di</strong> Dio<br />
Esiste un altro elemento importante nell‘insegnamento sulla <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong><br />
Giuseppe Frassinetti, ed è suscitare nel cuore <strong>di</strong> ogni giovane il santo timore <strong>di</strong> Dio. «Il santo<br />
timor <strong>di</strong> Dio è il fondamento e la base della cristiana perfezione, perciò è necessario alle anime<br />
anche piú <strong>di</strong>vote e piú sante» 442 . Questa virtú è il frutto <strong>di</strong> un grande rispetto ed amore per Dio.<br />
437<br />
Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú, 640.<br />
438<br />
Ibid.<br />
439<br />
Ibid.<br />
440<br />
Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> un giovinetto cristiano, O.A., I, 651-652.<br />
441<br />
Ibid., 652.<br />
442<br />
Il conforto dell‟anima <strong>di</strong>vota, O.A., I, 55.<br />
106
Questo timore che non è causato dal terrore o dalla paura, è uno dei sette doni dello Spirito<br />
Santo. «Il timore <strong>di</strong> Dio è il settimo dono dello Spirito Santo. È un timore per il grande amore<br />
per Lui: il timore <strong>di</strong> offenderlo. È stato chiamato anche timore del bambino secondo<br />
l‘insegnamento <strong>di</strong> san Tommaso e precisamente un bene dallo Spirito Santo» 443 .<br />
Perciò è una forza che custo<strong>di</strong>sce qualunque anima ad evitare tutto ciò ch‘è contrario<br />
alla volontà <strong>di</strong> Dio. «È il timore del peccato. Chi teme il peccato ha il vero timore <strong>di</strong> Dio; perché<br />
teme quel gran male che solo ci può far castigare da Dio. Dunque quando vi si <strong>di</strong>ce che temiate<br />
Dio, ecco che cosa vi si <strong>di</strong>ce: temete il peccato» 444 . È un timore che trasforma le anime in<br />
Cristo, perché lo scopo è <strong>di</strong> compiere solo ciò che è gra<strong>di</strong>to a Dio e <strong>di</strong> operare solo ciò che è<br />
buono per l‘anima.<br />
g. Ricor<strong>di</strong> per l’amore <strong>di</strong> Dio<br />
L‘ultimo elemento da considerare nella guida dei giovani è l‘amore <strong>di</strong> Dio. Piú che nelle<br />
parole e nel vuoto desiderio, essi si devono impegnare a testimoniare durante il loro cammino il<br />
vero significato dell‘amore cristiano. L‘amore <strong>di</strong> Dio, come ci insegna il Vangelo, si misura con<br />
l‘amore per il prossimo. L‘amore è l‘identità unica <strong>di</strong> ogni cristiano: egli è colui che ama e ama<br />
perché si sente amato. Egli è amato da Dio il cui nome è Amore! La santità cristiana allora non è<br />
altro che la pienezza dell‘amore. Santo e santa è colui o colei che ama. «L‘Amore <strong>di</strong> Dio, in<br />
sostanza altro non è che l‘uniformità della nostra con la volontà <strong>di</strong> Dio: <strong>di</strong> modo che se noi<br />
vogliamo ciò che vuole Dio, noi abbiamo l‘amore <strong>di</strong> Dio» 445 .<br />
È notevole perciò inculcare nei cuori e nelle menti dei giovani lo scopo o la mèta a cui<br />
devono tendere. «Il Signore vuol essere amato: per questo vi ha dato un cuore che è fatto per<br />
amare, e vi comanda <strong>di</strong> amarlo con tutto questo cuore» 446 . In ogni modo, dato che questo amore<br />
è reale e concreto, deve manifestarsi nella nostra vita concreta quoti<strong>di</strong>ana. «Il primo segno per<br />
sapere se un giovane è innamorato <strong>di</strong> Dio si può verificare dal Vangelo: coloro che mi amano<br />
seguono i miei comandamenti. Questo significa che solo coloro che veramente osservano i<br />
comandamenti amano Dio veramente» 447 . Il segno seguente come descriveva il Frassinetti è<br />
l‘applicazione attuale <strong>di</strong> questo amore. «I giovani che amano Dio compiono le opere ispirati<br />
dall‘amore <strong>di</strong> Dio. L‘amore <strong>di</strong> Dio è come un fuoco vivente. È sempre ardente mai ozioso. È<br />
sempre in azione. Piú che questo santo fuoco aumenta ed è perfezionato nel cuore, piú perfetto<br />
saranno le opere che possono essere realizzate per l‘amore <strong>di</strong> Dio» 448 .<br />
Per accompagnare i giovani a mettere in pratica questa con<strong>di</strong>zione, Frassinetti ancora<br />
una volta enfatizza il ruolo importante della guida spirituale perché non si lascino trasportare via<br />
dalle loro illusioni e il loro entusiasmo sia effettivamente guidato. «Vi sono tante cose che<br />
piacciono a Dio: le orazioni, i <strong>di</strong>giuni, le limosine; non siamo però certi che Dio voglia da noi<br />
quell‘orazione, quel <strong>di</strong>giuno, quella limosina; e perciò l‘amore <strong>di</strong> Dio, anche perfetto, non<br />
richiede da noi tutte le orazioni, tutti i <strong>di</strong>giuni, tutte le limosine possibili; ma soltanto quelle che<br />
una manifesta ragione, o il consiglio del nostro <strong>di</strong>rettore spirituale ci fa conoscere il volere <strong>di</strong><br />
Dio che noi le facciamo» 449 .<br />
Giuseppe Frassinetti sottolineava tutti questi elementi fondamentali per la formazione<br />
della coscienza dei giovani che desideravano trovare il senso della loro esistenza con l‘aiuto del<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale.<br />
2. Due mezzi privilegiati nella via alla Santità<br />
443<br />
G. FRASSINETTI, Esercizi spirituali per i giovinetti d‟ambo i sessi, 93.<br />
444<br />
Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú, 657.<br />
445<br />
Il Convito del <strong>di</strong>vino Amore, O.A., I, 343.<br />
446<br />
Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> un giovinetto cristiano, 658.<br />
447<br />
Esercizi spirituali per i giovinetti d‟ambo i sessi, 113.<br />
448<br />
Ibid., 116.<br />
449<br />
Il Convito del <strong>di</strong>vino Amore, O.A., I, 345.<br />
107
Per convincere i giovani che la santità non è un traguardo <strong>di</strong>fficile, il sacerdote<br />
Giuseppe Frassinetti ha loro in<strong>di</strong>cato due mezzi privilegiati da utilizzare per arrivare alla santità:<br />
l‘eucaristia e castità. La prima assicura la grazia <strong>di</strong> Dio che accompagna l‘uomo nel suo<br />
cammino e la seconda non è altro che la risposta dell‘uomo alla grazia ricevuta – una risposta<br />
che inclina a camminare sempre meglio nella via del Signore.<br />
a. L’Eucaristia e la comunione quoti<strong>di</strong>ana<br />
Il santo pastore ha sempre insegnato ai suoi figli spirituali che l‘Eucaristia è<br />
in<strong>di</strong>spensabile nella vita <strong>di</strong> ogni cristiano perché quando uno riceve la comunione, riceve Cristo<br />
nella sua vita. «Oh, se pensassimo che cosa sia il Santissimo Sacramento, che contiene il Corpo<br />
e il Sangue <strong>di</strong> Nostro Signore Gesú Cristo! Il Corpo e il Sangue dell‘Uomo-Dio! Quelle carni<br />
sacratissime, vive nella stessa vita <strong>di</strong> Dio! Il gran lavoro dello Spirito Santo! Il fiore del sangue<br />
purissimo della Vergine <strong>Maria</strong>! La manna <strong>degli</strong> Angeli e dei Santi! L‘infinita grazia d‘ogni cuor<br />
mondo! Il Sole del Para<strong>di</strong>so! La gloria dell‘universo! Il miracolo piú magnifico della <strong>di</strong>vina<br />
Sapienza, della <strong>di</strong>vina Potenza e della <strong>di</strong>vina Bontà! La vera gioia, la piena compiacenza del<br />
<strong>di</strong>vin Padre! Tutto il bello, tutto il buono, tutto il grande delle creature e del Creatore, in unità<br />
della Divina Persona!» 450 .<br />
La verità è che nessuno sarebbe degno <strong>di</strong> riceverla per tutto quello che è nella sua<br />
santità, ma Dio come padre desidera incontrare ogni figlio nell‘Eucaristia per <strong>di</strong>mostrare il suo<br />
grande amore per ognuno <strong>di</strong> noi. Ecco perché egli ha sempre insistito sull‘importanza <strong>di</strong><br />
ricevere la santa comunione frequentemente. «La Comunione quoti<strong>di</strong>ana ci fa <strong>di</strong>ventare<br />
santi» 451 .<br />
Nell‘Eucaristia riceviamo la grazia santificante <strong>di</strong> Dio. «È dogma <strong>di</strong> fede, che tutti i<br />
sacramenti nelle anime giuste accrescono la grazia santificante, piú che tutte le altre opere<br />
buone, ch‘esse possano fare; ma, fra tutti i sacramenti quello della Santissima Eucaristia<br />
l‘accresce in maggiore abbondanza. Essa, non solo è canale <strong>di</strong> grazia come tutti gli altri; ma ne<br />
ha in sé la stessa fonte e l‘autore, che è Nostro Signore Gesú Cristo» 452 . La grazia santificante è<br />
il sostegno dell‘anima nel cammino alla santità 453 . «La grazia santificante, che si chiama anche<br />
grazia abituale, è un dono soprannaturale <strong>di</strong> Dio, permanente e inerente all‘anima nostra per<br />
modo <strong>di</strong> abito, in forza del quale l‘uomo è fatto giusto e amico <strong>di</strong> Dio, e perciò, figlio adottivo<br />
<strong>di</strong> Dio, fratello <strong>di</strong> Gesú Cristo ed erede del para<strong>di</strong>so» 454 . È la stessa grazia che aiuta l‘anima ad<br />
acquisire le altre virtú necessarie per progre<strong>di</strong>re in una vita spirituale matura 455 .<br />
Nella sua vasta esperienza <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore spirituale, ha constatato i frutti nell‘anima <strong>di</strong> un<br />
cristiano derivati dalla <strong>Santa</strong> Comunione 456 . Ed ecco che egli invita gli accompagnatori spirituali<br />
450<br />
Ai fedeli <strong>di</strong>voti del ss. Sacramento, O.A., I, 413-414.<br />
451<br />
G. FRASSINETTI, Dissertazione sulla comunione quoti<strong>di</strong>ana, Tipografia della Gioventú, Genova 1867,<br />
70.<br />
452<br />
Il Convito del <strong>di</strong>vino Amore, 342.<br />
453<br />
―Il Frassinetti fu un apostolo ad litteram della chiamata universale della santità, per cui il cristiano in<br />
stato <strong>di</strong> grazia è veramente santo, e ha in sé l‘amore <strong>di</strong> Cristo: infatti non è stato creato per il timore ma<br />
per l‘amore‖ V. CACCIOTTI, Due brevi saggi frassinettiani, Centro Vocazionale G. Frassinetti, Roma<br />
1968, 28.<br />
454<br />
Il Convito del <strong>di</strong>vino Amore, 339.<br />
455<br />
«Ora da questo gran bene devono seguire altri beni. Corrispondono alla grazia santificante la carità<br />
<strong>di</strong>ffusa nel cuore dallo Spirito Santo, ne consegue, che accrescendosi nell‘anima la grazia, ivi pure<br />
accresca l‘amor <strong>di</strong> Dio; ed accrescendosi il <strong>di</strong>vino amore, crescano ezian<strong>di</strong>o tutte le virtú che sono a lui<br />
inseparabilmente congiunte, cosicché perseverando nella frequenza della comunione, avverrà che a poco<br />
a poco migliori la propria condotta, e vada insieme emendandosi dalle sue imperfezioni e veniali<br />
mancanze» G. FRASSINETTI, Dissertazione sulla comunione quoti<strong>di</strong>ana, 30.<br />
456<br />
«Questa poi è una verità pratica, della quale hanno continua esperienza i <strong>di</strong>rettori delle anime. Essi, tra<br />
coloro che sono assidui alla sacra Mensa, trovano buon numero <strong>di</strong> anime, le quali, quando a cosí <strong>di</strong>re,<br />
evitarono appena la tentazione che si avvicina, invece <strong>di</strong> percepirne quel senso <strong>di</strong> seduzione e <strong>di</strong> lusinga<br />
che tanto naturalmente sollecita il cuore, ne sentono e pena e schifo, e senza pur riflettervi, come avviene<br />
negli atti indeliberati… Cosicché i <strong>di</strong>rettori <strong>di</strong> certe anime non hanno alcun timore <strong>di</strong> vederle un dí<br />
macchiate del vizio impuro: non perché non possono peccare <strong>di</strong> questo vizio; ma perché, alla forza della<br />
108
a guidare le anime sotto le loro cure ad amare l‘Eucaristia e riceverla frequentemente,<br />
specialmente i giovani e gli adolescenti. «Adoperatevi dunque per invogliare alla Comunione<br />
frequente e quoti<strong>di</strong>ana tutte le anime che potete; invogliatene specialmente le anime ancora<br />
innocenti, dove Gesú troverà particolari delizie. Quei giovanetti, quelle giovinette che non sono<br />
ancora tiranneggiate dall‘amore del mondo, invogliatele della Comunione frequente,<br />
in<strong>di</strong>rizzatele a quei confessori che sono piú facili ad accordarla. La Comunione frequente fa<br />
santi i cristiani <strong>di</strong> qualunque età, fossero <strong>di</strong> già stati anche gran<strong>di</strong> peccatori: quanto piú farà santi<br />
gl‘innocenti» 457 .<br />
Comunque sia, la preparazione personale del penitente e la sua <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> ricevere<br />
la santa Comunione deve essere sempre sotto la guida del <strong>di</strong>rettore spirituale 458 . Giuseppe<br />
Frassinetti per il suo grande amore dell‘Eucaristia non ha soltanto invitato i suoi figli spirituali a<br />
ricevere la Comunione frequentemente ma anche a propagare la devozione per l‘Eucaristia,<br />
l‘adorazione perpetua. Tutto per guadagnare la salvezza dell‘anima che ha bisogno della<br />
misericor<strong>di</strong>a e grazia <strong>di</strong> Dio 459 .<br />
b. La castità e verginità<br />
Il secondo mezzo per raggiungere la perfezione o la santità è la castità e verginità 460 .<br />
«La castità è la virtú che ogni cristiano deve conquistare perché è il tipo <strong>di</strong> virtú che non si può<br />
nascondere nel nome dell‘umiltà, e secondo la pre<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> S. Vincenzo Ferrer, deve<br />
splendere in ogni angolo del mondo» 461 . È una delle tante grazie che si può acquisire dalla<br />
comunione quoti<strong>di</strong>ana.<br />
La castità è una virtú che spunta dal profondo desiderio <strong>di</strong> un‘anima innocente <strong>di</strong><br />
appartenere totalmente al Signore. Non è una virtú solo per i consacrati ma per ogni cristiano.<br />
La sua concreta realizzazione sta nell‘impegno <strong>di</strong> rispettare e vivere la propria sessualità<br />
secondo il proprio stato <strong>di</strong> vita, come un dono ricevuto da Dio. «La castità infatti, non solo<br />
genera un cuore puro che considera ogni cosa e le persone in Dio, ma produce anche nella<br />
persona la trasparenza della potenza e dell‘amore <strong>di</strong> Dio» 462 .<br />
La persona casta vive l‘amore evangelico che genera unità e comunione. La castità aiuta<br />
il cristiano a vedere l‘altro con gli stessi occhi <strong>di</strong> Dio. «Amanti <strong>di</strong> Gesú! Siate ecclesiastici o<br />
secolari, siate celibi o coniugati, siate giovani, siate vecchi; siate <strong>di</strong> qualunque con<strong>di</strong>zione,<br />
potete tutti accogliere la mia proposta, e in qualunque modo promuoverne l‘inseguimento,<br />
secondo i mezzi, secondo l‘opportunità, colle debite regole della prudenza cristiana, dalla quale<br />
deve essere sempre accompagnato lo zelo anche piú ardente della gloria <strong>di</strong> Dio e della salute<br />
delle anime» 463 .<br />
Egli ha sempre considerato la verginità come una virtú nobile. «Vi peritate dunque <strong>di</strong><br />
farvi apostolo della piú bella, della piú splen<strong>di</strong>da fra le cristiane virtú, quale è la santa<br />
grazia ch‘esse hanno da Dio, aggiungano una <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> animo per loro quasi cangiata in natura, per<br />
cui, ciò che agli altri è <strong>di</strong> solletico, per esse è <strong>di</strong> pena» Ibid., 351-352.<br />
457 Ibid., 404.<br />
458 «Parlando ora della frequenza, colla quale i cristiani devono accostarsi alla Mensa del Signore,<br />
comincerò dall‘accennarvi al principio, ciò che sarà la conclusione dell‘argomento: cioè che i cristiani<br />
devono accostarsi alla ss. Comunione colla frequenza cha sarà loro in<strong>di</strong>cata o permessa dai rispettivi<br />
<strong>di</strong>rettori spirituali, cioè dai loro confessori» Ibid., 371.<br />
459 «Chi fa ascendere in maggior copia al trono <strong>di</strong> Dio l‘incenso dell‘orazione, ne fa <strong>di</strong>scendere altresí in<br />
maggior abbondanza le misericor<strong>di</strong>e sugli uomini» Culto perpetuo ad onore del ss. Sacramento, O.A., I,<br />
407.<br />
460 «La verginità è un dono dello Spirito, che consacra tutto il nostro essere a Dio sommamente amato; è<br />
sorgente della nostra spirituale fecon<strong>di</strong>tà nel mondo, è mezzo efficacissimo per lo sviluppo integrale della<br />
nostra persona: è segno escatologico del regno futuro, se vissuta in pienezza e totalità, causa <strong>di</strong> gioia<br />
spirituale purissima» A. PIGNA, La <strong>di</strong>rezione spirituale nella vita religiosa, in A.A. V.V., Rivista <strong>di</strong> vita<br />
religiosa e <strong>di</strong>rezione spirituale, Anno XXXIX, Padri Carmelitani Scalzi, Roma 1985, 82<br />
461 G. FRASSINETTI, Manuale pratico del parroco novello, Tipografia della Gioventú, Genova 1902, 474.<br />
462 E. BIANCHI, Le parole della spiritualità, Rizzoli, Milano 1999, 148.<br />
463 Due gioie nascoste, 635.<br />
109
verginità» 464 . Il nostro <strong>di</strong>rettore spirituale ha sempre incoraggiato i giovani ad abbracciare la<br />
verginità per il bene della propria crescita spirituale. «Un cuore che meglio sia unito a Dio, e<br />
non debba <strong>di</strong>videre le proprie affezioni, resta senza dubbio piú inclinato alle opere <strong>di</strong> religione e<br />
<strong>di</strong> carità, e questa maggiore inclinazione ne deve facilitare l‘esercizio» 465 .<br />
La pratica della verginità è una maniera <strong>di</strong> vivere la propria sessualità per l‘amore del<br />
Vangelo e del Regno <strong>di</strong> Dio. «E notate, che veramente il vostro corpo deve essere considerato<br />
come santo, perché fu santificato nel Battesimo, nella Cresima, e viene santificato<br />
continuamente nella Santissima Comunione: oltre che, il vostro corpo, come l‘anima vostra, è<br />
cosa destinata per il Para<strong>di</strong>so» 466 . Sicuramente è una virtú da vivere da tutti i cristiani perché<br />
non si riferisce solo al corpo ma soprattutto alla purezza del cuore e dell‘anima. E per quanto<br />
riguardo la verginità del corpo egli ha sempre consigliato i giovani <strong>di</strong> conservare la virginità<br />
fino al giorno del matrimonio. «Infatti, devono osservare questa virtú tutte le fanciulle e tutti i<br />
giovani fino all‘età in cui trovino occasione <strong>di</strong> matrimonio» 467 . La fedeltà nell‘impegno <strong>di</strong><br />
vivere la castità aiuta un giovane a dare il giusto valore all‘amore, e lo aiuta a formare una<br />
personalità matura.<br />
La verginità non è una cosa negativa ed impossibile. È la virtú dei santi: sposati e<br />
consacrati. La persona che decide <strong>di</strong> abbracciare la verginità è uno che sceglie <strong>di</strong> vivere l‘amore<br />
<strong>di</strong> Dio, non l‘amore umano che spesso è schiavo dell‘egoismo. Dio ha sempre chiamato guide<br />
spirituali per i giovani per accompagnarli a vivere e godere la bellezza <strong>di</strong> questa virtú, ed ecco<br />
perché è fondamentale trovare un <strong>di</strong>rettore spirituale che accompagna i giovani a vivere la<br />
propria verginità.<br />
Conosceva bene le <strong>di</strong>fficoltà che un giovane può incontrare nel mondo per poter<br />
preservare la propria verginità, egli allora elenca i <strong>di</strong>versi mezzi a cui ricorrere come aiuto e<br />
sostegno: la pratica dell‘umiltà, la preghiera costante, i sacramenti, le mortificazioni, gli<br />
impegni contro la pigrizia, la sobrietà e devozione per la <strong>Santa</strong> Vergine. Far conoscere la vita<br />
dei santi è un altro mezzo efficace per aiutarli a desiderare sempre la verginità. «È da coltivare<br />
nei giovani la castità dello spirito, esponendo e facendo leggere ai medesimi gli esempi dei Santi<br />
che si mostrano piú amanti della perfetta castità, nonché <strong>di</strong> altri purissimi giovani dell‘uno e<br />
dell‘altro sesso, i quali, sebbene non canonizzati dalla Chiesa, si segnalarono in questa virtú» 468 .<br />
La castità e verginità secondo il Frassinetti sono elementi fondamentali che devono<br />
essere presenti nel programma <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale per i giovani. Perché sono veramente<br />
essenziali per arrivare alla santità.<br />
3. L’accompagnamento e il <strong>di</strong>scernimento vocazionale<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale è fondamentale per <strong>di</strong>scernere la propria vocazione 469 , è un altro<br />
elemento molto importante dell‘accompagnamento spirituale del sacerdote Giuseppe Frassinetti:<br />
egli ha scritto tante opere a proposito <strong>di</strong> questo argomento. Il buon Dio ha piantato in ogni cuore<br />
umano una vocazione e l‘uomo la deve scoprire e rispondere a questa chiamata per poter<br />
realizzare la pienezza della sua esistenza. Vivere la propria vocazione aiuta l‘uomo a conoscere<br />
la sua <strong>di</strong>gnità come immagine <strong>di</strong> Dio. Questa verità, lo aiuta a compiere il suo dovere come<br />
figlio <strong>di</strong> Dio ed amministratore della creazione, ma ha soprattutto il grande dovere <strong>di</strong><br />
collaborare per realizzare il grande progetto <strong>di</strong> salvezza <strong>di</strong> Dio per l‘umanità.<br />
464 Lettera sul celibato, O.A., I, 447.<br />
465 La gemma delle fanciulle cristiane, O.A., I, 514.<br />
466 Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú, 642.<br />
467 La gemma delle fanciulle cristiane, O.A., I, 514.<br />
468 Il Para<strong>di</strong>so in terra nel celibato cristiano, O.A., I, 489.<br />
469 «Inten<strong>di</strong>amo la <strong>di</strong>rezione spirituale vocazionale soprattutto in questo senso e con questo orientamento:<br />
come un servizio <strong>di</strong> lettura e rilettura, o <strong>di</strong> assunzione e ri-assunzione del proprio vissuto, che porti a<br />
scoprire il significato che esso già in parte ha e che l‘in<strong>di</strong>viduo – a sua volta – è chiamato a dargli, ovvero<br />
operazione che – dal punto <strong>di</strong> vista del contenuto – conduca il soggetto a evidenziare – constatare il bene<br />
o l‘amore ricevuto, per decidere <strong>di</strong> rispondere responsabilmente a questo amore» A. CENCINI, Direzione<br />
spirituale e accompagnamento vocazionale, a cura Centro Nazionale Vocazioni, E<strong>di</strong>trice Ancora, Milano<br />
1996, 23.<br />
110
La strada della santità comporta <strong>di</strong>verse tappe progressive, è molto importante che la<br />
persona conosca la sua missione se vuole perseverare ad arrivare alla sua destinazione che non è<br />
altro che la santità. Il buon <strong>di</strong>scernimento lo aiuta ad in<strong>di</strong>rizzare i suoi doni, talenti, sacrifici,<br />
prove e <strong>di</strong>fficoltà per perseverare nel suo cammino 470 . Il <strong>di</strong>rettore spirituale svolge un ruolo<br />
importante per il <strong>di</strong>scernimento vocazionale 471 .<br />
L‘età adolescenziale e giovanile è tempo favorevole per questo tipo <strong>di</strong> pastorale. «La<br />
<strong>di</strong>rezione spirituale è necessaria per la crescita e maturità dell‘in<strong>di</strong>viduo, ma esiste un momento<br />
della vita che è veramente in<strong>di</strong>spensabile e fondamentale, come nella vita adolescenziale e nella<br />
giovinezza, soprattutto nel momento in cui una persona decide lo stato <strong>di</strong> vita che vuole seguire<br />
e la vocazione da abbracciare» 472 . I giovani devono osservare con attenzione i vari segni<br />
positivi, gli aspetti che riflettono lo stato <strong>di</strong> vita che è piú adatto per loro 473 .<br />
Il <strong>di</strong>scernimento è soprattutto dono dello Spirito Santo. I giovani devono imparare ad<br />
invocare ed essere docili allo Spirito. Egli è colui che illumina e dona saggezza ai loro <strong>di</strong>rettori<br />
spirituali perché possano essere guide sicuri e prudenti. «Prega il buon Dio per ogni decisione<br />
da prendere, per poter sempre seguire la sua volontà, capita sotto l‘ispirazione <strong>di</strong>vina, ed essa sia<br />
confermata dal consenso del <strong>di</strong>rettore spirituale che lavora in te nel nome <strong>di</strong> Dio» 474 .<br />
La figura <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti come <strong>di</strong>rettore spirituale fu fondamentale nella vita dei<br />
tanti giovani nel suo tempo per la loro scelta vocazionale.<br />
Cerchiamo <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re i punti significativi dell‘accompagnamento spirituale del<br />
Frassinetti per <strong>di</strong>scernere la vocazione al sacerdozio, alla vita consacrata e del cristiano (laico)<br />
che vive nel mondo.<br />
a. Il <strong>di</strong>scernimento per il Sacerdozio<br />
Giuseppe Frassinetti ha subito capito dopo la sua or<strong>di</strong>nazione il ruolo fondamentale del<br />
sacerdozio per il cammino <strong>di</strong> santità <strong>di</strong> ogni cristiano. Il nostro <strong>di</strong>rettore spirituale non si è mai<br />
stancato <strong>di</strong> promuovere la grandezza della vocazione sacerdotale e si è impegnato<br />
personalmente a curare ed accompagnare i giovani sacerdoti nella loro preparazione e<br />
formazione. I primi che hanno guadagnato da questo impegno sono i suoi fratelli, senza<br />
<strong>di</strong>menticare tanti altri santi sacerdoti della Congregazione del Beato Leonardo.<br />
Domenico Fassiolo, uno dei suoi tanti figli spirituali, scrive nella biografia del<br />
Frassinetti : «Ho avuto la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> testimoniare la vita <strong>di</strong> una persona che è per me un<br />
maestro e guida nella giovinezza, e ho avuto anche il dono <strong>di</strong> convivere con lui per due anni.<br />
Durante questi anni, ho ascoltato con grande ammirazione i suoi insegnamenti ed approfon<strong>di</strong>to<br />
le sue opere, e che rimangono sempre nella mia memoria» 475 .<br />
Guidare il battezzato a scoprire la sua vocazione alla santità è il primo impegno del<br />
sacerdote. Siccome un cieco non può essere una guida per l‘altro cieco, è fondamentale che il<br />
sacerdote viva una vita degna della sua vocazione come immagine visibile <strong>di</strong> Cristo per il suo<br />
470<br />
«La <strong>di</strong>rezione spirituale, infatti, come abbiamo detto, è un‘esperienza spirituale e, piú precisamente, è<br />
una educazione alla libertà, al <strong>di</strong>scernimento spirituale e alla docilità allo Spirito Santo. Per questo c‘è un<br />
inizio, c‘è un itinerario a tappe, una crescita progressiva, un cammino or<strong>di</strong>nato e irreversibile a partire<br />
dalla realtà storica, ma con salti <strong>di</strong> qualità, con rottura <strong>di</strong> ritmo e forza anche con momenti conflittuali»<br />
M. COSTA, Direzione spirituale e <strong>di</strong>scernimento, E<strong>di</strong>zioni ADP, Roma 2000, 79.<br />
471<br />
«Sin dalle origini ciò che ha determinato il costituirsi della comunità religiosa è stato proprio il<br />
desiderio <strong>di</strong> mettersi alla scuola <strong>di</strong> un maestro spirituale. E tutte le forme <strong>di</strong> vita religiosa che lo Spirito ha<br />
suscitato lungo la storia esprimono la loro originalità anche nel modo <strong>di</strong> concepire e <strong>di</strong> praticare la<br />
<strong>di</strong>rezione spirituale» A. PIGNA, La <strong>di</strong>rezione spirituale nella vita religiosa, 85.<br />
472<br />
S. DE PIERI, Orientamento educativo e accompagnamento vocazionale, ELLEDICI, Torino 2000, 74.<br />
473<br />
«La guida spirituale si propone <strong>di</strong> promuovere delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> libertà interiore, per una concreta<br />
risposta ai valori cristiani. È una guida spirituale vista in ottica essenziale: aiutare le persone non solo a<br />
prendere coscienza dei valori, ma anche a viverli nella propria esistenza; non solo pensare bene, ma<br />
soprattutto agire bene» A. CENCINI, Direzione spirituale e accompagnamento vocazionale, 195.<br />
474<br />
G. FRASSINETTI, Colloqui per la novena <strong>di</strong> S. Angela Merici con orazione per la scelta dello stato,<br />
Tipografia della Gioventú, Genova 1862, 8.<br />
475<br />
D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vita del sac. Giuseppe Frassinetti, 8.<br />
111
popolo in pellegrinaggio in questa terra. La formazione dei giovani alla vocazione sacerdotale è<br />
in<strong>di</strong>spensabile perché un santo sacerdote produce santi fedeli 476 . «La Chiesa e la società, che<br />
senza la Chiesa non può avere buona esistenza, hanno bisogno <strong>di</strong> sacerdoti, senza dei quali non<br />
potrebbe sussistere la religione nei popoli; hanno bisogno <strong>di</strong> persone che coltivino i consigli<br />
evangelici; <strong>di</strong> persone che vivano <strong>di</strong>staccate dal mondo e abbiano zelo particolare per la gloria<br />
<strong>di</strong> Dio e pel bene dei loro prossimi; che siano pronte ad andare anche in capo al mondo per<br />
convertire gl‘infedeli e per coltivarli quin<strong>di</strong> nello spirito e incivilirli» 477 .<br />
Il sacerdote svolge un ruolo importante non solo nella <strong>di</strong>mensione spirituale della<br />
persona ma nella totalità della sua personalità: dell‘essere cristiano e nello stesso momento<br />
dell‘essere citta<strong>di</strong>no. È un ministero molto delicato che non è per tutti. La vocazione sacerdotale<br />
è un dono che viene dall‘alto. Discernere la vocazione al sacerdozio è un compito molto<br />
impegnativo, richiede tempo e tanti sacrifici. «Riguardo ad essi abbiamo specialmente pazienza;<br />
aspettiamo che l‘effetto segua la causa. Avremo molto che fare, egli è vero, per ottenere che i<br />
giovani vincano il riguardo umano per comunicarsi spesso; ma noi non risparmiamo per ciò<br />
fatica ed industrie» 478 .<br />
Il primo dovere <strong>di</strong> ogni sacerdote è <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare questi giovani che <strong>di</strong>mostrano una<br />
particolare attrazione per la Chiesa e per le cose <strong>di</strong> Dio, e se il sacerdote stesso non si sente<br />
adatto per tale compito <strong>di</strong> accompagnamento, lui stesso in<strong>di</strong>rizzi il giovane che può essere un<br />
possibile can<strong>di</strong>dato al sacerdozio ad un confratello preparato e piú esperto.<br />
La prima cosa da vedere in questo giovane è la sincerità del suo desiderio. Un‘altra cosa<br />
da osservare come segno positivo <strong>di</strong> tale desiderio è il comportamento verso l‘altro, soprattutto<br />
nel suo modo <strong>di</strong> rapportarsi con gli altri. «Quelli che hanno <strong>di</strong>mostrato un‘inclinazione <strong>di</strong> vivere<br />
la castità hanno la migliore <strong>di</strong>sposizione per il sacerdozio» 479 . Il <strong>di</strong>rettore spirituale dopo aver<br />
provato la sincerità del desiderio del giovane, deve poi impegnarsi ad educarlo nella fede. «Con<br />
zelo singolarissimo tu devi adoprarti nella coltura dei giovani che aspirano al santo ministero del<br />
quale tu sei insignito» 480 .<br />
Ha elencato delle proposte concrete per i giovani aspiranti al sacerdozio. Prima <strong>di</strong> tutto,<br />
è fondamentale che si impegnino ad avere la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> accostarsi alla comunione<br />
quoti<strong>di</strong>ana, è molto importante evitare letture, conversazioni e compagnie che possono causare<br />
l‘impurità del cuore, della mente e del corpo, devono essere assidui e costanti nella preghiera<br />
personale, e finalmente, devono avere una devozione particolare per la Vergine <strong>Maria</strong>.<br />
E ancora per poter sostenere tale desiderio, Giuseppe Frassinetti organizzava incontri <strong>di</strong><br />
formazione tra questi giovani per far crescere sempre <strong>di</strong> piú l‘amore per il sacerdozio. Sono<br />
state fondate tante pie associazioni per promuovere questo apostolato. «Finalmente promoviamo<br />
tutte le buone istituzioni e quelle in specialità che piú si confanno ai bisogni dei tempi.<br />
Soprattutto procuriamo <strong>di</strong> coltivare quei giovanetti <strong>di</strong> buona e pia indole, che danno speranza <strong>di</strong><br />
ecclesiastica vocazione. Questo è il supremo bisogno del giorno» 481 .<br />
b. Discernimento per la vita consacrata<br />
Il venerabile Giuseppe Frassinetti ha dato il suo contributo alla Chiesa aiutando tanti<br />
giovani a trovare la vocazione alla vita consacrata. «Tra la grande <strong>di</strong>versità dei doni, tutti coloro<br />
che sono stati chiamati dal Signore a vivere i consigli evangelici, e che si impegnano veramente<br />
a professarli nella fedeltà, offrono se stessi al Signore in modo speciale» 482 . Il metodo <strong>di</strong><br />
476 «C‘insegna la storia e l‘esperienza che il bene che fa un sacerdote pieno dello Spirito <strong>di</strong> Dio è grande,<br />
cosí da non potersi facilmente calcolare: e siamo persuasi che se nel popolo cristiano fossero molti <strong>di</strong> tali<br />
sacerdoti, si rime<strong>di</strong>erebbe alla maggior parte dei mali del mondo, e ci sarebbe un bene immenso per la<br />
gloria <strong>di</strong> Dio e per la salute delle anime» Proposti fatti per sé e per alcuni amici, 618.<br />
477 Due gioie nascoste, 632.<br />
478 Brevi parole ai sacerdoti fratelli, O.A., II, 608.<br />
479 G. FRASSINETTI, Sulla deficienza delle vocazioni allo stato ecclesiastico, Tipografia <strong>di</strong> Giovanni<br />
Ghianni, Oneglia 1870, 20.<br />
480 Gesú Cristo regola del sacerdote, 582.<br />
481 Brevi parole ai sacerdoti fratelli, 608.<br />
482 Vatican Council II, PC, n.1.<br />
112
Giuseppe Frassinetti come abbiamo già accennato si fonda nella sua unica passione per la<br />
santificazione delle anime 483 . Fu la ragione per cui egli ha cercato <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare tanti giovani a<br />
consacrare la loro vita totalmente al Signore.<br />
La vita religiosa è un bene per la Chiesa. I consacrati che vivono i consigli evangelici<br />
continuano la missione del Signore in terra. «La Chiesa poi e la società, specialmente in questi<br />
tempi, hanno bisogno <strong>di</strong> un gran numero <strong>di</strong> suore, vuoi della carità, vuoi del Sacro Cuore, <strong>di</strong> San<br />
Giuseppe, ecc. ecc., le quali, non parlando della nostra Italia, in tutta l‘Europa e in tutte le altre<br />
quattro parti del mondo, hanno a coltivare innumerevoli scuole, educandati, ospedali, prigioni<br />
ed ergastoli, e <strong>di</strong> piú devono in tanti luoghi prestare la loro opera ai missionari che si affaticano<br />
alla conversione delle genti» 484 . È per questa ragione che il nostro <strong>di</strong>rettore spirituale ha sempre<br />
insistito sull‘importanza dell‘accompagnamento spirituale dei giovani, che dopo la pratica della<br />
castità e verginità <strong>di</strong>mostrano il desiderio <strong>di</strong> abbracciare i consigli evangelici della povertà,<br />
castità ed obbe<strong>di</strong>enza per il regno <strong>di</strong> Dio 485 .<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti per il <strong>di</strong>scernimento della vita consacrata<br />
non solo ha prodotto tante sante consacrate per la Chiesa, ma anche tanti fondatori e fondatrici.<br />
Il primo esempio è la sua sorella stessa, santa Paola Frassinetti. Nell‘ambito maschile è nata<br />
anche una congregazione, i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>.<br />
È stata pubblicata ultimamente un‘operetta che rivela la santità del servo <strong>di</strong> Dio, il<br />
titolo è Fautore <strong>di</strong> santi 486 . L‘autore <strong>di</strong> questo libro ha scoperto <strong>di</strong> persona mentre era in terra <strong>di</strong><br />
missione tante congregazioni i cui fondatori e fondatrici hanno avuto il Frassinetti come maestro<br />
e <strong>di</strong>rettore spirituale.<br />
L‘impegno <strong>di</strong> promuovere l‘importanza e la grandezza <strong>di</strong> tale scelta vocazionale si può<br />
capire nelle sue tante opere e scritti. La monaca in casa 487 fu uno <strong>di</strong> questi in esso è evidente la<br />
de<strong>di</strong>cazione e passione del Frassinetti per la vita consacrata. Quest‘opera contiene non solo gli<br />
elementi fondamentali dell‘accompagnamento spirituale per la vita religiosa ma rivela un nuovo<br />
modo <strong>di</strong> vivere la consacrazione al Signore, la consacrazione secolare.<br />
Giuseppe Frassinetti ha proposto alcune considerazioni nel processo del <strong>di</strong>scernimento<br />
spirituale per la vita consacrata, alcune in<strong>di</strong>cazioni che coinvolgono il can<strong>di</strong>dato in prima<br />
persona ma anche il <strong>di</strong>rettore spirituale. Prima <strong>di</strong> tutto, la persona che desidera entrare nella vita<br />
religiosa deve aver vissuto una vita virtuosa e casta; deve avere il coraggio <strong>di</strong> staccarsi dalla<br />
propria famiglia, il che non vuol <strong>di</strong>re abbandonarla ma de<strong>di</strong>care totalmente la vita solo al<br />
Signore. Nel suo cuore deve avere la certezza che lui o lei appartiene al Signore e solo per Lui<br />
esiste, e perciò cerca sempre <strong>di</strong> impegnarsi ad evitare ogni occasione <strong>di</strong> peccato e guardarsi da<br />
ogni cosa che può allontanarlo dalla grazia e amore <strong>di</strong> Dio. Questo suo desiderio deve essere<br />
accompagnato dal grande impegno <strong>di</strong> aspirare sempre alla perfezione e santità, e deve essere per<br />
lui l‘unico e costante desiderio nel cammino <strong>di</strong> preparazione.<br />
483 «Per affrontare il tema della vita consacrata in Giuseppe Frassinetti bisogna tenere presenti alcuni dati<br />
fondamentali: in primo luogo il cuore della sua teologia spirituale e pastorale, rappresentato dall‘anelito<br />
ad una santità universale, considerata vocazione <strong>di</strong>vina ed insieme impegno della volontà umana; il<br />
secondo luogo la stima particolare per la castità perfetta, mezzo ascetico privilegiato <strong>di</strong> santificazione; ed<br />
infine il vissuto personale, da cui traspare la <strong>di</strong>mensione feconda dell‘esercizio virtuoso della castità<br />
sacerdotale: - una luce potentissima che ha illuminato la sua attività intellettuale e guidato la pastorale <strong>di</strong><br />
santificazione» M. F. PORCELLA, La consacrazione femminile. pensiero e prassi in Giuseppe Frassinetti,<br />
LAS, Roma 1999, 58.<br />
484 Due gioie nascoste, 632.<br />
485 «C‘è infatti chi presenta il volto paterno <strong>di</strong> Dio e il volto materno della Chiesa, <strong>di</strong> chi metta in gioco la<br />
propria vita, perché altri abbiano vita e speranza» GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, Vita<br />
Consecrata, 25 marzo 1996, n. 105, L‘Osservatore Romano, Città del Vaticano 1996, 184-185.<br />
486 Cfr. M. QUADRACCIA, Fautore <strong>di</strong> santi. E<strong>di</strong>zione Risonanze, Roma 2004.<br />
487 «Essere monaca in casa vuol <strong>di</strong>re: vivere nella propria casa e nella propria famiglia senza alcun affetto<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato per la medesima; praticare i consigli evangelici ed attendere al conseguimento della<br />
perfezione cristiana, cioè della perfetta santità. Essere monaca in casa vuol <strong>di</strong>re: fare nella propria casa e<br />
nella propria famiglia tutto ciò che si dovrebbe far in monastero, per consacrare a Dio tutta la propria<br />
persona, anima e corpo, onde vivere solamente per Lui, e non volere piú esistere, se non per dare a Lui<br />
gloria, gusto ed onore» La monaca in casa, O.A., II, 5.<br />
113
L‘aspirante deve contemplare e capire bene i consigli evangelici: il voto <strong>di</strong> povertà deve<br />
suscitare in lui o in lei non solo il <strong>di</strong>stacco dai beni materiali ma soprattutto lo spirito della<br />
povertà per il regno. Vivere in povertà è una scelta in uno stile <strong>di</strong> vita secondo il vangelo. Il voto<br />
<strong>di</strong> povertà significa anche ringraziare il Signore per ogni dono e bene della vita, ma poi <strong>di</strong>venta<br />
un impegno nel donare ogni bene per il bene dell‘altro. Perciò non è solo un vivere in semplicità<br />
ed essenzialità ma soprattutto un atteggiamento del cuore. Povero è colui o colei che <strong>di</strong>pende<br />
tutto dal Signore e dona tutto quello che ha agli altri.<br />
Non esiste una vita consacrata senza il voto <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza. L‘obbe<strong>di</strong>enza è l‘umiltà<br />
dell‘uomo consacrato che sottomette la propria volontà alla volontà <strong>di</strong> Dio per il regno. Per<br />
Giuseppe Frassinetti l‘obbe<strong>di</strong>enza è il fondamento della vita religiosa. Tutti devono obbe<strong>di</strong>re<br />
per <strong>di</strong>ventare santi; e sottolinea l‘importanza particolare <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>re al proprio <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale.<br />
Il cuore <strong>di</strong> ogni consacrato deve essere trasformato nel cuore <strong>di</strong> Gesú, perciò un cuore<br />
puro. Questo è il fondamento della castità per il regno. L‘uomo casto per il regno è un uomo che<br />
segue l‘esempio del maestro: avere un cuore in<strong>di</strong>viso e totalmente offerto per il regno ma che<br />
deve risplendere nel suo mondo esteriore, cioè nel suo modo <strong>di</strong> conversare e nel suo rapporto<br />
con gli altri.<br />
Oltre all‘osservanza dei consigli evangelici, ogni aspirante alla vita consacrata deve<br />
mirare anche ad acquistare le virtú dell‘umiltà, la mortificazione, l‘amore <strong>di</strong> Dio, l‘amore per il<br />
prossimo, lo zelo per le anime, l‘abbandono totale a Dio e l‘amore per la Croce. Queste virtú<br />
non sono solo necessarie ed essenziali per il personale progresso spirituale ma <strong>di</strong>ventano un<br />
bene grande e un eccellente esempio per gli altri giovani.<br />
Finalmente, Frassinetti ha proposto altri due mezzi per <strong>di</strong>scernere la vocazione alla vita<br />
consacrata: la amicizia spirituale e il metodo <strong>di</strong> vita. Il giovane ha bisogno del sostegno dagli<br />
altri giovani che con<strong>di</strong>vidono lo stesso desiderio. È anche fondamentale che chi inizia viva<br />
secondo un metodo <strong>di</strong> vita sotto la guida del suo <strong>di</strong>rettore spirituale 488 .<br />
c. Discernimento nella vita del cristiano laico<br />
Giuseppe Frassinetti ha creato e favorito la consacrazione laicale. «L‘apostolato del<br />
laicato è una parte fondamentale della missione salvifica della Chiesa» 489 . La santità non è solo<br />
una vocazione per i preti, suore e frati ma per tutti i cristiani battezzati. Egli sempre ha svegliato<br />
la sensibilità <strong>di</strong> tanti fedeli, sotto la sua guida, per impegnarsi a vivere la loro vocazione come<br />
cammino <strong>di</strong> santità. «La Chiesa e la società ora piú che mai hanno bisogno <strong>di</strong> cristiani e <strong>di</strong><br />
cristiane fervorose, anche secolari, che formino e mantengano dappertutto buone associazioni, le<br />
quali possano opporre alle cattive che da per tutto sono stabilite e piú che mai incoraggiate e<br />
protette; che promuovano ovunque le opere della religione e della carità, che ovunque sono<br />
osteggiate dallo spirito incredulo e sovversivo del secolo» 490 .<br />
Per promuovere la vocazione del cristiano laico, Giuseppe Frassinetti ha scritto Il<br />
religioso al secolo 491 . Quest‘opera contiene la sua dottrina dell‘impegno concreto che ogni laico<br />
cristiano deve avere per vivere la sua chiamata alla perfezione cristiana.<br />
488<br />
«Vorrei che vi persuadeste bene della necessità che avete <strong>di</strong> un buon <strong>di</strong>rettore, perché questa vi farà<br />
piú fervorosa del domandarlo a Dio, piú impegnata <strong>di</strong> fare buona scelta. Credete dunque, che senza un<br />
buon <strong>di</strong>rettore spirituale, or<strong>di</strong>nariamente, non si fa nulla, anche dalle anime desiderose <strong>di</strong> vivere bene: né i<br />
libri, anche i migliori, possono adoperarsi a supplirvi» Ibid., 64.<br />
489<br />
Vatican Council II, LG, n. 33.<br />
490<br />
Due gioie nascoste, 632-633.<br />
491<br />
«Qui si parla in genere dell‘uomo religioso, il quale può vivere anche in mezzo al mondo, o da solo, o<br />
in famiglia; e questi potrà definirsi: un uomo, tutto consacrato al culto <strong>di</strong> Dio, <strong>di</strong> modo che per quanto le<br />
necessità della vita, interamente si occupa delle cose spettanti al <strong>di</strong>vino servizio. Si <strong>di</strong>ce per quanto<br />
comportano le necessità della vita, perché dovendo vivere al secolo, dovrà attendere alla conservazione<br />
dei propri beni, all‘esercizio della propria professione, arte o lavoro, per procacciarsi il necessario<br />
sostentamento e per mantenersi nello stato in cui lo ha posto la <strong>di</strong>vina Provvidenza; e perciò dovrà<br />
occuparsi in molte cose che non riguardano imme<strong>di</strong>atamente il culto e il servizio <strong>di</strong>vino» Il religioso al<br />
secolo, O.A., II, 91.<br />
114
La prima considerazione è che ogni <strong>di</strong>rettore spirituale deve suscitare nei fedeli il<br />
desiderio della santità. Dal desiderio la guida deve procedere all‘invito a fare il cammino della<br />
conversione, ed infine, a perseverare in questo processo <strong>di</strong> accompagnamento con l‘impegno <strong>di</strong><br />
vivere una nuova vita in Cristo 492 .<br />
Questo desiderio <strong>di</strong> vivere in Cristo deve trasformare tutta la vita. Il cristiano laico vive<br />
nel mondo ma non per il mondo. Certamente, egli deve impegnarsi a contribuire al bene della<br />
società ma vive sotto l‘ispirazione del vangelo. Ogni fatica del suo vivere deve essere un passo<br />
sempre avanti per la vita eterna. Il cristiano laico chiamato alla santità è testimone dell‘amore <strong>di</strong><br />
Gesú per l‘umanità.<br />
Per <strong>di</strong>ventare un segno efficace della Chiesa come sacramento <strong>di</strong> salvezza deve<br />
osservare i consigli evangelici <strong>di</strong> povertà, castità ed obbe<strong>di</strong>enza. Certamente non nella maniera<br />
in cui li vivono le persone consacrate, ma secondo il suo stato <strong>di</strong> vita. Vive la povertà dello<br />
spirito; si impegna a rispettare e utilizzare ogni bene materiale per il servizio <strong>degli</strong> altri. La sua<br />
castità è testimoniata della sua capacità <strong>di</strong> vivere la propria sessualità secondo il piano <strong>di</strong> Dio.<br />
Finalmente, deve essere sempre <strong>di</strong>sponibile ad obbe<strong>di</strong>re alla volontà <strong>di</strong> Dio che passa sempre<br />
attraverso le persone designate da Dio con un particolare autorità.<br />
Ogni fedele deve sentire proprio l‘impegno della Chiesa per la salvezza delle anime. Ed<br />
ecco che si impegna con tutte le sue possibilità a contribuire a questa missione che può avere<br />
una espressione concreta con alcune iniziative <strong>di</strong> carità e <strong>di</strong>verse opere <strong>di</strong> pietà 493 . Il cristiano<br />
partecipa attivamente alla vita comunitaria e alle celebrazioni liturgiche come parte del popolo<br />
<strong>di</strong> Dio. «L‘iniziativa dei cristiani è particolarmente necessaria quando si tratta <strong>di</strong> scoprire, <strong>di</strong><br />
ideare mezzi per permeare le realtà sociali, politiche ed economiche delle esigenze della dottrina<br />
e della vita cristiana» 494 .<br />
Altre considerazioni per vivere la propria vocazione sono l‘amicizia spirituale, la<br />
preghiera personale, la comunione quoti<strong>di</strong>ana e la devozione per la Beata Vergine <strong>Maria</strong>.<br />
d. Devozione per la beata Vergine <strong>Maria</strong><br />
Nella <strong>di</strong>rezione spirituale il servo <strong>di</strong> Dio ha sempre dato importanza alla presenza <strong>di</strong><br />
<strong>Maria</strong> nel cammino <strong>di</strong> ogni giovane verso la santità. Egli fu uno <strong>di</strong> tanti ardenti promotori della<br />
devozione della Vergine <strong>Maria</strong>. Ha sottolineato il ruolo fondamentale <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> nell‘opera della<br />
salvezza che si è realizzata e si sta realizzando nella storia. «La letteratura mariana del<br />
<strong>di</strong>ciannovesimo secolo rivela la lotta fra gli strani movimenti mariani nella loro ascesa e <strong>di</strong>scesa<br />
per quanto riguarda la devozione alla Vergine <strong>Maria</strong> e anche il ruolo della Madre <strong>di</strong> Dio<br />
nell‘economia della salvezza che spesso viene contrastato per la sottolineatura della figura<br />
femminile, pericoloso nel cadere a promuovere il femminismo» 495 . Frassinetti fu il grande<br />
<strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> una autentica devozione della Beata Vergine <strong>Maria</strong>.<br />
<strong>Maria</strong> è dono <strong>di</strong> Dio per l‘umanità 496 . La sua missione <strong>di</strong> Madre <strong>di</strong> Dio continua nella<br />
storia come madre dell‘umanità. Ella è la mamma <strong>di</strong> ogni cristiano, una mamma che<br />
492<br />
«Tutti i vari campi della vita laicale rientrano nel <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> Dio, che li vuole come il luogo storico del<br />
rivelarsi e del realizzarsi della carità <strong>di</strong> Gesú Cristo a gloria del Padre e a servizio del fratelli» GIOVANNI<br />
PAOLO II, Esortazione Apostolica Christifidelis Laici, 30 <strong>di</strong>cembre 1988, n. 59, EDB, Bologna 1989, 95.<br />
493<br />
«No less fervent a zeal on the part of lay people for today; present circumstances, in fact, demand<br />
from the man apostolate infinitely broader and more intense» Vatican Council, AA, n. 1, 766.<br />
494<br />
CCC, n. 899..<br />
495<br />
S. DE FIORES, <strong>Maria</strong> sintesi <strong>di</strong> valori. storia culturale della mariologia, E<strong>di</strong>zioni San Paolo, Milano<br />
2005, 294.<br />
496<br />
«Tutto il bene che l‘infinita Divina Bontà ha sparso in tutte le opere della creazione, non uguaglia il<br />
bene che ha messo in <strong>Maria</strong>. Quin<strong>di</strong>, la sua innocenza, purità e can<strong>di</strong>dezza inarrivabile, va congiunta a<br />
tale ricchezza <strong>di</strong> pregi e <strong>di</strong> virtú, che non solo è la piú bella e la piú buona tra le opere della mano <strong>di</strong> Dio,<br />
ma tutte siffattamente le vince in bellezza e bontà, che non potersi tra quelli e <strong>Maria</strong> far paragoni»<br />
Amiamo <strong>Maria</strong>, O.A., II, 341-342.<br />
115
accompagna i figli per incontrare il suo <strong>Figli</strong>o Gesú. <strong>Maria</strong> è la madre <strong>di</strong> tutti i santi; la Janua<br />
Coeli! 497 .<br />
La Chiesa considera <strong>Maria</strong> la prima <strong>di</strong>scepola del Signore e madre spirituale <strong>degli</strong><br />
apostoli, è sicuramente la persona giusta ed esperta nelle cose <strong>di</strong> Dio e della santità. Nessuno<br />
conosce cosí bene Gesú come <strong>Maria</strong>, essendo sua madre; ed ecco perché è fondamentale avere<br />
un rapporto filiale con la Madonna per conoscere meglio, amare e seguire il Maestro. «Cerca <strong>di</strong><br />
immaginare tutto quello che fa una buona madre per i suoi figli, è la stessa cosa, oppure ancora<br />
meglio <strong>Maria</strong> può fare a noi, dobbiamo essere contenti <strong>di</strong> averla come madre» 498 .<br />
<strong>Maria</strong> è una mamma che non desidera altro che il bene dei suoi figli e siccome non<br />
esiste nulla <strong>di</strong> piú sublime in questo mondo che la santità, dunque <strong>Maria</strong> non desidera altro che<br />
tutti i suoi figli <strong>di</strong>ventano santi come lei. Questa è la vera ragione perché lei è sempre pronta ad<br />
intercedere e soccorrere ogni figlio o figlia che chiama il suo nome in aiuto 499 . «Sí, come lo<br />
splendore del sole fa scomparire gli splendori <strong>di</strong> tutte le stelle, cosí lo splendore delle grazie<br />
concedute a <strong>Maria</strong> fa scomparire lo splendore delle grazie <strong>di</strong> tutti i santi» 500 . È fondamentale<br />
allora avere una devozione speciale per la Vergine <strong>Maria</strong> 501 . «Quella devozione,che secondo san<br />
Tommaso, è totale offerta del cuore per tutto quello che è e per il servizio del regno, non è altro<br />
che lo stesso seme d‘amore che Dio ha piantato nel cuore <strong>di</strong> ogni uomo» 502 .<br />
La prima tappa per avere una devozione a <strong>Maria</strong> è <strong>di</strong> consacrare il proprio cuore a lei.<br />
Giuseppe Frassinetti in prima persona ha ricevuto il bene spirituale <strong>di</strong> questa pia pratica. Da<br />
parroco portava i bambini della sua parrocchia per fare la consacrazione alla Madonna. «La<br />
devozione che vi raccomando è la consacrazione dei vostri cuori durante la vigilia della festa<br />
della Madonna. Offriteli sull‘altare della Madre <strong>di</strong> Dio, offriteli tutti alla nostra mamma, perché<br />
lei possa curarli come una buona madre e vedrete che sicuramente lei accetterà i vostri cuori<br />
innocenti, li proteggerà nel suo onore e per la vostra consolazione» 503 .<br />
La vera devozione per la Madonna richiede da parte dei giovani due virtú fondamentali:<br />
l‘obbe<strong>di</strong>enza e la purità. Queste virtú sono necessarie per avanzare nel cammino della santità.<br />
«Eppure l‘obbe<strong>di</strong>enza è una virtú <strong>di</strong> cui abbiamo bisogno nell‘adolescenza, piú che in<br />
qualunque altra età della nostra vita; mentre in questa età siamo ancora privi dell‘esperienza<br />
delle cose del mondo; e quin<strong>di</strong> è necessario piú che mai, che siamo <strong>di</strong>retti e guidati da persone<br />
che questa esperienza si abbiano già acquistato» 504 .<br />
I giovani che desiderano onorare la Madonna devono chiedere al Signore la grazia della<br />
purità 505 . «L‘altra virtú, nella quale vi dovete segnalare per assicurarvi il piú tenero e prelibato<br />
amor <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, è quella che è rappresenta dalla stella piú brillante fra le do<strong>di</strong>ci che la coronano<br />
in Para<strong>di</strong>so e che nelle corone dei Santi in cielo è la perla piú luminosa. Di tale virtú<br />
497<br />
«Siffatta pre<strong>di</strong>zione s‘è avverata, non solo in quanto Nostro Signore ha preso carne in <strong>Maria</strong> e ne è<br />
<strong>di</strong>venuto suo figlio, ma ancora in quanto Ella ebbe un posto nell‘economia della Redenzione» J. H.<br />
NEWMAN, Janua Coeli. Me<strong>di</strong>tazioni mariane, E<strong>di</strong>trice Stu<strong>di</strong>orum, Roma 1942, 36.<br />
498<br />
G. FRASSINETTI, Esercizi spirituali pei giovinetti d‟ambo i sessi, 102.<br />
499<br />
«<strong>Maria</strong> il giar<strong>di</strong>no delle delizie <strong>di</strong> Dio è pure giar<strong>di</strong>no <strong>di</strong> delizie per tutti voi, anime pie, che nella<br />
coltura della sua devozione raccogliete fiori altrettanto fruttiferi che odorosi, quali sono specialmente<br />
quelli delle cristiane virtú» Mazzolino <strong>di</strong> fiori pel mese <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, O.A., II, 445.<br />
500<br />
L‟Ossequio piú gra<strong>di</strong>to a <strong>Maria</strong> Santissima <strong>Immacolata</strong>, O.A.,II, 396.<br />
501<br />
«Sí, cari fanciulli, la Madonna vi invita, la Madonna vi chiama, perché come vostra amorosa madre<br />
vuol farvi molto bene, prendersi grande cura <strong>di</strong> voi, provvedervi <strong>di</strong> quanto abbisognate e mettervi a parte<br />
delle sue preziose carezze, come le madri fanno per i loro amati figli» L‟offerta del cuore a <strong>Maria</strong><br />
Santissima, O.A., II, 465.<br />
502<br />
G. FRASSINETTI, La rosa senza spine. Memorie sulla vita della pia zitella Rosa Cordone, 53.<br />
503<br />
G. FRASSINETTI, La Devozione al santuario <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima Assunta in cielo, Stabilimento<br />
Tipografico Ligustico, Genova 1853, 25.<br />
504<br />
Avviamento dei giovinetti, 379.<br />
505<br />
«Ah, giovani cari, voi che per la semplicità del vostro cuore vi meritate in modo speciale la tenerezza<br />
del mio amore materno, custo<strong>di</strong>te con tutta la vostra attenzione la santa purità; è impossibile che<br />
v‘immaginiate quanto è preziosa! E in modo particolarissimo è preziosa nella vostra età. Io vi assicuro<br />
che se adesso la perdete, sarà <strong>di</strong>fficile che l‘acquistate mai piú, che se invece adesso ve la conserverete,<br />
non la perderete mai piú» Parole <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima ai suoi <strong>di</strong>voti, O.A., II, 407.<br />
116
comunemente non si conosce il gran valore; e tanto meno lo potete conoscere voi nella vostra<br />
età; ma per questo la dovrete voi stimare meno?» 506 .<br />
L‘amore per la Vergine <strong>Maria</strong> aiuta i giovani ad avere la forza <strong>di</strong> perseverare nel loro<br />
cammino <strong>di</strong> fede. Avendo una mamma che li accompagna devono chiedere la grazia <strong>di</strong> essere<br />
preservati dal peccato mortale, anche se si deve logicamente chiedere anche la grazia <strong>di</strong> non<br />
commettere i peccati veniali, ma specialmente devono chiedere l‘intercessione della Madonna<br />
per poter <strong>di</strong>scernere la propria vocazione. «La <strong>terza</strong> grazia che voi chiederete a <strong>Maria</strong>, sarà<br />
quella <strong>di</strong> conoscere lo stato a cui Dio vi chiama; grazia da cui <strong>di</strong>pende in tanta parte la vostra<br />
salvezza» 507 .<br />
La beata Vergine <strong>Maria</strong> non è solo la Madre <strong>di</strong> Gesú e madre dell‘umanità, ella è anche<br />
il modello eccellente della vera fede 508 . I giovani devono imparare da lei obbe<strong>di</strong>enza e<br />
perseveranza. «Per la sua piena adesione alla volontà del Padre, all‘opera redentrice del suo<br />
<strong>Figli</strong>o, ad ogni mozione dello Spirito Santo, la Vergine <strong>Maria</strong> è il modello della fede e della<br />
carità per la Chiesa» 509 .<br />
Nella vita della Madonna tutto è frutto della <strong>di</strong>sponibilità e fedeltà della volontà <strong>di</strong> Dio.<br />
I giovani devono mettersi alla scuola <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> per poter conoscere ed obbe<strong>di</strong>re al progetto <strong>di</strong><br />
Dio nella loro vita. Giuseppe Frassinetti ha elencato do<strong>di</strong>ci virtú da imitare usando la metafora<br />
delle stelle che adornano la sua corona: fede, speranza, l‘amore <strong>di</strong> Dio, religione, umiltà, castità,<br />
fortezza, povertà <strong>di</strong> spirito, carità fraterna, obbe<strong>di</strong>enza, misericor<strong>di</strong>a e modestia.<br />
«Nell‘imitazione <strong>di</strong> queste virtú sta la devozione piú grata a <strong>Maria</strong>, e piú vantaggiosa alle anime<br />
nostre» 510 .<br />
Assicurava i suoi giovani che le virtú ricevute attraverso l‘intercessione della beata<br />
Vergine <strong>Maria</strong> portano veramente il frutto desiderato nella loro vita. «Si vede pure che le anime,<br />
quanto piú crescono nelle cristiane virtú, tanto piú si perfezionano nella devozione a <strong>Maria</strong>» 511 . I<br />
giovani che desiderano la santità devono avere <strong>Maria</strong> come modello e madre.<br />
4. La Direzione spirituale <strong>di</strong> gruppo<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale è possibile anche in un gruppo <strong>di</strong> tante persone. «Or<strong>di</strong>nariamente<br />
consideriamo un processo <strong>di</strong> guida spirituale come un rapporto solo tra due persone: il <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale e la persona da guidare. Comunque, esiste anche l‘accompagnamento spirituale in un<br />
incontro <strong>di</strong> gruppo. Insieme il gruppo può mirare al <strong>di</strong>scernimento della volontà <strong>di</strong> Dio non solo<br />
per l‘attività del gruppo ma anche per il <strong>di</strong>scernimento in<strong>di</strong>viduale» 512 . È un altro metodo per<br />
accompagnare le anime nel cammino della perfezione. «La comunità in quanto sanior pars<br />
propone ed incarna i valori, aiuta tutti i membri per la sua realizzazione. Queste valori<br />
manifestano il <strong>di</strong>scernimento da decidere oppure il bene che possa essere guadagnato» 513 . È<br />
molto chiaro che questo tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione mira a sostenere ogni membro del gruppo per lo stesso<br />
scopo.<br />
Giuseppe Frassinetti conosce bene il valore che è nel cuore <strong>di</strong> ogni giovane, cioè<br />
l‘amicizia. Quest‘età segna un grande bisogno del gruppo per sentirsi accettato; un gruppo <strong>di</strong><br />
amici dove uno può con<strong>di</strong>videre i suoi sentimenti, interessi, sofferenze, sogni ma soprattutto i<br />
momenti decisivi nella propria storia. Infatti, egli descrive questa tappa come la primavera della<br />
vita, ma sa anche molto bene che è un momento molto delicato e pericoloso. Spesso tanti<br />
giovani si perdono per le cattive compagnie. Ed ecco che ha sempre consigliato a loro <strong>di</strong><br />
506<br />
Avviamento dei giovinetti, 379.<br />
507<br />
Ibid., 388.<br />
508<br />
«È il sí <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> per tutti i cristiani lezione ed esempio per fare dell‘obbe<strong>di</strong>enza alla volontà del Padre<br />
la via e il mezzo della propria santificazione» PAOLO VI, Esortazione Apostolica, <strong>Maria</strong>lis Cultis, 2<br />
febbraio 1974, n. 21, EN 5/66.<br />
509<br />
CCC, n, 967.<br />
510<br />
Le do<strong>di</strong>ci stelle ossia le virtú della B. V. <strong>Maria</strong>, O.A., II, 433.<br />
511<br />
Frutti del mese mariano, O.A., II, 439.<br />
512<br />
C. MICHAEL, An introduction to spiritual <strong>di</strong>rection, Paulist Press, U.S.A. 2004, 11.<br />
513<br />
A. GENTILI, Direzione spirituale e accompagnamento vocazionale, a cura CENTRO NAZIONALE<br />
VOCAZIONI, E<strong>di</strong>trice Ancora, Milano 1996, 99.<br />
117
scegliere bene i loro amici 514 . Frassinetti ha inventato una soluzione per questa <strong>di</strong>fficoltà; cioè<br />
ha organizzato associazioni e gruppi <strong>di</strong> amicizia sotto la guida <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rettore spirituale.<br />
Incoraggiò personalmente i giovani a creare un gruppo con lo stesso interesse e obiettivo:<br />
sostenersi ed aiutarsi uno l‘altro per il bene della propria crescita spirituale.<br />
Il gruppo <strong>di</strong> amici non è semplicemente un insieme <strong>di</strong> persone ma un incontro in cui i<br />
membri si impegnano tutti insieme a vivere la fede e a camminare verso la vocazione alla<br />
santità. Lo spirito che unisce l‘uno l‘altro è l‘amicizia spirituale. «L‘amicizia necessita <strong>di</strong> un<br />
rapporto ontologico, una comunione tra le persone, che promuovono e rendono l‘amore<br />
mutuale» 515 .<br />
L‘amicizia è una cosa che appartiene alla natura dell‘uomo, cioè l‘uomo ha bisogno<br />
dell‘altro per crescere. «Con questo, inten<strong>di</strong>amo la necessità dell‘uomo <strong>di</strong> amare e <strong>di</strong> essere<br />
amato. È un bisogno essenziale e fondamentale nella vita» 516 . Questa verità vale ancora <strong>di</strong> piú<br />
quanto si tratta <strong>di</strong> parlare della vita spirituale dell‘in<strong>di</strong>viduo. «Il mistero cristiano è un Dio che<br />
dona se stesso per noi ed entra nella nostra vita come amico. Questa parola è stata proclamata da<br />
Colui che ha creato i nostri cuori e che stimola la sete <strong>di</strong> offrire noi stessi senza limiti ad amare,<br />
e come frutto <strong>di</strong> questo amore riceviamo l‘infinito» 517 . L‘amicizia vera allora non può essere che<br />
un‘amicizia spirituale. È un tipo <strong>di</strong> amicizia che mira allo stesso obiettivo: la gloria <strong>di</strong> Dio e la<br />
salvezza delle anime.<br />
Giuseppe Frassinetti ha esercitato il suo ministero <strong>di</strong> guida spirituale anche con i gruppi<br />
<strong>di</strong> persone. Ha accompagnato i giovani sia in un grande gruppo nella forma <strong>di</strong> una associazione,<br />
sia <strong>di</strong> un piccolo gruppo nella forma dell‘amicizia spirituale.<br />
a. L’amicizia spirituale<br />
Giuseppe Frassinetti ha sempre sostenuto l‘importanza dell‘amicizia per i giovani e il<br />
bene che uno può guadagnare per la propria crescita umana e spirituale. Occorre però scegliere<br />
una buona amicizia ed evitare la cattiva compagnia. Ed ecco che personalmente invitava i suoi<br />
figli spirituali a creare un piccolo gruppo <strong>di</strong> amici: un‘amicizia spirituale. Era un metodo per<br />
assicurare che i giovani fossero in mani sicure. «Mentre dobbiamo amare singolarmente le<br />
anime che amano Dio, tra <strong>di</strong> loro dobbiamo amare <strong>di</strong> piú quelli con quali abbiamo un rapporto<br />
<strong>di</strong> amicizia spirituale affinché si possa crescere insieme nell‘amore <strong>di</strong> Dio» 518 . Questo suo<br />
insegnamento sull‘amicizia spirituale è stato ispirato dalla dottrina <strong>di</strong> santa Teresa<br />
sull‘amicizia 519 .<br />
L‘amicizia spirituale secondo il servo <strong>di</strong> Dio inizia con una buona selezione tra <strong>di</strong> loro<br />
nella libertà. Il gruppo deve avere non piú <strong>di</strong> cinque membri. Ogni membro del gruppo deve<br />
514<br />
«Voi facilmente intendete quali possono essere per voi i compagni cattivi. Sono tutti quelli che si<br />
abusano della vostra amicizia per istillarvi delle cattive massime contro la Religione, contro le cose sante,<br />
contro i ministri <strong>di</strong> Dio, contro la buona morale; quelli vi danno cattivi consigli, cattivi esempi; con le<br />
parole o colle opere cercano <strong>di</strong> ritirarvi dal bene, come sarebbe santificazione delle feste, dalla frequenza<br />
dei sacramenti, dalle sante congregazioni, dall‘adempimento dei doveri del vostro stato, e invece cercano<br />
<strong>di</strong> indurvi a una vita oziosa, <strong>di</strong>ssipata, scostumata, senza religione e senza timor <strong>di</strong> Dio» Ricor<strong>di</strong> per un<br />
giovinetto cristiano, 650.<br />
515<br />
C. MILLA, Direzione spirituale. Amicizia in Cristo?, Teresianum, Roma 1994, 34.<br />
516<br />
B. GOYA, Vita spirituale tra psicologia e grazia, EDB, Bologna 2001, 126.<br />
517<br />
C. MILLA, Direzione spirituale. Amicizia in Cristo?, 34.<br />
518<br />
G. FRASSINETTI, Le Amicizie spirituali. Imitazione da S. Teresa <strong>di</strong> Gesú, Tipografia della Gioventú,<br />
Genova 1870, 5.<br />
519<br />
«Ma ben <strong>di</strong>verso è l‘amore perfetto un primo moto <strong>di</strong> naturale sensibilità si prova anche qui; ma la<br />
ragione esamina subito se le prove <strong>di</strong> quell‘anima sono or<strong>di</strong>nate alla perfezione, come le supporta e si sa<br />
approfittare: prega il Signore che le conceda pazienza, e le faccia acquistare molti meriti. E se la vede<br />
rassegnata, nonché angustiarsene, se ne rallegra grandemente. È vero che pur <strong>di</strong> non vederla soffrire,<br />
amerebbe soffrire in sua invece, sempre inteso che gliene possa poi cedere il merito, ma non per questo si<br />
turba, né perde la sua pace. Il suo amore, insomma – e lo ripeto ancora – è una copia <strong>di</strong> quello che ebbe<br />
per noi il vero Amante Gesú» T. DI GESÚ, Cammino <strong>di</strong> Perfezione, in Opere, Postulazione Generale<br />
O.C.D., Roma 1963, 572.<br />
118
promettere <strong>di</strong> collaborare all‘unico obbiettivo: aiutare l‘altro nel suo cammino <strong>di</strong> santità. Se<br />
qualche membro perde tale scopo, è consigliato <strong>di</strong> lasciare il gruppo.<br />
L‘amicizia spirituale deve essere sotto la guida <strong>di</strong> un padre spirituale, e sarà lui stesso ad<br />
in<strong>di</strong>care ai giovani dei mo<strong>di</strong> o tappe per il loro cammino come gruppo. Il <strong>di</strong>rettore spirituale<br />
<strong>di</strong>rige gli incontri <strong>di</strong> gruppo ed interviene soprattutto quando si tratta <strong>di</strong> parlare <strong>di</strong> argomenti<br />
morali e altri temi <strong>di</strong> fede. Giuseppe Frassinetti ha proposto cinque requisiti come metodo <strong>di</strong><br />
vita del gruppo.<br />
Il primo, è la comunione quoti<strong>di</strong>ana e la frequenza al sacramento della penitenza sotto la<br />
<strong>di</strong>rezione del loro padre spirituale. Insisteva sempre sull‘importanza dell‘Eucaristia per ogni<br />
cristiano, ma in modo particolare per i giovani. I giovani hanno bisogno della grazia santificante<br />
<strong>di</strong> Dio per sostenere il loro desiderio <strong>di</strong> santità. La comunione quoti<strong>di</strong>ana aiuta loro ad evitare<br />
ogni pericolo nel cadere nel peccato.<br />
Ogni giorno, il gruppo deve de<strong>di</strong>care un momento <strong>di</strong> preghiera insieme che può essere<br />
vocale oppure mentale. Comunque, è compito sempre del padre spirituale <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care loro il tipo<br />
<strong>di</strong> preghiera piú adatto al loro stato d‘animo.<br />
Una volta alla settimana devono impegnarsi a compiere un atto <strong>di</strong> mortificazione da<br />
decidere insieme come gruppo. Devono scegliere un sacrificio da fare insieme per aiutare<br />
ognuno a <strong>di</strong>sciplinare i sensi e non cadere nelle tentazioni. Ognuno del gruppo deve aiutare<br />
l‘altro, ma si deve sempre riferire la scelta al padre spirituale e sarà lui a decidere.<br />
Frassinetti ha anche proposto che ogni giorno il gruppo debba incontrarsi per una lettura<br />
spirituale. Durante questo momento, ognuno con<strong>di</strong>vide la sua esperienza con gli altri, e come<br />
abbiamo accennato tutto sotto la <strong>di</strong>rezione del padre spirituale: è lui che deve scegliere i libri o<br />
le opere adatte per il gruppo. Dopo l‘incontro sono invitati poi a fare la visita al Santissimo<br />
Sacramento.<br />
L‘ultimo requisito da osservare come amici è che ogni giorno ogni membro deve<br />
chiedere a Dio tre grazie per se stesso e per ognuno dei componenti il gruppo. La prima grazia<br />
da chiedere al Signore è l‘umiltà; una profonda umiltà per accogliere la volontà <strong>di</strong> Dio. Pregano<br />
poi il Signore <strong>di</strong> essere sempre sostenuti soprattutto nel momento della prova e della tentazione.<br />
E finalmente devono pregare per la santa perseveranza.<br />
Una volta stabilito il loro metodo <strong>di</strong> vita, possono già scegliere il giorno e l‘orario<br />
dell‘incontro. Devono organizzare questa riunione nella casa <strong>di</strong> un membro del gruppo. Questo<br />
incontro è fondamentale per la loro crescita spirituale. Ognuno è responsabile della vita<br />
spirituale dell‘altro. Frassinetti ha anche sottolineato la correzione fraterna come elemento<br />
fondamentale dello spirito del gruppo. Ognuno si impegna a correggere l‘altro come gesto <strong>di</strong><br />
vera amicizia e amore fraterno 520 .<br />
b. Le associazioni <strong>di</strong> amici<br />
Giuseppe Frassinetti ha fondato tante associazioni per <strong>di</strong>verse attività <strong>di</strong> carità e pietà.<br />
Ognuno <strong>di</strong> questi gruppi nonostante la <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> servizi che compivano, mirava ad un unico<br />
obbiettivo: promuovere la chiamata universale <strong>di</strong> tutti alla santità. «Lo scopo <strong>di</strong> questa pia<br />
associazione è <strong>di</strong> educare i giovani ad imitare le gran<strong>di</strong> virtú <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>: la purezza, il timore <strong>di</strong><br />
Dio e la pratica delle pie devozioni» 521 . Frassinetti <strong>di</strong>rigeva tutti questi gruppi attentamente<br />
come buon pastore e prudente <strong>di</strong>rettore spirituale.<br />
Egli ha fondato una associazione per i sacerdoti. «Lo scopo è <strong>di</strong> incoraggiare tutto il<br />
bene che un sacerdote può contribuire a fare secondo la propria capacità e l‘occasione che glielo<br />
520 «Guardate bene che la vostra amicizia si conservi pura e spirituale, perché , come <strong>di</strong>ce San Giovanni<br />
della Croce nel luogo suddetto, quando l‘affezione non è pura spirituale, serve a raffreddare nell‘amore <strong>di</strong><br />
Dio, e ad allontanare la memoria; sicché quanto piú si pensa alla persona o persone alle quali si ha quella<br />
affezione, meno si pensa a Dio, e l‘anima ne sente un <strong>di</strong>sturbo, un rimorso, per cui può accorgersi che in<br />
quella amicizia altro non fa se non perdere del suo vero bene, che è Dio, e il Suo amore» G. FRASSINETTI,<br />
Le amicizie spirituali. Imitazione <strong>di</strong> S. Teresa <strong>di</strong> Gesú, 18.<br />
521 G. FRASSINETTI, Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> SS, sotto il titolo della Purità, Tipografia della<br />
Gioventú, Genova 1902, 3.<br />
119
permette nell‘esercizio del suo ministero» 522 . La congregazione del Beato Leonardo da Porto<br />
Maurizio è un esempio <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> accompagnamento spirituale. L‘obbiettivo principale <strong>di</strong><br />
questo gruppo è <strong>di</strong> promuovere la formazione culturale ed intellettuale dei sacerdoti per il bene<br />
dei fedeli. Li invitava ad organizzare incontri tra <strong>di</strong> loro. «Perché il gruppo funzioni, ogni<br />
incontro deve <strong>di</strong>ventare un momento <strong>di</strong> fraternità. Una volta a settimana possono riunirsi<br />
insieme nella casa del parroco per con<strong>di</strong>videre esperienze e proposte per il bene del loro<br />
ministero» 523 . Egli ha sostenuto con il suo intervento fraterno ed è stato sempre <strong>di</strong>sponibile a<br />
dare il suo contributo dottrinale per aiutarli 524 . «È una cosa sublime l‘esistenza <strong>di</strong> associazioni<br />
per i giovani in una parrocchia. I giovani che fanno parte nel gruppo devono avere un metodo <strong>di</strong><br />
vita sotto la guida del padre spirituale. Devono impegnarsi ad ascoltare la parola <strong>di</strong> Dio,<br />
partecipare attivamente alle celebrazioni liturgiche e mantenere l‘usanza virtuosa» 525 .<br />
Giuseppe Frassinetti ha esercitato il suo ministero <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore spirituale in tanti<br />
movimenti mariani, la maggioranza <strong>di</strong> questi erano composti prevalentemente da donne. Il suo<br />
metodo <strong>di</strong> accompagnamento spirituale è stato ammirevole e fruttuoso. Tanti <strong>di</strong> questi<br />
movimenti sono <strong>di</strong>ventati vere congregazioni religiose con approvazione pontificia. Queste<br />
congregazioni hanno preso la loro ispirazione <strong>di</strong> vita dalla dottrina del Frassinetti soprattutto<br />
per quel che riguarda la purità e la castità. «Fra tutte le altre osservazioni, è stato provato che<br />
l‘organizzazione delle pie associazioni che mirano alla devozione per la beata Vergine <strong>Maria</strong>,<br />
producono frutti <strong>di</strong> grazia e <strong>di</strong> santità» 526 .<br />
Tante altre associazioni sono state fondate e seguite paternamente dal Frassinetti allo<br />
scopo <strong>di</strong> educare i giovani nella fede cristiana. Come sempre, egli le ha seguite tutte anche<br />
in<strong>di</strong>vidualmente per non perdere il carisma del gruppo, ma soprattutto per seminare in ogni<br />
gruppo o movimento lo spirito evangelico e la passione per la santità.<br />
Giuseppe Frassinetti ha fondato una congregazione solo per i giovani <strong>di</strong> sesso maschile,<br />
i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>. Il 14 gennaio 1866, tre membri <strong>di</strong> questa associazione hanno<br />
deciso <strong>di</strong> vivere in comune e consacrare la loro vita per il Signore. Essi sono Pietro Olivari,<br />
Emanuele Pedemonte e Pietro Ghiglione 527 . Giuseppe Frassinetti li ha accolti nella sua<br />
canonica. Essi hanno deciso <strong>di</strong> aiutare i poveri giovani che avevano il desiderio <strong>di</strong> essere<br />
sacerdoti e sostenerli con tutto quello che guadagnavano con il loro lavoro. Sono <strong>di</strong>ventati i<br />
primi membri della congregazione fondata secondo la spiritualità del Giuseppe Frassinetti.<br />
5. Direzione spirituale e letture<br />
Il sacerdote Giuseppe Frassinetti ha anche svolto la sua <strong>di</strong>rezione spirituale attraverso le<br />
sue opere e scritti 528 . «La sua vita ne è una prova. Tutte le sue opere sono destinate per tutte le<br />
menti, anche per la gente semplice, e questo per rendere accessibile a tutti la via della santità,<br />
per offrire il cuore alla misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Dio e portare tutti specialmente i giovani a Gesú,<br />
l‘Eucaristia» 529 .<br />
522<br />
G. FRASSINETTI, Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici, Tipografia della Gioventú, Genova 1835, 3.<br />
523<br />
G. FRASSINETTI, Proposte agli ecclesiastici, Tipografia delle Letture Cattoliche, Pisa 1861, 2.<br />
524<br />
«È pur cosa della maggiore importanza il procurare unioni particolari per i buoni giovani e per le<br />
buone fanciulle, nelle quali sempre totalmente separate si coltivi il loro spirito nella pietà e anche nello<br />
zelo per i loro simili. L‘esperienza <strong>di</strong>mostra che sí gli uni come le altre, unendosi in apposite<br />
congregazioni, non solo fanno essi buon progresso nelle cristiane virtú, ma facilmente tirano al bene<br />
anche i loro simili» Industrie spirituali, O.A., I, 127.<br />
525<br />
G. FRASSINETTI, Manuale del parroco novello, 155-156.<br />
526<br />
G. FRASSINETTI, Pia unione dell‟<strong>Immacolata</strong>, Stabilimento Tipografico Ligustico, Genova 1855, 5.<br />
527<br />
Cfr. M. QUADRACCIA, Fautori <strong>di</strong> santi, 92.<br />
528<br />
«Vivono negli scritti che gli meritano l‘onore <strong>di</strong> uno tra i primi scrittori del secolo XIX, e che<br />
propagati in tutto il mondo in moltiplicate e<strong>di</strong>zioni continuano tuttora l‘opera sua <strong>di</strong> ristorazione morale<br />
informando alla vera vita cristiana tante anime bisognose <strong>di</strong> sano pascolo e <strong>di</strong> una guida amorosa e<br />
sicura» G. CAPURRO, Giuseppe Frassinetti e l‟opera sua, Tipografia della Gioventú, Genova 1908, 24.<br />
529<br />
E. F. FALDI, Il priore <strong>di</strong> S. Sabina. Il Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, Scuola Grafica Don Bosco,<br />
Genova 1964, 46.<br />
120
In quel tempo la cattiva stampa ha portato via tanti giovani dalla fede 530 . Attentamente<br />
e saggiamente come un padre non si è mai stancato <strong>di</strong> ricordare i pericoli che possano avere<br />
come effetto le cattive letture. «Nel leggere bisogna fare come si fa nel mangiare, se si sa che un<br />
cibo è velenoso, quel cibo non si mangia. Quando pare che sia velenoso, quantunque non si<br />
sappia <strong>di</strong> certo, nemmeno allora si mangia; perché nessuno vuol mangiare col pericolo <strong>di</strong><br />
avvelenarsi. Lo stesso si deve fare per le letture, le quali, se sono buone, sono cibo dell‘anima;<br />
se sono cattive, ne sono il veleno» 531 .<br />
Un altro motivo per questo suo impegno nel <strong>di</strong>rigere le anime attraverso le letture era <strong>di</strong><br />
aiutare i suoi confratelli sacerdoti che chiedevano il suo aiuto su alcuni argomenti dottrinali e<br />
pastorali. Scriveva per i confratelli sacerdoti con l‘intento sempre <strong>di</strong> curare i giovani.<br />
«Dobbiamo fare tutto il possibile per promuovere le letture istruttive che possono essere un<br />
grande aiuto per la formazione dei nostri giovani» 532 .<br />
Ogni opera od opuscolo del Frassinetti aveva lo scopo <strong>di</strong> guidare le anime verso la<br />
santità. Questo modo <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione abbracciava anche le anime piú lontane. «Le opere del<br />
Frassinetti sono conosciute popolarmente, anche se non era questa la sua intenzione, perché il<br />
suo cuore desiderava solo il bene delle anime e svegliare il suo lettore alla chiamata alla<br />
santità» 533 .<br />
Un‘altra caratteristica della sua <strong>di</strong>rezione spirituale attraverso le letture fu la saldezza<br />
della dottrina della fede. Ogni lavoro manifestava la sua buona preparazione e cultura per la<br />
Sacra Scrittura, i Padri della Chiesa, e gli insegnamenti dei santi. Ed ecco perché ha sempre<br />
guadagnato la stima e fiducia <strong>di</strong> tanti confratelli sacerdoti. I suoi scritti sono stati strumenti<br />
in<strong>di</strong>spensabili per tanti <strong>di</strong>rettori delle anime. «Nelle opere <strong>di</strong> Frassinetti è nascosta la sua<br />
profonda saggezza, derivatagli dai suoi trent‘anni <strong>di</strong> esperienza come confessore, quarant‘anni<br />
<strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o, tanti sacerdoti durante il suo tempo hanno riconosciuto il grande contributo <strong>di</strong><br />
Frassinetti per l‘aiuto ricevuto attraverso le sue opere e scritti» 534 .<br />
Quello che rende piacevoli le sue opere è il suo stile semplice, breve e la chiarezza nel<br />
proporre i suoi argomenti e spiegazioni. Il suo modo conquista la grande massa della gente<br />
semplice ma anche <strong>di</strong>venta un strumento valido per tanti pastori che si trovano nella <strong>di</strong>fficoltà<br />
ad esprimere la dottrina della fede con il linguaggio della gente. «Gli scritti ed opere del<br />
Frassinetti sono stati sempre raccomandati per la semplicità e chiarezza <strong>di</strong> stile, toccano nel<br />
profondo il cuore del suo lettore, e come conseguenza stimolano e producono entusiasmo per<br />
mettere in pratica tutto quello che insegna» 535 .<br />
Le opere del Frassinetti rivelano tutta la sua personalità e santità. Egli è veramente un<br />
uomo <strong>di</strong> Dio. Un uomo che ha de<strong>di</strong>cato tutta la sua vita al servizio del Regno. Un maestro dello<br />
spirito per la chiamata universale della santità. «Egli fu un santo pastore delle anime, morto per<br />
il mondo, vive solo per le sue pecore, ha offerto tutta la sua energia per il loro bene;<br />
consigliando quelli che erano nel dubbio, consolando gli afflitti, istruendo gli ignoranti. Non si è<br />
mai allontanato dal suo gregge. Ogni sorta <strong>di</strong> persone veniva per incontralo, da ogni città solo<br />
per essere illuminati dalla sua dottrina ed insegnamento. E hanno sempre trovato nella sua<br />
persona la figura <strong>di</strong> padre, maestro e consolatore» 536 .<br />
530 «Si osservi poi che l‘apostolato <strong>degli</strong> empi si adopera specialmente al sovvertimento della gioventú;<br />
perciocché essi, non senza qualche speranza <strong>di</strong> riuscirvi, aspirano a formare all‘empietà tutta la sorgente<br />
generazione. È per questo che la provvedono <strong>di</strong> libri iniqui o pericolosi, che procurano <strong>di</strong>vagamenti e<br />
sollazzi, i quali accrescano maggiormente la naturale leggerezza ed incostanza e ne sollecitano l‘incauto<br />
orgoglio, e cosí ad<strong>di</strong>venga ogni piú insubor<strong>di</strong>nata e scapestrata. Ora, noi a questa <strong>di</strong>sgraziata generazione<br />
che va sorgendo dobbiamo opporre una generazione pia e morigerata, che possa colle sue virtú<br />
contrappesare i vizi <strong>di</strong> quella, e si rende perciò necessario che coltiviamo con premure particolari la<br />
gioventú. Ad essa procuriamo buoni libri» Riflessioni proposte agli ecclesiastici, O.A., II, 528-529.<br />
531 Ricor<strong>di</strong> per un giovinetto cristiano, 649-650.<br />
532 G. FRASSINETTI, Proposta agli ecclesiastici, 5.<br />
533 A. PITTO, Il priore Giuseppe Frassinetti, A.F., I, 56.<br />
534 A. CAMPANELLA, Giuseppe Frassinetti. Priore in S. Sabina in Genova, A.F., I, 67.<br />
535 Il sacerdote Giuseppe Frassinetti priore <strong>di</strong> S. Sabina, A.F., I, 92.<br />
536 F. LUXARDO, Giuseppe Frassinetti. Pastore d‟anime. Autore <strong>di</strong> religiose istituzioni, scrittore <strong>di</strong> opere<br />
sacre, A.F., I, 73.<br />
121
6. Direzione spirituale e lettere<br />
Esiste un modo straor<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> guidare le anime, attraverso le lettere. Alcune persone,<br />
non potendo piú incontrarsi con il loro padre spirituale a causa <strong>di</strong> spostamenti non volontari o<br />
altre circostanze simili, chiedono <strong>di</strong> continuare la <strong>di</strong>rezione per lettera. Altre cercano <strong>di</strong> supplire<br />
con il <strong>di</strong>alogo epistolare alla <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> trovare nel luogo della nuova residenza una guida<br />
appropriata. La <strong>di</strong>rezione per lettera viene considerata sempre un mezzo straor<strong>di</strong>nario da usare<br />
eccezionalmente, solo dopo che è esistita prima una conoscenza vicendevole e un rapporto<br />
gratificante.<br />
Il sacerdote Giuseppe Frassinetti ha anche esercitato la pratica della <strong>di</strong>rezione spirituale<br />
attraverso le lettere. Queste lettere contengono la sua premurosa attenzione ad ogni figlio e<br />
figlia spirituale soprattutto nei loro momenti <strong>di</strong> prova e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà. Ogni lettera rivela la<br />
saggezza <strong>di</strong> un padre spirituale che non si è mai stancato <strong>di</strong> ricordare ai figli <strong>di</strong> continuare a<br />
combattere e perseverare nel cammino <strong>di</strong> santità.<br />
I primi destinatari <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> accompagnamento spirituale <strong>di</strong> Frassinetti sono la<br />
sorella Paola e i suoi fratelli. Paola fu chiamata a Roma dalla <strong>di</strong>vina Provvidenza per guidare le<br />
sue sorelle e rispondere all‘invito del Santo Padre <strong>di</strong> estendere il loro servizio in altri luoghi.<br />
Ella ha risposto imme<strong>di</strong>atamente in obbe<strong>di</strong>enza sotto la guida del fratello Giuseppe. Le sue<br />
lettere al fratello <strong>di</strong>mostrano un rapporto <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale. «Ho ricevuto le tue lunghe<br />
lettere, e ti ringrazio per tutti i consigli soprattutto per i casi molto critici. E senza dubbio che le<br />
tue ragioni sono giuste e ti assicuro la mia obbe<strong>di</strong>enza» 537 .<br />
Tutti i santi nella loro vita hanno avuto l‘esperienza del calvario come prova della fede.<br />
Giuseppe Frassinetti anche lui ha avuto l‘esperienza del suo Golgota. Fu l‘esperienza dell‘esilio.<br />
Questa è stata una sofferenza provvidenziale, perché proprio durante questo periodo Frassinetti<br />
ha scritto il suo capolavoro: Il Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia Morale, un‘opera che ha accompagnato<br />
la formazione <strong>di</strong> tanti sacerdoti ma soprattutto tanti guide spirituali <strong>di</strong> anime, ed in quel<br />
frangente ha esercitato la <strong>di</strong>rezione spirituale con le lettere. Egli ha sempre guidato i fratelli<br />
sacerdoti che lo hanno sostituito nella cura della parrocchia. «Quello che ti sto scrivendo adesso<br />
è <strong>di</strong> incoraggiarti <strong>di</strong> non temere e non avere paura, che possibilmente ti porta a <strong>di</strong>menticare il<br />
quaerite primum Regnum Dei. Era molto chiaro nella presente situazione la <strong>di</strong>gitus Dei, e non<br />
est alius pugnet pro nobis» 538 .<br />
Durante il periodo <strong>di</strong> questa grande prova ha continuato a seguire e guidare<br />
spiritualmente attraverso le lettere. «Per i <strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong> Cristo ogni cosa è desinata per un grande<br />
bene, non per interesse personale, ma dobbiamo sperare con grande convinzione che ogni<br />
sofferenza che affrontiamo nella nostra vita è sempre per il nostro bene. Ed ecco perché<br />
dobbiamo pregare e confidare nel Signore per una consolazione spirituale, accettando tutto<br />
come impegno <strong>di</strong> aderire sempre alla sua volontà, che è per il nostro bene» 539 .<br />
Le sue sono lettere <strong>di</strong> carattere familiare: non si è mai stancato <strong>di</strong> ricordare <strong>di</strong><br />
perseverare nel loro cammino <strong>di</strong> santità. «La tua lettera è una grande consolazione per me che<br />
rivela che il buon Dio ha messo nel tuo cuore il grande desiderio per la santità: questo desiderio<br />
che ti ha dato è un segno, è un grande dono che ti concederà nel futuro; perché Dio non ti da il<br />
desiderio se non ti darà la forza per poter realizzarla» 540 .<br />
Spesso le lettere sono <strong>di</strong> verifica del loro progresso spirituale. «Devi sempre offrire<br />
totalmente te stesso a Dio per poter sempre <strong>di</strong>scernere quello che il Signore vuole da te.<br />
Impegnati ad allontanare ogni tristezza nell‘anima. Non ti devi preoccupare se qualche volta<br />
ca<strong>di</strong>, abbi pazienza! Con l‘aiuto <strong>di</strong> Dio sono sicuro che riuscirai a superare tutto; coraggio,<br />
coraggio all‘obbe<strong>di</strong>enza» 541 .<br />
537<br />
Frassinetti, Lettere, Congregazione delle Suore <strong>di</strong> santa Dorotea della Frassinetti, Scuola Tipografica<br />
Italo-Orientali S. Nilo, Roma 1985, 886.<br />
538<br />
Ai fratelli sacerdoti, L.S., 5.<br />
539<br />
Alla signora contessa Carlotta Galli, L.S., p6-7.<br />
540<br />
Alla suora Carlotta Gibelli, L.S., 12.<br />
541<br />
Alla figlia Rosa Pedemonte, L.S., 25.<br />
122
Giuseppe Frassinetti ha anche seguito con le sue lettere <strong>di</strong> accompagnamento spirituale i<br />
gruppi ed associazioni da lui fondati. «Forse state esperimentando tanti dubbi interiori, l‘ansietà<br />
nell‘anima; vi conosco e <strong>di</strong>co <strong>di</strong> stare calmi: dovete essere sempre pronti, quando il Signore vi<br />
manderà alcuni croci da abbracciare. Ho una grande confidenza in Dio che sicuramente vi<br />
aiuterà; ed egli vi darà la grazia <strong>di</strong> fare tutto secondo la sua volontà. Solo in Dio viene ogni<br />
bene» 542 .<br />
Il servo <strong>di</strong> Dio fu un maestro dello spirito per la santità dell‘uomo nel suo tempo. La<br />
ricchezza della sua dottrina <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale rimane per la Chiesa fonte d‘acqua viva per la<br />
sua missione <strong>di</strong> salvare le anime.<br />
542 Alla figlia Angela Maccagno, L.S., 26.<br />
123
CAPITOLO QUARTO<br />
L’ATTUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO DEL SAC. GIUSEPPE FRASINETTI<br />
A. La situazione dei giovani nel nostro tempo<br />
La situazione dei giovani oggi non è paragonabile a quella del tempo <strong>di</strong> Padre Giuseppe<br />
Frassinetti. Possiamo descrivere il nostro tempo come periodo <strong>di</strong> progresso altamente<br />
tecnologico. Sviluppo questo che ha portato cambiamenti profon<strong>di</strong>: un nuovo modo <strong>di</strong> pensare e<br />
<strong>di</strong> vivere, ma ciò non significa che il cammino interiore è stato parallelo, anzi ci sembra <strong>di</strong><br />
assistere a un degrado morale. «L‘uomo d‘oggi è privato <strong>di</strong> casa, vive in un campo aperto in<br />
cerca del proprio orientamento» 543 . Anche se il mondo contemporaneo sembra <strong>di</strong>mostrare il suo<br />
potere con il progresso tecnologico, in realtà, è vuoto ed è in crisi <strong>di</strong> senso 544 .<br />
Da questa situazione generale dobbiamo cercare <strong>di</strong> capire la situazione del mondo<br />
giovanile d‘oggi. «La generazione giovanile è frutto del suo tempo, cosí ieri come oggi. Non c‘è<br />
una <strong>di</strong>stinzione chiara tra il mondo dei giovani e la società. Parlare <strong>di</strong> loro, dei loro<br />
atteggiamenti e contestazioni, significa, in un certo modo, riflettere il tipo <strong>di</strong> società a cui<br />
appartengono» 545 .<br />
La presente complicata situazione crea due tendenze nella generazione giovanile. La<br />
prima si manifesta nei giovani stanchi e delusi 546 . Questo modo <strong>di</strong> essere è causato delle<br />
cosiddette complicazioni sociali. La presente società offre loro dei valori ambigui e idee<br />
contrad<strong>di</strong>ttorie sul mondo e sulla vita stessa. Sono confusi. Non sanno che cammino<br />
intraprendere, quin<strong>di</strong> sono delusi <strong>di</strong> questa società che non fornisce <strong>degli</strong> orientamenti cre<strong>di</strong>bili<br />
per la crescita e sviluppo. Questa tendenza a sua volta produce due reazioni estreme. La prima<br />
si manifesta nella aggressività e nella ribellione: sorgono gruppi <strong>di</strong> reciproco sostegno con i<br />
quali identificarsi. Normalmente si tratta <strong>di</strong> ideologie fatue e per lo piú <strong>di</strong>mostrative che servono<br />
per attrare qualche attenzione. La seconda è il chiudersi in se stessi, in una in<strong>di</strong>fferenza<br />
personale e sociale, in un regresso nel privato 547 . Si <strong>di</strong>venta cechi e sor<strong>di</strong> all‘ambiente esterno e<br />
si vive in un mondo virtuale a propria misura; i mezzi tecnici o<strong>di</strong>erni: computer, musica,<br />
cellulare, internet e altri innovazioni tecnologiche aiutano in questa fuga.<br />
Il mondo giovanile <strong>di</strong> oggi non è però una trage<strong>di</strong>a totale. Esistono anche dei giovani in<br />
cerca della verità e della vera felicità. Vogliono scoprire il senso e significato della loro vita e<br />
del mondo in cui si trovano. Questa tendenza a sua volta può produrre due reazioni. La prima<br />
reazione è rappresentata da una ricerca della verità e felicita nel modo sbagliato: la generazione<br />
giovanile che spende e spreca il tempo, energia e sol<strong>di</strong> per il piacere <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ato consumo,<br />
droga, alcool e tanti altri tipi <strong>di</strong> deviazioni. Una seconda in chi insegue una religiosità vaga fatta<br />
<strong>di</strong> sogni ideologici e filosofico-religiosi: <strong>di</strong>scepoli della Nuova Era (New Age) 548 , sette<br />
sataniche e tante altre denominazioni.<br />
543<br />
S. CURRÒ, Il giovane al centro. Prospettive <strong>di</strong> rinnovamento della pastorale giovanile, <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> San<br />
Paolo, Milano 1999, 11.<br />
544<br />
IBID, «La cultura attuale è attraversata profondamente da un senso <strong>di</strong> crisi e <strong>di</strong> smarrimento, che tocca<br />
non soltanto aspetti periferici del pensare e del vivere ma le sue stesse strutture».<br />
545<br />
M. SANTORO, Silenzio nel mondo giovanile d‟oggi, in Dio Parla nel silenzio, a cura F. LAMBIASI – et,<br />
al., E<strong>di</strong>zioni del Teresianum, Roma 1989, 127.<br />
546<br />
«I giovani continuano a interrogarsi e cercano una con<strong>di</strong>visione che rafforzi la loro identità, poiché<br />
sentono fragili e mutevoli gli appoggi della società dei consumi» M. TONDO, Di fronte al progetto <strong>di</strong> vita.<br />
Un percorso formativo con i giovani, EDB, Bologna 2005, 33.<br />
547<br />
«Questa tendenza alla soggettivazzazione, <strong>di</strong> cui l‘in<strong>di</strong>vidualizzazione è un volto, che caratterizza il<br />
mondo giovanile è presente anche nel mondo adulto, anche se in modo meno evidente e leggibile, perché<br />
essa è il frutto dell‘intreccio <strong>di</strong> quei fenomeni culturali, sociali e psicologico – esistenziali che sono<br />
all‘origine dell‘attuale particolare fase della modernità che qualcuno chiama submodernità» M.POLLO, Le<br />
sfide educative dei giovani d‟oggi, ELLEDICI, Torino 2003, 8.<br />
548<br />
«Il New Age crede nella perfettibilità della persona umana per mezzo <strong>di</strong> una vasta gamma <strong>di</strong> tecniche<br />
e terapie in contrasto con la visione cristiana della cooperazione con la grazia <strong>di</strong>vina. In generale<br />
concorda con Nietzche, secondo il quale il cristianesimo ha impe<strong>di</strong>to all‘umanità autentica <strong>di</strong> manifestarsi<br />
pienamente. La perfezione, in questo contesto, significa raggiungere l‘autorealizzazione, secondo un<br />
124
C‘è chi cerca la verità e la felicita nella fede in Dio. Sono pochi e in pericolo. Questa è<br />
la sfida principale della situazione giovanile nel nostro mondo d‘oggi.<br />
B. Urgenza e necessità per la pastorale giovanile d’oggi<br />
La riflessione sulla situazione attuale della generazione giovanile è un appello della<br />
necessità della loro formazione. «Nel processo della crescita, il giovane è nella tappa <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scernimento dei valori, il <strong>di</strong>scernimento della sua identità e intimità con gli altri, il desiderio<br />
verso l‘in<strong>di</strong>pendenza e la responsabilità sociale» 549 . La generazione giovanile d‘oggi ha bisogno<br />
<strong>di</strong> una guida, un punto <strong>di</strong> riferimento nel cammino. Ha bisogno <strong>di</strong> persone che la accompagnano<br />
nella crescita per arrivare alla maturità della propria personalità 550 . I giovani stanno cercando la<br />
loro identità e anche il ruolo che devono svolgere nella società, ma soprattutto desiderano<br />
scoprire il senso della propria esistenza e la strada giusta per la vera felicità; <strong>di</strong> qui la necessità<br />
della <strong>di</strong>rezione spirituale e anche <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettori spirituali. C‘è l‘urgenza <strong>di</strong> sacerdoti, <strong>di</strong> uomini e <strong>di</strong><br />
donne capaci <strong>di</strong> ascoltare e collaborare con l‘aiuto dello Spirito Santo a questa missione.<br />
1. Il bisogno della <strong>di</strong>rezione spirituale<br />
Uno dei tanti mezzi che la Chiesa utilizza per guidare le anime è la <strong>di</strong>rezione spirituale.<br />
La situazione attuale manifesta il bisogno <strong>di</strong> riscoprire l‘importanza <strong>di</strong> tale ministero per il<br />
cammino <strong>di</strong> fede <strong>di</strong> ogni cristiano. «C‘è una necessità urgente d‘una <strong>di</strong>rezione spirituale oggi,<br />
causata dagli insegnamenti dei concili e l‘esigenza del laicato, che sta scoprendo e maturando il<br />
proprio ruolo vitale nella formazione dei nuovi cristiani, e dall‘altra parte, saranno essi<br />
responsabili nel dare al mondo contemporaneo i tratti dell‘immagine <strong>di</strong> Cristo» 551 . Questa<br />
necessità è piú manifesta tra la generazione giovanile che lotta per imparare dagli adulti ad<br />
assumere valori che sono utili alla loro formazione. «I giovani, per crescere hanno bisogno <strong>di</strong><br />
una guida constante per essere anche constanti a se stessi senza cadere nel scoraggiamento, che<br />
è molto comune alla loro età; sarebbe la cosa peggiore se perdessero il senso della loro<br />
esistenza. Il modo migliore per aiutarli è quello <strong>di</strong> iniziarli alla <strong>di</strong>rezione spirituale, che li aiuti a<br />
valorizzare la fede, la preghiera, i sacramenti, la chiesa e li prepari allo stato <strong>di</strong> vita a cui sono<br />
chiamati, compiendo responsabilmente la scelta corrispondente» 552 .<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale tra i giovani d‘oggi deve essere esercitata prudentemente e con il<br />
buon senso 553 , prendendo in considerazione il momento <strong>di</strong>fficile della loro crescita. Si può<br />
or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> valori che noi stessi creiamo e che otteniamo con le nostre forze. Si può quin<strong>di</strong> parlare <strong>di</strong> un sé<br />
che si auto crea» PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA E PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO<br />
INTERRELIGIOSO, Gesú Cristo portatore dell‟acqua viva. Una riflessione cristiana sul “New Age”,<br />
Paoline, Milano 2003, 43; «The emphasis in New Age Psychology is self-actualization of innate human<br />
potential. Christianity emphasizes our innate inability to please God because of selfishness at the root of<br />
our being, but it does stress the potential of God‘s grace to transform in<strong>di</strong>viduals into the image of Christ,<br />
to become new creationS. This indeed requires the transpersonal <strong>di</strong>mension not in the sense of confusing<br />
deity with humanity – because God, the Supreme Person, transcends our limitations and offers us hope,<br />
through Christ, for positive psychological change in this life and perfection in the next» D. R.<br />
GROOTHUIS, Unmasking the New Age, Intervarsity Press, England 1986, 90-91.<br />
549<br />
S. CURRÒ, Il giovane al centro. Prospettive <strong>di</strong> rinnovamento della pastorale giovanile, 134.<br />
550<br />
«Ma ciò non è né facile né scontato, soprattutto per i giovani che vivono in maniera ambivalente la<br />
realtà della crescita nell‘attuale società che tende a prolungare oltre il dovuto i tempi <strong>di</strong> maturazione e <strong>di</strong><br />
assunzione <strong>di</strong> responsabilità. Ne sono interessanti in<strong>di</strong>catori, osservati prevalentemente negli adolescenti,<br />
la voglia <strong>di</strong> crescere e nello stesso tempo il ritorno a comportamenti e atteggiamenti <strong>di</strong> stampo<br />
chiaramente regressivo» Ibid., 195-196.<br />
551<br />
S. RIVA, La <strong>di</strong>rezione spirituale nell‟età dello sviluppo, Quiriniana, Brescia 1967, 225.<br />
552<br />
A. BALLESTRERO, Giovani verso Cristo: mete e itinerari per la pastorale giovanile, ELLEDICI,<br />
Torino 1986, 22.<br />
553<br />
«È chiaro che la <strong>di</strong>rezione spirituale non è l‘infilare i giovani, con una specie <strong>di</strong> prepotenza morale, in<br />
una strada preconcetta da chi, del resto, non possiede neppure la topografia del regno <strong>di</strong> Dio, è invece,<br />
l‘arte <strong>di</strong> far intervenire coor<strong>di</strong>nare, dosare, gli elementi utili perché – ogni vita raggiunga il suo intento,<br />
125
descrivere con questa analogia. «È come per cercare l‘oro. Arriva la persona da guidare e<br />
incontra il <strong>di</strong>rettore, insieme si immergono nell‘acqua del fiume della sua vita, tirano su tante<br />
cose: pietre e sassi <strong>di</strong> ogni tipo e misura – non si sa che può succedere dopo – tutti i conflitti,<br />
problemi, sofferenze, ma ad un tratto emerge qualche pepita d‘oro puro mentre si naviga in giro,<br />
svuotando solo le pietre» 554 .<br />
Un‘altro ruolo importante della <strong>di</strong>rezione spirituale per i giovani è la sua applicazione<br />
nella vita concreta. «É compito della <strong>di</strong>rezione spirituale aiutare i giovani a vivere con un senso<br />
religioso. La spiritualità non può essere separata dalla vita reale, ed è proprio in questo ambito<br />
che devono essere aiutati nel decidersi a vivere da cristiani» 555 .<br />
La situazione presente necessita <strong>di</strong> una <strong>di</strong>rezione spirituale che si adatta alla situazione<br />
dell‘uomo d‘oggi. Generalmente l‘accompagnamento oggi è <strong>di</strong>retto a un giovane che soffre,<br />
confuso e nella ricerca <strong>di</strong> qualche speranza per il suo futuro, che, con tutti i suoi <strong>di</strong>fetti e<br />
fragilità, deve raggiungere la meta. «Ogni incontro spirituale, non viene solo dal piano <strong>di</strong><br />
salvezza, dove il <strong>di</strong>rettore e la persona guidata agiscono sotto la guida dello Spirito santo, ma è<br />
concretamente orientato alla inclusione perfetta nel piano <strong>di</strong> salvezza, attraverso una decisione<br />
concreta che perfeziona il progetto della vita» 556 .<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale oggi deve aiutare i giovani a riscoprire l‘importanza della<br />
presente tappa della loro vita spirituale, quin<strong>di</strong> deve essere condotta continuamente<br />
nell‘acquisizione dei valori e nel prendere una decisione. «Una delle profonde speranze della<br />
<strong>di</strong>rezione spirituale è quella <strong>di</strong> rendere possibile alle persone <strong>di</strong> riscoprire quello che sono<br />
chiamate a fare, come possono veramente utilizzare il loro tempo ed energie» 557 .<br />
2. Il bisogno della figura del <strong>di</strong>rettore spirituale.<br />
La pastorale giovanile non può non ricorrere e valorizzare la figura del <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale per salvaguardare il futuro dei giovani. Il maggior numero dei giovani d‘oggi è stanco<br />
<strong>di</strong> seguire i falsi profeti e maestri nella società contemporanea che promette solo vuoto, e che si<br />
approfitta la loro fresca ingenuità. Essi hanno bisogno <strong>di</strong> una persona cristiana matura che li<br />
accompagna alla verità e sulla strada della felicità vera. «Il <strong>di</strong>rettore spirituale è colui che<br />
cammina con loro passo a passo e li guida progressivamente alla piena maturità in Cristo, colui<br />
che può mantenere una relazione realistica ed autentica; e tutto questo <strong>di</strong>pende dalla maturità del<br />
<strong>di</strong>rettore stesso» 558 . I giovani d‘oggi chiedono un <strong>di</strong>rettore spirituale che sia esperto nell‘arte e<br />
nella scienza della <strong>di</strong>rezione spirituale. «La guida cristiana, che si cimenta ad assistere gli altri<br />
necessariamente deve andare al <strong>di</strong> là della scienza umana. Deve essere immerso in quella<br />
visione della vita, con chiaro riferimento al metodo classico della <strong>di</strong>rezione spirituale» 559 . Deve<br />
essere uno pieno <strong>di</strong> umanità e <strong>di</strong> fede 560 .<br />
I giovani reclamano un <strong>di</strong>rettore spirituale che sia soprattutto un uomo <strong>di</strong> Dio. Uno che<br />
riflette sulla sua parola e configura la sua azione all‘insegnamento del vangelo. «L‘uomo d‘oggi<br />
è bisognoso <strong>di</strong> incontrare la persona che possa accettare la sua storia senza chiedere il perché, il<br />
finché Cristo sia formato in lui» L. OLIATI, La <strong>di</strong>rezione spirituale dei giovani d‟oggi: appunti per una<br />
impostazione pastorale, ELLEDICI, Torino 1978, 39.<br />
554 J. K. RUFFING, Spiritual <strong>di</strong>rection: beyond the begginings, Paulist Press, Mah Wah NJ 2000, 44.<br />
555 L. D‘ASCENZO, La <strong>di</strong>rezione spirituale dei giovani nel loro progetto <strong>di</strong> vita, Teresianum, Roma 1998,<br />
76.<br />
556 R. FRATTELLONE, La <strong>di</strong>rezione spirituale oggi. Una proposta <strong>di</strong> ricomprensione, SEI, Torino 1996,<br />
135.<br />
557 C. GRATTON, The art of spiritual guidance, Claretian Publications, In<strong>di</strong>a 2000, 15.<br />
558 S. PAGANI, L‟accompagnamento spirituale dei giovani. Verso una regola <strong>di</strong> vita, San Paolo, Milano<br />
1997, 21.<br />
559 C. GRATTON, The art of spiritual guidance, 21.<br />
560 «Ideale sarebbe <strong>di</strong> trovarle tutte riunite nella stessa persona; questo però non sarà facile. Dovendo<br />
scegliere si dovrà tener presente che prudenza e virtú sono sempre necessarie, e non sono sufficienti; per<br />
iniziare le anime al cammino della perfezione, si dovrà preferire il <strong>di</strong>rettore che ha esperienza, potendo<br />
ricorrere all‘aiuto dei doti, se necessario» C. DI RIENZO, Vivi nello Spirito. La <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong> S.<br />
Teresa D‟Avila, E<strong>di</strong>zione Dehoniane, Napoli 1992, 95.<br />
126
come, e il dove del suo passato, ma farlo sentire a casa come nella parabola del figlio pro<strong>di</strong>go.<br />
Un <strong>di</strong>rettore spirituale, che è capace <strong>di</strong> accettare la persona, ha sicuramente il dono della<br />
compassione, grazie al quale è capace <strong>di</strong> assumere in se stesso la ferita <strong>degli</strong> altri, amandoli<br />
come Dio li ama» 561 .<br />
I giovani cercano un <strong>di</strong>rettore spirituale che sia molto umano, la cui parola e<br />
insegnamento rifletta la situazione attuale e concreta della vita. «Nello sforzo <strong>di</strong> aiutare la gente<br />
a farla entrare nel non-creato, nella potenza del Mistero, il <strong>di</strong>rettore non può ignorare le varie e<br />
nuove forme <strong>di</strong> idolatria, <strong>di</strong>pendenze, costrizioni, emozioni ferite, la confusione che cambia la<br />
norma della moralità e della vita familiare, e tutto per prevenire depressioni, paure e tristezze<br />
che caratterizzano la mancanza <strong>di</strong> consapevolezza <strong>di</strong> sé, e favorire una comunicazione con<br />
l‘Altro, il Divino» 562 . Hanno bisogno <strong>di</strong> una guida vera, un amico che li possa accettare nel loro<br />
viaggio <strong>di</strong> vita anche se bisogna cambiare drasticamente.<br />
Quando i giovani stessi cercano un <strong>di</strong>rettore esemplare con queste qualità e chiedono<br />
aiuto per avere una esperienza <strong>di</strong> Dio, è il momento che il <strong>di</strong>rettore spirituale cominci il suo<br />
ministero. Il primo passo è quello <strong>di</strong> dare un metodo <strong>di</strong> vita 563 . Questo è un itinerario verso la<br />
maturità cristiana, è un programma volto a svegliare le virtú cristiane, la celebrazione dei<br />
sacramenti, la partecipazione attiva alle attività ecclesiali. È poi necessaria la sua supervisione<br />
nell‘intero processo se vuole assicurare frutti buoni 564 .<br />
Per avere un competente <strong>di</strong>rettore spirituale per i giovani bisogna prepararlo per questo<br />
compito importante 565 . «Quando un <strong>di</strong>rettore spirituale è dotato e sperimentato nelle vie del<br />
Signore, può dare ai giovani un aiuto maggiore » 566 . C‘è una necessità urgente <strong>di</strong> preparare dei<br />
<strong>di</strong>rettori spirituali che siano all‘altezza delle richieste dei giovani d‘oggi 567 , persone che non<br />
solo siano esperti nella teoria e prassi della <strong>di</strong>rezione spirituale ma soprattutto che possano<br />
rappresentare Dio. «Come aiuto nel compimento del loro ministero sacerdotale, i sacerdoti<br />
devono amare il <strong>di</strong>alogo con Dio, perciò visitino il Santissimo Sacramento come loro pratica <strong>di</strong><br />
devozione personale. Devono trovare tempo per curare la loro vita spirituale» 568 . E finalmente<br />
devono avere la passione per la salvezza delle anime ed amore per i giovani 569 .<br />
La Direzione spirituale per i giovani d‘oggi è una avventura misteriosa. Diventa un<br />
compito <strong>di</strong>fficile e pesante. Il <strong>di</strong>rettore deve assumere la sua responsabilità ed essere<br />
561<br />
O. CANTINI, La paternità spirituale, in Diventare padri nello Spirito. La formazione delle guide<br />
spirituali, a cura, CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI, Ancora, Milano 1999, 13.<br />
562<br />
C. GRATTON, Spiritual <strong>di</strong>rection, in A.A. V.V., The new <strong>di</strong>ctionary of catholic spirituality, The<br />
Liturgical Press, Minnesota 1993, 914.<br />
563<br />
«Fornire loro <strong>degli</strong> strumenti che li aiuteranno a trovare il significato della loro crescita e delle loro<br />
crisi e pian piano, essi stessi, mo<strong>di</strong>ficheranno i costumi che non solo non esprimono ideali, ma ad<strong>di</strong>rittura<br />
li massificano rendendoli piatti, privi <strong>di</strong> vera iniziativa e creatività» M. SANTORO, Silenzio nel mondo<br />
Giovanile d‟Oggi, pp. 134-135.<br />
564<br />
«I ragazzi, gli adolescenti siano invitati a scoprire ad apprezzare il dono della <strong>di</strong>rezione spirituale, a<br />
ricercarlo e a sperimentarlo, a chiederlo con fiduciosa insistenza ai loro educatori nella fede» GIOVANNI<br />
PAOLO II, Esortazione Apostolica, Pastoris dabo vobis, 25 marzo 1992, n. 40, EDB, Bologna 1993, 84.<br />
565<br />
«They should be taught correctly the aids provided by pedagogy, psychology, in keeping with the<br />
regulations of ecclesiastical authority. They should also be carefully taught how to inspire and encourage<br />
apostolic action among the laity, and to promote various and more effective forms of apostolate» Vatican<br />
Council II, OT, n. 20.<br />
566<br />
C. P. MICHAEL, An introduction to spiritual <strong>di</strong>rection, Paulist Press, U.S.A. 2004, 13.<br />
567<br />
«Si insegni loro accuratamente l‘arte <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere le anime, per mezzo della quale possano dare a tutti i<br />
figli della chiesa quella formazione che li porta ad una vita cristiana pienamente consapevole ed<br />
apostolica e all‘adempimento dei doveri del proprio stato» Vatican Council II, OT, n. 20.<br />
568<br />
Ibid., p. 897.<br />
569<br />
«Da come è la giovinezza <strong>di</strong>pende in grande misura il futuro dell‘uomo, cioè il futuro d‘una concreta<br />
ed irripetibile persona umana. La giovinezza, dunque, nella vita d‘ogni uomo è una fase <strong>di</strong> particolare<br />
responsabilità. L‘amore per i giovani è prima <strong>di</strong> tutto consapevolezza <strong>di</strong> questa responsabilità,<br />
<strong>di</strong>sponibilità del con<strong>di</strong>viderla» GIOVANNI PAOLO II, L‟Amore piú grande, a cura L. SAPIENZA, E<strong>di</strong>trice<br />
Rogate, Roma 2005, 88.<br />
127
consapevole che il vero <strong>di</strong>rettore è lo Spirito Santo 570 . Il <strong>di</strong>rettore è solo un strumento per il bene<br />
della persona. Questo è un compito sfida. «Quando la <strong>di</strong>rezione spirituale è principalmente per il<br />
bene <strong>degli</strong> altri, Dio non manca <strong>di</strong> donare il carisma al <strong>di</strong>rettore per la sua trasformazione e<br />
purificazione. Questo è un dono integrante nella vita <strong>di</strong> fede del <strong>di</strong>rettore; mentre rimane come<br />
dono, questo carisma è una conseguenza della propria rinascita spirituale in Cristo, ed è<br />
importante per la sua santificazione» 571 .<br />
C. Rilevanza attuale della <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti<br />
La dottrina della <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti è applicabile alle necessità<br />
d‘oggi. Le riflessioni sul tempo presente presentano gli stessi elementi nel suo tempo. La<br />
semplicità del suo metodo è piena <strong>di</strong> efficacia. «Se oggi la <strong>di</strong>rezione spirituale è necessaria, la<br />
pratica <strong>di</strong> essa <strong>di</strong>pende però dal metodo che si utilizza» 572 . Dal suo stile <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere i giovani<br />
Frassinetti ha contribuito a prospettarci una valida soluzione alla grande sfida del nostro tempo.<br />
Il punto <strong>di</strong> partenza dell‘accompagnamento spirituale del servo <strong>di</strong> Dio è la chiamata<br />
universale della santità. La risposta dell‘in<strong>di</strong>viduo a questa chiamata è la chiave per capire il<br />
senso della propria esistenza ed anche della ricerca della felicità. È questo il messaggio centrale<br />
della <strong>di</strong>rezione spirituale del Frassinetti. Egli ci ha insegnato che il cammino da percorre è un<br />
processo che dura tutta la vita. Possiamo paragonare questo processo con l‘immagine della<br />
guerra. È una questione d‘arte strategica, coraggio e forza <strong>di</strong>vina. La vittoria <strong>di</strong>pende dalla<br />
capacità del <strong>di</strong>rettore e dalla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> colui che desidera la guida. Il cammino della vita<br />
spirituale richiede <strong>di</strong>ligenza, pazienza ed impegno.<br />
Giuseppe Frassinetti ha elaborato varie tappe per poter guidare i giovani nella<br />
formazione alla santità. Dal suo insegnamento possiamo dedurre tre elementi che possono<br />
essere utili per la pratica della <strong>di</strong>rezione spirituale d‘oggi: guidare i giovani a capire il vero<br />
significato dell‘amore, accompagnarli a vivere il dono della sessualità ed in<strong>di</strong>rizzarli nella strada<br />
giusta che li porta alla felicità.<br />
1. Educare i giovani al vero significato dell’amore<br />
La prima con<strong>di</strong>zione importante è la cognizione esatta del significato dell‘amore. Infatti,<br />
Giuseppe Frassinetti ha sempre insistito nel presentare alla generazione giovanile il significato<br />
vero dell‘amore. L‘amore è il principio dell‘esistenza dell‘uomo, ma anche del suo destino.<br />
L‘uomo non può vivere senza l‘amore, siamo stati creati per puro amore. È un dono <strong>di</strong> Dio: è<br />
Lui che lo ha piantato nel nostro cuore. L‘uomo allora è un essere ―amato‖, amato da Dio. I<br />
giovani devono scoprire questa verità ed impegnarsi a riconoscere l‘amore <strong>di</strong> Dio nella propria<br />
storia.<br />
Dall‘amore per amare: amare o vivere secondo l‘amore è un dovere <strong>di</strong> ogni battezzato.<br />
Frassinetti ci suggeriva due mo<strong>di</strong> per esercitare questo dono: l‘amore a Dio e l‘amore al<br />
prossimo. Uno può manifestare il suo amore a Dio esercitando la virtú della castità. Per l‘amore<br />
al prossimo ci suggeriva l‘amicizia spirituale.<br />
570 «Lo Spirito illumina il pensiero della persona perché sappia <strong>di</strong>scernere quello che veramente vuole,<br />
quello che Dio aspetta da lei, quello che farebbe Gesú al suo posto. Produce anche le sue mozioni o<br />
emozioni, a livello <strong>di</strong> stato interno, in modo che abbia gli stessi sentimenti <strong>di</strong> Gesú e sperimenti l‘impulso<br />
necessario per realizzare le aspettative che Dio Padre ha nei suoi confronti. Cosí pure, lo Spirito imprime<br />
la sua potenza nella persona, affinché questa si <strong>di</strong>a all‘azione e realizzi la missione che il Padre aspetta<br />
che lei compia» L. J. GONZÁLEZ, Guidati dallo Spirito. Accompagnamento spirituale <strong>di</strong> stile integrativo,<br />
Libreria E<strong>di</strong>trice Vaticana, Città del Vaticano 1998, 2.<br />
571 F. K. NEMECK – M. T. COOMBS, The way of spiritual <strong>di</strong>rection, Michael Glazier Inc., U.S.A. 1985, 50.<br />
572 L. M. MENDIZÁBAL, La <strong>di</strong>rezione spirituale. Teoria e pratica, EDB, Bologna 1999, 13.<br />
128
Amore e amicizia sono valori importanti per i giovani d‘oggi 573 . Tuttavia essi non hanno<br />
una chiara comprensione del significato dell‘amore. È il motivo per cui a volte l‘amicizia<br />
<strong>di</strong>venta la fonte <strong>di</strong> tante manifestazioni deviate.<br />
Comunque questa forte tendenza del bisogno d‘amore e il valore dell‘amicizia che è<br />
fortemente presente nella loro esistenza è un grande segno <strong>di</strong> speranza, ed è su questo punto che<br />
il <strong>di</strong>rettore spirituale deve lavorare. Il suo lavoro principale è quello <strong>di</strong> purificare il concetto <strong>di</strong><br />
amore che hanno e trasformarlo alla luce dell‘insegnamento cristiano dell‘amore.<br />
È interessante riflettere su alcuni passi della prima enciclica del Papa Benedetto XVI<br />
―Deus caritas est‖. Questa enciclica ci da l‘idea chiara <strong>di</strong> cosa significhi il vero amore. Ci<br />
richiama alla nostra identità cristiana e la nostra missione 574 . «L'amore <strong>di</strong> Dio per noi è<br />
questione fondamentale per la vita e pone domande decisive su chi è Dio e chi siamo noi.» 575 .<br />
Parte tutto dall‘amore <strong>di</strong> Dio che <strong>di</strong>venta il principio del vivere cristiano. «Non possiamo<br />
sopravvivere senza interagire e comunicare con altre persone. Uno nasce, vive, ama e lavora in<br />
un contesto interpersonale, dove il bisogno della relazione è realizzato attraverso la<br />
comunicazione e il rapporto con gli altri» 576 .<br />
Quando i giovani scoprono il vero significato dell‘amore, scoprono anche la bellezza<br />
del dono della vita. «L‘amore ci in<strong>di</strong>ca una <strong>terza</strong> relazione interpersonale importante per la vita<br />
dell‘uomo: senza amore non c‘è un‘autentica vita interpersonale. La caratteristica dell‘amore<br />
vero è dare se stesso come dono per gli altri. Amore è una forza unificante, è un momento<br />
sublime della relazione interpersonale che fa <strong>di</strong> due persone un solo essere» 577 . Una volta<br />
accolto il significato originale dell‘amore, i giovani scoprono che la felicità e il senso della vita<br />
è una questione d‘amore.<br />
2. Guidare i giovani a capire il dono della sessualità umana<br />
Un‘altra con<strong>di</strong>zione importante per la <strong>di</strong>rezione spirituale nella dottrina del Frassinetti è<br />
quella <strong>di</strong> far comprendere ai giovani il dono della sessualità. La sessualità umana trova la sua<br />
espressione imme<strong>di</strong>ata nel corpo; il rispetto al corpo è correlato al fatto che è tempio dello<br />
Spirito Santo.<br />
Il corpo umano è un dono per un motivo definito, e come dono non è proprietà<br />
personale, ha un‘origine <strong>di</strong>vina per un motivo <strong>di</strong>vino. «Sessualità ha un senso <strong>di</strong>vino: non è<br />
residuo della nostra animalità» 578 . Il modo migliore per valorizzare questo dono secondo il<br />
nostro Frassinetti è <strong>di</strong> vivere in castità 579 . Ognuno deve considerare il proprio corpo come<br />
l‘espressione piú sacra della propria personalità. «Il corpo umano è un strumento della<br />
comunicazione sensitiva, il corpo è la parola parlata, un argomento aperto, proposta da essere<br />
accettata. Non si deve usare per quel piacere egoistico che demoralizza e ostacola quella sua<br />
natura <strong>di</strong> essere dono» 580 .<br />
La generazione giovanile d‘oggi ha una comprensione povera sul dono della sessualità.<br />
Ci sono due tendenze estreme <strong>di</strong> questa affermazione. La prima considera il corpo umano come<br />
573 «La prima tendenza caratteristica comune dei giovani è proprio la tendenza associativa, il bisogno del<br />
gruppo: i giovani amano stare insieme, sentirsi e vivere in gruppo dove è facile stabilire dei rapporti, una<br />
comunicazione e trovare una sicurezza» Ibid., 133.<br />
574 Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica, Deus caritas est, 25 <strong>di</strong>cembre 2005, n. 1, Libreria E<strong>di</strong>trice<br />
Vaticana, Città del Vaticano 2006, 3.<br />
575 Ibid., 2.<br />
576 G. CREA, Gli altri e la formazione <strong>di</strong> sé, EDB, Bologna 2005, 129.<br />
577 A. LOBATO, La <strong>di</strong>gnità della persona umana. Privilegio e conquista, E<strong>di</strong>zioni Stu<strong>di</strong>o Domenicano,<br />
Bologna 2003, 135.<br />
578 Y. SEMEN, La sessualità secondo Giovanni Paolo II, E<strong>di</strong>zioni San Paolo, Milano 2005, 199.<br />
579 «Il concetto della castità si completa e si eleva con la visione cristiana, secondo la quale la castità è<br />
virtú e anche frutto dello Spirito Santo: è virtú in quanto è forza che opera in conformità al dettato della<br />
ragione; è frutto, in quanto risultato gioioso che lo stesso atto della castità produce» V. G. HOZ,<br />
Educazione della sessualità, E<strong>di</strong>zioni San Paolo, Milano 1994, 24.<br />
580 A. MAGGIOLINI, La meta e la strada. Proposta cristiana agli adolescenti, PIEMME, Trento 1999, 69-<br />
70.<br />
129
un mezzo del piacere e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vertimento. L‘altra tendenza valorizza il corpo e lo idealizza come<br />
la cosa piú importante della vita dell‘uomo; ciò sfocia poi in una ossessione nella cura esagerata<br />
e rigida del proprio corpo anche con il rischio della salute.<br />
La dottrina cristiana ha sempre insegnato la cura e il rispetto del corpo, infatti, Dio<br />
stesso ha preso il corpo umano per <strong>di</strong>mostrare l‘importanza della corporeità. Da una parte la<br />
preoccupazione dei giovani per il loro corpo è un aspetto positivo 581 , ma non basta, occorre<br />
capire bene il significato e lo scopo <strong>di</strong> esso. Svolge infatti un ruolo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione tra il mondo<br />
interiore dell‘uomo e quello esteriore, attraverso il nostro corpo costruiamo rapporti <strong>di</strong> amicizia<br />
ed affetto con le persone. In pratica, grazie al corpo umano noi viviamo ed esistiamo. Trattare<br />
male, abusare e giocare con il proprio corpo equivale a non dare importanza alla propria vita ed<br />
esistenza, approfittare del corpo dell‘altro come mezzo del piacere non è amore, è offendere e<br />
<strong>di</strong>sprezzare la <strong>di</strong>gnità della persona. È compito del <strong>di</strong>rettore spirituale far capire ai giovani come<br />
valorizzare la propria sessualità nel rispetto del proprio corpo e <strong>di</strong> quello altrui 582 .<br />
La sessualità umana è la espressione piú alta dell‘amore umano; il corpo possiede un<br />
linguaggio imme<strong>di</strong>ato. «La comunione della persona presuppone la integrità del linguaggio del<br />
corpo, dunque presuppone che il linguaggio sia totale e vero» 583 . Il corpo umano è destinato a<br />
produrre vita, non solamente nell‘or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> riproduzione ma anche nell‘or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong><br />
una sana e degna relazione 584 . Un giovane che è capace <strong>di</strong> rispettare il proprio corpo è una<br />
persona sana che è capace <strong>di</strong> relazione genuina, come si ad<strong>di</strong>ce alla natura sociale dell‘uomo.<br />
L‘uomo non è chiamato soltanto a stabilire un rapporto con gli altri ma anche, anzi,<br />
soprattutto con il suo Creatore. Quin<strong>di</strong>, il corpo umano è anche un strumento per stabilire una<br />
comunione intima con Dio. «Quando ti sforzi <strong>di</strong> avere un cuore casto, sicuramente potresti fare<br />
della vita un dono» 585 .<br />
3. Accompagnare i giovani verso la strada della vera felicità<br />
Accompagnare i giovani sulla strada che porta alla vera felicità è il terzo elemento<br />
importante che possiamo imparare della <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti. Ogni uomo<br />
desidera la felicità, ogni sforzo dell‘uomo nella vita è sempre una continua sfida per raggiungere<br />
la felicità. La nostra esperienza ci insegna sempre che c‘è qualcosa che desideriamo che è al <strong>di</strong><br />
là delle gioie e <strong>di</strong>vertimenti che esperimentiamo nella quoti<strong>di</strong>anità. Cerchiamo ciò che ci fa<br />
sentire bene per sempre, è il desiderio della vera felicità.<br />
La felicità è una questione <strong>di</strong> cuore e <strong>di</strong> spirito. «Essere ―umano‖ significa essere<br />
spirituale. Gli esseri umani hanno un desiderio e un‘aspirazione che può avere esito soltanto<br />
quando la capacità spirituale della persona viene presa seriamente»‖. 586 Una persona è felice<br />
quando trova l‘armonia tra la sua vita interiore e il mondo esteriore.<br />
Giuseppe Frassinetti sapeva che il desidero appartiene alla stessa natura dell‘uomo.<br />
Ch‘è in comunione con Dio e il prossimo è contento. È questo un dono ma anche una conquista<br />
581 «È importante conoscere il nostro corpo prima che qualcun altro lo conosca, proprio come se<br />
volessimo esplorare e possedere un dono prima <strong>di</strong> darlo ad un altro. Se ciò accade, il senso della propria<br />
iniziativa viene perso ed il risultato può apparire un furto o un danno: piuttosto che provenire da noi stessi<br />
ed appartenerci, le nostre risposte ed i nostri sentimenti sembrano essere pure reazioni provocate da un<br />
altro» E. NOONAN, Counselling psico<strong>di</strong>namico con adolescenti e giovani adulti, a cura M. SIMONETTA –<br />
G. ADAMO, Gnochi, Napoli 1997, 8.<br />
582 «La giovinezza è l‘età delle scelte. Diventare liberi significa scegliere il bene. I giovani chiedono<br />
all‘educatore <strong>di</strong> essere aiutati in questo, con pronta luci<strong>di</strong>tà e sincero rispetto. La persona umana si pone<br />
nella storia come una libertà che è in esercizio me<strong>di</strong>ante il corpo» S. PAGANI, L‟accompagnamento<br />
spirituale dei giovani. Verso una regola <strong>di</strong> vita, San Paolo, Milano 1997, 66.<br />
583 Y. SEMEN, La sessualità secondo Giovanni Paolo II, p. 199.<br />
584 «È importante che il giovane abbia un rapporto sereno con la propria sessualità, che la concepisca<br />
come un dono <strong>di</strong> Dio. Ma al tempo stesso deve imparare che nel rapporto con la stessa sessualità rimane<br />
libero e non ne dev‘essere con<strong>di</strong>zionato o ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong>laniato» A. GRÜN, La cura dell‟anima.<br />
L‟esperienza <strong>di</strong> Dio tra fede e psicologia, <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> San Paolo, Milano 2004, 109.<br />
585 O. CANTONI, E brillerà la tua luce!, 55.<br />
586 C. GRATTON, The art of spiritual <strong>di</strong>rection, 2.<br />
130
dell‘uomo. Le persone sante sono sempre allegre e felici, infatti, Giuseppe Frassinetti invitava i<br />
giovani del suo tempo ad imitare San Filippo Neri, che lui stesso considerava come prototipo<br />
dei <strong>di</strong>rettori spirituali. Si può <strong>di</strong>re allora che la gioia o la felicità è il premio della santità <strong>di</strong> vita.<br />
Anche durante il tempo <strong>di</strong> Frassinetti i giovani <strong>di</strong>mostrano tale desiderio, ma tanti, si sa,<br />
lo hanno incanalato nella <strong>di</strong>rezione sbagliata, invece <strong>di</strong> trovare la felicità hanno incontrato la<br />
solitu<strong>di</strong>ne e l‘inquietu<strong>di</strong>ne dell‘anima.<br />
I giovani d‘oggi come i giovani <strong>di</strong> quel tempo cercano la felicità ma non hanno una<br />
chiara idea che cosa realmente li fa felici e non conoscono la strada per raggiungerla. Tante<br />
volte questa ricerca cade nel piacere dell‘alcolismo, della droga, del libertinaggio, del gioco<br />
d‘azzardo e <strong>di</strong> altri vizi. Questa realtà li <strong>di</strong>strugge ed essi <strong>di</strong>ventano vittime e schiavi <strong>di</strong> una<br />
società alla quale interessa solo il denaro.<br />
Esiste una sola via verso la felicità. «Se desideriamo veramente <strong>di</strong> essere felici<br />
dobbiamo camminare nella via della santità» 587 . Camminare nella santità vuole <strong>di</strong>re camminare<br />
con Cristo: via, verità e vita dell‘uomo.<br />
Un‘altra caratteristica presente nella psicologia dei giovani che rivela il bisogno <strong>di</strong> un<br />
punto <strong>di</strong> riferimento per costruire una propria appartenenza: l‘idolatrare la persona <strong>di</strong> giocatori,<br />
cantanti, attrici e altri personaggi televisivi famosi; c‘è una imitazione <strong>di</strong> queste persone nel loro<br />
modo <strong>di</strong> vestire, parlare e comportarsi. Tale atteggiamento richiama ancora la vali<strong>di</strong>tà e la<br />
necessità della figura del <strong>di</strong>rettore come punto <strong>di</strong> riferimento per loro. È Gesú Cristo il vero,<br />
unico ―idolo‖ e maestro da seguire 588 . Il Signore deve essere il centro della loro vita perché lui è<br />
la via della felicità. Accompagnare i giovani sulla strada della vera gioia significa formarli ad un<br />
incontro personale con Gesú, conoscerlo, per amarlo e seguirlo 589 .<br />
Il primo impegno, ed è il fondamento <strong>di</strong> tutto, è l‘incontro personale con Cristo. Il<br />
Signore si fa incontrare in <strong>di</strong>versi mo<strong>di</strong> ma soprattutto in maniera piú comune nella preghiera e<br />
nei sacramenti 590 . «I sacramenti ripresentano il punto <strong>di</strong> incontro con Dio, piú sublime e intenso:<br />
attraverso i sacramenti il tempo entra nell‘eternità e l‘eternità prevale sul tempo. Portare Cristo<br />
nella nostra esistenza è il desiderio della nostra storia, troviamo pienezza nella vita e sopporto<br />
per la nostra speranza» 591 . Giuseppe Frassinetti insegnava che tra tutti i sacramenti la santa<br />
Eucaristia è modo piú efficace <strong>di</strong> incontrare ed accogliere Cristo nella propria vita 592 : è Cristo<br />
stesso che incontrano e che offrí se stesso per noi 593 . L‘incontro <strong>di</strong> Cristo nella vita dei giovani li<br />
trasforma in Lui. L‘amore e la conoscenza del Salvatore li accompagnerà alla sequela del loro<br />
Maestro. «La vita spirituale deve essere nutrita dalla grazia, inspirata dall‘amore <strong>di</strong> Cristo e<br />
deve svilupparsi come de<strong>di</strong>cazione autentica nel seguirlo personalmente, lui che ha dato<br />
significato all‘intera vita cristiana» 594 .<br />
Camminare nella strada del Signore significa vivere in comunione con Lui. La preghiera<br />
personale è celebrare la presenza <strong>di</strong> Cristo nella quoti<strong>di</strong>anità e nella propria storia <strong>di</strong> salvezza 595 .<br />
587 L. J. GONZÁLEZ, Pedagogia della santità, Libreria Eitrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, 11.<br />
588 «Accompagnare i giovani vorrà <strong>di</strong>re aiutarli a scoprire e vivere Gesú Cristo come centro unificatore<br />
della loro esistenza e come opzione fondamentale che orienta la loro scelta vocazionale; accordare la<br />
propria vita con quella <strong>di</strong> Gesú – Verità» G. MOIOLI, L‟esperienza spirituale, Glossa, Milano 192, 11.<br />
589 «Non ci si improvvisa <strong>di</strong>scepoli del Signore: <strong>di</strong> inizio in inizio si prende il cammino, anche facendo<br />
tesoro dei propri limiti e perfino dei propri peccati, sostenuti dalla convinzione che non manca mai la<br />
misericor<strong>di</strong>a del Signore a chi si apre a riceverla incessantemente nella comunità» A. MAGGIOLINI,<br />
Regola <strong>di</strong> vita cristiana per i giovani, 5.<br />
590 «In this age of the Church, Christ now lives and acts in and with his Church, in a new way appropriate<br />
to this new age. He acts through the sacraments». CCC, n. 1076.<br />
591 R. TONELLI, Educhiamo i giovani a vivere da cristiani adulti, ELLEDICI, Torino 2000, 64.<br />
592 «For it is the liturgy through which, especially in the <strong>di</strong>vine sacrifice of the Eucharist, the work of our<br />
redemption is accomplished» Vatican Council II, SC, n. 2,.<br />
593 «L‘incorporazione a Cristo, realizzata attraverso il Battesimo, si rinnova e si consolida continuamente<br />
con la partecipazione al Sacrificio Eucaristico, soprattutto con la piena partecipazione ad esso che si ha<br />
nella comunione sacramentale» GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Ecclesia De Eucaristia, 17 aprile<br />
2003, n. 22, ELLEDICI, Torino 2004, 26.<br />
594 L. M. MENDIZÀBAL, La <strong>di</strong>rezione spirituale. Teoria e pratica, 118.<br />
595 «Non si può vivere senza la preghiera: esistono situazioni in cui la forza dell‘uomo non basta piú, la<br />
sua buona volontà non regge. Ci sono momenti nella vita in cui l‘uomo, se vuole sopravvivere, ha<br />
131
«La vita spirituale, comunque, non è limitata alla partecipazione alla liturgia. Un cristiano è<br />
chiamato sempre a pregare con gli altri, ma soprattutto da solo anche nella sua camere in<br />
segreto» 596 . Un <strong>di</strong>alogo constante aiuta a conoscere meglio Dio, sapendo che si conosce una<br />
persona attraverso la conversazione. «Nella <strong>di</strong>rezione spirituale si deve sottolineare la<br />
importanza <strong>di</strong> coltivare la propria vita vissuta alla presenza <strong>di</strong> Dio, e anche con gli altri con il<br />
Suo constante sostegno» 597 .<br />
La strada della vera felicità è un percorso da fare con <strong>Maria</strong>. La pienezza <strong>di</strong> gioia e<br />
santità della madre risplende proprio nella sua bellezza. «Un devozione intima con la Beata<br />
Vergine <strong>Maria</strong> ci aiuta a vivere santamente in pace e con una serenità dello spirito» 598 . <strong>Maria</strong><br />
essendo la Madre <strong>di</strong> Cristo è la persona piú competente che guida verso il suo <strong>Figli</strong>o.<br />
«Attraverso la sua carità maternale, ella prende cura <strong>di</strong> quelli che seguono il suo <strong>Figli</strong>o, che<br />
ancora camminano in questa terra, accerchiati dai pericoli e <strong>di</strong>fficoltà fin quando raggiungano la<br />
casa beata» 599 .<br />
La vera felicità per un cristiano è camminare secondo la via <strong>di</strong> Cristo. «La via <strong>di</strong> Cristo<br />
conduce alla vita mentre la via contraria alla <strong>di</strong>struzione» 600 . La vita eterna in Dio è senza altro<br />
la meta della <strong>di</strong>rezione spirituale 601 .<br />
D. Una delle sfide attuali<br />
La dottrina della <strong>di</strong>rezione spirituale <strong>di</strong> Padre Giuseppe Frassinetti contiene un altro<br />
elemento importante: l‘amore per la Chiesa Cattolica 602 e per il Sommo Pontefice 603 . Il Vicario<br />
<strong>di</strong> Cristo è il <strong>di</strong>rettore spirituale dei cristiani pellegrini sulla terra. Il Papa è l‘immagine visibile e<br />
strumento <strong>di</strong> Cristo per guidare il suo popolo. È importante rispettare i suoi insegnamenti per<br />
amore <strong>di</strong> Dio e per il nostro bene. «Il Papa è importante perché è un Padre per i fedeli, il Vicario<br />
<strong>di</strong> Cristo» 604 .<br />
La Chiesa ha sempre centralizzato la sua attenzione verso i giovani perché sono il<br />
futuro, la speranza. «Voi giovani, avete la speranza perché appartenete al futuro come il futuro<br />
appartiene a voi» 605 . Un esempio concreto per l‘amore e passione per i giovani è l‘azione <strong>di</strong><br />
Papa Giovanni II. Ha de<strong>di</strong>cato la sua vita intera ai giovani fino ad ultimo respiro. Per questo egli<br />
è considerato come apostolo dei giovani. Egli ha iniziato gli Incontri Mon<strong>di</strong>ali della Gioventú,<br />
iniziativa che ha riavvicinato tanti giovani alla fede. Lo chiamano ―Papa Boys‖ (Il Papa dei<br />
ragazzi). Ha lasciato tanti messaggi ad ogni giovane d‘oggi e <strong>di</strong> domani che lo incoraggiano a<br />
percorrere il cammino sotto la guida della madre Chiesa.<br />
Oggi piú che mai, la pastorale giovanile è nel cuore della Chiesa. Sono stati promosse<br />
<strong>di</strong>verse iniziative per favorire la formazione ed l‘accompagnamento spirituale dei giovani. La<br />
Chiesa cammina con i giovani, perché sono loro il futuro della Chiesa.<br />
bisogno dell‘incontro <strong>di</strong>retto con la forza <strong>di</strong> Dio» A. GASPARINO, Maestro, insegnaci a pregare,<br />
ELLEDICI, Torino 1999, 13.<br />
596<br />
Vatican Council II, SC, n. 7.<br />
597<br />
IBID., 122.<br />
598<br />
IBID.<br />
599<br />
Vatican Council II, LG, n. 62.<br />
600<br />
CCC, n. 1696.<br />
601<br />
F. K. NEMECK – M. T.COOMBS, The way of spiritual <strong>di</strong>rection, 215.<br />
602<br />
«La vocazione universale alla santità non può non realizzarsi che in seno alla Chiesa. Pur essendo<br />
peccatrice, in quanto peccatori siamo noi, suoi figli, è santa e santificatrice perché è animata dallo Spirito,<br />
è il Corpo <strong>di</strong> Cristo e cammina verso il Padre che l‘attrae col suo amore e con la grazia» L. J. GONZÁLEZ,<br />
Pedagogia della santità, 95.<br />
603<br />
«Dagli scritti del Frassinetti traspare cosí evidente l‘attaccamento alla Chiesa e al Papa, che si sarebbe<br />
potuto non aggiungere altro. Ma mi è parso togliere qualcosa a lui carissima a non dare risalto come<br />
questo attaccamento alla Sede <strong>di</strong> Pietro e alla parola del suo Vicario fosse stata in lui connaturata fin dalla<br />
fanciullezza» M. FALASCA, Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, Cantagalli, Siena 2004, 152.<br />
604<br />
Ibid., 153.<br />
605<br />
GIOVANNI PAOLO II, Cari giovani, aprite bene gli occhi! Tutti i messaggi della Giornata Mon<strong>di</strong>ale<br />
della Gioventú, Chirico, Napoli 2005, 14.<br />
132
Conclu<strong>di</strong>amo questo capitolo riportando due insegnamenti importanti per i giovani; da<br />
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ed infine, l‘autore <strong>di</strong> questo lavoro proporrà il brano dei<br />
<strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong> Emmaus dal vangelo <strong>di</strong> Luca come icona del cammino spirituale dei giovani.<br />
1. “Siamo venuti per adorarlo” (Mt 2,2)<br />
I giovani sono stati sempre nel cuore del Papa Giovanni Paolo II. Era per loro una<br />
guida, un padre e un <strong>di</strong>rettore spirituale. Era e sarà sempre considerato come fedele, loro fedele<br />
―compagno <strong>di</strong> viaggio‖ 606 .<br />
Giovanni Paolo II, ha affidato ai giovani una missione importante: ha chiesto loro <strong>di</strong><br />
testimoniare la propria fede al mondo. «Per questo, vibrando con il loro entusiasmo, non ho<br />
esitato <strong>di</strong> chiedere una scelta ra<strong>di</strong>cale <strong>di</strong> fede e <strong>di</strong> vita, proponendo un compito meraviglioso che<br />
è quello <strong>di</strong> fare <strong>di</strong> se stessi ―sentinelle del mattino‖ al principio del nuovo millennio» 607 . Ma il<br />
Papa sapeva che non era facile quello che chiedeva ai giovani. Di fronte alla tendenza al<br />
pessimismo ha lasciato loro un itinerario come modello. È il racconto dei magi nel vangelo <strong>di</strong><br />
Matteo. ―Siamo venuti adorarlo‖ (Mt 2,2). Era il tema della mon<strong>di</strong>ale della gioventú <strong>di</strong> Colonia<br />
in Germania. Purtroppo, Giovanni Paulo II è morto prima <strong>di</strong> questo grande evento. Questo<br />
messaggio – itinerario <strong>di</strong> fede è <strong>di</strong>ventato il suo testamento spirituale per i giovani. Sapeva bene<br />
che nel tempo presente i giovani hanno <strong>di</strong>fficoltà ad incontrare Cristo. Con la riflessione del<br />
vangelo <strong>di</strong> Matteo ha incoraggiato i giovani a non esasperarsi, dubitare e confondersi. Come la<br />
stella ha guidato i magi verso Cristo, cosi anche Dio manderà vali<strong>di</strong> strumenti per guidare i Suoi<br />
giovani.<br />
Il Papa incoraggiava sempre a cercare una guida spirituale, una stella, per realizzare un<br />
viaggio fruttuoso. I magi stessi sono <strong>di</strong>ventati guida per i giovani pellegrini verso Cristo. Il tema<br />
dell‘incontro invita i giovani a seguire i magi e fare un viaggio interiore per incontrare Cristo,<br />
per ricevere, come loro, durante il cammino, gratuitamente in dono la propria conversione.<br />
Questo conduce ognuno <strong>di</strong> loro ad adorarlo e farne l‘unico senso della loro esistenza per<br />
cominciare una vita nuova con la luce e la gioia <strong>di</strong> Dio.<br />
Giovanni Paolo II ha lasciato una ere<strong>di</strong>tà spirituale per i giovani <strong>di</strong> oggi. Non resta altro<br />
che impegnarsi a metterla in pratica con l‘aiuto della <strong>di</strong>rezione spirituale.<br />
2. “Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul<br />
mio cammino” (Sal 119, 105)<br />
Dio ha mandato un altro pastore per il suo gregge e ha scelto Papa Benedetto XVI come<br />
Vicario <strong>di</strong> Cristo. Il nuovo Sommo Pontefice ha cominciato la sua missione apostolica<br />
insegnandoci l‘amore cristiano con il Deus caritas est. È una lettera enciclica in<strong>di</strong>rizzata a tutti i<br />
cristiani ed invita tutti a cercare la persona giusta che possa guidare al vero significato<br />
dell‘amore.<br />
Papa Benedetto XVI ha seguito l‘esempio del suo predecessore nel invitare tutti cristiani<br />
a continuare il loro cammino verso Cristo. «E<strong>di</strong>ficate la vostra vita in Cristo, accettando la gioia<br />
della parola <strong>di</strong> Dio e mettendo in pratica il suo insegnamento: questa è la gioventú del terzo<br />
millennio, questo deve essere il vostro programma! Una necessità urgente per la nuova<br />
generazione <strong>degli</strong> apostoli ra<strong>di</strong>cati nella parola <strong>di</strong> Cristo, capace <strong>di</strong> rispondere alle tante sfide<br />
del tempo e pronti a proclamare il vangelo a tutto il mondo. È questo ciò Dio ti chiede, ciò che<br />
la Chiesa ti chiede, ciò il mondo spera da Te» 608 .<br />
606<br />
The same affirmation is expressed by Pope Bene<strong>di</strong>ct XVI in his message remembering the first year<br />
anniversary of the death of John Paul II during a <strong>Maria</strong>n Vigil organized by the Diocese of Rome last<br />
April 2, 2006.<br />
607<br />
GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica, Novo millennio ineunte, 6 gennaio 2001, n. 9, Paoline, Milano<br />
2001, 13.<br />
608<br />
BENEDETTO XVI, Lampada per i miei passi è la tua Parola luce sul mio cammino. Messaggio per la<br />
XXI Giornata Mon<strong>di</strong>ale della Gioventú, Libreria E<strong>di</strong>trici Vaticana, Città del Vaticano 2006, 9.<br />
133
Nella XXI Giornata Mon<strong>di</strong>ale della Gioventú, il nuovo Papa ha seguito la linea <strong>di</strong><br />
pensiero <strong>di</strong> Giovanni Paolo II concernente la necessità <strong>di</strong> guidare le anime alla vera strada della<br />
vocazione cristiana: la santità. Egli ha cercato <strong>di</strong> illustrare questo insegnamento alla luce <strong>di</strong> un<br />
documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. Questo documento sottolinea il ruolo vitale<br />
della Parola <strong>di</strong> Dio nella vita <strong>di</strong> ogni cristiano. ―Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce<br />
sul mio cammino‖ (Sal 119, 105). Questo tema invita tutti i giovani e anche i <strong>di</strong>rettori spirituali<br />
a sottoporre il loro cammino alla luce della Parola <strong>di</strong> Dio.<br />
3. “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il<br />
cammino?” (Lc 24,32)<br />
L‘episo<strong>di</strong>o dei due <strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong> Emmaus nel vangelo <strong>di</strong> Luca rappresenta l‘attuale<br />
cammino dei giovani d‘oggi. «I giovani <strong>di</strong> oggi, come i <strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong> Emmaus, sono noma<strong>di</strong> nelle<br />
strade della vita. Loro domandano, vogliono capire però cadono nell‘errore nel giu<strong>di</strong>care cosa<br />
era successo nella loro vita e invocano aiuto, ad un altro che possa accompagnarli nella giusta<br />
<strong>di</strong>rezione e a qualcuno che illumini i loro momenti confusi e oscuri» 609 .<br />
È un messaggio <strong>di</strong> speranza per i giovani cristiani oggi. In questa con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>fficile<br />
Gesú appare e incontra i due <strong>di</strong>scepoli lungo il cammino. Il Signore vuole incontrare i giovani <strong>di</strong><br />
oggi. Egli desidera camminare con loro. Egli desidera parlare con loro. E desidera entrare nella<br />
loro vita per offrire loro il suo amore e la sua misericor<strong>di</strong>a; ma occorre fare un cammino<br />
interiore per poterlo incontrare.<br />
Nel nostro tempo Gesú manda <strong>degli</strong> strumenti per aiutare i giovani ad incontrarlo, sono<br />
i <strong>di</strong>rettori spirituali: persone che devono essere autentiche e fedeli perché hanno incontrato Dio<br />
nella loro vita. Cristo utilizza strumenti umani per raggiungere i giovani piú facilmente e<br />
imme<strong>di</strong>atamente. Gesú ha aperto i cuori dei due <strong>di</strong>scepoli attraverso la sua Parola ed<br />
l‘Eucaristia. Questo è un messaggio importante per i giovani oggi. Se vogliono incontrare Cristo<br />
lo possono attraverso la Sacra Scrittura e la Eucaristia.<br />
Questo evento rivela una riflessione molto importante per chi è stato chiamato a guidare<br />
le anime. Cristo <strong>di</strong>venta il <strong>di</strong>rettore spirituale dei due <strong>di</strong>scepoli. Non li giu<strong>di</strong>ca ma li ascolta con<br />
pazienza. Gesú li ha accompagnati preparando il loro cuore ed illuminando loro mente a<br />
riconoscere il Maestro. È un esempio concreto per tutti i <strong>di</strong>rettori spirituali. La pazienza, la<br />
prudenza e la perseveranza sono le virtú del maestro <strong>di</strong> spirito.<br />
In fine, lo stesso brano ci fa capire che il <strong>di</strong>rettore spirituale è solo un strumento.<br />
Quando l‘anima dopo il cammino <strong>di</strong> accompagnamento ha incontrato Cristo, il ruolo e la<br />
missione del <strong>di</strong>rettore finisce, perché deve camminare ora con Cristo. È quello che Gesú ha<br />
insegnato ai due <strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong> Emmaus. «Dopo ciò che è successo, la presenza visibile <strong>di</strong> Cristo è<br />
scomparsa, per dare spazio alla fede che è molto piú personale e molto piú capace per una<br />
conversione gioiosa del cuore. Rimane con loro rendendoli responsabili del loro futuro,<br />
<strong>di</strong>ventando cristiani maturi» 610 .<br />
609 M. TONDO, Di fronte al progetto <strong>di</strong> vita, 145.<br />
610 B. GOYA, Luce e guida nel cammino, EDB, Bologna 2004, pp. 57 -58.<br />
134
CONCLUSIONE<br />
Ogni cristiano riceve da <strong>di</strong> Dio un dono molto importante, la vocazione alla santità. La<br />
sua risposta ed impegno <strong>di</strong> vivere questa chiamata è la chiave della felicità.<br />
Questa verità <strong>di</strong>venta una grande sfida per il mondo <strong>di</strong> oggi. La tendenza attuale è <strong>di</strong><br />
allontanare l‘uomo da Dio. Esistono <strong>di</strong>versi tentavi per togliere nell‘uomo ogni legame con il<br />
suo Creatore, ma la vita senza Dio è vuota, non porta altro se non solitu<strong>di</strong>ne, violenza e morte.<br />
Questa triste realtà contribuisce ad avere tanti giovani che <strong>di</strong>ventano causee vititme <strong>di</strong><br />
tanti problemi nella nostra società.<br />
I giovani <strong>di</strong> oggi cercano la verità ed hanno bisogno <strong>di</strong> guide vere che li accompagnino<br />
ad incontrarla per avere la vita. La situazione attuale del nostro tempo manifesta l‘urgenza del<br />
ministero della <strong>di</strong>rezione spirituale. La chiesa ha bisogno <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettori spirituali che sappiano<br />
accompagnare i giovani nel loro cammino <strong>di</strong> crescita. I giovani cercano guide che siano<br />
veramente immagini visibili <strong>di</strong> Cristo. Hanno bisogno <strong>di</strong> accompagnatori spirituali capaci <strong>di</strong><br />
trasmettere la gioia e la bellezza della vita vissuta in Cristo, un veri testimoni da imitare.<br />
In questo lavoro, abbiamo cercato <strong>di</strong> esporre attentamente l‘insegnamento del sacerdote<br />
Giuseppe Frassinetti. Il suo metodo <strong>di</strong> accompagnamento spirituale ha aiutato tanti giovani del<br />
suo tempo come <strong>di</strong>scernere e vivere la propria vocazione alla santità.<br />
A questo punto, l‘autore può <strong>di</strong>re che ha esaurito lo scopo dello <strong>stu<strong>di</strong></strong>o con chiarezza e<br />
ampiezza nella presentazione dei <strong>di</strong>versi argomenti necessari per il tema. Quello che rimane<br />
ancora da <strong>di</strong>re è che spera che il suo lavoro possa contribuire ed aiutare gli accompagnatori<br />
spirituali <strong>di</strong> oggi nel loro impegno tanto prezioso <strong>di</strong> guida delle anime, avendo nel cuore il<br />
grande insegnamento del venerabile Giuseppe Frassinetti che la santità è una cosa semplice,<br />
facile e possibile per tutti, perché Dio cammina con noi e ci sostiene sempre con il suo amore<br />
infinito. ―Il Signore fa sicuri i passi dell‘uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non<br />
rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano‖ (Salmo 37,23-24).<br />
135
BIBLIOGRAFIA<br />
A. LE OPERE DI GIUSEPPE FRASSINETTI<br />
FRASSINETTI G., Opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te, 13 Vol., Poliglotta Vaticana, Roma 1906-1913.<br />
FRASSINETTI G., Opere ascetiche. Introduzione e note <strong>di</strong> RENZI GIORDANO, 2 vol., Curia<br />
Generale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Roma 1978.<br />
In particolare:<br />
- Propositi fatti per sé e per alcuni amici, Tip. Della Gioventú, Genova 1879.<br />
- Il religioso al secolo, Tip. Della Gioventú, Genova 1864.<br />
- Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú, Tip. Ligustica, Genova 1851.<br />
- Offerta <strong>di</strong> noi a Dio, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1912.<br />
- Ricor<strong>di</strong> per un giovinetto cristiano, Tip. Ligustica, Genova 1851.<br />
- Il conforto dell‟anima <strong>di</strong>vota, Tip. Festa, Napoli 1852.<br />
- Il Convito del <strong>di</strong>vino Amore, Tip. Della Gioventú, Genova 1867.<br />
- Ai fedeli <strong>di</strong>voti del ss. Sacramento, Tip. Como, Genova 1851.<br />
- Culto perpetuo ad onore del ss. Santissimo, Tip. Como, Genova 1839.<br />
- Due gioie nascoste, Tip. Della Gioventú, Genova 1864.<br />
- Lettere sul celibato, Tip. Ghilini, Oneglia 1861.<br />
- La gemma delle fanciulle cristiane, Tip. Ferrando, Genova 1841.<br />
- Il para<strong>di</strong>so in terra nel celibato cristiano, Tip. G.B. Paravia, Torino 1861.<br />
- Gesú Cristo regola del sacerdote, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1966.<br />
- Brevi parole ai sacerdoti fratelli, Tip. Della Gioventú, Genova 1865.<br />
- La monaca in casa, Tip.Tasso, Oneglia 1859.<br />
- Il religioso al secolo, Tip. Della Gioventú, Genova 1864.<br />
- Mazzolino <strong>di</strong> fiori pel mese <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, Tip. Arcivescovile, Milano 1862.<br />
- L‟ossequio piú gra<strong>di</strong>to a <strong>Maria</strong> Santissimo <strong>Immacolata</strong>, Tip. Ligustica, Genova<br />
1855.<br />
- L‟offerta del cuore a <strong>Maria</strong> Santissima, Tip. Della Gioventú, Genova 1869.<br />
- Avviamento dei giovinetti, Tip. Monal<strong>di</strong>, Roma 1864.<br />
- Parole <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima al suoi <strong>di</strong>voti, Tip. Como, Genova 1855.<br />
- Amiamo <strong>Maria</strong>, Tip. della Gioventú, Genova 1864.<br />
- Le do<strong>di</strong>ci stelle ossia le virtú della B.V. <strong>Maria</strong>, Tip. Fassi-Como, Genova 1857.<br />
- Frutti del mese mariano, Tip. della Gioventú, Genova 1860.<br />
- Industrie spirituali, Tip. G.B. Paravia, Torino 1860.<br />
- Riflessioni proposte agli ecclesiastici, Tip. Ferrando, Genova 1837.<br />
FRASSINETTI G., Esercizi spirituali per i Giovinetti d‟ambo i sessi, Tip. della Gioventú, Genova<br />
1865.<br />
FRASSINETTI G., La missione delle fanciulle. Racconti contemporanei, Tip. <strong>di</strong> Giovanni Ghiani,<br />
Oneglia 1865.<br />
FRASSINETTI G., Il modello della povera fanciulla Rosina Pedemonte, Tip. <strong>di</strong> Giovanni Ghiani,<br />
Oneglia 1863.<br />
136
FRASSINETTI G., La rosa senza spine. Memorie sulla vita della pia zitella Rosa Cordone, Tip.<br />
della Gioventú, Genova 1867.<br />
FRASSINETTI G., Compen<strong>di</strong>o della Teologia Morale <strong>di</strong> S. Alfonso M. de‟ Liguori, I, Scuola<br />
Tipografica Salesiana, Torino 1948.<br />
FRASSINETTI G., Dissertazione sulla comunione quoti<strong>di</strong>ana, Tip. della Gioventú, Genova 1867.<br />
FRASSINETTI G., Manuale pratico del parroco novello, Tip. della Gioventú, Genova 1902.<br />
FRASSINETTI G., Colloqui per la novena <strong>di</strong> S. Angela Merici con orazione per la scelta dello<br />
stato, Tip. della Gioventú, Genova 1902.<br />
FRASSINETTI G., Sulla deficienza delle vocazioni allo stato ecclesiastico, Tip. <strong>di</strong> Giovanni<br />
Ghiani, Oneglia 1870.<br />
FRASSINETTI G., La devozione al santuario <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima Assunta in cielo, Stabilimento<br />
Tipografico Ligustico, Genova 1853.<br />
FRASSINETTI G., Le amicizie spirituali. Imitazione da S. Teresa <strong>di</strong> Gesú, Tip. della Gioventú,<br />
Genova 1858<br />
.<br />
FRASSINETTI G., Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici, Tip. della Gioventú, Genova 1835.<br />
FRASSINETTI G., Proposte agli ecclesiastici, Tip. delle Letture Cattoliche, Pisa 1861.<br />
FRASSINETTI G., Pia unione dell‟<strong>Immacolata</strong>, Stabilimento Tipografico Ligustico, Genova<br />
1902.<br />
FRASSINETTI G., Pia unione delle figlie <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. sotto il titolo della Purità, Tip. della<br />
Gioventú, Genova 1902.<br />
FRASSINETTI G., Lettere spirituali (ine<strong>di</strong>te) del Priore G. Frassinetti, E<strong>di</strong>zione-Risonanze, Arte<br />
Grafica Romana, Porto Romano 1954.<br />
B. PUBBLICAZIONI SULLA VITA E SPIRITUALITÀ DI GIUSEPPE<br />
FRASSINETTI<br />
BRUZZONE D. – PORCELLA M.F., (a cura) in La formazione alla santità nella Chiesa genovese<br />
dell‟ottocento. Il contributo <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, LAS, Roma 2004.<br />
CACCIOTTI V., Due breve saggi frassinettiani, Centro Vocazionale G. Frassinetti, Roma 1968.<br />
CAPURRO G., Giuseppe Frassinetti e l‟opera sua, Tip. della Gioventú, Genova 1908.<br />
DE ANGELIS A., The prior Joseph Frassinetti and the spirituality of Genoa in the 19th century,<br />
Don Bosco Press, Makati City 2000.<br />
FALASCA M.P., Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, Cantagalli, Siena 2004.<br />
FALDI E.F., Il priore <strong>di</strong> S. Sabina. Il Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, Scuola Tifografica Don<br />
Bosco, Genova 1964.<br />
FASSIOLO D., Memorie storiche intorno alla vita del sac. Giuseppe Frassinetti, Tip. Della<br />
Gioventú, Genova 1879.<br />
137
GHEDA P., Giuseppe Frassinetti. Testimone e formatore <strong>di</strong> santità, Postulazione Generale dei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Litografia Trudu e <strong>Figli</strong> SNC, Cagliari 2004.<br />
OLIVARI C., Il Servo <strong>di</strong> Dio sacerdote Giuseppe Frassinetti, Tipografia Poliglotta Vaticana,<br />
Roma 1928.<br />
PORCELLA M.F., La consacrazione femminile. Pensiero e prassi in Giuseppe Frassinetti, LAS,<br />
Roma 1999.<br />
POSADA M.E., Storia e santità. Influsso del teologo Giuseppe Frassinetti sulla spiritualità <strong>di</strong> S.<br />
<strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello, LAS, Roma 1992.<br />
QUADRACCIA M., Fautori <strong>di</strong> santi. Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, E<strong>di</strong>zione Risonanze,<br />
Roma 2004.<br />
RENZI G., Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche. Catalogo bibliografico generale delle<br />
opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te del Servo <strong>di</strong> Dio, Tifografia Don Guanella, Roma 1979.<br />
ROSSETTO R., Paola Frassinetti. In punta <strong>di</strong> pie<strong>di</strong>, E<strong>di</strong>zioni Messaggero, Padova 1984.<br />
PITTO A., Il priore Giuseppe Frassinetti, in Archivio Frassinettiano, I-II, a cura <strong>di</strong> MORELLI R. –<br />
REGOLI R., Centro Vocazionale ―Giuseppe Frassinetti‖, Roma 1967-1969.<br />
CAMPANELLA A., Giuseppe Frassinetti. Priore in S. Sabina in Genova, in Archivio<br />
Frassinettiano, I-II, a cura <strong>di</strong> MORELLI R. – REGOLI R., Centro Vocazionale ―Giuseppe<br />
Frassinetti‖, Roma 1967-1969.<br />
LUXARDO F., Giuseppe Frassinetti. Pastore d‟anime, autore <strong>di</strong> religiose istituzioni, scrittore <strong>di</strong><br />
opere sacre, in Archivio Frassinettiano, I-II, a cura <strong>di</strong> MORELLI R. – REGOLI R, Centro<br />
Vocazionale ―Giuseppe Frassinetti‖, Roma 1967-1969.<br />
FRASSINETTI P., Lettere, Congregazione delle Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea della Frassinetti, Scuola<br />
Tipografica Italo-Orientali S. Nilo, Roma 1985.<br />
C. DOCUMENTI DEL MAGISTERO<br />
BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica, Deus caritas est, Libreria Vaticana, (25 <strong>di</strong>cembre 2005)<br />
Città del Vaticano 2006.<br />
BENEDETTO XVI, Lampada per i miei è la tua Parola e luce sul mio cammino, Messaggio per<br />
la XXI Giornata Mon<strong>di</strong>ale della Gioventú, Libreria Vaticana, Città del Vaticano 2006.<br />
Catechism of the Catholic Church, Doubleday Pubblication, U.S.A. 1994.<br />
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, Christifideles laici, (30 <strong>di</strong>cembre 1988), EDB,<br />
Bologna 1989.<br />
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, Pastores dabo vobis, (25 marzo 1992),<br />
ELLEDICI, Leumann (To) 1993.<br />
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, Vita consecrata, (12 marzo 1996), L‘Osservatorio<br />
Romano, Città del Vaticano 1996.<br />
138
GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica, Novo millennio inieunte, (6 gennaio 2001), Paoline,<br />
Milano 2001.<br />
GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica, Ecclesia de Eucaristia,(17 aprile 2003), ELLEDICI,<br />
Leumann (To) 2003.<br />
GIOVANNI PAOLO II, Cari giovani, aprite bene gli occhi! Tutti i messaggi della Giornata<br />
Mon<strong>di</strong>ale delle Gioventú, Chirico, Napoli 2005.<br />
GIOVANNI PAOLO II, L‟amore piú grande. Giovani Paolo II ai sacerdoti, (a cura <strong>di</strong>) L.<br />
SAPIENZA, E<strong>di</strong>trice Rogate, Roma 2005.<br />
PAOLO VI, Esortazione Apostolica, <strong>Maria</strong>lis cultus, (2 febbraio 1974), EDB, Bologna 1974.<br />
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA E PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO<br />
INTERRELIGIOSO, Gesú Cristo portatore dell‟acqua viva. Una riflessione cristiana sul “New<br />
Age”, Paoline, Milano 2003.<br />
VATICAN II DOCUMENTS:<br />
Sacrosanctum concilium, Dogmatic constitution on the sacred liturgy, (Dicember 4, 1964).<br />
Apostolicam actuositatem, Decree on the apostolate of lay people, (November 18, 1965).<br />
Dei verbum, Dogmatic constitution on <strong>di</strong>vine Revelation, (November 18, 1965).<br />
Lumen gentium, Dogmatic constitution on the Church, (November 21, 1964).<br />
Optatam totius, Decree on the training of priests, (October 28, 1965).<br />
Perfectae caritatis, Decrees on the up-to date renewal of the religious life, (October 28, 1965).<br />
Presbyterorum or<strong>di</strong>nis, Decree on the ministry and life of priests, (December 7, 1965).<br />
All the above Second Vatican Council documents are found in FLANNERY A. (ed.), The<br />
Vatican Council II: The Conciliar and PostConciliar Documents, Dominican Pubblications,<br />
Dublin 1982.<br />
D. DIZIONARI<br />
ANCILLI E., Direzione spirituale, in A.A. V.V., Dizionario <strong>di</strong> spiritualità dei laici, E<strong>di</strong>zioni O.R.,<br />
Milano 1981.<br />
BEDOULLE., Giansenismo, in A.A. V.V., Dizionario <strong>di</strong> storia della Chiesa, E<strong>di</strong>zioni Stu<strong>di</strong>o<br />
Domenicano, Bologna 1997.<br />
BOWKER J., St. Alphonsus de‟ Liguori, in A.A. V.V., The Oxford <strong>di</strong>ctionary of religions, Oxford<br />
University Press, China 1999.<br />
GLAZIER M., St. Francis de Sales, in A.A. V.V, The modern Catholic Encyclope<strong>di</strong>a, Claretian<br />
Publications, In<strong>di</strong>a 1997.<br />
GRATTON C., Spiritual <strong>di</strong>rection, in A.A. V.V., The new <strong>di</strong>ctionary of catholic spirituality, The<br />
Liturgical Press, Minnesota 1993.<br />
OCCHIALINI U., Direzione spirituale, in A.A. V.V., Dizionario <strong>di</strong> mistica, Libreria E<strong>di</strong>trice<br />
Vaticana, Città del Vaticano 1998.<br />
RUFFING J.K., Spiritual <strong>di</strong>rection, in A.A. V.V., The new SCM <strong>di</strong>ctionary of christian<br />
spirituality, SCM Press, London 2005.<br />
139
E. ALTRI STUDI<br />
AVILA T., The way of perfection, (translated by) E.A. PEERS, Image Books E<strong>di</strong>tion, U.S.A. 1964.<br />
AVILA T., Cammino <strong>di</strong> perfezione, in Opere, Postulazione Generale O.C.D., Roma 1963.<br />
BALLESTRERO A., Giovani verso Cristo: mete e itinerari per la pastorale giovanile, E<strong>di</strong>trice<br />
ELLEDICI, Leumann (To) 1986.<br />
BIANCHI E., Le parole della spiritualità, Rizzoli, Milano 1999.<br />
BOLENKOTTER T., A concise history of the catholic Church, Image Books Doubleday, U.S.A.<br />
1990.<br />
BERNARD C.A., Teologia spirituale, E<strong>di</strong>zioni Paoline, Roma 1983.<br />
BORRIELLO L. – DELLA CROCE G. – SECONDIN B., Storia della spiritualità. La spiritualità<br />
cristiana nell‟età contemporanea, Borla, Roma 1985.<br />
CANTINI O., La paternità spirituale, in Diventare padri nello spirito. La formazione delle guide<br />
spirituali, (a cura <strong>di</strong>), CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI, Ancora, Milano 1999.<br />
CASTELLANO J., Presenza ed azione dello Spirito Santo nella liturgia, in Lo Spirito Santo nella<br />
vita spirituale, E<strong>di</strong>zioni del Teresianum, Roma 1981.<br />
CENCINI A., Direzione spirituale e accompagnamento vocazionale, (a cura <strong>di</strong>), CENTRO<br />
NAZIONALE VOCAZIONI, E<strong>di</strong>trici Ancora, Milano 1996.<br />
COMBY J., How to read the Church history. From the reformation to the present day, SCM<br />
Press London 1998.<br />
COSTA M., Direzione spirituale e <strong>di</strong>scernimento, E<strong>di</strong>zioni ADP, Roma 2000.<br />
CREA G., Gli altri e la formazione <strong>di</strong> sé, EDB, Bologna 2005.<br />
CULLIGAN K.G., Spiritual <strong>di</strong>rection. Contemporary rea<strong>di</strong>ngs, Living Flame Press, U.S.A. 1983.<br />
CURRO S., Il giovani al centro. Prospettive <strong>di</strong> rinnovamento della pastorale giovanile, <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong><br />
San Paolo, Milano 1999.<br />
D‘ASENZO L., La <strong>di</strong>rezione spirituale dei giovani nel loro progetto <strong>di</strong> vita, Teresianum, Roma<br />
1998.<br />
DE FIORES S., <strong>Maria</strong> sintesi <strong>di</strong> valori. Storia culturale della Mariologia, E<strong>di</strong>zioni San Paolo,<br />
Milano 2005.<br />
DE LIBERO D., San Filippo ride e gioca, Coletti E<strong>di</strong>tore, Roma 1962.<br />
DEL PIERO S., Orientamento educativo e accompagnamento vocazionale, ELLEDICI, Leumann<br />
(To) 2000.<br />
DI RIENZO C., Vivi nello Spirito. La <strong>di</strong>rezione spirituale in S. Teresa d‟Avila, E<strong>di</strong>zioni<br />
Dehoniane, Napoli 1962.<br />
DOUGLAS J.M., Handbook of spiritual <strong>di</strong>rectors, Paulist Press, Mah Wah (NJ) 1998.<br />
140
FINUTTI G., Il maestro del cuore: la <strong>di</strong>rezione spirituale in San Filippo Neri, Morcelliana,<br />
Brescia 1997.<br />
FRATELLONE R., La <strong>di</strong>rezione spirituale oggi. Una proposta <strong>di</strong> ricomprensione, SEI, Torino<br />
1996.<br />
GASPARINO A., Maestro insegnaci a pregare, ELLEDICI, Leumann (To) 1999.<br />
GENTINI A., Direzione spirituale e accompagnamento vocazionale, (a cura <strong>di</strong>) CENTRO<br />
NAZIONALE VOCAZIONI, E<strong>di</strong>trice Ancora, Milano 1996.<br />
GONZALEZ L.J., Guidati dallo Spirito. Accompagnamento spirituale <strong>di</strong> stile integrativo, Libreria<br />
E<strong>di</strong>trice Vaticana, Città del Vaticano 1998.<br />
GONZALEZ L.J., Pedagogia della santità, Libreria E<strong>di</strong>trice Vaticana, Città del Vaticano 1998.<br />
GOYA B., Luce e guida nel cammino, EDB, Bologna 2004.<br />
GOYA B., Vita spirituale tra psicologia e grazia, EDB, Bologna 2001.<br />
GRAVISS D., Portrait of the spiritual <strong>di</strong>rector in the writings of St. John of the Cross, Istitutum<br />
Carmelitanum, Roma 1983.<br />
GRENN T., The friend of the bridegroom: spiritual <strong>di</strong>rection and the encounter with Christ, Ave<br />
<strong>Maria</strong> Press, Notre Dame (IN) 2000.<br />
GRITHUIS D.R., Unmasking the New Age, Intervarsity Press, England 1986.<br />
GRÚN A., La cura dell‟anima. L‟esperienza <strong>di</strong> Dio tra fede e psicologia, <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> San Paolo,<br />
Milano 2000.<br />
HOZ GARCIA V., Educazione della sessualità, E<strong>di</strong>zioni San Paolo, Milano 1994.<br />
LAUDAZI C., L‟azione dello Spirito nella crescita del cristiano, in Lo Spirito Santo nella Vita<br />
Spirituale, E<strong>di</strong>zioni del Teresianum, Roma 1981.<br />
LOBATO A., La <strong>di</strong>gnità della persona umana. Privilegio e conquista, E<strong>di</strong>zioni Stu<strong>di</strong>o<br />
Domenicano, Bologna 2003.<br />
LUZZATO S., Giovani e rivoluzionari. L‟età contemporanea, in storia dei giovani (a cura <strong>di</strong>), G.<br />
LEVI – J.C. SCHMITT, E<strong>di</strong>tori La<strong>terza</strong>, Roma 1994.<br />
MAGGIOLINI A., La meta e la strada. Proposta cristiana agli adolescenti, PIEMME, Trento<br />
1999.<br />
MENDIZAL L.M., La <strong>di</strong>rezione spirituale. Teoria e Pratica, EDB, Bologna 1999.<br />
MICHAEL C.P., An introduction to spiritual <strong>di</strong>rection, Paulist Press, U.S.A., 2004.<br />
MILLA C.P., Direzione spirituale, amicizia in Cristo?, Teresianum, Roma 1994.<br />
MOIOLI G., L‟esperienza spirituale, Glossa, Milano 1992.<br />
NEMECK F.K. – COOMBS M.T., The way of spiritual <strong>di</strong>rection, Michael Glazier Inc., U.S.A.<br />
1985.<br />
141
NEWMAN J.H., Janua Coeli. Me<strong>di</strong>tazione <strong>Maria</strong>ne, E<strong>di</strong>trice Stu<strong>di</strong>orum, Roma 1942.<br />
NOONAN E., Counselling psico<strong>di</strong>namico con adolescenti e giovani adulti, (a cura <strong>di</strong>) M.<br />
SIMONETTA – G. ADAMO, Gnochi, Napoli 1997.<br />
OLIATI L., La <strong>di</strong>rezione spirituale dei giovani d‟oggi: appunti per una impostazione pastorale,<br />
E<strong>di</strong>trice ELLEDICI, Leumann (To) 1978.<br />
PACHO E., Storia della spiritualità moderna, Teresianum, Roma 1984.<br />
PAGANI S., L‟accompagnamento spirituale dei giovani. Verso una regola <strong>di</strong> vita, San Paolo,<br />
Cinisello Balsamo (Mi) 1999.<br />
PIGNA A., La <strong>di</strong>rezione spirituale nella vita religiosa, in Rivista <strong>di</strong> Vita Religiosa ed Direzione<br />
Spirituale, Anno XXXIX, Padri Carmelitani Scalzi, Roma 1985.<br />
POLLO M., Le sfide educative dei giovani d‟oggi, E<strong>di</strong>trice ELLEDICI, Leumann (To) 2003.<br />
RAGAZZONI M., Storia della spiritualità moderna, Teresianum, Roma 2005.<br />
ROCCHETTA C., Lo Spirito e le meraviglie <strong>di</strong> Dio, in Lo Spirito Santo nella Vita Spirituale,<br />
E<strong>di</strong>zioni del Teresianum, Roma 1981.<br />
RIVA S., La <strong>di</strong>rezione spirituale nell‟età dello sviluppo, Quiriniana, Brescia 1967.<br />
RUFFING J.K., Spiritual <strong>di</strong>rection: beyond the beginnings, Paulist Press, Mah Wah (NJ) 2000.<br />
RUIZ F., Le vie dello Spirito, EDB, Bologna 1999.<br />
SAPA A., Direzione spirituale a <strong>di</strong>stanza: criteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale per tutte le categorie <strong>di</strong><br />
persone d‟ogni età, E<strong>di</strong>trice La Tifografia, San Curi 1996.<br />
SANTORO M., Silenzio nel mondo giovanile d‟oggi, in Dio Parla nel Silenzio, (a cura <strong>di</strong>), F.<br />
LAMBIASI – et, al., E<strong>di</strong>zioni del Teresianum, Roma 1989.<br />
SERENTHAL L., La <strong>di</strong>rezione spirituale oggi, Ancora, Milano 1998.<br />
SEMEN Y., La sessualità secondo Giovanni Paolo II, E<strong>di</strong>zioni San Paolo, Milano 2005.<br />
TONDO M., Di fronte al progetto <strong>di</strong> vita. Un percorso formativo con i giovani, EDB, Bologna<br />
2005.<br />
TONELLI R., Educhiamo i giovani a vivere da cristiani adulti, E<strong>di</strong>trice ELLEDICI, Leumann<br />
(To) 2000.<br />
ZOVATTO P., (ed.), Storia della spiritualità italiana,Città Nuova, Roma 2000.<br />
ABBREVIAZIONI<br />
AA Vatican Council II, Apostolicam actuositatem, Decree on the Apostolate<br />
of Lay People.<br />
142
AF Arichivio Frassinettiano, I-II, a cura <strong>di</strong> MORELLI REMO – REGOLI<br />
RENATO, Centro Vocazionale ―Giuseppe Frassinetti‖, Roma 1967 –<br />
1969. Pro manuscripto, in Archivio della Curia Generalizia della<br />
Congregazione del <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> (Roma, Via del<br />
Mascherone 55)<br />
CCC Catechism of the Catholic Church.<br />
DV Vatican Council II, Dei verbum, Dogmatic Constitution on Divine<br />
Revelation.<br />
LG Vatican Council II, Lumen gentium, Dogmatic Constitution on the<br />
Church.<br />
LS Lettere Spirituali ine<strong>di</strong>te del Priore G. Frassinetti, E<strong>di</strong>zione –<br />
Risonanze, Arte Grafica Romana, Porto Romano 1954.<br />
OA [FRASSINETTI GIUSEPPE], Opere Ascetiche. Introduzione e note <strong>di</strong><br />
RENZI Giordano, 2 voll.,Postulazione Generale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, Roma 1978.<br />
OT Vatican Council II, Optatam totius, Decrees on the Training of Priests.<br />
PC Vatican Council II, Perfectae caritatis, Decrees on the Up-to.Date<br />
Renewal of the Religious Life.<br />
PO Vatican Council II, Presbyterorum or<strong>di</strong>nis, Decree on the Ministry and<br />
Life of Priests.<br />
SC Vatican Council II, Sacrosanctum concilium, Dogmatic Constitution on<br />
the Sacred Liturgy.<br />
Dominic Tabal<br />
143
LA PREGHIERA, UNIONE D‘AMORE TRA DIO E L‘UOMO.<br />
STUDIO ALLA LUCE DEL ―PATER NOSTER‖<br />
DI SANTA TERESA DI GESÚ.<br />
UN TRATTATO SULLA PREGHIERA DI GIUSEPPE FRASSINETTI 611<br />
ORAZIONE A SANTA TERESA<br />
Teresa <strong>di</strong> Gesú, voi che della sua <strong>di</strong>vina luce aveste sí illuminata la mente, da essere appellata la<br />
Maestra del vero spirito, e della fiamma del suo perfetto amore aveste cosí acceso il cuore da<br />
meritarvi il nome <strong>di</strong> Serafina, ottenetemi da Gesú la grazia d‘una somigliante luce e <strong>di</strong> un<br />
consimile amore, onde sia guidato sulla via della perfezione cristiana, e sia in me consumato<br />
ogni <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato amore terreno; affinché, come voi lo foste, sia pur io interamente <strong>di</strong> Gesú.<br />
(Venerabile Giuseppe Frassinetti, La devozione illumina/a, manuale <strong>di</strong> preghiere, OA II, 262)<br />
Grazie a te mamma, papà, babyette, bongbong, tess, tingting, alla mia amata Congregazione, ai<br />
professori del Teresianum…<br />
611 Dissertazione per la Licenza in Teologia, con la specializzazione in Teologia Spirituale Pontificia<br />
Facultas Theologica Pontificium Institutum Spiritualitatis Teresianum, Roma, studente Jimmy Pantin N°<br />
matr.: 9282/S, Anno Accademico 2005-2006, Moderatore: Prof. Luigi Borriello.<br />
Padre Jmmy Pantin è un giovane sacerdote della Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, che,<br />
fondato sui suoi <strong>stu<strong>di</strong></strong>, porta la forza della Parola e della preghiera tra la gente. Ha lavorato pastoralmente<br />
in Argentina e attualmente in Italia.<br />
144
AAS Acta Apostolicae Se<strong>di</strong>s<br />
AA. VV. Autori Vari<br />
ABBREVIAZIONI<br />
AG Ad Gentes: Decreto dell‘attività missionaria della Chiesa del Concilio<br />
Vaticano II<br />
AGFSMI Archivio della Curia Generalizia della Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong> (Roma, Via del Mascherone 55).<br />
CCC Catechismo della Chiesa Cattolica<br />
CIC Codex Iuris Canonici<br />
DENZ H. Denzinger, Enchiri<strong>di</strong>on Symbolorurn<br />
DV Dei Verbum: Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione del Concilio<br />
Vaticano II<br />
Ed/eds E<strong>di</strong>tore/ e<strong>di</strong>zione/ e<strong>di</strong>to<br />
GS Gau<strong>di</strong>um et Spes: Costituzione pastorale sulla Chiesa e mondo moderno del<br />
Concilio Vaticano II<br />
LAS Libreria Ateneo Salesiana<br />
LEV Libreria E<strong>di</strong>trice Vaticana<br />
LG Lumen Gentium: Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II<br />
OA (G. FRASSINETTI), Opere ascetiche. Introduzione e note <strong>di</strong> G. RENZI, Roma,<br />
Postulazione Generale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> 1978, 2 voll.<br />
OCD Or<strong>di</strong>ne Carmelitane Scalze<br />
OEI (G. FRASSINETTI), Opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te, Poliglotta Vaticana, Roma, 1906-<br />
1913, 13 voll.<br />
OT Optatam Totius: Decreto sulla formazione alla vita sacerdotale del Concilio<br />
Vaticano II<br />
PC Perfèctae Caritatis: Decreto sul rinnovamento della vita religiosa del Concilio<br />
Vaticano II<br />
PO Presbyteronim Or<strong>di</strong>nis: Decreto sulla vita e il ministero dei presbiteri del<br />
Concilio Vaticano II<br />
SC Sacrosanctuni Conciliurn: Costituzione sulla sacra Liturgia del Concilio<br />
Vaticano II<br />
STh Summa Theologiae<br />
145
INTRODUZIONE<br />
La preghiera è la manifestazione piú semplice ed anche piú bella dell‘unione dell‘uomo<br />
con Dio; il <strong>di</strong>alogo con Lui rappresenta l‘aspetto essenziale della vita cristiana.<br />
Con il termine ―unione‖ noi inten<strong>di</strong>amo una con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> idee, una conoscenza<br />
reciproca ed una intima relazione amorosa. «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre<br />
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo <strong>di</strong>mora presso <strong>di</strong> lui» (Gv 14,23), cioè un<br />
<strong>di</strong>namismo ed una energia <strong>di</strong> reciproco amore. Come in una conversazione tra persone, pregare<br />
implica il parlare e l‘ascoltare.<br />
Ogni <strong>di</strong>alogo personale deve essere caratterizzato da due note: come uno percepisce se<br />
stesso e come percepisce l‘altro. L‘uomo si percepisce come un figlio pre<strong>di</strong>letto <strong>di</strong> Dio, come il<br />
migliore amico, come una creatura, come una sposa <strong>di</strong> Dio. L‘uomo è amato senza sosta da Dio,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dagli sbagli che compie. Questo è pregare. Diecimila libri possono darci<br />
definizioni speculative sulla preghiera, ma una descrizione esperienziale e vitale da parte dei<br />
santi in particolare <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila completa ed arricchisce tutte le altre definizioni.<br />
Il Venerabile Padre Giuseppe Frassinetti fu un sacerdote santo e zelante, parroco <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Sabina in Genova. Lui è stato anche definito: teologo, scrittore, apostolo dell‘Eucarestia e<br />
del sacerdozio, <strong>di</strong>fensore della fede cattolica contro i pericoli della filosofia illuminista, i<br />
principi massonici, il giansenismo, il protestantesimo del 19° secolo a Genova. È stato inoltre<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale e fautore <strong>di</strong> santi per esempio: <strong>Santa</strong> Paola Frassineti, <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Domenica<br />
Mazzarello, ed idealmente <strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila. Egli interpreta e riscrive con un<br />
suo taglio <strong>di</strong> teologia ascetica e mistica il pensiero spirituale <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila.<br />
La Autobiografia, Il cammino <strong>di</strong> perfezione e Il Castello interiore erano le sue letture<br />
preferite, scrisse il Il Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú, che è considerato un vero trattato<br />
sulla preghiera. Questa opera, che possiamo considerare uno dei capolavori del Frassinetti, dal<br />
suo originale italiano fu tradotto in molte lingue. Il Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú.<br />
Trattato sulla preghiera (1860), in spagnolo: El Pater noster de <strong>Santa</strong> Teresa de Jesús. Tratado<br />
de la oración (1888), in tedesco: Schule des gebetes der keilingen Teresia; in inglese: Saint<br />
Teresa‟s Pater noster, a treatise on prayer (1887). Questo suo lavoro, sintesi della sua dottrina<br />
sulla preghiera, è <strong>di</strong> carattere pastorale e popolare.<br />
Hans Urs von Balthasar rivolse molta attenzione ai santi e fece appello ai teologi <strong>di</strong> fare<br />
altrettanto. I santi ed i mistici favoriscono la teologia e questo teologo della nostra era afferma<br />
che la teologia e la santità devono andare mano nella mano. I loro esempi sono uno dei Loci<br />
Theologici nelle scienze religiose, devono essere considerati un sopporto per il Magistero e la<br />
Sacra Scrittura. Infatti, i santi sono esegeti esistenziali perché sono i testimoni <strong>di</strong> cosa è il<br />
<strong>di</strong>scepolato e la sequela Christi 612 .<br />
Il santo sacerdote <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina si mantenne fermo nella dottrina spirituale della<br />
fondatrice e riformatrice del Carmelo, una dottrina con un tocco <strong>di</strong> femminilità e non basata<br />
sulla esposizione speculativa. Percepiva che <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú era maestra <strong>di</strong> preghiera e ciò<br />
è stato definito dalla Chiesa cattolica, per mezzo del Papa Paolo VI, con la proclamazione <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Teresa dottore della Chiesa, soprattutto per la sua dottrina in materia <strong>di</strong> spiritualità<br />
mistica. Da sempre gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> sulla sua dottrina hanno sottolineato questa sua tendenza per il<br />
misticismo.<br />
Scoperti gli insegnamenti spirituali dei santi Carmelitani, scriveva in alcune lettere<br />
inviate a figli spirituali che si sentiva conquistato dagli scritti <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa e confessava: «Io<br />
in questo tempo mi sono innamorato delle opere <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa (…)».<br />
In questo periodo era marcato il <strong>di</strong>vorzio tra l‘ascetica e la mistica ed il Padre Giuseppe<br />
ha toccato importanti temi della teologia mistica in cui si percepisce lo sforzo della sintesi con la<br />
<strong>di</strong>mensione ascetica.<br />
Il Capitolo 5° della Lumen gentium del Concilio Vaticano II afferma che ogni uomo e<br />
donna è chiamato alla santità. Ogni uomo e donna è chiamato a raggiungere la vetta piú<br />
sublime. Già <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Avila lo affermava; era in<strong>di</strong>spensabile una vita <strong>di</strong> preghiera seria<br />
612 Ve<strong>di</strong> U. VON BALTHASAR, Telogia e santità, in Verbum Caro, Saggi teologici I, Brescia 1968; ve<strong>di</strong><br />
anche ID., Sorelle nello spirito. Teresa <strong>di</strong> Liseux ed Elisabetta <strong>di</strong> Digione, Jaka Book, Milano 1974.<br />
146
senza la quale nessuno riesce a vivere il Vangelo interamente. Di conseguenza ognuno deve<br />
essere reso edotto che la preghiera e la preghiera contemplativa è non solo per i santi e i mistici;<br />
per questo nel cuore profondo della vita cristiana essa si trova ―in nuce‖ in ogni credente.<br />
La liturgia ha qualcosa da insegnarci, quando ci esorta a pregare, nella festa <strong>di</strong> <strong>Santa</strong><br />
Teresa <strong>di</strong> Gesú, affinché ognuno possa essere ―riempito del suo celestiale insegnamento‖.<br />
Il santo e zelante pastore <strong>di</strong> Genova P. Giuseppe Frassinetti ha scritto e commentato il<br />
Pater noster e lo ha reso accessibile ai suoi parrocchiani, convinto come era, che la <strong>Santa</strong> <strong>di</strong><br />
Avila nel suo insegnamento è comprensibile da tutti.<br />
È interessante notare che durante le lezioni su Dottrina e messaggio <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong><br />
Gesú, Dottore della Chiesa il professore Jesus Castellano Cerveda abbia sottolineato la<br />
universale vocazione <strong>di</strong> entrare nel Castello interiore, appunto per l‘intimità e la comunione con<br />
la Trinità.<br />
Ognuno è chiamato alla santità ognuno è chiamato alla preghiera, ognuno è chiamato a<br />
correre verso e ad entrare nelle porte della Mansione che conduce all‘Unione con Dio, e questa<br />
meta cosí affascinante, è ciò che la Chiesa ci presenta correntemente, nella Liturgia, negli<br />
insegnamenti del Vaticano II, ad esempio nella Lumen gentium n. 41, Ad Gentes n. 18, Dei<br />
Verbum n. 2 e 8 . Il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico, Canone 663 afferma che «primo e particolare<br />
dovere deve essere l‘esperienza della <strong>di</strong>vina presenza nella orazione», i cristiani posseggono la<br />
caratteristica <strong>di</strong> «essere chiamati alla comunione con Dio nella contemplazione» e riassumere<br />
ogni cosa «in una ricca descrizione della preghiera come unione amorosa tra Dio e l‘uomo».<br />
La dottrina <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa è strutturata sulla esperienza <strong>di</strong> Dio per mezzo della<br />
preghiera, lei non ha mai pensato <strong>di</strong> voler essere nostra maestra ma la sua autobiografia e la<br />
testimonianza della <strong>di</strong>vina presenza nella sua vita ci donano una descrizione psicologica e<br />
esperienziale della preghiera. La preghiera mentale è «tratar de amistad estando muchas veces<br />
tratando a solas con quien sabemos nos ama» (Vita VIII, 5).<br />
Metodologicamente parlando, noi abbiamo seguito un approccio descrittivo, analitico e<br />
sintetico che ci sembra il piú conveniente per questo tema classico della Teologia Spirituale: la<br />
preghiera.<br />
Nel primo capitolo si illustrano i mezzi. Nel secondo, si mette in risalto l‘influenza <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila nella spiritualità <strong>di</strong> Padre Frassinetti. Nel terzo si presenta con un metodo<br />
analitico la rilevanza <strong>di</strong> Padre Frassinetti nel terzo millennio. Questo ―lavoro‖ pone molta<br />
attenzione alla Sacra Scrittura e all‘insegnamento della Tra<strong>di</strong>zione e della Chiesa<br />
nell‘esposizione <strong>di</strong> alcune questioni <strong>di</strong> teologia o<strong>di</strong>erna per renderle accessibili al popolo <strong>di</strong> Dio.<br />
L‘intento <strong>di</strong> questo lavoro è mettere in evidenza l‘influsso spirituale <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila nel<br />
pensiero teologico <strong>di</strong> Padre Giuseppe Frassinetti.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista della bibliografia il Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú. Trattato<br />
sulla preghiera è la principale fonte usata. Un altro scritto, capolavoro del suo spirito mistico è<br />
Osculetur me osculi oris sui (Cantico dei Cantici 1,1) e il Pactum pacis. Ci sono molti altri<br />
scritti con impronta mistica, si tratta <strong>di</strong> piccoli lavori che si ispirano quasi sempre a santi<br />
Carmelitani: Le amicizie spirituali, imitazioni <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú, Stimolo allo zelo per la<br />
salute delle anime <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Maddalena de‟ Pazzi, Alcuni effetti che produce nell‟anima<br />
l‟Amor <strong>di</strong>vino, ricavato quest‘ultimo dall‘opuscolo <strong>di</strong> San Giovanni della Croce Fiamma<br />
d‟amor vivo.<br />
L‘autore ha inoltre utilizzato riferimenti alla Sacra Scrittura, ai documenti del Concilio<br />
Vaticano II, al Catechismo della Chiesa Cattolica e ad altri documenti importanti come il<br />
Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico, documenti del Magistero Pontificio, la lettera della Sacra<br />
Congregazione per la Dottrina per la Fede Orationis formas. Ha infine consultato libri e articoli<br />
<strong>di</strong> teologia spirituale; naturalmente sono stati basilari i due anni <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o nel Pontificio Ateneo<br />
Teresianum.<br />
Soprattutto il capitolo primo risponde alla domanda, chi è Padre Giuseppe Frassinetti.<br />
Vi si descrive l‘habitat in cui è nato e cresciuto, la sua famiglia e come sia stato un pastore<br />
zelante, un teologo, uno scrittore, promotore e fondatore <strong>di</strong> gruppi e associazioni ecclesiali e<br />
fautore e sostegno <strong>di</strong> molte persone giunte alla santità.<br />
Il secondo capitolo getta, a volo <strong>di</strong> uccello, uno sguardo sull‘ambiente sociale e<br />
religioso <strong>di</strong> Genova nel 19.mo secolo, per giungere al cuore del nostro tema cioè alla scoperta<br />
147
dei Santi Carmelitani quali <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila, San Giovanni della Croce e <strong>Santa</strong> Maddalena<br />
de‘ Pazzi. È questa una introduzione alla lettura del capolavoro <strong>di</strong> mistica del Frassinetti: il<br />
commento al Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa, testo che mette in luce una preghiera <strong>di</strong> relazione<br />
paterna e filiale, amichevole, sponsale o nuziale.<br />
L‘ultimo capitolo mette in rilievo l‘importanza <strong>di</strong> Padre Frassinetti per noi oggi, gente<br />
del terzo Millennio. Si prenderà in esame l‘aggancio della teologia con la santità vissuta e si<br />
affronterà la questione dell‘apostolato oggi alla luce della teologia spirituale del Padre<br />
Frassinetti.<br />
La conclusione metterà in luce alcune conseguenze.<br />
148
A. Profilo <strong>di</strong> un uomo apostolico<br />
CAPITOLO PRIMO<br />
PADRE FRASSINETTI: CHI SEI?<br />
Il giovane sacerdote Giuseppe Frassinetti nel 1831 fu nominato parroco <strong>di</strong> San Pietro in<br />
Quinto al Mare (Genova) paese <strong>di</strong> pescatori, marinai e conta<strong>di</strong>ni nella Riviera <strong>di</strong> Levante. Erano<br />
suoi collaboratori don Boccalandro e don Figuri e con essi nella casa canonica aveva formato<br />
una associazione <strong>di</strong> vita comune.<br />
Il Frassinetti aveva concentrato il suo lavoro pastorale soprattutto nella pre<strong>di</strong>cazione<br />
della Parola <strong>di</strong> Dio, nel catechismo ai fanciulli e nell‘amministrazione dei sacramenti.<br />
Si <strong>di</strong>stinse come apostolo dell‘Eucaristia, promosse l‘adorazione perpetua del<br />
Santissimo Sacramento. La sua azione pastorale era fondata sull‘ottimismo e sulla gratitu<strong>di</strong>ne;<br />
aveva attenzione ai lontani da Dio e dalla Chiesa e con uno stile persuasivo riuscí a<br />
regolarizzare molti matrimoni 613 .<br />
Si prese cura del suo gregge anche con l‘assidua presenza nel confessionale, con la<br />
<strong>di</strong>sponibilità per la <strong>di</strong>rezione spirituale. Era prudente e comprensivo verso i peccatori<br />
opponendosi alle correnti rigoristiche che si ispiravano al Giansenismo. Fu assorbito dal lavoro<br />
pastorale verso i giovani; per le ragazze chiese ed ottenne la collaborazione <strong>di</strong> sua sorella Paola.<br />
Ella nel prendersi cura dell‘educazione delle ragazze, insegnò loro un lavoro, il catechismo e i<br />
ru<strong>di</strong>menti della cultura.<br />
Nel 1835 Don Luca Passi <strong>di</strong> Bergamo, amico del Frassinetti introdusse la Pia Opera <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Dorotea in Genova ed in particolare in Quinto. Questo sacerdote bergamasco affidò a<br />
Paola il compito <strong>di</strong> raggiungere le giovani povere nelle loro situazioni <strong>di</strong> vita. Da qui Paola<br />
scoprí la responsabilità e il desiderio <strong>di</strong> consacrarsi totalmente all‘apostolato e con un gruppo <strong>di</strong><br />
ragazze fondò una comunità sotto il nome <strong>di</strong> Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea, cambiando il nome<br />
iniziale <strong>di</strong> <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Fede.<br />
Padre Frassinetti sostenne ed incoraggiò la nuova comunità e scrisse le prime<br />
costituzioni. I rapporti tra Paola e il fratello si fecero piú ra<strong>di</strong> quando essa si trasferí a Roma.<br />
Il pastore <strong>di</strong> Quinto al Mare era membro <strong>di</strong> due associazioni sacerdotali create per la<br />
pre<strong>di</strong>cazione e la catechesi. Si tratta della Congregazione dei Missionari Urbani e della<br />
Congregazione dei Operai Evangelici detti Franzoniani. Il gruppo era nato nel 1643 sotto la<br />
guida dell‘Arcivescovo Stefano Durazzo che animò un ircolo <strong>di</strong> sacerdoti per la pre<strong>di</strong>cazione<br />
nelle aree urbane. Don Paolo Franzoni istituí l‘altra. Sebbene tutte e due collaborassero tra loro,<br />
tuttavia quest‘ultima si occupava <strong>di</strong> oratori aperti per il catechismo, la preparazione ai<br />
sacramenti e la formazione sacerdotale 614 .<br />
Don Luigi Sturla, l‘amico piú intimo del Frassinetti era anche lui membro <strong>di</strong> queste<br />
Congregazioni. Lavorarono gomito a gomito ed ebbero l‘intuizione <strong>di</strong> creare la Congregazione<br />
del Beato Leonardo da Porto Maurizio 615 . Con<strong>di</strong>visero le stesse aspirazioni e interessi per i<br />
futuri sacerdoti, creando per essi le con<strong>di</strong>zioni per una solida formazione umana e spirituale.<br />
La situazione della formazione sacerdotale era debole e precaria, basti <strong>di</strong>re che molti<br />
chierici non avevano capito che cosa significasse realmente ―stato clericale‖; molti <strong>di</strong> loro<br />
vivevano sparpagliati nella città, una parte viveva in seminario ma in piena <strong>di</strong>ssipazione morale,<br />
gli altri vivevano nella loro famiglia. Questi due uomini <strong>di</strong> Dio prepararono il regolamento<br />
dell‘Associazione, approvato poi il 2 luglio 1832 e promossero molte attività a tale scopo.<br />
613 Cfr C. OLIVARI, Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti Fondatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1928, 45.<br />
614 Per maggiori informazione intorno ai gruppi ecclesiali esistenti durante il ministero del Frassinetti cfr.<br />
C. OLIVARI, Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, op.cit., 28 – 29.<br />
615 Cfr F. PUDDU,La Congregazione del Beato Leonardo a Genova nel quadro dell‟antigesuitismo<br />
giobertiano 1831 – 1848, Dissertazione per il Dottorato in Lettere presso la Terza Università <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> Roma, 1993/94, 17 – 19.<br />
149
Uno dei biografi del Frassinetti afferma che il suo apostolato non aveva limiti: istruí nel<br />
catechismo perfino i sordomuti, con un metodo da lui inventato 616 .<br />
Per ampliare il suo raggio d‘azione Frassinetti iniziò l‘apostolato anche con la penna. La<br />
prima pubblicazione risale all‘anno 1835 e tratta della Congregazione del Beato Leonardo 617 . La<br />
Congregazione del Beato Leonardo ebbe un notevole sviluppo, in essa Frassinetti era in qualche<br />
modo il teorico mentre lo Sturla l‘organizzatore.<br />
In seguito, Sturla e Frassinetti fondarono una Accademia <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> Ecclesiastici.<br />
L‘Accademia riuniva i migliori elementi del giovane clero e le menti piú brillanti dei professori<br />
<strong>di</strong> teologia <strong>di</strong> Genova furono accolte come professori. Le gelosie suscitate dai successi <strong>di</strong> questa<br />
opera fecero sorgere intorno un‘atmosfera burrascosa.<br />
I libretti del Frassinetti Riflessioni proposte agli Ecclesiastici e Osservazioni intorno<br />
agli <strong>stu<strong>di</strong></strong> ecclesiastici erano una specie <strong>di</strong> esortazione per sé e per gli amici della<br />
Congregazione del Beato Leonardo secondo i suoi fini e la sua impostazione. In essa si<br />
conferma piena fedeltà alla fede e alla tra<strong>di</strong>zione, amore per la Sede Apostolica, e impegno<br />
nello smascherare i nemici della Chiesa tra cui il Giansenismo 618 .<br />
Si ispirò a Sant‘Alfonso M. de‘ Liguori, tenace avversario della dottrina morale del<br />
Giansenismo e <strong>di</strong> ogni forma <strong>di</strong> rigorismo che dunque si può considerare un maestro spirituale<br />
<strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti.<br />
Nel 1842 Frassinetti pubblicò il Compen<strong>di</strong>o della Teologia Dogmatica in forma <strong>di</strong><br />
domanda e risposta. Fu una chiarificazione ed una esposizione essenziale dei dogmi cattolici<br />
in<strong>di</strong>rizzati soprattutto ai Catechisti. Negli anni precedenti, Frassinetti aveva scritto vari opuscoli<br />
sulla verginità cristiana, considerandola uno dei mezzi per la santità 619 .<br />
Nel 1846 pubblicò Avviamento dei giovinetti alla <strong>di</strong>vozione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima, primo<br />
e ricercato opuscolo su tema mariano 620 .<br />
Frassinetti ha continuato le sue pubblicazioni su temi <strong>di</strong> carattere ascetico come Il<br />
conforto dell‟anima <strong>di</strong>vota, libretto in<strong>di</strong>rizzato ai cristiani in genere, che desiderano vivamente<br />
capire ed adempiere la volontà <strong>di</strong> Dio 621 .<br />
Il santo sacerdote scrisse un libro in<strong>di</strong>rizzato ai preti: Gesú Cristo regola del sacerdote,<br />
si tratta <strong>di</strong> una semplice e densa sintesi dell‘ideale <strong>di</strong> colui che serve all‘altare 622 , e si può<br />
616<br />
Cfr ibid., 58 – 61.<br />
617<br />
Cfr. G. FRASSINETTI, Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. e dei ss. Apostoli<br />
e del Beato Leonardo da Porto Maurizio, Tip. Ferrando, Genova 1835. Tutte le citazioni delle opere <strong>di</strong><br />
Padre Giuseppe Frassinetti <strong>di</strong> questo lavoro sono prese da 1. G. FRASSINETTI, Opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te, Tip.<br />
Poliglotta Vaticana, Roma 1906 – 1913, 13 voll.; 2. ID., Opere Ascetiche, Introduzione e note <strong>di</strong> Renzi<br />
Giordano, Postulazione Generale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Roma 1978, 2 voll.; 3. Lettere<br />
spirituali <strong>di</strong> Padre Frassinetti, Archivio della Curia Generalizia dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>; ve<strong>di</strong><br />
R. MORELLI – R. REGOLI, Archivio Frassinettiano, Centro Vocazionale ―Giuseppe Frassinetti‖, Roma<br />
1967 – 1969. Pro manuscripto, abbreviato in AGFSMI.<br />
618<br />
L‘iniziatore del Giansenismo fu Cornelio Giansenio, Vescovo <strong>di</strong> Ypres e professore dell‘Università <strong>di</strong><br />
Lovanio., Egli aderí alla teologia <strong>di</strong> Sant‘Agostino circa la natura del peccato originale, la libertà umana,<br />
e la natura e l‘efficacia della grazia <strong>di</strong> Dio. Cfr. T. BOKENKOTTER, A concise history of the Catholic<br />
Church, Image Books Doubleday, U.S.A. 1990, 239; cfr anche G. BEDOUELLE, Giansenismo, in<br />
Dizionario della Storia della Chiesa, E<strong>di</strong>zioni Stu<strong>di</strong>o Domenicano, Bologna 1997, 106 – 108.<br />
619<br />
Cfr G. FRASSINETTI, La santa verginità, Tip. Ferrando, Genova 1841, ID, La forza <strong>di</strong> un libretto, e<strong>di</strong>to<br />
anonimo, Tip. Ferrando, Genova 1841.<br />
620<br />
ID, Avviamento dei giovinetti alla <strong>di</strong>vozione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima, Tip. Monal<strong>di</strong>, Genova 1846, Tra gli<br />
altri scritti citiamo: L‟ossequio piú gra<strong>di</strong>to a <strong>Maria</strong> Santissima <strong>Immacolata</strong>, Tip. Ligustico 1855; Le<br />
do<strong>di</strong>ci stelle, ossia le virtú della Beata Vergine <strong>Maria</strong>, Tip. Fassi – Como, Genova 1857; La Via Matris,<br />
ricavata dalle riflessioni <strong>di</strong> S. Alfonso <strong>Maria</strong> de‟ Liguori sopra ciascuno dei sette dolori <strong>di</strong> <strong>Maria</strong><br />
Santissima me<strong>di</strong>tati in forma <strong>di</strong> Via Crucis, Tip. Fassi – Como, Genova 1859: Amiamo <strong>Maria</strong>!, Tip.<br />
Gioventú, Genova 1864.<br />
621<br />
G. FRASSINETTI, Il conforto dell‟anima <strong>di</strong>vota, Tip. Bettolo, Genova 1844. Questo libro è stato tradotto<br />
in tedesco, francese, spagnolo ed inglese. Per ulteriori informazioni su libri del Frassinetti e le varie<br />
e<strong>di</strong>zioni e lingue ve<strong>di</strong>: M. FALASCA, Il Frassinetti in giro per il mondo, in Risonanze, 59 1984 4, 9-24.<br />
622<br />
ID, Gesú Cristo regola del sacerdote, Tip. Cecchi, Firenze 1852. Questo libro ha avuto trentadue<br />
e<strong>di</strong>zioni in italiano ed è stato tradotto in tedesco, francese, inglese, spagnolo e polacco.<br />
150
affermare che esso è il capolavoro del Frassinetti per la profon<strong>di</strong>tà dei concetti che si ispirano<br />
alla Sacra Scrittura; la sua <strong>di</strong>ffusione fu notevole. In<strong>di</strong>rizzò alle ragazze il libretto La gemma<br />
delle fanciulle cristiane, ossia la santa verginità, e subito dopo pubblicò ancora un altro scritto<br />
La forza <strong>di</strong> un libretto 623 .<br />
Egli non varcò mai il confine <strong>di</strong> Genova ma attraverso i suoi scritti giunse in molti parti<br />
d‘Europa ed anche in America.<br />
Nella primavera del 1849 Frassinetti, dopo tre<strong>di</strong>ci mesi si allontanamento coatto dalla<br />
sua parrocchia, fece ritorno a Genova e riallacciò i legami con i principali membri della<br />
Congregazione del Beato Leonardo, ormai liquidata. Da questo momento si intensifica il suo<br />
impegno per far sorgere gruppi e associazioni apostoliche.<br />
Incoraggiò e promosse in Genova l‘Opera del Buon Pastore, una istituzione <strong>di</strong> origine<br />
francese in aiuto alle ragazze ―pericolanti‖.<br />
La Pia associazione in onore <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima per la conservazione ed incremento<br />
della Fede Cattolica iniziata nel 1852, fu un progetto del Frassinetti; era in qualche modo la<br />
continuazione della Congregazione del Beato Leonardo; essa potrebbe essere considerata, a<br />
detta comune, come un‘Azione Cattolica in embrione 624 . Si tratta <strong>di</strong> una associazione aperta a<br />
tutti i cattolici, siano essi ecclesiastici o laici, con lo scopo dell‘ascolto della Parola <strong>di</strong> Dio, la<br />
preghiera e l‘impegno per le pubblicazioni cattoliche. In seguito si aggiunsero altri scopi come<br />
gruppi che promuovevano l‘adorazione eucaristica anche notturna, il catechismo ai bambini,<br />
l‘impegno contro la <strong>di</strong>ffusione del protestantesimo nella città. L‘associazione era sotto la guida<br />
del vescovo. Gli aderenti erano molto numerosi e particolarmente attivi erano i gruppi<br />
femminili 625 .<br />
Il Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina fu creatore e sostenitore <strong>di</strong> molte associazioni e Pie Unioni, che<br />
nel tempo dettero tante vocazioni alla <strong>di</strong>ocesi. Nel 1854 con Mons. Salvatore Magnasco creò la<br />
Società Operaia <strong>di</strong> Mutuo Soccorso, una delle prime società <strong>di</strong> aiuto e <strong>di</strong> apostolato sociale in<br />
Italia.<br />
Il Pastore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina promosse numerose associazione per coinvolgere anche i laici<br />
nel lavoro pastorale e parrocchiale; vale la pena menzionare alcune <strong>di</strong> esse: Pia Unione della<br />
<strong>Santa</strong> Modestia, Opera della <strong>Santa</strong> Infanzia, le già note Congregazione del Beato Leonardo,<br />
Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> e Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, in<strong>di</strong>rizzate ai giovani Associazione <strong>di</strong> Gesú Bambino, Associazione della <strong>Santa</strong><br />
Purità, Unione per la conversione dei peccatori, e inoltre Congregazione delle vedove cristiane,<br />
Amicizie spirituali <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa e <strong>Santa</strong> Lega <strong>degli</strong> amanti del Sacro Cuore <strong>di</strong> Gesú 626 .<br />
B. Note sull’ambiente sociale e politico<br />
Il <strong>di</strong>ciannovesimo secolo in Europa rappresenta il periodo dei contrasti tra restaurazione<br />
e rivoluzione, tra<strong>di</strong>zionalismo, <strong>roma</strong>nticismo e illuminismo. Anche nel contesto italiano, può<br />
623 Succintamente in P. ZOVATTO, Storia della spiritualità italiana, Città Nuova, Roma 2000, pp. 564-<br />
567, si trovano <strong>di</strong>versi epiteti adattati alla figura del Frassinetti come: <strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila,<br />
animatore e fondatore <strong>di</strong> gruppi ed associazioni, consolatore in cura animarum, apostolo della <strong>Santa</strong><br />
Eucarestia.<br />
624 ID, Altro cenno sulla Pia Associazione per la conservazione ed incremento della Fede Cattolica in<br />
Genova, stampato da manoscritto ine<strong>di</strong>to in OEI III, 97 e ss. ; F. PUDDU, La Congregazione…op. cit.,<br />
173-175.<br />
625 ID., Regolamento per la Conferenza dei promotori della Pia Associazione per la promozione ed<br />
incremento della Fede Cattolica, Tip. Ligustico, Genova 1853. ID., Regolamento per la Conferenza dei<br />
promotori della Pia Associazione per la promozione ed incremento della Fede Cattolica in Genova, con<br />
l‟aggiunta della Pia Associazione da promuoversi nelle parrocchie da promuoversi nelle parrocchie<br />
dell‟Archi<strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> Genova ad onore <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. ma per lo stesso scopo, Tip. Fassi – Como, Genova<br />
1856.<br />
626 L‘elenco <strong>di</strong> queste Associazioni, Congregazioni e Pie Unioni è stato preso da :CONGREGATIO DE<br />
CAUSIS SANTORUM, IANUEN. Canonizationie servi Dei Josephi Frassinetti, Prioris Paroeciae S. Sabinae,<br />
Fundatoris Filiorum Sanctae <strong>Maria</strong>e Immaculatae 1804 – 1868. Positio super virtutibus. Informatio.<br />
Roma [s.e.1981], 11.<br />
151
essere osservata la stessa <strong>di</strong>namica. Dovremmo cercare in particolare la situazione <strong>di</strong> Genova<br />
durante questo periodo, il posto dove Padre Giuseppe Frassinetti era nato. Possiamo subito<br />
affermare che la situazione globale durante questa era aveva un influsso molto forte. Era infatti<br />
un secolo dagli avvenimenti tormentati <strong>di</strong>battuti e che si <strong>di</strong>ffondevano a macchia d‘olio; un<br />
esempio è nominare le vicissitu<strong>di</strong>ni collegate a Genova, che aveva perso la sua libertà<br />
plurisecolare e pace interna a causa dello scoppio delle opposte passioni e partiti locali. Nel<br />
sangue <strong>di</strong> ogni genovese non c‘era solo la lotta per l‘in<strong>di</strong>pendenza contro i francesi ma anche un<br />
conflitto emergente tra il popolo. Il Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe ha vissuto e lavorato mentre<br />
esistevano tendenze opposte vecchie e nuove. Non si lasciò mai ingannare dalle illusioni facili,<br />
ha osservato attentamente quelle con<strong>di</strong>zioni umane alla luce dell‘eternità. Non fu mai politico né<br />
<strong>di</strong>lettante e nemmeno <strong>di</strong>scepolo della politica; egli fu un prete e la sua politica fu soltanto il<br />
Vangelo.<br />
Questo era il retroterra politico all‘inizio del Diciannovesimo secolo. C‘erano molti<br />
problemi interni e non riconducibili ad unità che avevano origine politica e filosofica. Il 30<br />
giugno 1805 Napoleone era stato coronato Re d‘Italia e aveva preso possesso della Penisola. Le<br />
conseguenze <strong>di</strong> tale rivoluzione si ripercossero sulla situazione religiosa <strong>di</strong> Genova: saccheggi<br />
<strong>di</strong> chiese, soppressione e <strong>di</strong>ssacrazione <strong>di</strong> conventi e monasteri, confisca delle loro proprietà<br />
passate in uso allo Stato.<br />
Il 1846, per il sorgere <strong>di</strong> un acceso anticlericalismo, fu un anno <strong>di</strong> particolare <strong>di</strong>fficoltà:<br />
il Papa Pio IX fu costretto a rifugiarsi a Gaeta, Roma fu governata da un Triunvirato, a Novara<br />
ci fu una clamorosa sconfitta, il fallimento del Risorgimento mazziniano. La morte del<br />
Car<strong>di</strong>nale Arcivescovo <strong>di</strong> Genova Placido M. Ta<strong>di</strong>ni mise la Chiesa genovese in grande<br />
<strong>di</strong>fficoltà. La sede vacante durò cinque anni; la Diocesi restò sotto la <strong>di</strong>rigenza del Vicario<br />
Generale Monsignor Giuseppe Ferrari. Era egli un uomo retto ma non aveva il carattere deciso<br />
richiesto dalle circostanze determinate dagli eventi politici e dal comportamento del clero,<br />
simpatizzante delle idee liberali. Dopo cinque anni <strong>di</strong> sede vacante, arrivò a Genova il nuovo<br />
Arcivescovo il 23 gennaio 1853 nella persona <strong>di</strong> Mons. Andrea Charvaz.<br />
Vincenzo Gioberti con i suoi libri in particolare I Prolegomeni e Il Primato <strong>degli</strong><br />
Italiani confondeva le coscienze. Questi scritti contenevano anche impietosi attacchi ai gesuiti<br />
che erano considerati i responsabili delle traversie che affrontava la società italiana. Il<br />
Frassinetti seppe opporsi con lo scritto, gli rispose con un saggio che metteva in luce la<br />
pervicacia della <strong>di</strong>alettica e della religiosità del Gioberti. Questo libro causò un pubblico<br />
trambusto e Gioberti fece del Frassinetti il bersaglio dei suoi strali, accusò la Congregazione del<br />
Beato Leonardo <strong>di</strong> essere una associazione <strong>di</strong> retrogra<strong>di</strong> e <strong>di</strong> cospiratori.<br />
Nel frattempo la pubblicazione del Gioberti Il Gesuita moderno portò i frutti avvelenati<br />
che si prevedeva. Sebbene il re Carlo Alberto si fosse rifiutato <strong>di</strong> espellere da Genova i <strong>di</strong>scepoli<br />
<strong>di</strong> Sant‘Ignazio <strong>di</strong> Loyola, essi furono cacciati dal furore popolare; e dopo i gesuiti fu la volta<br />
dei Gesuitanti.<br />
Don Luigi Sturla, amico del Frassinetti e confondatore della Congregazione del Beato<br />
Leonardo fu mandato in esilio. Il Frassinetti durante le agitazioni, appena appena sfuggí<br />
all‘arresto. Si rifugiò in Val Polcevera presso l‘abate Gerolamo Campanella dove rimase<br />
nascosto tre<strong>di</strong>ci mesi e sopportò le <strong>di</strong>fficoltà e le sofferenze con fede e confidenza in Dio.<br />
C. La sua famiglia e la sua vita<br />
Paolo Giuseppe <strong>Maria</strong> Frassinetti 627 fu il primogenito <strong>di</strong> Giovanni Battista e Angela<br />
Viale. I suoi genitori erano persone pie e modello <strong>di</strong> virtú. La casa fu benedetta con l‘arrivo <strong>di</strong><br />
627 Esistono <strong>di</strong>verse biografie del Padre Giuseppe Frassinetti: D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla<br />
vita del Sac. Giuseppe Frassinetti, Tip. della Gioventú, Genova 1879; C. OLIVARI, Della vita e delle<br />
opere del Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina in Genova, Fondatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1928; G. RENZI, Giuseppe Frassinetti e le sue<br />
opere ascetiche, Tip. Don Guanella, Roma 1969; M. FALASCA, Storia <strong>di</strong> un parroco il Ven. Giuseppe<br />
Frassinetti, Fondatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Cantagalli, Siena 2006; ve<strong>di</strong> anche: P.<br />
PARENTE, Il Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti commemorato a Siena il 27 ottobre 1968, in<br />
152
altri tre figli: Francesco, Giovanni e Raffaele tutti <strong>di</strong>venuti sacerdoti e <strong>di</strong> una figlia Paola<br />
fondatrice delle Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea. Giuseppe crebbe nell‘atmosfera serena della sua casa,<br />
grazie ai suoi genitori che allevarono i figli nella pietà e nel timor <strong>di</strong> Dio. All‘interno della<br />
famiglia Giuseppe ricevette la prima e fondamentale educazione cristiana.<br />
Giuseppe fu consacrato alla Madonna nel santuario detto della Madonnetta in<br />
Genova.Non è nota la data precisa della sua Prima Comunione, certa è quella della Cresima: il<br />
17 aprile 1817. Questi furono momenti <strong>di</strong> profonda riflessione per ciò che egli aveva sempre<br />
avvertito nel profondo del suo cuore cioè la chiamata <strong>di</strong>vina. Angela Viale era una donna<br />
semplice ma con una profonda spiritualità ed umanità. Giuseppe ere<strong>di</strong>tò da lei pietà e generosità<br />
<strong>di</strong> cuore. Il padre, Giovanni Battista, era un uomo umile ed onesto, pieno <strong>di</strong> senso del dovere e<br />
lavoratore instancabile.<br />
All‘età <strong>di</strong> 15 anni Giuseppe perse sua madre. Essa non poté vedere realizzato il <strong>di</strong>segno<br />
dei figli che <strong>di</strong>vennero tutti e quattro sacerdoti e della figlia che si consacrò al Signore. Il<br />
marito, uomo <strong>di</strong> grande fede; accettò la morte <strong>di</strong> Angela con rassegnazione alla volontà <strong>di</strong> Dio.<br />
Dotato <strong>di</strong> una brillante intelligenza, Giuseppe probabilmente apprese i ru<strong>di</strong>menti della<br />
lingua latina da Fra Angelico, un frate osservante. Egli frequentò la scuola del seminario come<br />
esterno, e si <strong>di</strong>stinse anzi superò gli altri seminaristi nel ren<strong>di</strong>mento soprattutto nelle materie<br />
umanistiche. Inoltre egli si <strong>di</strong>stinse nel campo della Filosofia e della Teologia, ottenendo lo<strong>di</strong> e<br />
conseguendo premi.<br />
Tra il 7 giugno 1824 e il 9 giugno egli ricevette tutti gli Or<strong>di</strong>ni minori e maggiori e fu<br />
or<strong>di</strong>nato sacerdote il 22 settembre 1827. È incerta la chiesa in cui celebrò la sua prima Messa;<br />
probabilmente la chiesa della Madonna della Misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Savona. Giuseppe aveva appena<br />
23 anni quando fu or<strong>di</strong>nato sacerdote.<br />
All‘età <strong>di</strong> 34 anni il 10 giugno 1839 il Padre Giuseppe fu nominato parroco-priore <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Sabina in Genova; il titolo <strong>di</strong> priore era collegato alla storia <strong>di</strong> quella chiesa. In canonica<br />
viveva con il vecchio padre e due fratelli sacerdoti: Giovanni e Raffaele. Si de<strong>di</strong>carono insieme<br />
con vivo zelo alla cura spirituale dei fedeli con particolare riguardo alle confessioni e alla<br />
pre<strong>di</strong>cazione. Erano vere guide del popolo cristiano.<br />
Vi rimase fino alla morte. Il santo sacerdote si de<strong>di</strong>cò tutto alla cura spirituale del suo<br />
gregge, con particolare attenzione alla confessione e alla pre<strong>di</strong>cazione. Erano folle che<br />
accorrevano e ricercavano la sua guida spirituale e la consolazione interiore. La vita<br />
parrocchiale gli dette l‘opportunità <strong>di</strong> allargare il lavoro sacerdotale, per cui pensò <strong>di</strong> servirsi<br />
anche <strong>degli</strong> scritti per <strong>di</strong>ffondere il messaggio religioso.<br />
Il Frassinetti morí a Genova il 2 gennaio 1868.<br />
D. Animatore, collaboratore e fondatore <strong>di</strong> pie associazioni ed altri gruppi ecclesiali<br />
La Chiesa Cattolica era in tripu<strong>di</strong>o per la proclamazione del Dogma dell‘<strong>Immacolata</strong><br />
Concezione; Frassinetti profondamente devoto della Madonna <strong>Immacolata</strong> pensò <strong>di</strong> intitolare ad<br />
essa la nuova Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> che prendeva vita in <strong>Santa</strong> Sabina.<br />
La Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> era una comunità per la formazione<br />
dei laici consacrati me<strong>di</strong>ante i consigli evangelici e che sostenevano i seminaristi nel loro<br />
cammino verso il sacerdozio. Da questa Pia Unione è sorta in seguito la Congregazione dei <strong>Figli</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>.<br />
Si trattava <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> alcuni giovani che iniziavano una esperienza <strong>di</strong> vita cristiana<br />
e consacrata. Egli era il sostenitore e l‘anima della associazione. I membri della Pia Unione si<br />
consideravano come religiosi al secolo, le cui linee <strong>di</strong>rettive e lo stile <strong>di</strong> vita era simile a quelle<br />
del ramo femminile. Essi vivevano nella loro famiglia e si de<strong>di</strong>cavano a varie attività <strong>di</strong><br />
apostolato, seguendo comunque una regola <strong>di</strong> vita. Li incitava non solo a conseguire la<br />
personale santificazione ma anche a promuovere il bene delle anime ed emulare i religiosi nella<br />
L‘Osservatore Romano 107 31 -10 – 1968; G. SIRI, Priore Giuseppe Frassinetti, Tip. Don Guanella,<br />
Roma 1968; A. DE ANGELIS, The Venerable Joseph Frassinetti, Founder of the Sons of Holy Mary<br />
Immaculate, Quality Catholic Pubblications, Manila 1997.<br />
153
perfezione pur rimanendo nella vita attiva. Ad imitazione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> anche alcuni <strong>di</strong><br />
loro si riunirono per vivere in comunità. Il Priore preparò per loro il testo Il religioso al secolo.<br />
Che relazione c‘è tra Padre Giuseppe Frassinetti e la Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong><br />
<strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>? Per indagare su questo problema è opportuno dare uno sguardo retrospettivo<br />
alla Parrocchia <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina <strong>di</strong> Genova. Il Priore fondò il 14 novembre 1860 la Pia Unione<br />
dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> i cui membri erano giovani laici che si proponevano come<br />
fine il sostegno per le vocazioni sia dal punto <strong>di</strong> vista materiale che spirituale.<br />
Piú tar<strong>di</strong> tre <strong>di</strong> essi iniziarono una esperienza <strong>di</strong> vita comune continuando tuttavia la loro<br />
professione. L‘inaugurazione avvenne il 14 gennaio 1866, quando nel santuario della<br />
Madonnetta, al mattino presto si posero sotto la protezione della Vergine <strong>Santa</strong>. I tre giovani,<br />
che si possono definire i pionieri erano Pietro Olivari, Emanuele Pedemonte e Pietro Ghiglione.<br />
In seguito la Pia Unione <strong>di</strong>venne Opera dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> i cui membri era<br />
<strong>di</strong> appoggio ai can<strong>di</strong>dati al sacerdozio. Con il crescere del numero anche la canonica <strong>di</strong>venne<br />
insufficiente ma proprio in quel tempo il Priore morí. P. Antonio Piccardo, un giovane prete<br />
molto attivo prese la <strong>di</strong>rezione dell‘Opera, lasciata dal Priore. In cinquat‘anni 420 sacerdoti<br />
furono or<strong>di</strong>nati e presentati alla Chiesa. Da sempre Padre Piccardo sognava <strong>di</strong> poter trasformare<br />
l‘Opera dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> in Congregazione religiosa.<br />
L‘otto <strong>di</strong>cembre 1903 la Diocesi <strong>di</strong> Roma emise il Decreto delle erezione in<br />
Congregazione dell‘Opera dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>. Il 21 maggio 1904 il Papa Pio<br />
X ex plenitu<strong>di</strong>ne potestatis concesse con Motu proprio il Decretum lau<strong>di</strong>s e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>venne <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ritto pontificio. Frassinetti probabilmente non aveva pensato <strong>di</strong> creare una Congregazione<br />
religiosa, forse per la sua immatura morte, ma le vie della Provvidenza sono <strong>di</strong>fferenti. Senza la<br />
semina compiuta dal Frassinetti della Pia Unione, la Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong> non sarebbe esistita. Paolo Giuseppe <strong>Maria</strong> Frassinetti è stato proclamato<br />
Venerabile il 14 maggio 1991. La Congregazione <strong>di</strong>ffonde la forza del carisma del fondatore in<br />
Italia, Argentina, Cile, Filippine, Polonia e Messico.<br />
D. Fautore e guida spirituale <strong>di</strong> santi 628<br />
Molti sono i sacerdoti, i religiosi ed i laici la cui santità è fiorita accanto al Padre<br />
Frassinetti. Oltre a quelli che descriveremo piú sotto sono degni <strong>di</strong> menzione: Don Luigi Sturla,<br />
Monsignor Salvatore Magnasco, Padre Ballerini, Angela Maccagno insieme ad altre <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong><br />
<strong>Maria</strong>, 629 Clelia Barbieri, Teresa Camera, <strong>Maria</strong> Maddalena Starace, Eugenia Ravasco, Giacinto<br />
Bianchi, Agostino Roscelli, Nicolò D‘Aste, Luigi Guanella, Marcella Bosatta e le<br />
guanelliane 630 . Molti <strong>di</strong> questi santi erano accanto al Frassinetti per cui o con il suo aiuto <strong>di</strong>retto<br />
o in<strong>di</strong>retto hanno ricevuto nel segreto del loro cuore l‘ispirazione <strong>di</strong> vivere santamente indotti<br />
dalla sua guida o dai suoi scritti. 631<br />
1. Paola Frassinetti<br />
628 Padre Giuseppe aveva la fama <strong>di</strong> essere ―il curato d‟Ars <strong>di</strong> Oltralpe‖: cfr. J.C.WILLKE, in AA. VV.,<br />
New Catholic Encyclope<strong>di</strong>a, Vol. VI., Washington E<strong>di</strong>tion, The Catholic University of America 1967, 81.<br />
629 Frassinetti è conosciuto come l‘apostolo della vita consacrata. Il Postulatore generale della Causa <strong>di</strong><br />
Beatificazione ha de<strong>di</strong>cato molti capitoli su questo tema, particolarmente sottolineato in una recente<br />
pubblicazione. Eccone alcuni esempi: 1. Giuseppe Frassinetti alle origini delle Dorotee; 2. Primi passi<br />
delle Dorotee sotto la giuda del Frassinetti; 3. Differenze <strong>di</strong> vedute tra fratello e sorella Giuseppe e Paola;<br />
4. La storia delle regole; 5. Don Pestarino e le ragazze <strong>di</strong> Mornese; 6. Le <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong><br />
―Monache in casa‖; 7. Alcune <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Ausiliatrice; 8. I <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong><br />
<strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> – P. Piccardo. Cfr. M. P. FALASCA, Storia <strong>di</strong> un parroco, il Venerabile Giuseppe<br />
Frassinetti, Ed. Cantagalli, Siena 2000, 465 – 652. Cfr. anche M. F. PORCELLA, La consacrazione<br />
secolare femminile, pensiero e prassi in Giuseppe Frassinetti, LAS, Roma 1999, 71 – 123.<br />
630 I santi che sono vissuti ―accanto‖ al Frassinetti sono stati descritti in M. QUADRACCIA, Fautori <strong>di</strong><br />
santi, E<strong>di</strong>zioni Risonanze, Roma 2004, 56 – 91.<br />
631 <strong>Santa</strong> Teresa de los Andes e il Beato John Henri Newman hanno letto i suoi scritti. Questo argomento<br />
sarà descritto nel prossimo capitolo.<br />
154
Padre Giuseppe, che era parroco a Quinto, ha offerto a Paola ospitalità per un<br />
certo tempo, aveva 19 anni. L‘attività parrocchiale le ha dato opportunità <strong>di</strong> aiutare il<br />
fratello Giuseppe nel lavoro apostolico. Tante ragazze erano attratte dai suoi mo<strong>di</strong><br />
gentili e dalla sua de<strong>di</strong>zione nel servire Dio.<br />
Svolgendo le attività parrocchiali, lei ha scoperto la sua vocazione come<br />
educatrice; un piccolo gruppo <strong>di</strong> ragazze si è radunato attorno a lei e ha cominciato a<br />
condurre una vita comunitaria. Nella mente <strong>di</strong> Paola, l‘idea del nuovo istituto <strong>di</strong>venta<br />
chiara e trova conferma nell‘assicurazione del fratello, Padre Giuseppe a cui l‘aveva<br />
confidata.<br />
Paola ha trovato la <strong>di</strong>mensione apostolica della sua vocazione nell‘aiuto alle<br />
ragazze povere e bisognose. Le suore che si chiamavano <strong>Figli</strong>e della Fede hanno<br />
mutato poi il nome in Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea. Si impegnarono nell‘evangelizzazione,<br />
tramite l‘educazione con preferenza per i giovani e per i poveri. Alcune case sono state<br />
costruite a Genova, ma Paola rivolse la sua attenzione a Roma. Papa Gregorio XVI<br />
entusiasta dell‘opera delle Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea nel 1844 affidò a Paola la <strong>di</strong>rezione<br />
del Conservatorio <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>di</strong> Rifugio a San Onofrio dove ora hanno la casa<br />
generalizia. Ci sono stati perio<strong>di</strong> in cui non sono mancate sofferenze e <strong>di</strong>fficoltà, ma il<br />
suo zelo apostolico ha prevalso e l‘istituto si è espanso piano piano in Italia, Brasile e<br />
Portogallo. All‘alba dell‘11 Giugno 1882, Paola si congeda da questa terra. L‘8 Giugno<br />
1930 Paola è stata <strong>di</strong>chiarata beata e l‘11 Marzo, 1984, la Chiesa Cattolica Romana l‘ha<br />
proclamata santa.<br />
2. Giovanni Bosco<br />
Don Bosco e Giuseppe Frassinetti erano amici. La loro amicizia aveva anche<br />
legami <strong>di</strong> collaborazione nel campo dell‘e<strong>di</strong>toria: il primo era e<strong>di</strong>tore e l‘altro era un<br />
redattore 632 . La loro era un‘unità <strong>di</strong> cuore e <strong>di</strong> mente ed hanno lavorato all‘unisono per<br />
la Chiesa e per il prossimo. Tale rapporto era noto prima del 1857, anche se non ci sono<br />
prove sicure ma solo <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>zi, infatti sembra che il Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina avesse<br />
preso l‘iniziativa <strong>di</strong> chiedere la fondazione del primo oratorio per i bambini <strong>di</strong> strada a<br />
Genova, come farà il santo a Torino.<br />
La loro amicizia è durata tutta la vita ed è stata uno stimolo per Don Bosco ad<br />
aprire la loro prima casa a Genova, come hanno fatto costruendo il grande collegio <strong>di</strong><br />
Sampierdarena.<br />
San Giovanni Bosco, che aveva cominciato una serie <strong>di</strong> pubblicazioni religiose<br />
nelle Letture Cattoliche, aveva bisogno <strong>di</strong> materiale ed ha chiesto a Frassinetti alcuni<br />
testi. Il primo frutto <strong>di</strong> questa collaborazione fu la vita <strong>di</strong> Rosa Cordone, una giovane<br />
<strong>Figli</strong>a <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> della Pia Unione stabilita a <strong>Santa</strong> Sabina. Ci sono tante opere ed articoli<br />
del Frassinetti apparsi in Letture Cattoliche. Ecco alcuni titoli: Dialoghetti sui<br />
comandamenti della Chiesa, Vita <strong>di</strong> Rosa Cordone, Industrie spirituali secondo il<br />
bisogno dei tempi, Il para<strong>di</strong>so in terra nel celibato cristiano, Dell‟impiego del denaro.<br />
Stefano Sciaccabugan in Don Bosco a Genova <strong>di</strong>ce che due <strong>di</strong> questi libri<br />
ebbero un successo particolare: La Vita <strong>di</strong> Rosa Cordone L‟impiego del denaro<br />
pubblicato nel Aprile <strong>di</strong> 1866. Ciò fu un provvidenziale aiuto, una esortazione alla<br />
generosità da parte soprattutto dei possidenti, e Don Bosco, impegnato come era nella<br />
costruzione del Santuario <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Ausiliatrice con uno stato finanziario debole, ne<br />
ebbe sicuri benefici. Frassinetti ha messo in questa breve opera, piú che lo spirito del<br />
prete pieno <strong>di</strong> carità, il suo talento pratico <strong>di</strong> un genovese. Il Vaccari nel suo scritto Don<br />
632 Per ulteriori informazioni circa questa amicizia cfr. G. VACCARI, S. Giovanni Bosco e il Priore<br />
Giuseppe Frassinetti, Porto Romano [s.e.] 1954. L‘amicizia tra il Frassinetti e Don Bosco è sottolineata<br />
pure da un arcivescovo <strong>di</strong> Genova con queste parole: «Don Bosco lo conosceva, lo stimava, gli era amico:<br />
come salesiano faccio miei i sentimenti del mio Fondatore e spero che la Chiesa possa presto venerarli<br />
insieme nella Liturgia» T. BERTONE, in D. BRUZZONE – M.F. PORCELLA a cura <strong>di</strong>, La formazione alla<br />
santità nella chiesa genovese dell‟Ottocento, il contributo <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, Roma 2004, 6.<br />
155
Bosco e il Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti parla delle E<strong>di</strong>zioni Torinesi come anche<br />
della corrispondenza tra <strong>di</strong> loro.<br />
Altri punti <strong>di</strong> contatto erano le norme del metodo preventivo che erano scritte<br />
nelle in<strong>di</strong>cazioni che il priore dà ai catechisti illustrando il modo <strong>di</strong> suscitare l‘interesse<br />
su Gesú dei ragazzi e ragazze <strong>di</strong> catechismo. Queste norme Don Bosco le assumerà per<br />
il suo lavoro e le tematizzerà per i suoi collaboratori. Questo argomento è stato<br />
approfon<strong>di</strong>to da Sylvie Vrancken‘s Il tempo della scelta, LAS, Roma, 2000 633 . <strong>Maria</strong><br />
Ester Posada nelle sue opere specialmente in Storia e Santità sviluppa l‘influsso del<br />
priore sull‘apostolato <strong>di</strong> Don Bosco con le donne e le <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Ausiliatrice a cui<br />
praticamente aveva dato il compito <strong>di</strong> prendersene cura e <strong>di</strong> guidarle, essa scrive che<br />
Frassinetti era il punto <strong>di</strong> convergenza tra San Giovanni Bosco e <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Domenica<br />
Mazzarello 634 .<br />
Don Bosco è rimasto vicino al priore in una maniera particolare durante la crisi<br />
della nuova regola delle nuove suore orsoline. Ha parlato con gli amici vescovi, ha<br />
voluto organizzare un incontro a Roma quando i vescovi si fossero riuniti per il<br />
Concilio Ecumenico Vaticano Primo insieme con il Frassinetti, con l‘intento <strong>di</strong> ottenere<br />
l‘approvazione della <strong>Santa</strong> Sede. Avevano progettato <strong>di</strong> partire insieme per Roma nel<br />
1867 ma le <strong>di</strong>fficili circostanze li hanno obbligati a rimandarlo nel 1868, troppo tar<strong>di</strong><br />
perché per il Priore arrivò il momento finale del suo viaggio terreno. Don Bosco ha<br />
visitato la casa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> nel 1870 e nel 1871, questo contatto<br />
è continuato dopo la sua morte con il Beato Michael Rua e il Car<strong>di</strong>nale Cagliero. Don<br />
Bosco e il Priore furono amici e nella reciprocità ammiratori e campioni <strong>di</strong> santità nella<br />
Chiesa.<br />
3. <strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello<br />
<strong>Maria</strong> Domenica nacque a Mornese nel 1847 e morí nel 1881. Con la sua<br />
compagna Angela Maccagno a cui era legata da una profonda e fraterna amicizia,<br />
avevano creato un gruppo <strong>di</strong> giovani ragazze, con il proposito <strong>di</strong> vivere secondo la<br />
legge <strong>di</strong> Dio ed erano guidate spiritualmente da Don Domenico Pestarino. Questo santo<br />
sacerdote era stato studente dell‘Accademia Frassinettiana <strong>degli</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong> ecclesiastici che<br />
era una p<strong>roma</strong>nazione della Congregazione <strong>di</strong> Beato Leonardo. Fu costretto ad<br />
andarsene da Genova durante i moti rivoluzionari del 1848 ed era ritornato a Mornese<br />
dove era nato. Vi è rimasto per tutta la sua vita. Era un <strong>di</strong>scepolo ed amico del Priore<br />
Frassinetti. È stato detto che faceva a Mornese quello che si faceva a <strong>Santa</strong> Sabina e non<br />
decideva niente senza consultare il priore.<br />
Angela Maccagno, una ragazza buona, attiva ed intelligente, che allora aveva 18<br />
anni, vedeva la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> seguire una vocazione religiosa come suora per <strong>di</strong>fficoltà<br />
finanziarie, che non gli consentivano <strong>di</strong> portare in convento ―la dote‖, per il fatto che i<br />
suoi genitori erano vecchi e soli. Lei è venuta nell‘idea <strong>di</strong> consacrarsi e vivere come una<br />
suora in casa. Questa idea era con<strong>di</strong>visa da altre compagne, tra cui la Mazzarello, e si<br />
sentivano realmente religiose ―al secolo‖. Era una realtà nuova e ine<strong>di</strong>ta nella Chiesa<br />
633 Cfr. Spunti pedagogici in alcuni scritti <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, in SYLVIE VRANCKEN‘S, Il tempo della<br />
scelta, LAS, Roma 2000, 48-55. Il Padre Frassinetti promosse la formazione intellettuale non solo per i<br />
sacerdoti, ma per tutti. Proprio perché lui era pastore, si impegnò a chiarire come pre<strong>di</strong>care, come fare<br />
catechismo, come essere confessore e guida spirituale e promuovere le vocazioni ecc. Ve<strong>di</strong> Ibid. Quale<br />
accompagnamento per i giovani selle vie della santità?, in D. BRUZZONE – M.F. PORCELLA a cura <strong>di</strong>, La<br />
formazione alla santità nella chiesa genovese dell‟Ottocento, il contributo <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, Roma<br />
2004, 263-291. Cfr. CONGREGATIO DE CAUSIS SANTIRUM, JANUENSIS, Canonizationis servi Dei Pauli<br />
Josephi <strong>Maria</strong>e Frassinetti Parochi-Prioris Paroeciae S. Sabinae, Fundatoris Congregationis Filiorum S.<br />
<strong>Maria</strong>e Immacultae 1804-1868. Relativo et vota. Congressus peculiaris super virtutibus. Die 13<br />
novembris An 1990 abiti, Tip. Guerra, 1990, 46.<br />
634 Cfr. ―Il Frassinetti come luogo d‟incontro <strong>di</strong> San Giovanni Bosco e <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Domenica<br />
Mazzarello, in M. E. POSADA, Storia e santità. Influsso del teologo Giuseppe Frassinetti sulla spiritualità<br />
<strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello, Las, Roma 1992, 80-82.<br />
156
che avrà una enorme importanza a partire dall‘approvazione dalla Chiesa con il decreto<br />
Provvida Mater nel 1947.<br />
Angela Maccagno ha presentato a Don Pestarino, insieme al piano anche una<br />
regola che ha preparato per il nuovo stile <strong>di</strong> vita. Don Pestarono per sua piena<br />
tranquillità l‘ha mandata al Priore nel 1853. Il Priore non gli ha data risposta, come se la<br />
lettera si fosse persa. Ha mandato una seconda lettera ma ugualmente nessuna risposta.<br />
In quanto a questo fatto, abbiamo due versioni. Una è che Frassinetti si è accorto<br />
dell‘enormità della nuova realtà e aveva bisogno <strong>di</strong> muoversi lentamente, allo stesso<br />
tempo osservando la compattezza della decisione dei can<strong>di</strong>dati e notare se la cosa aveva<br />
un certo seguito. L‘altra versione, secondo Penelope Mazzarelo, è che Frassinetti stesso<br />
avesse detto che alla vigilia dell‘<strong>Immacolata</strong>, ha trovato il testo della regola sopra la<br />
scrivania come se fosse stato qualcuno a lasciarlo un momento prima. Comunque il<br />
Priore ha de<strong>di</strong>cato il suo tempo per esaminare, correggere ed elaborare la Regola; l‘ha<br />
corretta considerevolmente, ma a suo detto afferma <strong>di</strong> averci apportato solo alcuni<br />
ritocchi. L‘ha mandata a Don Pestarino nell‘ottobre 1855 e l‘8 Dicembre 1855 il gruppo<br />
<strong>di</strong> Mornese è <strong>di</strong>ventato la Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, con la promessa<br />
<strong>di</strong> osservare le regole e il voto della castità. Erano cinque e la piú giovane era <strong>Maria</strong><br />
Domenica Mazzarello.<br />
Nel 1854 Frassinetti ha fondato a <strong>Santa</strong> Sabina la prima Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e<br />
<strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> con Virginia Avio come presidente.<br />
Dopo aver ottenuto l‘approvazione del vescovo <strong>di</strong> Acqui è cominciata, come<br />
abbiamo visto una espansione straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> questa unione; ma dobbiamo proseguire<br />
con la vita della nostra santa il cui stile e sistema <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> conduzione, oggi è<br />
chiamato dalle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Ausiliatrice ―lo spirito <strong>di</strong> Mornese‖: era qualcosa <strong>di</strong><br />
importante e contagiante, un viaggio destinato alla santità, sotto la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> Don<br />
Pestarino, e con l‘aiuto del Priore, che, per quelle ragazze determinate a <strong>di</strong>ventare<br />
seriamente sante, era lo strumento straor<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Dio.<br />
La presenza <strong>di</strong> Frassinetti si prolungava con i suoi scritti e le sue pubblicazioni<br />
e che muovevano verso una consacrazione gioiosa al Signore. Secondo la narrazione<br />
intorno alle prime <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Ausiliatrice, come i piú recenti e interessanti <strong>stu<strong>di</strong></strong> ci<br />
descrivono, scopriamo la profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> quella via <strong>di</strong> perfezione iniziata dalle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>.<br />
<strong>Maria</strong> Domenica ha assistito i suoi parenti che erano ammalati con la febbre <strong>di</strong><br />
tifo, ed aveva riportato conseguenze serie per la sua salute. Dal 1861 aveva avuto un<br />
contatto ravvicinato con Frassinetti insieme con il suo gruppo <strong>di</strong> consacrate. Insieme<br />
con le sue compagne ha iniziato un‘assistenza speciale <strong>di</strong> due case dei orfani e anche <strong>di</strong><br />
una scuola. Per poter lavorare meglio esse hanno deciso <strong>di</strong> vivere insieme in vita<br />
comune che facilitava il loro lavoro quoti<strong>di</strong>ano.<br />
Nel 1864 Don Pestarino ha ricevuto Don Bosco a Mornese, che sorpreso della<br />
santità e dall‘atmosfera eccezionale che regnava tra le <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> capí che il sogno<br />
avuto, nel quale <strong>Maria</strong> gli ha chiesto <strong>di</strong> impegnarsi anche per il bene <strong>di</strong> ragazze, poteva<br />
avere qui a Mornese la sua attuazione. Nella sua visita nel 1867 Don Bosco aveva già<br />
pensato alla Mazzarello come ad una roccia <strong>di</strong> fondazione <strong>di</strong> un nuovo istituto, una<br />
scelta che non era facile per lei da accettare che si realizzò solo nel 1872. Dall‘altra<br />
parte anche Don Pestarino <strong>di</strong>venne salesiano legato con i voti religiosi ed era stato<br />
lasciato da Don Bosco a guidare il nuovo istituto. Come tutte le fondatrici e con<br />
fondatrici, anche <strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello ha avuto tanto a soffrire. Morí in giovane<br />
età.<br />
4. Antonio <strong>Maria</strong> Gianelli<br />
Era insegnante nel Seminario <strong>di</strong> Genova. In quel periodo Frassinetti era<br />
studente esterno, ma tra <strong>di</strong> loro sorse un‘amicizia profonda e rapporti spirituali<br />
particolari che sono durati tutta la vita. Erano consiglieri l‘uno dell‘altro, confidenti,<br />
amici per il servizio santo del Signore. I loro interessi erano <strong>degli</strong> interessi della Chiesa<br />
e della fede. Ci sono lettere conservate che ci illustrano il loro rapporto spirituale.<br />
157
Dal seminario Gianelli fu trasferito a Chiavari come parroco e lí fondò, nel<br />
santuario <strong>di</strong> Chiavari che è <strong>di</strong>ventato la Chiesa Cattedrale, la Congregazione delle<br />
<strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> Nostra Signora dell‟Orto dette Gianelline.<br />
Nel 1838 Gianelli fu eletto vescovo <strong>di</strong> Bobbio; fu un pastore santo, ed oggi è<br />
venerato come il santo patrono delle valli dove aveva lavorato in mezzo a tante<br />
<strong>di</strong>fficoltà. Morí nel 1846, è stato proclamato beato nel 1925 e canonizzato nel 1951.<br />
Per anni è stato professore nell‘Accademia e nella congregazione del Beato<br />
Leonardo da Porto Maurizio. Aveva un cuore aperto all‘aiuto dei poveri.<br />
Gli interessi <strong>di</strong> Dio erano sempre al primo posto dei loro interessi, sia per il<br />
Frassinetti che per il Gianelli, e si sono aiutati uno l‘altro nell‘ottenere il dono della<br />
santità. Si sono anche assistiti reciprocamente nei momenti <strong>di</strong>fficili; in una parola essi<br />
avevano un‘armonia totale nella dottrina e nelle priorità pastorali.<br />
5. Tommaso Reggio<br />
Questo santo arcivescovo <strong>di</strong> Genova ha avuto un rapporto particolare con Padre<br />
Frassinetti determinato dal fatto che egli era studente dell‘Accademia <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong><br />
Ecclesiastici. Il suo biografo Emilio Fal<strong>di</strong> in Tommaso Reggio, Arcivescovo <strong>di</strong> Genova<br />
<strong>di</strong>ce «Il Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti è <strong>di</strong>ventato il maestro supremo del suo<br />
sacerdozio». Non è possibile conoscere Don Tommaso Reggio senza considerare la sua<br />
connessione con Frassinetti.<br />
Era nato a Genova nel 1818 da una famiglia nobile e aveva avuto una buona<br />
educazione cristiana e culturale che gli ha assicurato una carriera brillante. A venti anni<br />
il Signore Dio lo ha chiamato alla vita sacerdotale, scelta che lo ha obbligato ad<br />
abbandonare le precedenti aspirazioni.<br />
Certamente il contatto con Frassinetti fu per lui decisivo. Prima della sua<br />
or<strong>di</strong>nazione ha scritto :«Io voglio <strong>di</strong>ventare santo, ad ogni costo, vivendo la mia vita<br />
con 2 pietre angolari del cristianesimo, preghiera e vita ascetica».<br />
Aveva 25 anni quando è <strong>di</strong>ventato vice rettore del seminario <strong>di</strong> Genova, e poi<br />
rettore del seminario <strong>di</strong> Chiavari che al tempo era una sezione separata <strong>di</strong> quello <strong>di</strong><br />
Genova. Ha fondato un giornale cattolico, che è durato fino al 1874 quando la <strong>Santa</strong><br />
Sede ha or<strong>di</strong>nato ai cattolici <strong>di</strong> non votare alle lezioni italiane, mentre il suo giornale e<br />
quelli <strong>degli</strong> altri giornali erano favorevoli alla creazione <strong>di</strong> un partito cattolico.<br />
Fu fatto vescovo <strong>di</strong> Ventimiglia nel 1877 e l‘anno seguente ha fondato la<br />
Congregazione delle Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Marta «che servono il povero con le loro mani<br />
umili come Marta ha servito Gesú».<br />
In un primo tempo, il nuovo istituto aveva le regole delle Pie Unioni <strong>di</strong><br />
Frassinetti, per questa ragione la congregazione religiosa è considerata come<br />
propaggine <strong>di</strong> quelle che possiamo chiamare le ―<strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> Frassinetti‖.<br />
La <strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> Ventimiglia era povera e scomoda, tra l‘altro era quasi priva <strong>di</strong><br />
strade, i collegamenti erano rappresentati soprattutto da mulattiere e sentieri e<br />
nonostante tutto egli ha convocato 15 sino<strong>di</strong> <strong>di</strong>ocesani, che hanno dato nuovo vigore<br />
alla spiritualità del clero <strong>di</strong> tutta la <strong>di</strong>ocesi.<br />
Stanco, ha presentato la rinuncia della <strong>di</strong>rezione della <strong>di</strong>ocesi al Papa Leo XIII<br />
nel 1892 ed il successore <strong>di</strong> San Pietro l‘ha accettata con una sorpresa, lo ha elevato ad<br />
Arcivescovo <strong>di</strong> Genova. Egli ha nominato Padre Piccardo Antonio, successore del<br />
Frassinetti, rettore del seminario arci<strong>di</strong>ocesano insistendo sulla formazione della<br />
congregazione <strong>di</strong>ocesana dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> che egli avrebbe favorito.<br />
Morí nel 1901 ed è stato beatificato da Giovanni Paolo II.<br />
6. Rosa Gattorno<br />
158
Rosa nacque a Genova nel 1831, morí a Roma il 06 Maggio 1900. È stata<br />
beatificata da Giovanni Paolo II il 19 Aprile 2000. Ha fondato la congregazione delle<br />
<strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Anna, i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Anna e le Suore Contemplative <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Anna 635 .<br />
Era sposata. Suo marito era un uomo d‘affari senza molti scrupoli, che in un<br />
certo momento è andato a trovare fortuna a Marsiglia in Francia ma avendo fallito è<br />
tornato a Genova pieno dei debiti. Avevano 3 figli, ed è rimasta vedova all‘età <strong>di</strong> 27<br />
anni.<br />
Il rapporto tra Rosa Gattorno e il Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina è anteriore al tempo del<br />
suo matrimonio. Gli anni della sua vedovanza sono decisivi, per la sua spiritualità,<br />
segnata dal senso intenso della maternità spirituale. La sua casa ed il suo cuore erano<br />
aperti alle persone malate, ai poveri, alle ragazze giovani in pericolo ed ai bambini che<br />
avevano bisogno della formazione alla fede.<br />
Aiutata dal confessore, Don Giuseppe Firpo, si è arresa totalmente a Dio,<br />
riscoprendo la pace ed il suo bene reale. La sua vita era totalmente cambiata: pregava<br />
molto giorno e notte, faceva astinenza con penitenze molto accentuate. Si è affidata e<br />
legata totalmente a Gesú suo sposo con i voti <strong>di</strong> castità, povertà ed obbe<strong>di</strong>enza.<br />
Tante donne della nobiltà <strong>di</strong> Genova, che appartenevano, come lei, alla Pia<br />
Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, hanno fatto amicizia intima con lei e sono<br />
<strong>di</strong>ventate sue <strong>di</strong>scepole fedeli.<br />
L‘amicizia spirituale, che era parte integrante del metodo frassinettiano ha<br />
aperto la sua anima ad orizzonti <strong>di</strong> apostolato. Le sue amiche scrivevano a lei come ad<br />
una guida spirituale e confidavano a lei i loro secreti piú intimi, erano profondamente<br />
motivate nel collaborare con lei nell‘opera umile della carità.<br />
Quasi tutte <strong>di</strong> queste lettere sono un in<strong>di</strong>ce che tale impulso nel servizio <strong>di</strong> Dio<br />
e tale desiderio della perfezione che provoca una meraviglia autenticamente piacevole<br />
non è legato allo stato <strong>di</strong> vita. Ebbe anche una chiara illuminazione del piano <strong>di</strong> Dio su<br />
<strong>di</strong> lei: fondare un nuovo istituto, una nuova congregazione.<br />
Quando la fondatrice santa muore, c‘erano circa 3500 suore religiose in 368<br />
case nelle varie nazioni. In questo modo erano nate le <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Anna, le Madri <strong>di</strong><br />
<strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Anna, le suore contemplative <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Anna.<br />
Aveva fenomeni mistici straor<strong>di</strong>nari 636 e compiva per obbe<strong>di</strong>enza miracoli,<br />
come le suore in agonia che per obbe<strong>di</strong>enza vanno in Chiesa con la comunità e<br />
l‘infermità sparisce. C‘è una evidente rassomiglianza tra la sua umiltà e quella del<br />
Frassinetti, nello sforzo <strong>di</strong> non essere considerati anzi <strong>di</strong>menticati.<br />
E. Teologo e Scrittore<br />
Gli ultimi <strong>di</strong>eci anni della vita del Priore furono i piú produttivi dal punto <strong>di</strong> vista<br />
intellettuale, quasi come sapesse che la fine era vicina. Padre Frassinetti ha scritto tanti articoli,<br />
saggi, piccole opere su vari temi per poter rendere il suo ministero presbiterale come una<br />
risposta ai bisogni catechetici e pastorali del suo tempo: sulla devozione mariana 637 , sulla vita<br />
consacrata 638 , e sulla teologia ascetica e mistica.<br />
635 Per una piú approfon<strong>di</strong>ta conoscenza della vita e della santità della Beata Rosa Gattorno cfr A.M.<br />
FIOCCHI, La Serva <strong>di</strong> Dio Rosa Gattorno, fondatrice delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> Sant‟Anna, Casa Generalizia delle<br />
<strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> Sant‘Anna, Roma 1937. ID, Rosa Gattorno, Fondatrice 1831-1900, Seconda e<strong>di</strong>zione riveduta,<br />
ampliata e aggiornata a cura <strong>di</strong> A. E. DEGETO, Congregazione <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> Sant‘Anna, Roma 1996.<br />
636 Le esperienze mistiche della Beata Rosa si trovano in R. GATTORNO, Memorie. Diario intimo delle<br />
esperienze mistiche. Trascritte da A. E. DEGETTO, Introduzioni e note <strong>di</strong> I. IRIATE, Casa Generalizia delle<br />
Suore <strong>di</strong> Sant‘Anna, Roma 1996.<br />
637 G. FRASSINETTI, Avviamento dei giovinetti alla devozione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima, Tip. Mona<strong>di</strong>, Genova<br />
1846. Don Bosco apprezzò moltissimo questo libretto e lo pubblicò in Letture cattoliche. Per maggiori<br />
informazioni cfr. G. RENZI, Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche, opera citata. Altri scritti <strong>di</strong><br />
carattere mariano sono: G. FRASSINETTI, L‟ossequio piú gra<strong>di</strong>to a <strong>Maria</strong> Santissima <strong>Immacolata</strong>, Tip.<br />
Ligustico, Genova 1855; ID., La Via Matris, ricavata dalle riflessioni <strong>di</strong> S. Alfonso M. de‟ Liguori sopra<br />
ciascuno dei sette dolori <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima, me<strong>di</strong>tati in forma <strong>di</strong> Via Crucis, Tip. Fassi-Como, Genova<br />
159
Dopo Il Manuale pratico del Parroco novello 639 , segue Il Compen<strong>di</strong>o della Teologia<br />
Morale 640 , la sua opera maggiore. Ha scritto anche piccole opere: L‟arte <strong>di</strong> farsi santi, Il<br />
Conforto dell‟Anima Divota e Il convito del Divino Amore. Questi tre libri hanno tentato <strong>di</strong><br />
eliminare le ultime ma piú resistenti tracce <strong>di</strong> Giansenismo. Nel libretto Il conforto dell‟Anima<br />
Divota, l‘autore ha esposto in uno stile chiaro e semplice il concetto della santità cristiana, non<br />
solo in senso or<strong>di</strong>nario ma anche in senso perfetto. Essa non è riservata solo ad alcuni ma è per<br />
tutti, senza eccezione. Ogni in<strong>di</strong>viduo deve tendere ala perfezione cristiana, secondo la sua<br />
posizione nella vita. Dopo due anni dalla morte, Il convito del Divino Amore 641 ha visto la luce.<br />
Questo aureo libretto può essere il testamento spirituale <strong>di</strong> una vita de<strong>di</strong>cata alla santa<br />
Eucaristia. Già in altra pubblicazione, l‘autore ha sostenuto e vigorosamente ha promosso la<br />
comunione frequente. Questa era la tesi che ha limpidamente sostenuto con sicurezza dottrinale.<br />
Anche se oggi è una cosa pacifica, non lo era ai tempi del Priore. Padre Frassinetti non aveva<br />
visto sulla terra il grande bene che il suo libro avrebbe causato alle anime, e il riconoscimento<br />
ufficiale che la Chiesa, con il Decreto Sacra Tridentini Sinodus il 16 Dicembre 1905 <strong>di</strong> Poi X ai<br />
suoi insegnamenti e consigli riguardo alla comunione frequente dette il sigillo. In esso si<br />
<strong>di</strong>chiara tra l‘altro: «La comunione frequente e quoti<strong>di</strong>ana deve essere <strong>di</strong>sponibile a tutti i fedeli,<br />
<strong>di</strong> qualunque classe e con<strong>di</strong>zione essi appartengono, e non essere negata a nessuno che si trova<br />
in grazia <strong>di</strong> Dio e con la retta intenzione. I sacerdoti, i confessori, i pre<strong>di</strong>catori devono guidare il<br />
popolo cristiano a questa pratica pia e sana».<br />
Il santo prete <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina era attento nel curare i peccatori. La con<strong>di</strong>zione morale <strong>di</strong><br />
quelle menti lo rattristava molto ed era consumato dal desiderio <strong>di</strong> portare tutti a Dio. Il suo era<br />
un atteggiamento <strong>di</strong> accoglienza e <strong>di</strong> misericor<strong>di</strong>a; esistevano però alcuni teologi, i quali,<br />
adottando sistemi rigi<strong>di</strong>, avevano reso la via della salvezza <strong>di</strong>fficile e irta <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà.<br />
Appellandosi alla legge della carità e della giustizia, Padre Frassinetti ha spinto i confessori ad<br />
adottare criteri <strong>di</strong> attitu<strong>di</strong>ne paterna. Oggi chiamiamo questa ―Pastorale della Misericor<strong>di</strong>a‖. Per<br />
questa ragione, Il suo Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> teologia morale aveva uno scopo prettamente pastorale.<br />
Tante generazioni si sono formate agli insegnamenti morali <strong>di</strong> Padre Frassinetti.<br />
Egli si de<strong>di</strong>ca a scrivere tale Compen<strong>di</strong>o, come abbiamo visto, durante il suo<br />
allontanamento forzato dalla parrocchia. La sua prima idea era scriverlo in latino. In seguito ha<br />
cambiato idea e lo ha pubblicato in Italiano con note e spiegazioni. Ed è veramente nelle note e<br />
nelle spiegazioni dove si trova il valore della sua opera. Questo non è certamente il luogo per<br />
una analisi accurata, noi possiamo brevemente notare le ragioni e i criteri che hanno guidato<br />
l‘autore in questo lavoro gran<strong>di</strong>oso.<br />
1859; ID., Amiamo <strong>Maria</strong>!, Tip. della Gioventú, Genova 1864. Tutti queste operette sono raccolte in G.<br />
RENZI, Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche, opera citata, 74-106.<br />
638 Padre Frassinetti è conosciuto come fondatore e animatore della vita consacrata femminile secolare in<br />
quel tempo come abbiamo ampiamente descritto in questo lavoro. Per tale ragione scrisse molto al<br />
riguardo: ID., La santa verginità, Tip. Ferrando, Genova 1841. Scrisse biografie <strong>di</strong> testimoni <strong>di</strong> questo<br />
genere <strong>di</strong> vita consacrata. ID., Memorie sulla vita della pia zitella Rosa Cordone, morta in Genova ai 26<br />
Novembre 1858, Tip. Giovan Battista Paravia, Torino 1858. ID., La monaca in casa, Tip. Tasso, Oneglia<br />
1859. ID., Il modello della povera fanciulla Rosina Pedemonte, morta in Genova all‟età <strong>di</strong> 20 anni il dí<br />
30 Gennaio del 1860, Tip. Giovan Battista Paravia, Torino 1860. ID., La missione delle fanciulle<br />
cristiane, racconti contemporanei, Tip. Ghilini, Oneglia 1863. Queste brevi scritti del Frassinetti sono<br />
stati pubblicati anche in Letture Cattoliche, rivista fondata da San Giovanni Bosco. Per gli uomini<br />
consacrati il Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina scrisse un libretto da titolo Il religioso al secolo e Regola dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Tip. della Gioventú, Genova 1864, questo libretto ha avuto molte e<strong>di</strong>zioni ed è<br />
stato tradotto anche in tedesco. ID., Lettera sul celibato, de<strong>di</strong>cato a chiunque sia in posizione <strong>di</strong> poterlo<br />
promuovere nella cristiana società, Tip. Ghilini, Oneglia 1861; ID., Il para<strong>di</strong>so in terra nel celibato<br />
cristiano, Tip. Giovan Battista Paravia, Torino 1861.<br />
639 ID., Manuale pratico del Parroco novello, Tip. Miglio, Novara 1863. In italiano è arrivato alla<br />
do<strong>di</strong>cesima e<strong>di</strong>zione. È stato tradotto in francese, spagnolo, tedesco e inglese.<br />
640 ID., Compen<strong>di</strong>o della teologia morale <strong>di</strong> Sant‟Alfonso <strong>Maria</strong> de‟ Liguori con apposite note e<br />
<strong>di</strong>ssertazioni, 2 voll., Tip. della Gioventú, Genova 1865-1866.<br />
641 ID., Il convito del Divino Amore, Tip. della Gioventú, Genova 1870. Questo libro è stato e<strong>di</strong>to molte<br />
volte e tradotto in spagnolo, francese e tedesco.<br />
160
Prima <strong>di</strong> tutto Frassinetti ha scritto un lavoro eminentemente pratico per aiutare i nuovi<br />
confessori. Ha cominciato a configurare la sua opera con i principi della Teologia Morale alla<br />
luce della quale la coscienza, anche con varietà <strong>di</strong> opinioni, è libera da ogni incertezza e il<br />
confessore può assolvere senza paura <strong>di</strong> fare uno sbaglio. Alcuni hanno ritenuto che Frassinetti<br />
fosse troppo liberale. La cosa certa è che al seguito del suo grande maestro Sant‘Alfonso <strong>Maria</strong><br />
de Liguori 642 , il Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina era un seguace della teoria giusta ed ha combattuto teorie<br />
opposte.<br />
Frassinetti non era un teologo lassista. Ha o<strong>di</strong>ato il lassismo. Ascoltiamo alle sue parole:<br />
«Dottrine lasse non sono dottrine benigne, ma crudeli, che portano le anime all‘oblio». Nei suoi<br />
scritti ha usato prudenza e umiltà, specialmente nelle sue opere maggiori. «Desidero solo <strong>di</strong> fare<br />
il bene», ha detto, «la semplice idea <strong>di</strong> fare il male mi fa paura. Per questa ragione non mi sono<br />
fidato durante tutti i lunghi anni <strong>di</strong> confessione. Ho sempre chiesto l‘aiuto <strong>di</strong> Dio, ogni volta che<br />
ho preso la penna in mano non ho scritto niente senza consultare uomini pii ed dotti». L‘opera<br />
fu un successo. Si fecero <strong>di</strong>eci e<strong>di</strong>zioni e traduzioni in varie lingue. La fama del teologo<br />
genovese era sparsa, non solo in Italia, ma anche in tutta l‘Europa e l‘America. Giustamente, il<br />
suo nome era considerato tra i moralisti piú significativi del suo tempo.<br />
In un momento travagliato della sua vita ha conosciuto <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila, grande<br />
mistica spagnola 643 , si è avvicinato ad un altro santo carmelitano, San Giovanni della Croce e a<br />
<strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Maddalena de Pazzi. Ha me<strong>di</strong>tato e ha cominciato a scrivere un semplice e facile<br />
commentario su Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila, quasi un trattato sulla preghiera.<br />
Parlando della preghiera, Frassinetti pone l‘enfasi sulla me<strong>di</strong>tazione, senza ulteriore<br />
spiegazione della contemplazione infusa. Il libro Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa del Frassinetti è<br />
stato tradotto in spagnolo, inglese e secondo Padre Giordano Renzi, una traduzione anche in<br />
tedesco già esisteva e ha avuto tante e<strong>di</strong>zioni e ristampe 644 . Inoltre, questa opera ha raggiunto il<br />
Regno Unito, gli Stati Uniti d‘America 645 e l‘e<strong>di</strong>zione spagnola 646 è arrivata in Cile. Il<br />
642 «L‘attaccamento del giovane teologo Frassinetti al suo Elia Sant‘Alfonso fu tale da venire<br />
soprannominato il ―Liguorista‖ fin dai primi anni del suo sacerdozio. Scherzosamente dagli amici, con<br />
scherno dagli affetti <strong>di</strong> giansenismo…Sant‘Alfonso <strong>di</strong>venne talmente il maestro e la guida del Frassinetti,<br />
che potremmo chiamarlo un nuovo Sant‟Alfonso <strong>Maria</strong> de‟ Liguori ben piú a ragione che un secondo<br />
curato d‟Ars». M. FALASCA, Storia <strong>di</strong> un parroco il Ven. Giuseppe Frassinetti, Cantagalli, Siena 2006,<br />
332. Massimo Marocchi afferma che il Frassinetti è stato un seguace <strong>di</strong> Sant‘Alfonso nel campo della<br />
Teologia Morale e della <strong>di</strong>rezione spirituale come lo è stato Gaspare Bertoni, Pietro Leopar<strong>di</strong>, Vincenzo<br />
Pallotti, Luigi Braghi e Giuseppe Benaglio, cfr M. MAROCCHI, Spiritualità e vita religiosa tra<br />
cinquecento e novecento, E<strong>di</strong>trice Morcelliana, Brescia 2005, 520. Anche il professor Goya menziona il<br />
Frassinetti come <strong>di</strong>rettore spirituale nel capitolo primo del suo libro, soprattutto sotto l‘aspetto storico, cfr<br />
B. GOYA, Luce e guida nel cammino. Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale, EDB, Bologna 2004, 21.<br />
643 «…Viva Gesú, <strong>Maria</strong>, Giuseppe e Teresa» A. M. DE LIGUORI, Opere, vol. IV, Marietti, Torino 1847.<br />
Probabilmente l‘e<strong>di</strong>zione delle Opere della Marietti del 1824-1825 erano nelle mani <strong>di</strong> Padre Frassinetti,<br />
insieme alla Teologia Morale, e<strong>di</strong>ta dal Remon<strong>di</strong>ni 1923. Queste informazioni si ricavano da Padre<br />
Manfredo Falasca, Postulatore della Causa <strong>di</strong> Beatificazione del Venerabile Giuseppe Frassinetti, cfr. M.<br />
FALASCA, Storia <strong>di</strong> un parroco il Ven. Giuseppe Frassinetti, Cantagalli, Siena 2006, 332.<br />
644 Gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> Padre Renzi offrono al ricercatore altre e<strong>di</strong>zioni e traduzioni del Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong><br />
Teresa <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti: la prima e<strong>di</strong>zione: Tip. Fiaccadori, Parma 1860, la seconda : Tip. della<br />
Gioventú, Genova, e ancora: 1866. Tip. della Gioventú, 1867, <strong>terza</strong> e<strong>di</strong>zione: Tip. Salesiana, Torino 1872,<br />
Tipografia Salesiana, 1889, quarta e<strong>di</strong>zione: Tip. Salesiana in Collana ascetica, Torino 1904, Tip.<br />
Poliglotta Vaticana nella e<strong>di</strong>zione delle Opera Omnia vol I delle Opere ascetiche, Roma 1908, Tipografia<br />
Poliglotta Vaticana, Roma 1912. Traduzioni: in tedesco Schule des gebetes der heiligen Teresia, in<br />
spagnolo El Pater noster de <strong>Santa</strong> Teresa tradotto da un padre della Compagnia <strong>di</strong> Gesú, in inglese A<br />
treatise on Prayer, tradotto da Canon Hutch 5° e<strong>di</strong>zione; cfr G. RENZI, Giuseppe Frassinetti e le sue<br />
opere ascetiche, opera citata, 140. M. FALASCA, Il Frassinetti in giro per il mondo, in Risonanze, 59, 1984<br />
4, 9-24; ID, Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, op. cit, 325-333; ID, Storia <strong>di</strong> un parroco: il<br />
Venerabile Giuseppe Frassinetti, Fondatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Cantagalli, Siena<br />
2005, 704-713.<br />
645 Cfr. G. FRASSINETTI, Saint Teresa‟s Pater noster.A treatise on prayer. Tradotto dall‘italiano da Willim<br />
Hutch, DD. Nova e<strong>di</strong>zione, Burns Oathes and Washbourne 1887.<br />
646 ID. El Pater noster de <strong>Santa</strong> Teresa. Tratado de la oración, tradotto da un padre della Compagnia <strong>di</strong><br />
Gesú, 2 ed., Nueva Libreria de San José, Madrid 1888<br />
161
Car<strong>di</strong>nale Henry Newman aveva letto alcune opere del Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina e probabilmente il<br />
Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa; <strong>Santa</strong> Teresa de los Andes aveva usato l‘e<strong>di</strong>zione spagnola per le<br />
sue me<strong>di</strong>tazioni 647 .<br />
Il santo prete <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina ha in<strong>di</strong>rizzato la sua opera a tutti i fedeli, <strong>di</strong> qualsiasi<br />
stato <strong>di</strong> vita, senza togliere l‘aspetto essenziale <strong>degli</strong> insegnamenti <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa. Il suo scopo<br />
era pastorale e popolare. L‘ha scritta in modo che fosse comprensibile a tutti.<br />
È il merito <strong>di</strong> Frassinetti la <strong>di</strong>ffusione della dottrina <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa in Italia, non piú<br />
riservata solo ad una élite spirituale ma <strong>di</strong> possesso popolare 648 .<br />
647 Cfr SANTA TERESA DE LOS ANDES, Diario y cartas, Introductión, revisión del testo y notas: Marino<br />
Purroy Remon, 4 e<strong>di</strong>zione, E<strong>di</strong>ciones Carmelo Teresiano, Santiago de Chile 1993, 153.<br />
648 «È merito in<strong>di</strong>scusso del Frassinetti, dunque, l‘effettiva <strong>di</strong>vulgazione del pensiero teresiano in Italia e<br />
non soltanto a livelli <strong>di</strong> élite spirituale ma a livello popolare, ad ampio raggio» Cfr. M. E. POSADA, Storia<br />
e Santità, opera citata, 128; Cfr anche V. MACCA OCD, Presenza e influsso del Magistero Teresiano in<br />
Italia, in AA.VV., Teresa de Jesus: he<strong>stu<strong>di</strong></strong>os historico-leterarioS. Stu<strong>di</strong> Storico-Letterari, Teresianum,<br />
Roma 1982, 149-150. Padre Frassinetti possedeva le opera <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa e<strong>di</strong>te da E<strong>di</strong>trice- Pirotta <strong>di</strong><br />
Milano nel 1840-1841, in 6 volumi e 12 tomi, versione che secondo il Macca è stata curata da Alberto <strong>di</strong><br />
San Gaetano: Opere della <strong>Santa</strong> Madre Teresa <strong>di</strong> Gesú, novellamente tradotte secondo le accuratissime<br />
e<strong>di</strong>zioni castigliane uscite alla luce in questi ultimi anni in Barcellona e Madrid, Cesena 1782.<br />
162
CAPITOLO SECONDO<br />
SANTA TERESA D’AVILA E IL SUO DISCEPOLO TEOLOGO FRASSINETTI<br />
INSEGNAMENTI SULLA PREGHIERA<br />
A. La scoperta dei Santi Carmelitani<br />
Durante la sosta coatta a San Cipriano <strong>di</strong> Val Polcevera Frassinetti ha letto le gran<strong>di</strong><br />
opere <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila 649 e San Giovanni della Croce ed ha conosciuto <strong>Santa</strong> Maddalena<br />
<strong>Maria</strong> de‘ Pazzi.<br />
Vale la pena citare le parole del Car<strong>di</strong>nale Carlo <strong>Maria</strong> Martini ai giovani sacerdoti <strong>di</strong><br />
Milano durante gli esercizi spirituali tenutisi ad Avila, sul tema: ―La Spiritualità <strong>di</strong> San<br />
Giovanni della Croce e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú.‖ In una conferenza <strong>di</strong>sse: «I due santi<br />
carmelitani sono quelli che hanno illustrata nel dettaglio della dottrina e con l‟esempio della<br />
vita la spiritualità del cristiano, ne hanno tracciato l‟itinerario, hanno descritto tale cammino<br />
con abbondanza <strong>di</strong> particolari, hanno usato i simboli della salita alla montagna e del castello<br />
dalle stanze innumerevoli (…)» 650 .‖ I Sommi Pontefici Paolo VI 651 , Giovanni Paolo II 652 e<br />
Benedetto XVI 653 consideravano Teresa d‘Avila vera Maestra <strong>di</strong> preghiera.<br />
1. <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú<br />
Teresa de Cepeda y Ahumada 654 fu una figura importante nella Riforma della Chiesa.<br />
Ella fu una mistica spagnola, scrittrice e riformatrice <strong>di</strong> grande spessore nell‘ambito della vita<br />
religiosa. Nacque in Avila il 28 Marzo 1515. Morí in Alba de Torres il 4 Ottobre 1582. È stata<br />
riconosciuta dalla Chiesa Romana Cattolica come una delle poche sante, donne, Dottore della<br />
Chiesa, insieme a <strong>Santa</strong> Caterina <strong>di</strong> Siena e santa Teresa <strong>di</strong> Lisieux. I genitori furono Alonso<br />
Sanchez de Cepeda e Beatriz d‘Avila y Ahumada. Ella fu affascinata dalle vite dei santi e tante<br />
volte da bambina cercò il martirio.<br />
649 Frassinetti scriveva ad un amico sacerdote: «Io sono sempre stato bene e per dono <strong>di</strong> Dio anche<br />
tranquillo perché sempre vi<strong>di</strong> e vedo sempre chiaro che il tutto ha <strong>di</strong>sposto per il mio miglior bene ….<br />
Frattanto che bel tempo per pensare a sé, a starsene riposatamente con Dio! Questo non si era mai avuto<br />
né si poteva altrimenti sperare …. Io in questo tempo mi sono innamorato delle Opera <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa; se<br />
non le avete lette postamente vorrei che voi le leggeste» Lettere spirituali <strong>di</strong> Frassinetti, in AGFSMI –<br />
OA II, 644.<br />
650 Preso dai <strong>di</strong>scorsi dell‘Arcivescovo <strong>di</strong> Milano ai giovani sacerdoti in un ritiro ad Avila, la mattina del<br />
14 febbraio 1995. Le conferenze furono pubblicate in seguito, «… questi due Santi carmelitani ci<br />
illustrano la preghiera nei dettagli con esempi presi dalla vita, essi hanno seguito alcuni itinerari<br />
simbolici, cosí hanno usato il simbolo dell‘ascesa al Monte Carmelo e del Castello con <strong>di</strong>verse stanze».<br />
Questa è una traduzione mia. C. M. MARTINI, Solo Dios basta. La preghiera nella vita del pastore,<br />
E<strong>di</strong>trice Ancora, Milano 1995, 17. Alcune espressioni uguali si trovano anche nella Lettera Apostolica<br />
Novo millennio ineunte <strong>di</strong> Giovanni Paolo II, n. 16-28.<br />
651 PAOLO VI, Omelia tenuta nella Basilica Vaticana in occasione della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa<br />
d‟Avila Dottore della Chiesa universale 27 Settembre 1970, AAS 62 1970, 590-596.<br />
652 GIOVANNI PAOLO II, Santiminialibus Carmelitis Discalceatis, IV expleto speculo ad obitu Sanctae<br />
Teresiae a Jesu, AAS 74 1982, 836-841; Acta OCD 27 1982, 10-15.<br />
653 Durante la Veglia <strong>di</strong> Preghiera nella XX Giornata della Gioventú sulla collina <strong>di</strong> Marienfeld il 20<br />
Agosto 2005, parlando sul tema Il pellegrinaggio interiore, il papa Benedetto XVI fece riferimento a<br />
<strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila, come una delle sante <strong>di</strong> questo pellegrinaggio, insieme a San Benedetto, San<br />
Francesco d‘Assisi, Sant‘Ignazio d‘Antiochia, San Carlo Borromeo, ai fondatori <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni religiosi e<br />
innumerevoli santi dei nostri tempi come San Massimiliano Kolbe, E<strong>di</strong>th Stein, Madre Teresa e Padre<br />
Pio. Ognuno <strong>di</strong> essi ci ha insegnato il senso profondo dell‘adorazione.. Tutte queste informazioni sono<br />
prese da BENDETTO XVI, La rivoluzione <strong>di</strong> Dio, LEV, Città del Vaticano 2005, 65.<br />
654 Per maggiori dettagli sulla vita e sulla spiritualità <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú ve<strong>di</strong> P. GABRIELE DI S.<br />
MARIA MADDALENA, <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú, maestra <strong>di</strong> vita spirituale, Milano 1958. L. BORRIELLO-G.<br />
DELLA CROCE, Temi maggiori <strong>di</strong> spiritualità teresiana, II E<strong>di</strong>zione rivista e corretta, E<strong>di</strong>zioni OCD,<br />
Roma Morena 2005.<br />
163
Un giorno ella partí dalla sua casa <strong>di</strong> nascosto, entrò nel monastero delle suore<br />
Carmelitane in Avila. Soffrí a causa <strong>di</strong> varie malattie e proprio in quei momenti sperimentò<br />
l‘estasi. Fece il voto <strong>di</strong> seguire le regole come sono per essere piú vicina e piú intima al<br />
Signore, perciò, <strong>di</strong> impegnò a rifondare la congregazione Carmelitana e superare la fiacchezza,<br />
che regnava nella monastero in cui si trovava. Nel marzo 1563, Teresa ricevette dal Papa una<br />
in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> stabilire i principi della povertà assoluta e della rinuncia alla propria proprietà.<br />
Per questa ragione, formulò le costituzioni secondo lo spirito <strong>degli</strong> inizi. Dietro il suo esempio,<br />
un simile movimento, promosso dal pio carmelitano Giovanni della Croce incominciò a fiorire<br />
anche nel ramo maschile. Tale movimento promosse la vita interiore secondo lo spirito<br />
riformato dall‘insegnamento <strong>di</strong> Teresa. Ella si trovò ad essere contestata in modo ri<strong>di</strong>colo, non<br />
solo dalle stesse suore ma anche alcuni uomini <strong>di</strong> chiesa e dalle autorità civili.<br />
Fondò tanti altri monasteri. Come donna <strong>di</strong> Dio de<strong>di</strong>ta al bene <strong>degli</strong> altri, ha de<strong>di</strong>cato la<br />
sua vita alla preghiera e all‘intensa intimità con Dio. I suoi scritti sono testimonianza della sua<br />
intensa vita spirituale, sotto la guida del suo <strong>di</strong>rettore.<br />
I suoi scritti sono considerati dagli <strong>stu<strong>di</strong></strong>osi <strong>di</strong> cose spirituali molto rilevanti e classici<br />
della letteratura mistica. Alcuni <strong>di</strong> essi sono: ―L‟Autobiografia,‖ ―La Via della Perfezione,‖ ― la<br />
Mansione‖. La mistica esigeva una <strong>di</strong>sciplina formativa e <strong>di</strong>dattica ed i suoi scritti hanno avuto<br />
un forte influsso sulla ―Scuola Francese‖, su ―Francesco de Sales‖, su ―Alfonso de Liguori‖, su<br />
―Giuseppe Frassinetti‖, e tanti altri teologi 655 .<br />
Padre Giuseppe prese in considerazione soprattutto La Via della Perfezione,<br />
L‟autobiografia e La Mansione 656 .<br />
2. San Giovanni della Croce<br />
Giovanni 657 è nato nel Nord della Spagna nel 1542, ed ha imparato l‘importanza del<br />
sacrificio <strong>di</strong> sé nell‘amore dei suoi genitori. Suo padre dovette abbandonare tutte le sue<br />
ricchezze, il prestigio nella società, e il lusso perché si sposò con la figlia <strong>di</strong> un tessitore e,<br />
<strong>di</strong>seredato, lasciò da parte la nobiltà della famiglia. Quando suo padre morí, la madre tenne<br />
insieme la povera famiglia rimasta senza tetto e in cerca <strong>di</strong> lavoro. Questi furono gli esempi dai<br />
quali Giovanni comprese l‘amore <strong>di</strong> Dio. Quando finalmente trovarono lavoro, Giovanni ancora<br />
in cerca <strong>di</strong> cibo andò nella città piú ricca della Spagna. All‘età <strong>di</strong> quattor<strong>di</strong>ci anni, prese un<br />
lavoro all‘ospedale per curare i malati <strong>di</strong> malattie incurabili. Di fronte all‘irreversibilità <strong>di</strong><br />
queste malattie e sofferenze Giovanni scoprí la bellezza e la gioia in Dio.<br />
Entrò nell‘or<strong>di</strong>ne dei Frati Carmelitani e <strong>stu<strong>di</strong></strong>ò teologia a Salamanca. Fu or<strong>di</strong>nato<br />
sacerdote all‘età <strong>di</strong> venticinque anni e subito scaturí in lui il desiderio <strong>di</strong> vivere una vita austera<br />
e ra<strong>di</strong>cale, ed è nell‘incontro con Teresa d‘Avila che egli è stato persuaso <strong>di</strong> restare e riformare i<br />
Carmelitani. In questo lavoro <strong>di</strong> riforma, si è fatto tanti nemici fra i frati: l‘hanno arrestato e<br />
imprigionato in Toledo e fu un‘occasione per Giovanni per mettere in luce lo splendore della<br />
sua poesia. Al buio esiste una piccola finestrina la cui l‘insuperabilità, la paura dell‘oscurità, il<br />
<strong>di</strong>sagio del freddo e della desolazione immane ravvivano il suo amore e la sua fede, come fuoco<br />
che brilla. Dopo nove mesi Giovanni fuggí svitando la serratura della porta ed eluse la<br />
sorveglianza delle guar<strong>di</strong>e. Egli si nascose dai suoi persecutori nel convento dove poté far<br />
conoscere le sue poesie alle suore. Da allora la sua vita è stata de<strong>di</strong>cata nel con<strong>di</strong>videre e<br />
spiegare la sua esperienza dell‘amore <strong>di</strong> Dio. Giovanni lasciò tanti libri sulla preghiera e sul<br />
cammino verso la perfezione, come La salita del Monte Carmelo, La notte oscura dell‟anima, Il<br />
Cantico spirituale dell‟anima e La sposa <strong>di</strong> Cristo. Dopo qualche anno, come capo e maestro<br />
delle case riformate, ebbe a soffrire <strong>di</strong> nuovo altre crudeltà da parte suoi superiori e fu cacciato<br />
al Sud, nell‘Andalusia dove morí all‘età <strong>di</strong> 49 anni.<br />
655<br />
J. CASTELLANO CERVEDA, Dottrina e Messaggio <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú, Dottore della Chiesa pro<br />
manuscripto, Teresianum, Roma 2005, 11<br />
656<br />
G. FRASSINETTI, Note prese dall‟Autobiografia <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa dal Cammino <strong>di</strong> Perfezione e dalle<br />
Mansioni, [Genova] e [s.d.]. Manoscritto originale autografo, in AGFSMI.<br />
657<br />
Per maggiori dettagli sulla vita <strong>di</strong> San Giovanni della Croce ve<strong>di</strong> F. PUTTINI, Introduzione a San<br />
Giovanni della Croce, OCD, Roma 1987. E. PACHO, Temi fondamentali in San Giovanni della Croce,<br />
OCD, Roma 1989.<br />
164
3. <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Maddalena de’ Pazzi<br />
La santa mistica <strong>di</strong> Firenze nacque nell‘anno 1566 658 e fu battezzata con il nome <strong>di</strong><br />
Caterina. Ella era l‘unica figlia <strong>di</strong> Camillo de‘ Pazzi, <strong>di</strong> nobile famiglia, imparentato con i<br />
Me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> Firenze. Caterina fin da bambina amava visitare i luoghi solitari per entrare in <strong>di</strong>alogo<br />
con Dio. Nella sua giovinezza, ha potuto conoscere Dio come suo creatore, redentore e<br />
santificatore.<br />
All‘età <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci anni, fece voto <strong>di</strong> verginità e sentí la gioia <strong>di</strong> insegnare la dottrina<br />
cristiana ai bambini poveri. Il suo padre desiderò per lei un matrimonio prestigioso con un uomo<br />
nobile colto e ricco, e una vita come le nobildonne <strong>di</strong> Firenze, ma Caterina scelse <strong>di</strong> seguire la<br />
sua propria strada e persuase i suoi genitori a lasciarla entrare nel monastero delle Carmelitane.<br />
Fu ammessa nel convento nel giorno della morte <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila; cambiò il<br />
suo nome in <strong>Maria</strong> Maddalena, professò e fu suora nel monastero <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>degli</strong> Angeli in<br />
Firenze nel 1584.<br />
Durante il noviziato ebbe una strana malattia <strong>di</strong> crisi. La porta della morte sembrava<br />
vicina per lei, perciò la superiora decise <strong>di</strong> farle fare la professione dei voti con una celebrazione<br />
privata nella cappella. Subito dopo la professione ha avuto un‘estasi durata due ore. Questa<br />
esperienza si è ripetuta dopo 40 giorni durante la comunione. Le estasi furono momenti <strong>di</strong><br />
unione con Dio durante le quali le erano svelate straor<strong>di</strong>narie verità <strong>di</strong>vine.<br />
Tali estasi 659 sarebbero un argomento sufficienti per mostrare che <strong>Maria</strong> Maddalena <strong>di</strong><br />
Pazzi aveva una alta spiritualità. È <strong>di</strong>fficile interpretare questa realtà ma sappiamo che a questa<br />
esperienza d‘unione e d‘intimità con Dio sono seguiti cinque anni <strong>di</strong> desolazione in cui sentiva<br />
frustrato ogni suo desiderio spirituale. Si è trovata immersa in uno stato <strong>di</strong> oscurità in cui vedeva<br />
solo il male che era in lei e intorno <strong>di</strong> lei. Ebbe tentazioni incre<strong>di</strong>bili e subí sofferenze fisiche<br />
insuperabili. Morí nel 1607 all‘età <strong>di</strong> 41 anni; è stata proclamata santa nel 1669.<br />
Secondo P. Giuseppe Frassinetti, <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Maddalena <strong>di</strong> Pazzi ebbe uno zelo<br />
straor<strong>di</strong>nario per la salvezza delle anime. Ella era abituata a pregare con queste parole:<br />
«Desiderium animarum tuarum come<strong>di</strong>t me». <strong>Maria</strong> Maddalena era molto incline alla preghiera<br />
e agli esercizi penitenziali per le anime che <strong>di</strong>moravano nell‘oscurità del peccato. Nonostante<br />
tutto ciò, si sentiva in colpa per loro e chiedeva che queste anime si potessero convertire, e ciò<br />
sarebbe possibile se solo lei e le sue compagne suore pregassero ancora <strong>di</strong> piú con de<strong>di</strong>zione e<br />
fervore. Ella era pronta a subire qualsiasi sofferenza per le anime peccatrici. La mistica <strong>di</strong><br />
Firenze considerava le anime come ere<strong>di</strong>tà data dal Padre eterno alla sua sposa e Gesú, non<br />
sopporta che tale ere<strong>di</strong>tà sia perduta 660 .<br />
C. Il Pater noster<br />
Don Giuseppe sviluppò un trattato sulla preghiera: Il ―Pater noster‖, nel quale valorizzò<br />
un patrimonio teresiano. Il nostro considerava santa Teresa come maestra <strong>di</strong> orazione, fedele<br />
all‘insegnamento del magistero. Il ―Pater noster‖ si trova nei capitoli XXVII-XLII dell‘opera:<br />
―La Via della Perfezione.‖ Quest‘opera è una <strong>degli</strong> scritti maggiori e <strong>di</strong> grande importanza, è<br />
658 Per una maggiore conoscenza della vita e della spiritualità <strong>di</strong> questa ―santa mistica‖, ve<strong>di</strong> P.<br />
ERAMANNO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO OCD, L‟unione con Dio secondo <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Maddalena de‟<br />
Pazzi, Carmelitani, Roma 1957. A. VERBRUGGHE, <strong>Maria</strong> Maddalena de‟ Pazzi santa, in L. BORRIELLO-E.<br />
CARUANA-M. R. DEL GENIO-N. SUFFI a cura <strong>di</strong>, Dizionario <strong>di</strong> Mistica, LEV, Città del Vaticano 1998,<br />
788-790.<br />
659 Cfr I vari aspetti dell‘estasi in <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila e in San Giovanni della Croce: Il Castello<br />
interiore, 5 ed anche La notte oscura dell‟anima, 2,1-2. Altre fonti riguardanti i santi carmelitani sono<br />
prese; 1 TERESA D‘AVILA, Opere <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‟Avila, ICS Pubbilcations, Washington D.C. 1980. 2<br />
GIOVANNI DELLA CROCE, Opere <strong>di</strong> San Giovanni della Croce, ICS Pubbilcations, Washington D.C<br />
1979.3 SANTA TERESA DI GESÚ BAMBINO E DEL SANTO VOLTO, Opere complete Libreria E<strong>di</strong>trice<br />
Vaticana-E<strong>di</strong>zioni OCD, Roma 1977. 4 ELISABETTA DELLA TRINTÀ, Opere, San Paolo, Cinisello Balsamo<br />
1993<br />
660 G. FRASSINETTI, Il Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa, opera citata, 279-280.<br />
165
stata scritta per le monache per de<strong>di</strong>carsi con amore alla vita <strong>di</strong> preghiera. È un commento<br />
personale sulla preghiera che Gesú ci ha insegnato; «Padre nostro che sei nei cieli, sia<br />
santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo cosí in terra.<br />
Dacci oggi il nostro pane quoti<strong>di</strong>ano; e rimetti a noi i nostri debiti, come li rimettiamo ai nostri<br />
debitori; non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male» (Mt 6, 19 -13; cfr. anche Luca 11,<br />
2-4). Tale opera è stata de<strong>di</strong>cata ad un gruppo <strong>di</strong> suore che abitavano con lei. Dopo breve tempo,<br />
il libro venne anche usato in altri monasteri. Questo libro è stato scritto alla luce delle sue<br />
esperienze; personali-interiori, al suo rapporto con altre persone e con Dio, vero maestro <strong>di</strong><br />
preghiera. Il confessore chiese a Teresa <strong>di</strong> scrivere tutte le sue esperienze, emozioni, e<br />
sentimenti nei momenti delle sue preghiere. Da questo input incominciò in essa una scintilla del<br />
cuore che <strong>di</strong>venne fuoco nei suoi scritti 661 .<br />
L‘influsso <strong>di</strong> Teresa per quel che riguarda la preghiera era veramente forte. Don<br />
Giuseppe, pastore e guida <strong>di</strong> santi, raccomandò a tutti la dottrina <strong>di</strong> questa santa. Questo libro<br />
sul Padre nostro fu per lui la via che gli svelò la <strong>di</strong>mensione della teologia mistica; ma tuttavia<br />
Padre Frassinetti notò che il commento e le me<strong>di</strong>tazioni <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa non erano accessibili a<br />
tutti 662 . Se Il Pater noster fosse ulteriormente sviluppato sarebbe stato utile anche per anime<br />
inesperte e sarebbe stato piú agevole se fosse tutto in un unico volume. Frassinetti giunge alla<br />
conclusione che la materia doveva essere ritrattata ed adattata per i non iniziati e <strong>di</strong>visa in<br />
capitoli illustrando cioè le parti piú adatte e piú eccellenti che la <strong>Santa</strong> aveva scritto riguardo<br />
alla preghiera 663 . Il Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa lo possiamo considerare come l‘entrata<br />
inaugurale nella teologia mistica 664 , e nel periodo in cui visse Don Giuseppe l‘ascetica e la<br />
mistica erano argomenti che neppure venivano presi in considerazione dalla scienza<br />
teologica 665 .<br />
Il Padre nostro ebbe grande importanza nella catechesi battesimale. Era considerato la<br />
preghiera per eccellenza. Padre Frassinetti, ammiratore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa, metteva in risalto il<br />
rapporto tra la preghiera comune, consacrata dalla tra<strong>di</strong>zione della Chiesa universale, e la<br />
preghiera privata. Egli sosteneva che la preghiera comunitaria non era solo un atto <strong>di</strong> supplica o<br />
<strong>di</strong> richiesta ma anche un mezzo in<strong>di</strong>spensabile per la vita cristiana nell‘osservanza e nella<br />
pratica del culto. Era persuaso anche che doveva esserci un tempo, per quanto breve, <strong>di</strong><br />
preghiera in solitu<strong>di</strong>ne, un faccia a faccia con Dio, in essa le anime avrebbero riportato un<br />
chiaro vantaggio interiore 666 . La liturgia al suo interno pone grande attenzione alla catechesi<br />
mistagogica, e questa preghiera per eccellenza è molto significativa per la preparazione e<br />
nell‘amministrazione dei sacramenti, nei riti liturgici e nella liturgia delle ore 667 . Fu dunque<br />
anche per una ragione pastorale che don Giuseppe si accinse a commentare il Pater noster <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Teresa.<br />
661<br />
Cfr. M HERRAIZ GARCIA, Indro<strong>di</strong>ción al Camino de la Perfeción de Teresa de Jesús, Monte Carmelo,<br />
Burgos 2001.<br />
662<br />
La liturgia ha qualcosa da insegnarci, quando, nella festa <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú chiede che anche noi<br />
siamo riempiti della sua sapienza celeste. Cfr. The Sacramentary, Catholic Book Publishing Co., New<br />
York 1985: 15 ottobre, orazione iniziale. L‘autore vuole sottolineare che Teresa è maestra <strong>di</strong> preghiera<br />
per ognuno.<br />
663<br />
G. FRASSINETTI, Il Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa, opera citata, Prefazione passim.<br />
664<br />
«l periodo dell‘esilio, a mio avviso, svela un aspetto della personalità del Frassinetti non molto<br />
conosciuto: quello mistico. Tale aspetto lo si coglie soprattutto percorrendo e penetrando il suo epistolario<br />
<strong>di</strong> questo tempo …». M. E. POSADA, Storia e santità, opera citata, 41.<br />
665<br />
T. ALVAREZ, Garrigou-Lagrange, Teologo spirituale, In Angelicum 42 1965, 39-40.<br />
666<br />
G. FRASSINETTI, Il Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa, opera citata, 50-51<br />
667<br />
È utile riaffermare l‘importanza della ―preghiera silenziosa‖ e del ―Padre nostro‖ nella celebrazione<br />
eucaristica, cfr. A. G. MARTIMORT, The Church and the Prayer – Volume I: Principles of the Liturgy,<br />
Tradotto da O‘CONNEL, dall‘originale L‟eglise en Priore: Principes de la Liturgie, The Liturgical Press,<br />
Collegeville Mimnesota 1986, 153-155. Per ulteriori informazioni sul rapporto tra la Liturgia, fons et<br />
culmen della vita spirituale e le altre attività extra liturgiche come la preghiera personale, l‘ascesi, il<br />
vivere nelle virtú teologali, l‘apostolato ecc, cfr. Costituzione della Sacra Liturgia Sacrosantum<br />
Concilium, n. 9.10.11.12.13. Cfr anche il contributo <strong>di</strong> J. CASTELLANO CERVEDA, Liturgia e Spiritualità,<br />
AA.VV., in Pontificio Istituto Liturgico Sant‟Anselmo, Manuale <strong>di</strong> Liturgia II, Liturgia Fondamentale,<br />
<strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> A. J. CHUPUNGCO, E<strong>di</strong>zioni Piemme, Casale Monferrato AL 1998, 63-82.<br />
166
Il trattato sul commento al Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa è <strong>di</strong>viso in due parti: la<br />
preghiera in generale e le sette petizioni del Padre nostro 668 . La prima parte è <strong>di</strong>visa in un<strong>di</strong>ci e<br />
la seconda in <strong>di</strong>ciassette capitoli.<br />
Il primo capitolo è un‘esposizione sulla ferma risoluzione con la quale un cristiano deve<br />
praticare il santo esercizio della preghiera, mentre i sottotitoli affrontano la necessità della<br />
preghiera, la necessità <strong>di</strong> essere fedeli all‘osservanza della essa, il pericolo della paura, le<br />
ragioni per le quali dovremmo adottare questa risoluzione ed esortare ad essa le anime smarrite.<br />
Il secondo capitolo, soffuso della meravigliosa <strong>di</strong>screzione <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa, parla della<br />
rilevanza dell‘esercizio della preghiera: anche se le nostre decisioni non sono ferme ci danno<br />
una mano i saggi consigli <strong>di</strong> Teresa.<br />
Il terzo capitolo elenca alcuni tipi <strong>di</strong> preghiera, nei quali ognuno dovrebbe cercare <strong>di</strong><br />
applicarsi. I sottotitoli descrivono la qualità della preghiera, che siamo chiamati ad esercitare.<br />
Per quelli che non riescono a me<strong>di</strong>tare, la preghiera vocale è sufficiente. Un cristiano non si<br />
deve sforzare a pregare mentalmente se non ci riesce; questa dottrina è stata confermata da San<br />
Giovanni della Croce.<br />
Il capitolo quarto spiega che cosa significa per <strong>Santa</strong> Teresa la preghiera mentale<br />
necessaria a tutte le persone. In questo capitolo si descrivono due tipi <strong>di</strong> preghiera mentale, una<br />
meto<strong>di</strong>ca e una semplice: A ognuno o l‘una o l‘altra è possibile.<br />
Il capitolo quinto si concentra sulla preghiera mentale, che accompagna la preghiera<br />
vocale. La <strong>di</strong>fferenza tra preghiera vocale e mentale non consiste nel tenere la bocca chiusa o<br />
aperta, ma piuttosto nella consapevolezza <strong>di</strong> parlare con Dio e rivolgere l‘attenzione della<br />
mente, della bocca e del cuore a Dio.<br />
E l‘ultimo capitolo, il sesto, espone alcune attenzioni nel pregare: su come evitare la<br />
<strong>di</strong>strazione, cosí si acquista una famigliarità con Dio piú facilmente, e su come un fedele possa<br />
progre<strong>di</strong>re in breve tempo. È facile acquisire il dono della me<strong>di</strong>tazione, che è il fuoco del <strong>di</strong>vino<br />
amore che abbraccia con il suo calore le nostre anime.<br />
Il Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina ha de<strong>di</strong>cato la seconda parte dell‘opera <strong>di</strong> Teresa alle sette<br />
petizioni del Padre nostro.<br />
Il primo capitolo contiene la prima petizione: Padre nostro, che sei nei cieli, sia<br />
santificato il tuo nome. Si descrive lo stupore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa sulle prime parole del Padre<br />
nostro, sulla grazia <strong>di</strong> essere figli <strong>di</strong> Dio, sui tre tipi dell‘affiliazione <strong>di</strong>vina e sulle qualità <strong>di</strong><br />
essa.<br />
Il secondo capitolo è la continuazione della prima petizione. Tale petizione considera la<br />
perfezione con la quale noi dobbiamo desiderare <strong>di</strong> essere concor<strong>di</strong> con i doni della <strong>di</strong>vina<br />
affiliazione, il fidarsi <strong>di</strong> Dio, in unione a Gesú Cristo, e infine la consolazione, che viene da<br />
Dio.<br />
Il terzo capitolo, approfon<strong>di</strong>sce ancora la prima petizione, la quale parla <strong>di</strong> un<br />
sentimento <strong>di</strong> dolore e <strong>di</strong> gioia che ci accompagna nella nostra vita <strong>di</strong> fede, nel desiderio della<br />
santità.<br />
Il quarto capitolo si concentra nella seconda petizione: venga il tuo regno. Gli elementi<br />
essenziali <strong>di</strong> questa petizione mostrano l‘inquietu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sé, spiegano quanto siamo debitori<br />
verso il nostro re supremo, espongono l‘atteggiamento <strong>di</strong> gratuità nel servizio <strong>di</strong> Dio.<br />
Il quinto capitolo continua l‘approfon<strong>di</strong>mento della seconda petizione che presenta lo<br />
svuotamento <strong>di</strong> sé per il regno <strong>di</strong> Dio sulla terra, la preghiera <strong>di</strong> silenzio e alcuni consigli<br />
riguardanti la preghiera.<br />
Il sesto capitolo descrive la <strong>terza</strong> petizione: sia fatta la tua volontà come in cielo cosí<br />
anche in terra, e presenta Dio come sposo delle anime e il rapporto con Lui come una relazione<br />
sponsale.<br />
668 Questa parte è stata presa dell‘In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> G. FRASSINETTI, Il Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa, opera citata.<br />
Alcune parole utilizzate nel 1887 sono obsolete e queste sono state tralasciate o mutate. Questo<br />
capolavoro del Frassinetti nella e<strong>di</strong>zione inglese ha trecentose<strong>di</strong>ci pagine. L‘autore ha usato l‘inglese in<br />
voga negli Stati Uniti d‘America.<br />
167
Il capitolo seguente continua la spiegazione della <strong>terza</strong> petizione, ed approfon<strong>di</strong>sce, in<br />
una me<strong>di</strong>tazione, l‘unione intima delle anime con Dio sposo. Parla ancora sulla conoscenza <strong>di</strong><br />
sé, sull‘intelligenza e sull‘amore come doni <strong>di</strong> Dio che fanno desiderare i doni spirituali.<br />
Il capitolo ottavo percorre ancora il tema della <strong>terza</strong> petizione. Fare la sua volontà<br />
consiste nel riconoscere che l‘anima offre se stessa come sposa del Divino sposo, e nell‘offrire<br />
se stessa realizza il cielo in terra, nell‘accogliere la grazia tramite la sofferenza come<br />
espressione della volontà <strong>di</strong> Dio e la necessità <strong>di</strong> esservi sottomesso.<br />
Il nono capitolo elabora l‘offerta <strong>di</strong> sé come irrevocabile unione <strong>di</strong> se stessa a Dio.<br />
Il capitolo successivo tratta della quarta petizione: dacci oggi il nostro pane quoti<strong>di</strong>ano.<br />
Dio come il Pastore delle anime, è il pane che noi chie<strong>di</strong>amo perché Lui è l‘agnello immolato.<br />
Nell‘un<strong>di</strong>cesimo capitolo continuerà la quarta petizione e prenderà in considerazione il<br />
Santissimo Sacramento; la reciprocità dell‘amore l‘esigenza <strong>di</strong> una risposta alla domanda<br />
―perché Dio ha lasciato un dono cosí grande in nostro favore?‖<br />
Nel capitolo do<strong>di</strong>cesimo approfon<strong>di</strong>sce la quarta petizione e parla della fiducia, che<br />
dobbiamo avere verso il buon Pastore, ed anche del vantaggio <strong>di</strong> questa fiducia, dello<br />
svelamento del suo essere buon Pastore per noi, della necessità <strong>di</strong> ritirarsi interiormente e della<br />
preghiera <strong>di</strong> giaculatoria al Padre.<br />
Il capitolo tre<strong>di</strong>cesimo contiene la quinta petizione: ―e rimetti a noi i nostri debiti come<br />
noi li rimettiamo ai nostri debitori.” Questa petizione ci mostra Dio-Redentore, Dio-<br />
Misericor<strong>di</strong>oso.<br />
Il capitolo seguente pone attenzione alla <strong>di</strong>gnità personale, al perdono dei peccati e<br />
all‘amore verso gli empi; ivi si trova la vera contemplazione nel grado piú alto<br />
Il quin<strong>di</strong>cesimo capitolo parla della sesta petizione, ―e non ci indurre in tentazione.” In<br />
questa petizione esplicita almeno quattro punti molto significativi; su Dio come nostro me<strong>di</strong>co<br />
per eccellenza, su che cosa noi esigiamo dal me<strong>di</strong>co, sulla <strong>di</strong>fferenza tra i me<strong>di</strong>ci terreni e il<br />
Me<strong>di</strong>co delle anime ed infine approfon<strong>di</strong>sce le cinque piaghe <strong>di</strong> Gesú nostro Signore nelle quali<br />
siamo stati guariti.<br />
Il capitolo successivo continua la sesta petizione, espone le <strong>di</strong>verse tentazioni, mostra<br />
alcune tentazioni nascoste che sono meno dannose, e spiega come capire in caso <strong>di</strong> dubbio se<br />
tale tentazione provenga del <strong>di</strong>avolo. Continua cosí aggiungendo gli esempi <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa e le<br />
dottrine rilevanti <strong>di</strong> San Giovanni della Croce.<br />
Nel capitolo <strong>di</strong>ciassettesimo ancora prosegue la descrizione sulle tentazioni che sono<br />
gravemente dannose, sulla tendenza <strong>di</strong> considerare se stessi virtuosi, su come prevenire questo<br />
tipo <strong>di</strong> tentazione, sulla tentazione <strong>di</strong> un‘umiltà falsa, sulla esagerazione nelle penitenze, l‘essere<br />
reci<strong>di</strong>vo, e sulla sicurezza della propria vita spirituale.<br />
Il capitolo <strong>di</strong>ciottesimo descrive l‘amore e il santo timore con il quale accedere alla<br />
santità della vita, i segni dell‘amore <strong>di</strong> Dio e la contemplazione dell‘amore <strong>di</strong> Dio.<br />
Nel capitolo seguente si pone in evidenza l‘importanza del santo timor <strong>di</strong> Dio e delle<br />
conseguenze dannose della timidezza.<br />
Il capitolo ventesimo enuncia la settima petizione, “ma liberaci dal male.” Essa<br />
consiste nel pregare <strong>di</strong> liberarci da ogni male. <strong>Santa</strong> Teresa aggiunge alcuni consigli su questa<br />
petizione.<br />
L‘ultimo capitolo prosegue nel darci in<strong>di</strong>cazioni sul desiderio della morte, una morte in<br />
contemplazione e sull‘affermazione che questo desiderio può essere desiderabile da tutti. Infine,<br />
conclude con una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> umiltà.<br />
L‘insegnamento sulla preghiera <strong>di</strong> Padre Giuseppe Frassinetti è in<strong>di</strong>rizzato a qualunque<br />
in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong> sufficiente intelligenza. Questo trattato sulla preghiera è breve, pratico e chiaro.<br />
Perciò, il priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina seguí interiormente la dottrina <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa senza<br />
frammischiarlo con le sue opinioni. Egli ha riconosciuto che Teresa aveva davvero qualcosa da<br />
insegnarci sulla preghiera mentale e la sua opera non era in<strong>di</strong>rizzata solo a una élite.<br />
William Hutch nella sua prefazione scrisse, ―sono cosciente che alcune persone sono<br />
incerte nell‘assumere questo insegnamento come guida per la loro vita spirituale, perché<br />
pensano <strong>di</strong> cadere nella tendenza visionaria o mistica, e che i suoi insegnamenti siano troppo<br />
sublimi per uomini or<strong>di</strong>nari. Tale pregiu<strong>di</strong>zio è semplicemente una follia, per tutti quelli che<br />
hanno letto le sue opere. Infatti, alcuni santi possiedono giu<strong>di</strong>zi piú ra<strong>di</strong>cali <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> <strong>Santa</strong><br />
168
Teresa, mentre si rischia <strong>di</strong> cadere in una vita spirituale ridotta solo ad esercizio pratico <strong>di</strong><br />
ra<strong>di</strong>calità. 669 ‖ La preghiera non si può ridurre a una nozione perché è un‘esperienza.<br />
Un autore considera questa esperienza <strong>di</strong> preghiera in una bellissima descrizione con il<br />
titolo <strong>di</strong> ―Oratione‖, come unione d‘amore tra Dio e l‘uomo. Perciò tale relazione si potrebbe<br />
considerare come relazione filiale, sponsale, ossia amicizia spirituale nel vero senso della<br />
parola 670 . «(…) la fede nella presenza del nostro buon Dio, nell‟intimo dei nostri cuori, sarà<br />
una grande consolazione e una promessa <strong>di</strong> sicurezza ai cristiani, i quali sentono dentro <strong>di</strong> sé <strong>di</strong><br />
essere testimoni nella buona coscienza, e possono accogliere una speranza fondata <strong>di</strong> essere<br />
libera da ogni peccato mortale, e perciò arricchiti dalla grazia <strong>di</strong> Dio-Amico» 671 . Per questo, la<br />
persona dovrebbe essere consapevole della sua unione con Dio, che è la ricchezza piú preziosa.<br />
Alla luce della fede, ognuno possiede una presenza tutta unica dell‘Assoluto Buono,<br />
come è concesso agli angeli in cielo. Come una figlia vive sotto la protezione del migliore dei<br />
papà, come una sposa dell‘amatissimo sposo, cosí egli <strong>di</strong>mora in Dio-Padre e nel suo <strong>Figli</strong>o<br />
unigenito, vera forza, vera sapienza, vera gloria e sommo buono. Che gioia è questa presenza <strong>di</strong><br />
Dio per le anime dei cristiani in mezzo delle tribolazioni in questo mondo 672 . La preghiera è<br />
una consapevolezza <strong>di</strong> questa unione d‘amore tra Dio e l‘uomo, in cui noi consideriamo Dio<br />
come amico, padre, e sposo. L‘uomo non deve fare niente se non entrare in questa unione per<br />
essere in comunione 673 e dar luogo a questo innamoramento 674 .<br />
Padre Giuseppe incoraggiava tutti quanti a stabilire questa relazione d‘amore con Dio<br />
nella preghiera personale. Egli ha dato le sue in<strong>di</strong>cazioni a quelli che vogliono aderire, «Non<br />
abbiate paura, perciò, e non <strong>di</strong>sperate delle vostre debolezze, voi anime timide e irresolute, che<br />
non avete assaporato come buono è il Signore per quelli che in Lui esercitano santamente la<br />
preghiera. Abbiate fiducia nelle parole <strong>di</strong> santa Teresa e cominciate pure a de<strong>di</strong>carvi voi stessi<br />
alla preghiera, anche se qualche volta non riusciste a farla. Andate avanti un passo alla volta,<br />
in questa via è bene far qualcosa che niente» 675 .<br />
669 G. FRASSINETTI, Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, Citazione dalla Prefazione del traduttore.<br />
670 «Se è vero che l‘uomo esiste solo in relazione, Teresa si pone in rapporto imme<strong>di</strong>ato con l‘assoluto <strong>di</strong><br />
Dio: rapporto d‘amore con il tutto <strong>di</strong> Dio, il Dio <strong>di</strong> Gesú, che è Padre Sposo e Amico». L. BORRIELLO-G.<br />
DELLA CROCE, Temi maggiori <strong>di</strong> spiritualità teresiana, II E<strong>di</strong>zione rivista e corretta, E<strong>di</strong>zioni OCD,<br />
Roma Morena 2005, 120.<br />
671 Questa opera mette in rilievo la preghiera come esperienza della vita <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila,<br />
esperienza <strong>di</strong> rapporto con Dio come amica, figlia e sposa; la preghiera come esperienza è un luogo<br />
teologico <strong>di</strong> Padre Frassinetti. Da qui molti manuali <strong>di</strong> teologia spirituale hanno desunto definizioni che<br />
sono giunte fino a noi. Cfr CH. A. BERNARD, Teologia spirituale, E<strong>di</strong>zioni Paoline, Roma 1983, 391-430.<br />
F. RUIZ SALVATOR, Caminos de espiritu. Compen<strong>di</strong>o de Teologia espiritual, Ed, de Espiritualidad,<br />
Madrid V ed. 1998, 286-337.<br />
672 ID. Saint Teresa‟s Pater noster, opera citata, 81.<br />
673 Bisogna notare che questa espressione: è una chiamata universale a entrare nel Castello interiore in<br />
comunione <strong>di</strong> vita immanente con la Trinità. Ogni uomo è chiamato alla preghiera ad essere santo e ad<br />
entrare nella porta del castello interiore in cui possiederà l‘unione con Dio. Cfr. J. CASTELLANO-<br />
CERVEDA, Teresa <strong>di</strong> Gesú maestra e modello, in AA.VV., Teresa <strong>di</strong> Gesú. maestra <strong>di</strong> santità Nel IV<br />
Centenario della morte 1582-1982, e<strong>di</strong>zioni del Teresianum, Roma 1982, 24-25.<br />
674 L‘accento posto sulla preghiera come <strong>di</strong>alogo <strong>di</strong> salvezza mette in evidenza altri valori originali della<br />
preghiera cristiana. In un denso e breve articolo Mons. <strong>Maria</strong>no Magrassi ha ricordato queste cinque leggi<br />
spirituali del <strong>di</strong>alogo con Dio nelle quali è facile ritrovare l‘originalità della preghiera cristiana, con tutte<br />
le sue implicazione, e il criterio <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento per combatterne ogni possibile deviazione. Ecco le<br />
cinque regole d‘oro: 1 La preghiera presuppone un rapporto e piú precisamente un rapporto d‘amore, che<br />
viene ovviamente dal Dio che ci ha amato e ci ama per primo; 2 Nel rapporto con l‘uomo, Dio ha sempre<br />
l‘iniziativa; 3 Pregare è soprattutto ascoltare; 4 L‘uomo della Bibbia trasforma in preghiera tutte le realtà<br />
che popolano la sua vita; 5 La preghiera cristiana è soprattutto contemplativa, cioè è tutta rivolta verso<br />
Dio e non ricondotta continuamente verso un certo antropocentrismo. Citato da J. CASTELLANO-<br />
CERVEDA, in Mistero della rivelazione e autenticità della preghiera, in L‟Osservatore Romano, 5 gennaio<br />
1990; cfr. anche il contributo del Professore Jesus Castellano-Cerveda in CONGREGAZIONE PER LA<br />
DOTTRINA DELLA FEDE, “Orationis formas” Lettera e commenti, ai vescovi della Chiesa Cattolica su<br />
alcuni aspetti della me<strong>di</strong>tazione cristiana 15 ottobre 1989, LEV, Città del Vaticano 1991, 80-81.<br />
675 G. FRASSINETTI, Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 20. Le varie tappe del principiante,<br />
dell‘avanzato e del perfetto sono materia della Teologia Spirituale; cfr. anche SAN TOMMASO D‘AQUINO,<br />
169
Nella vita spirituale, ci sono alcuni che sono ancora al <strong>di</strong> fuori della porta del Castello<br />
Interiore, anche <strong>Maria</strong> Maddalena e San Paolo che erano peccatori ne erano fuori, ma essi hanno<br />
raggiunto l‘apice dell‘unione con Dio. Infatti, noi affermiamo che la preghiera, come <strong>di</strong>ce <strong>Santa</strong><br />
Teresa, è un rapporto tra Dio e l‘uomo, e sottolinea il viaggio dell‘uomo verso l‘esperienza<br />
trinitaria, la comunione con Cristo nella sua umanità, «(…) Dio nel chiamarti a con<strong>di</strong>videre la<br />
vita con suo <strong>Figli</strong>o, Gesú Cristo; è un Dio fedele.» (1 Cor 1, 9; cfr. anche Ef 1,4) 676 . Questa<br />
esperienza <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> preghiera tende all‘incontro interpersonale, alla comunione con Cristo, e<br />
per Lui con il Padre, nello Spirito Santo, al rapporto d‘amore, sia filiale, che fraterno,<br />
amichevole o sponsale. 677 Tale unione è possibile perché Dio ama l‘uomo. Per concludere,<br />
<strong>Santa</strong> Teresa definisce che «la preghiera è un esercizio d‘amore» 678 . Questo tipo <strong>di</strong> preghiera è<br />
assolutamente cristologica, centrata sull‘umanità <strong>di</strong> Cristo. «La me<strong>di</strong>tazione del cristiano nella<br />
preghiera cerca <strong>di</strong> comprendere la sublimità del <strong>di</strong>vino nell‘opera salvifica <strong>di</strong> Dio in Cristo, la<br />
Parola incarnata, e i doni dello Spirito» 679 e la comunione trinitaria della vita <strong>di</strong>morando nella<br />
Trinità 680 .<br />
1. La relazione d‘amicizia 681 .<br />
<strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila era una donna realista. Ella ha esteso la comprensione della<br />
nozione dell‘amicizia al rapporto tra Dio e l‘uomo. Dio è un amico (Gv. 15, 15) 682 . Ella ha<br />
descritto la vita <strong>di</strong> preghiera come un‘esperienza <strong>di</strong> crescita all‘interno delle virtú teologali che<br />
sono fede, speranza e carità 683 . Padre Giuseppe ha affermato che Teresa sosteneva che ciò era<br />
vero sia quando recitiamo il ―Padre nostro‖ o qualsiasi preghiera, sia quando sentiamo che il<br />
Signore è lontano da noi. L‘uomo deve pensare che Dio è presente nella persona che prega 684 .<br />
Animato dall‘accoglienza della sua presenza, l‘uomo deve affidare a Dio le sue intenzioni,<br />
aspettando pazientemente fino a quando egli non parlerà al cuore ispirato dalla sua grazia.<br />
Summa Teologica, 2°. 2°. q. 24 a. 9. <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila e San Giovanni della Croce hanno parimenti<br />
simili <strong>di</strong>stinzioni, cfr. per esempio San Giovanni della Croce, Raccolta delle Opere <strong>di</strong> San Giovanni della<br />
Croce, 239-357.<br />
676 Cfr. GS n. 19, n. 22. Il termine ―comunione‖ e ―unione‖ sono molto ricchi <strong>di</strong> significato nella<br />
tra<strong>di</strong>zione spirituale carmelitana, sia nelle opera <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa che <strong>di</strong> San Giovanni della Croce.<br />
677 Per queste espressioni cfr. J. CASTELLANO-CERVEDA, Incontro al Signore. Pedagogia della preghiera.<br />
E<strong>di</strong>zioni OVD, Roma Morena 2002, 254.<br />
678 The Book of Her Live, VII, 12. Per una piú ampia descrizione della preghiera <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa, cfr. T.<br />
ALVAREZ, Gli occhi fissi su Cristo: l‟orazione <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‟Avila, III ed.. E<strong>di</strong>zioni OCD, Morena<br />
2002, 25-26.<br />
679 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, “Orationis formas” Lettera e commenti, ai vescovi<br />
della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della me<strong>di</strong>tazione cristiana 15 ottobre 1989, LEV, Città del<br />
Vaticano 1991. La citazione è ripresa dall‘e<strong>di</strong>zione inglese della CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF<br />
FAITH, Letter to the Bishops of the Catholic Church on same aspects of christian me<strong>di</strong>tation 15 ottobre<br />
1989, Pauline, Boston 1991, n. 11<br />
680 «L‘incontro fra Dio e l‘uomo non è semplicemente uno stare del mio Io <strong>di</strong> fronte ad un Tu dello stesso<br />
livello. Il Tu <strong>di</strong> Dio è trinitario, ed esso stesso un circolo d‘amore, nel quale identità e alterità si fondono<br />
pienamente. Incontrare Dio quin<strong>di</strong> significa essere attratti all‘interno del circolo trinitario … Infatti il<br />
<strong>Figli</strong>o è <strong>di</strong>ventato uomo e dalla croce ci accoglie tutti nelle sue braccia. Questo significa che noi<br />
<strong>di</strong>ventiamo ―trinitari‖ per il fatto che insieme con il <strong>Figli</strong>o <strong>di</strong>ventiamo un unico nuovo Io: io vivo ma non<br />
sono io che vivo, ma Cristo vive in me. La risposta cristiana al problema della liberazione dal carcere<br />
dell‘io non vuole <strong>di</strong>re dunque <strong>di</strong>ssolvimento della persona, vuol <strong>di</strong>re piuttosto: amore, che nell‘alterità<br />
crea la massima unità e fa <strong>di</strong>ventare l‘essere altro la ricchezza dell‘unità» Ibid. Preso dall‘Introduzione<br />
del Car<strong>di</strong>nale Giuseppe Ratzinger, 11.<br />
681 Cfr. Amistad, in Diccionario de <strong>Santa</strong> Teresa de Jesús, <strong>di</strong>r. T. ALVAREZ, Monte Carmelo, Burgos<br />
2001, 43-45.<br />
682 Cfr. DV n. 2. L‘espressione ―amicizia <strong>di</strong> Dio con l‘uomo‖ si trova anche in Denz. N. 1528-1529 H.<br />
DENZINGER-P. HUNERMANN, in Enchiri<strong>di</strong>on Symbolorum, 37 e<strong>di</strong>zione, EDB, Bologna 2001, 651-652.<br />
683 Cfr. M. H. GARCIA, Mistica dell‟amicizia o mistica teologale, AA.VV., Mistica e mistica carmelitana,<br />
LEV, Città del Vaticano 2002, 124-130<br />
684 G. FRASSINETTI, Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 49.<br />
170
<strong>Santa</strong> Teresa ha indagato sul metodo per rimanere alla presenza del Maestro Divino<br />
mentre l‘uomo prega. Quando l‘uomo si de<strong>di</strong>ca nella preghiera è solo, ma ognuno è desideroso<br />
<strong>di</strong> essere in compagnia. E dunque, quale miglior compagno potrebbe avere se non il Maestro, il<br />
quale insegna a chiedere nella preghiera ciò che è conveniente? Egli infatti è il medesimo<br />
Signore che è presente in ogni persona, che con amore e umiltà istruisce ogni uomo. Dio rimane<br />
il miglior amico. Se la persona si è abituata ad avere tale intimità, ed Egli vede che detta persona<br />
si de<strong>di</strong>ca con affetto e che costantemente lo desidera, Egli non l‘abbandonerà mai. Consideri<br />
forse una cosa da poco avere un tale amico che è sempre al tuo fianco? 685 <strong>Santa</strong> Teresa e San<br />
Giovanni della Croce parlano della presenza <strong>di</strong>vina in ogni anima, e questa presenza è descritta<br />
come intima familiarità tra due amici nella stessa casa 686 . Chiunque è invitato a riflettere<br />
sull‘amore che il Signore ha con<strong>di</strong>viso con noi.<br />
Per ottenere la vita eterna Gesú comanda a tutti <strong>di</strong> mangiare la <strong>Santa</strong> Eucaristia.<br />
Sebbene la sua ineffabile Maesta è bene a conoscenza che molti potrebbero riceverlo con il<br />
peccato mortale, tuttavia l‘amore lo porta verso i suoi amici in modo irresistibile ed efficace.<br />
Egli ricerca l‘amore dei suoi amici e sopporta molti affronti compiuti contro <strong>di</strong> Lui dai suoi<br />
nemici. E dunque egli ha reso manifesto questo suo amore agli amici, e si è compiaciuto <strong>di</strong><br />
consacrare ed istituire questo sacro convito precisamente nel momento in cui proprio essi erano<br />
in procinto <strong>di</strong> ucciderlo. E sebbene il suo corpo e il suo sangue siano realmente presenti sotto le<br />
due specie, egli volle che ciascuna specie fosse consacrata separatamente per mostrarci che la<br />
separazione e la <strong>di</strong>visione erano segno necessario per in<strong>di</strong>carci la sua morte, che si ripete tante<br />
volte quante viene consacrato e tanto spesso quante volte viene offerto nella Chiesa Cattolica.<br />
2. Relazione paterno-filiale<br />
Dio abita nell‘interiorità dell‘uomo; questa è una verità a cui un‘anima deve<br />
continuamente rivolgere la sua riflessione. Quando l‘uomo, figlio del Padre celeste vuole parlare<br />
con Lui e godersi la Sua compagnia, non ha bisogno <strong>di</strong> andare in cielo e neppure <strong>di</strong> parlare ad<br />
alta voce, ma è sufficiente parlare a voce bassa, o anche solo con il pensiero, Dio, il Padre è<br />
sempre vicino, «Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il<br />
Padre tuo in segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,6; Lc 17,21; 2<br />
Cor 6,16; Mt 13,44).<br />
Non è necessario avere le ali e volare per parlare e trovarlo, ma mettersi in stato <strong>di</strong><br />
solitu<strong>di</strong>ne e contemplarlo 687 , e non lasciare da parte un tale ospite, ma parlare con Lui con<br />
grande umiltà come ad un Padre, pregarlo come si prega un Padre, esporre a Lui i propri<br />
problemi, e chiedere un rime<strong>di</strong>o, riconoscendo se stesso indegno <strong>di</strong> essere suo figlio 688 .<br />
<strong>Santa</strong> Teresa nelle sue me<strong>di</strong>tazioni ci descrive questo Padre. Considera che il tuo Padre<br />
è Dio in tre persone e uno in essenza, il principio e l‘autore <strong>di</strong> tutte le cose, un Essere senza<br />
principio, che è la causa <strong>di</strong> tutte cose create, e per il quale l‘uomo si muove e nel quale vive.<br />
Egli sostiene e mantiene tutto nell‘esistenza. Poi considera te stesso come un figlio <strong>di</strong> un Padre<br />
cosí potente. Può creare un infinito numero dei mon<strong>di</strong>; è molto sapiente, sa governarli tutti,<br />
come Lui governa il nostro mondo. Senza la Sua Provvidenza nessuna creatura, dalla piú alta e<br />
serafica fino al verme piú basso della terra non sussisterebbe. È cosí buono, che, senza nessun<br />
interesse, continua a comunicare se stesso a tutte le creature secondo la capacità <strong>di</strong> ognuno.<br />
L‘uomo, soprattutto, deve riflettere ed essere grato al Padre, perché è sua gioia dare all‘uomo<br />
l‘esistenza, e gode che egli sia suo figlio. Per il fatto che ha creato me, non gli è esclusa la<br />
possibilità <strong>di</strong> crearne altri molto migliori <strong>di</strong> me.<br />
In conseguenza <strong>di</strong> ciò fa attenzione quanto grande deve essere l‘amore e il rispetto per<br />
un tale Padre, che, grazie alla sua bontà ha creato tutte le cose per me, ed ha creato anche me<br />
perché lo possa servire e possa rallegrarmi <strong>di</strong> stare con Lui.<br />
685<br />
Cfr. ID., Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 58. Anche M. H. GARCIA, La preghiera una storia<br />
d‟amicizia, EDB, Bologna 2001, 39-97. Ve<strong>di</strong> anche L. BORRIELLO-G. DELLA CROCE, Temi maggiori <strong>di</strong><br />
spiritualità teresiana, opera citata, 109-132.<br />
686<br />
G. FRASSINETTI, Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 84.<br />
687<br />
Cfr. La via della perfezione, XXVIII, 2.<br />
688<br />
G. FRASSINETTI, Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 111.<br />
171
Anche un bambino deve considerare l‘istinto amoroso dei genitori. Loro amano i loro<br />
figli, anche se deformi; come pure li accolgono anche se ingrati: li sopportano, anche se testar<strong>di</strong>,<br />
sono pronti a perdonarli, quando tornano a casa e <strong>di</strong>ventano obbe<strong>di</strong>enti; mentre i figli sono liberi<br />
dalle preoccupazioni, i genitori lavorano per migliorare il loro stato <strong>di</strong> vita e il patrimonio.<br />
Rifletti come tutte queste qualità si trovano in Dio, in un grado infinitamente piú alto. Questo<br />
pensiero deve intenerire la tua anima, affinché possa causare speranze nuove <strong>di</strong> perdono sia in te<br />
stesso che negli altri. Ed infine, non puoi <strong>di</strong>sprezzare nessuno, sapendo che ognuno ha un Padre<br />
che è il Padre comune <strong>degli</strong> uomini e <strong>degli</strong> angeli.<br />
Dio ama ognuno come suo figlio. Un padre accetta un figlio anche se è oggetto <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sprezzo e <strong>di</strong> <strong>di</strong>spiacere alle persone in generale. Nella stessa maniera, anche se gli uomini<br />
sono molto <strong>di</strong>sprezzati, agli occhi del nostro Padre celeste, proprio perché sono Suoi figli, lui<br />
non li <strong>di</strong>sprezza né li abbandona. Lui non li o<strong>di</strong>a, al contrario, manifesta questo amore<br />
togliendo da essi quelle deformità. L‘uomo deve riflettere, infatti ogni padre deve fare<br />
esperienza che dai suoi figli gli derivano tante prove <strong>di</strong> ingratitu<strong>di</strong>ne, ma c‘è un Padre che non si<br />
stanca <strong>di</strong> sorreggerli e servirli in tanti mo<strong>di</strong>. Inoltre, un figlio deve riflettere come i padri<br />
sopportano i vizi dei loro figli, ed invece <strong>di</strong> punirli subito per la loro cattiva condotta , mostrano<br />
molta pazienza, nella speranza che cambino.<br />
Finalmente, l‘uomo deve riflettere che il Padre nostro celeste per mille vie provvede<br />
alle necessità con l‘ansia piú grande e un‘abbondanza <strong>di</strong> grazia, in modo che l‘uomo non<br />
rimanga nella deplorabile povertà che si meriterebbe, ma al contrario, possa trovare se stesso<br />
arricchito <strong>di</strong> tanti tesori 689 .<br />
<strong>Santa</strong> Teresa conclude cosí il Capitolo ventisette della sua La via <strong>di</strong> perfezione: «Il buon<br />
Gesú ha dato a ogni uomo un Padre molto eccellente. I figli del Padre meritano <strong>di</strong> godersi dei<br />
suoi favori, buttandosi nelle sue mani. Non si allontanerà dai suoi figli. Non importa quanto sia<br />
confusa e <strong>di</strong>stratta la mente dei suoi figli, tra un tale Padre e un tale <strong>Figli</strong>o, lo Spirito Santo la<br />
relazione è una necessità. Lascia che Lui infiammi la tua mente e la leghi con i suoi nessi <strong>di</strong><br />
amore. Sicuramente se uno considera che ha un padre in cielo, un padre molto nobile e buono,<br />
lui capirà come è grande il destino dell‘uomo, e conseguentemente, quanto santa e immacolata<br />
deve essere la sua vita, in modo che non sia indegno <strong>di</strong> essere suo figlio» 690 . Nel frattempo<br />
questa <strong>di</strong>gnità e questo destino è nostro, solo se riflettiamo su <strong>di</strong> esso attentamente, e sarà per<br />
noi fonte inesauribile <strong>di</strong> dolci consolazioni e <strong>di</strong> speranze.<br />
Le parole ovviamente non bastano a dare un commento adeguato del sentimento <strong>di</strong> cui<br />
parla la <strong>Santa</strong>: è troppo alto e sublime. Un figlio può comunque acquisire una conoscenza<br />
pratica della verità che comunica, me<strong>di</strong>tando sull‘amore eccessivo del <strong>Figli</strong>o <strong>di</strong> Dio, che ad un<br />
prezzo cosí caro è stato contento <strong>di</strong> riscattare per noi il nome e la realtà <strong>di</strong> essere figli <strong>di</strong> Dio, e<br />
sull‘amore eccessivo del Padre Celeste, che ha voluto darci il Suo proprio <strong>Figli</strong>o a questo scopo.<br />
Se de<strong>di</strong>chiamo noi stessi a tali riflessioni, lo Spirito Santo, che è l‘amore reciproco <strong>di</strong> un tale<br />
Padre e <strong>di</strong> un tale <strong>Figli</strong>o, infiammerà i nostri cuori in una maniera non descrivibile con il Suo<br />
santo amore 691 .<br />
<strong>Santa</strong> Teresa afferma inoltre che dopo la me<strong>di</strong>tazione deve sgorgare un dolore profondo<br />
al pensiero che i figli ingrati hanno offeso il Padre. Questo pensiero sarà proceduto dalla gioia,<br />
riflettendo che ci sono tanti servi <strong>di</strong> Dio nei quali la santità del loro Padre brilla. Un figlio o una<br />
figlia potrà addolorarsi per ogni peccato ed esempio malvagio che hanno compiuto. Allo stesso<br />
tempo però esulta per ogni virtú, che potrà conoscere e sentire negli altri. I figli <strong>di</strong> Dio devono<br />
ringraziarlo per aver creati i santi, i martiri, i confessori e le vergini, che hanno manifestamente<br />
mostrato <strong>di</strong> essere figli <strong>di</strong> un tale Padre. Dopo questa considerazione può arrivare un sentimento<br />
689 ID. Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 40-43.<br />
690 La seguente preghiera è stata trovata nel breviario <strong>di</strong> Padre Giuseppe ed è considerata un suo<br />
rapimento mistico: «Te, Domine, parce peccatis meis et omnes iniquitates meas dele. Docere me facere<br />
voluntatem tuam. Da mihi spiritum bonum. Pone me iuxta te. Ne permittas me separari a te. Custo<strong>di</strong> me<br />
ut pupillam oculi. Sine te, pulvis et cinis, nihil possum facere. Ego autem in nomine tuo, confisus auxilio<br />
gratiae tuae. Propterea pro me nihil aliud petam a te, neque pro rebus, neque pro vita, neque pro morte,<br />
nihil aliud petam a te. Hoc modo inter tuam et meam voluntatem fiat pax in virtute tua. Fiat in me et in<br />
aliis misericor<strong>di</strong>a tua in tempore et in aeternitate.» ID. Pactum pacis, Poliglotta Vaticana, Roma 1912.<br />
691 ID. Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 140-145.<br />
172
<strong>di</strong> confusione, per aver offeso Lui, e non aver apprezzato i suoi benefici, ed essersi comportato<br />
in modo non degno della <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> essere suoi figli e figlie adottivi <strong>di</strong> Dio. Tali sentimenti<br />
regali devono aver luogo nei nostri cuori generosi. L‘anima cristiana deve riflettere sui suoi<br />
peccati e ingratitu<strong>di</strong>ni, questo la rende indegna del nome e della realtà <strong>di</strong> essere figlia <strong>di</strong> Dio, e<br />
questo pensiero la deve riempire <strong>di</strong> sentimenti <strong>di</strong> umiltà profonda.<br />
Teresa d‘Avila e Padre Giuseppe hanno accennato che è un vantaggio che anche fuori<br />
del tempo <strong>di</strong> preghiera, ognuno possa essere alla presenza del Padre celeste. Tutti i cristiani<br />
devono riconoscere Lui in tutte le sue opere, e ricevere tutto come proveniente dalle sue mani.<br />
Soprattutto, l‘anima deve esultare a causa del suo privilegio, <strong>di</strong> essere sorella <strong>di</strong> Cristo, erede al<br />
suo regno e coerede con Cristo stesso.<br />
3. Relazione Sponsale<br />
<strong>Santa</strong> Teresa considera Dio come uno sposo per le nostre anime, cosí è anche<br />
considerato nei suoi scritti. Desidera che la volontà <strong>di</strong> Dio si compia in tutte le cose, niente <strong>di</strong><br />
piú che la sua volontà sia compiuta sulla terra, con la stessa perfezione dell‘amore con il quale è<br />
compiuta in cielo. Continuamente ha invitato ognuno a conformarsi a questa volontà <strong>di</strong>vina, a<br />
rappresentare alla propria mente questo Padre e Re dei re sotto il titolo <strong>di</strong> Sposo, il piú amabile<br />
sposo delle nostre anime.<br />
Dio attribuisce grande valore al titolo, ―Padre e Sposo‖. Quando invita Gerusalemme a<br />
pentirsi dalla sua condotta peccatrice ed adultera, chiede a lei <strong>di</strong> ritornare a Lui ed a chiamarlo.<br />
Questo titolo <strong>di</strong> sposo richiama prima alle nostre menti tutto ciò che comporta un amore<br />
generoso e fedele che si racchiude nell‘arrendersi reciproco delle volontà; e dunque,<br />
nell‘assumersi questo titolo 692 . Dio si vota all‘amore in<strong>di</strong>viso per l‘uomo, con tutta la mente ed<br />
il cuore. Già con Israele aveva fatto un contratto sposale, ha richiesto e comandato <strong>di</strong> amarlo<br />
con tutto il cuore, con tutta l‘anima, e con tutta la forza.<br />
Ancora <strong>di</strong> piú un cristiano deve riflettere in una maniera speciale sulla con<strong>di</strong>scendenza<br />
<strong>di</strong> Dio onnipotente, che, non contento <strong>di</strong> essere Padre e Re della anima che Lui ama, vuole<br />
anche essere il suo Sposo, e sembra che valorizzi questo titolo su <strong>di</strong> tutti gli altri. In verità, il<br />
Suo Divino Spirito ha dettato a Salomone un libro - il Cantico dei cantici – che può essere<br />
considerato come un inno sponsale tutto de<strong>di</strong>to a celebrare il matrimonio <strong>di</strong> Dio con l‘anima che<br />
ama. In questo libro, sotto il velo delle parole mistiche profonde, è descritto l‘amore piú santo<br />
ed ineffabile che passa tra l‘eterno Sposo e l‘anima che ha sposato. Questo libro, <strong>di</strong>fficile ad<br />
essere capito dalle menti carnali e mondane, è un para<strong>di</strong>so <strong>di</strong> luce e <strong>di</strong> dolcezza per le anime<br />
pure; ed è molto <strong>di</strong> piú, in proporzione alla loro vicinanza alla santità perfetta.<br />
Verso il fine della sua vita, San Bernardo ha trovato consolazione nello scrivere un<br />
commento a questo libro dell‘amore <strong>di</strong> Dio, ma non è stato capace <strong>di</strong> finire il suo lavoro,<br />
essendo chiamato a godersi in cielo questi trasporti, che ha provato a descrivere sulla terra.<br />
Santo Tommaso d‘Aquino ha spiegato questo libro ai monaci <strong>di</strong> Fossanova. San Giovanni della<br />
Croce ha voluto leggerlo per ritrovarlo nella sua ultima agonia, e si è ricordato nella sua vita<br />
che, sentendo le frasi amorevoli con le quali si era saziato, ha pianto ed esclamato: o che<br />
preziose perle sono queste! Anche <strong>Santa</strong> Teresa ha scritto pensieri nobili sulle parole del libro,<br />
ma è rimasta soltanto qualche traccia nelle sue opere 693 .<br />
In questo sublime cantico, lo Sposo Divino descrive, una per una, le bellezze del Suo<br />
amato, e scoppia in esclamazioni <strong>di</strong> meraviglia e d‘amore, che sono capaci <strong>di</strong> riempirci con<br />
stupore: «Mi baci con i baci della sua bocca! Si, le tue tenerezze sono piú dolci del vino. Per la<br />
fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, profumo olezzante è il tuo nome, per questo le<br />
giovinette ti amano. Attirami <strong>di</strong>etro a te, corriamo! M‟introduca il re nelle sue stanze: gioiremo<br />
692 L‘amicizia è un tema molto importante nella spiritualità biblica: ve<strong>di</strong> V. PASQUETTO, Chiamati a vita<br />
nuova. Temi <strong>di</strong> spiritualità biblica, I AT, LEV, Città del Vaticano 2002, ID. Chiamati a vita nuova. Temi<br />
<strong>di</strong> spiritualità biblica, II NT, LEV, Città del Vaticano 2002.<br />
693 Origene è stato il primo teologo che ha coniato una interpretazione mistico-spirituale del Cantico dei<br />
Cantici; cfr. J. DANIELOU, Origene, il Genio del Cristianesimo, E<strong>di</strong>zioni Arkeios, Roma 1991, 345-363.<br />
Padre Giuseppe Frassinetti spiega come alcuni santi acquistarono familiarità con il Cantico dei Cantici;<br />
ve<strong>di</strong> G. FRASSINETTI, Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 187.<br />
173
e ci rallegreremo per te, ricorderemo le tue tenerezze piú del vino. A ragione ti amano!»<br />
(Cantico dei cantici 1,1-4). Queste e altre espressioni meravigliose fa lo Sposo delle nostre<br />
anime, il Re del cielo, proclama il Suo amore per noi; e dopo tali <strong>di</strong>chiarazioni, non è necessario<br />
portare avanti altre prove <strong>di</strong> questo amore con altre citazione della Sacra Scrittura. 694 .<br />
San Giovanni della Croce ci ha lasciato sul Cantico dei Cantici nel suo Cantico<br />
spirituale e nella La fiamma vivente dell‟Amore un ardente commento 695 . Beato colui che può<br />
capire tutto quello che è scritto sull‘amore meraviglioso <strong>di</strong> Dio per le anime che a loro volta lo<br />
amano!<br />
Le anime che hanno ottenuto un grado alto <strong>di</strong> perfezione e <strong>di</strong> familiarità amabile con il<br />
loro Sposo Celeste sono poco numerose. Dall‘altra parte, ci sono tante anime in stato <strong>di</strong> grazia,<br />
e conseguentemente sposate da Dio, che sono imperfette e tiepide nel Suo amore. <strong>Santa</strong> Teresa<br />
ha insegnato quale regola <strong>di</strong> condotta tenere per <strong>di</strong>ventare amabili allo Sposo Celeste. Dunque<br />
esorta a riflettere quanto modesta, quanto vestita elegantemente deve essere la sposa per essere<br />
amata da un tale Re. Considera poi i gioielli e gli altri ornamenti con i quali lo Sposo sta per<br />
adornare le sue spose; non la lascia mai povera, nuda e <strong>di</strong>sadornata. Le spose devono chiedere i<br />
gioielli che sono piú piacevoli agli occhi della Sua Divina Maestà, per questo, il Signore<br />
comincerà nella sua bontà celeste ad alzarla e a riceverla nelle Sue mani, come Re Assuero ha<br />
fatto alla regina Ester.<br />
L‘anima sposata da Dio deve piacere a quello Sposo Sovrano, la cui bellezza e bontà<br />
sono infinite. Lei sarà la sua sposa, non per un tempo, ma per l‘eternità. Deve continuare ad<br />
adornarsi con tutte le virtú cristiane praticate nel grado piú perfetto, fino ad apparire davanti a<br />
Lui tutta bella e senza macchia.<br />
<strong>Santa</strong> Teresa arriva a <strong>di</strong>re che l‘anima sposata da Dio deve considerare la sua<br />
piccolezza: sono le ricchezze immense dello sposo che portano l‘anima a questo sposalizio.<br />
Inoltre, con il prezzo del Suo sangue, ha comprato dal Suo Padre le nostre anime, per farle<br />
<strong>di</strong>ventare Sue spose. Questo sposalizio è fatto nel battesimo 696 , dove ci ha dato la sua fede,<br />
insieme con le virtú ed i doni, che sono ornamenti delle nostre anime. E tutti i doni <strong>di</strong> Dio sono<br />
<strong>di</strong>ventati nostri attraverso questo sposalizio e ci ha regalato tutti i suoi benefici e portato a stesso<br />
tutti i mali 697 .<br />
694 G. FRASSINETTI, Osculetur me osculo oris tui cant. 1,1, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1912.<br />
695 Ve<strong>di</strong> la me<strong>di</strong>tazione teologico-spirituale del Frassinetti sul Dottore della Chiesa San Giovanni della<br />
Croce, ID. Alcuni effetti che fa nell‟anima l‟Amore <strong>di</strong>vino Ricavati dall‟opuscolo <strong>di</strong> San Giovanni della<br />
Croce “Fiamma d‟amor <strong>di</strong>vino”, Tip. Poliglotta, Roma 1912.<br />
696 Questa parte <strong>degli</strong> scritti accentua che <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila e Padre Giuseppe Frassinetti fanno uso del<br />
concetto <strong>di</strong> amore sponsale/nuziale come chiave ermeneutica nell‘interpretare il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> salvezza <strong>di</strong><br />
Dio; il mistero pasquale riguarda Gesú Cristo, come sposo fedele, che dona la sua vita per la<br />
Sposa/Chiesa/anima in<strong>di</strong>viduale, e si applica al sacramento dell‘Eucaristia come fons et culmen. È<br />
interessante notare che alcuni autori <strong>di</strong> teologia sacramentaria hanno strutturato la loro materia sulla<br />
teologia sponsale, per esempio Giorgio Mazzanti, sacerdote della <strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> Firenze, professore <strong>di</strong><br />
teologia sacramentaria alla Pontificia Università Urbaniana e alla Facoltà Teologica del Centro Italia. Egli<br />
ha pubblicato libri come: 1 G. MAZZANTI, I sacramenti simbolo e teologia. Introduzione generale, EDB,<br />
Bologna 1997. 2 ID. I sacramenti simbolo e teologia. Eucaristia, battesimo e confermazione, EDB,<br />
Bologna 1998. 3 ID. Teologia sponsale e sacramento delle nozze. Simbolo e simbolismo nuziale, EDB,<br />
Bologna 2002. 4 ID. Persone nuziali, saggio teologico <strong>di</strong> antropologia, EDB, Bologna 2005. Nella storia<br />
della salvezza c‘è tutta una manifestazione nuziale, che inizia nel libro della Genesi con Adamo ed Eva e<br />
termina con la festa <strong>di</strong> nozze <strong>di</strong> Cristo e della Chiesa nel libro dell‘Apocalisse. Nell‘economia della<br />
salvezza <strong>di</strong> Dio ci sono molti simboli nuziali come nel libro <strong>di</strong> Osea, nel Cantico dei Cantici ed alcune<br />
parabole del Vangelo. Gli evangelisti identificano Gesú con lo Sposo. I padri della Chiesa come Ippolito,<br />
Origene, Ambrogio, Tertulliano commentano il Cantico dei Cantici con una interpretazione ecclesiologica<br />
e mistica. I teologi, come Hans Urs von Balthasar, Enrico De Lubac e Jean Danielou e <strong>di</strong>versi altri hanno<br />
de<strong>di</strong>cato alcuni capitoli dei loro lavori alla teologia nuziale. Santi e mistici, come <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila,<br />
San Giovanni della Croce, <strong>Santa</strong> Brigida <strong>di</strong> Svezia descrivono l‘apice della loro esperienza mistica come<br />
un matrimonio spirituale, cfr. C. MILITELLO, La Chiesa “il corpo crismato”, EDB, Bologna 2003, 205-<br />
266.<br />
697 G. FRASSINETTI, Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 192-193.<br />
174
Gesú insegna all‘umanità <strong>di</strong> chiedere un tipo <strong>di</strong> pane: dacci oggi il nostro pane sovra<br />
sostanziale. In questa petizione l‘uomo chiede il pane della dottrina evangelica, le virtú, e la<br />
forza che tutto sopporta e rafforza la sua anima per la preservazione della sua vita spirituale.<br />
<strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong>ce che in questa petizione l‘uomo deve me<strong>di</strong>tare sul mistero del santissimo<br />
Sacramento, e sull‘eccellenza <strong>di</strong> questo cibo, che è la sostanza del Padre, e citando il santo re<br />
Davide, esaltando questo favore conferito da Dio agli uomini, <strong>di</strong>ce che questo pane è il ―midollo<br />
<strong>di</strong>vino‖. Questo è il piú grande miracolo: Dio <strong>di</strong>venta uomo; nell‘incarnazione, ha deificato la<br />
sua stessa anima e il suo stesso sangue unendoli alla sua Divina Persona: ma in questo<br />
sacramento, Dio desidera deificare tutti gli uomini, che sono nutriti <strong>di</strong> un cibo migliore <strong>di</strong> quello<br />
che hanno preso quando erano bambini. Attraverso il battesimo, Dio ha rigenerato l‘uomo ma<br />
con l‘Eucaristia egli desidera <strong>di</strong>ventare nostro nutrimento, per renderci piú conformi alla <strong>di</strong>gnità<br />
che ci ha conferito.<br />
L‘anima deve considerare l‘amore, che lei dovrebbe portare verso questo Sposo Celeste.<br />
È un amore forte, un amore preparato per il sacrificio <strong>di</strong> sé fino a versare il sangue. Tante anime<br />
vogliono contrarre lo sposalizio con Gesú, alla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> portargli solamente un amore<br />
tenero, dolce e piacevole. Sono terrificati e spaventati dal pensiero <strong>di</strong> portargli un amore forte,<br />
l‘amore che sacrifica se stesso, che non si tira in<strong>di</strong>etro nemmeno <strong>di</strong> fronte alla situazione <strong>di</strong><br />
versare il sangue. Possiamo essere chiamati a dare prova d‘amore nella sofferenza, ed è questo<br />
l‘amore che un‘anima deve portare al suo sposo Gesú 698 .<br />
Il priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina ha adottato il metodo della preghiera insegnata da <strong>Santa</strong> Teresa<br />
d‘Avila. Ha esortato i suoi parrocchiani e lettori del Pater noster a trattare familiarmente con<br />
Dio, come si fa con un parente vicino, oppure con un membro della propria famiglia. Il nostro<br />
Dio, che è Padre, nostro Amico e Sposo, non è <strong>di</strong>stante da noi. L‘uomo in ogni momento può<br />
abbracciare Dio e parlargli. Questo spinge l‘uomo a entrare in relazione <strong>di</strong> umile confidenza con<br />
Dio, per poter mettere davanti a Lui ogni desiderio e bisogno, come un bambino davanti al<br />
padre, un amico davanti ad un amico, oppure una moglie davanti al marito. È tramite gli occhi<br />
della fede che l‘uomo può sentire la presenza reale <strong>di</strong> Dio dentro se stesso e ha il privilegio <strong>di</strong><br />
trattare con Dio familiarmente. Poco a poco ogni in<strong>di</strong>viduo può essere consapevole dei<br />
sentimenti interiori del proprio cuore e rimanere solo con Dio in un colloquio familiare 699 .<br />
I titoli che <strong>Santa</strong> Teresa usa sono quelli <strong>di</strong> Re, Sposo, Pastore, Redentore, Amico e<br />
Giu<strong>di</strong>ce: ognuno <strong>di</strong> questi corrisponde alla sostanza <strong>di</strong> una delle petizioni del Pater noster.<br />
Comunque, il titolo <strong>di</strong> Padre appartiene ad ognuna delle petizioni <strong>di</strong> questa preghiera. Dunque,<br />
per esempio: ―Il Signore Sovrano: Venga il tuo regno, Sposo delle nostre anime: sia fatta la tua<br />
volontà‖ e cosí via. Comunque, questo lavoro si concentra sui tre titoli: Padre, Amico e Sposo.<br />
Questi titoli forniranno materia per pensieri e affezioni eccellenti e pii.<br />
698 Cfr. Ibid., 200.<br />
699 Cfr. Il Castello interiore, III, 4.<br />
175
CAPITOLO TERZO<br />
LA RILEVANZA DI PADRE FRASSINETTI NEL TERZO MILLENNIO<br />
A. La teologia vissuta dei santi 700<br />
La lettera apostolica Novo Millennio ineunte <strong>di</strong> Giovanni Paolo II invita il popolo <strong>di</strong> Dio<br />
a contemplare il Mistero <strong>di</strong> Cristo attraverso una ricerca teologica e la teologia vissuta dei santi.<br />
Il Papa ha proclamato Caterina da Siena e Teresa <strong>di</strong> Lisieux, dottori della Chiesa, maestre <strong>di</strong><br />
teologia mistica e simbolica. <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila e San Giovanni della Croce sono presentati<br />
come maestri <strong>di</strong> preghiera. In altro modo, la teologia vissuta dei santi è richiamata nell‘enciclica<br />
Fides et Ratio; qui i protagonisti sono Sant‘Anselmo e San Tommaso d‘Aquino, maestri <strong>di</strong><br />
teologia speculativa. Padre Giuseppe Frassinetti era attento alla vita dei santi, ha chiamato San<br />
Giovanni della Croce e <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila ―esperti della Scienza dei santi‖.<br />
Questo è, in verità, avere un apprezzamento proprio della bontà <strong>di</strong> Dio – «Rettamente<br />
pensate del Signore» (Sapienza 1,1). Sono solo i santi che hanno successo nell‘intrattenere il<br />
sentimento nobile in tutta la sua pienezza; perché essi soli, per quanto è permesso alla debolezza<br />
umana, hanno una concezione piena ed esultante della bontà immensa <strong>di</strong> Dio. L‘uomo non trova<br />
mai le espressioni <strong>di</strong> confidenza e sicurezza eccetto che negli scritti dei santi, perché confidenza<br />
e sicurezza possono procedere solo dai loro cuori infiammati 701 .<br />
È comunque vero che l‘uomo non può facilmente ottenere tale grado <strong>di</strong> perfezione pur<br />
imitando gli spiriti beati del cielo. Ogni in<strong>di</strong>viduo, tranne qualche caso troppo eccezionale e<br />
straor<strong>di</strong>nario, può ottenere una alta perfezione nell‘or<strong>di</strong>ne della grazia solo per gra<strong>di</strong> e poco a<br />
poco. Dunque, gli uomini hanno bisogno <strong>di</strong> tanta pazienza e perseveranza, ma, come <strong>Santa</strong><br />
Teresa <strong>di</strong>ce: ognuno non deve perdere tempo sulle cose in cui non sono efficientemente<br />
obbligati. Ogni uomo deve comunque essere persuaso che, anche se in questo mondo non può<br />
ottenere una perfezione tanto completa come è quello della beata visione <strong>di</strong> Dio, tuttavia può<br />
ottenere un grado <strong>di</strong> perfezione abbastanza esultante anche se appare incre<strong>di</strong>bile a coloro che<br />
ancora non l‘hanno ottenuta. E infatti comunemente noi troviamo questa prova nelle vite dei<br />
santi, che per natura erano esseri poveri inclini al male come noi.<br />
Anche se siamo mortali fragili, aspiriamo a <strong>di</strong>ventare creature celesti rinunciando alle<br />
cose <strong>di</strong> quaggiú: allora potrà <strong>di</strong>minuire la nostra indegnità <strong>di</strong> invocare l‘unione con Gesú Cristo<br />
e il Padre nostro che è in cielo 702 .<br />
Dai vari altri passaggi nel stesso Cantico dei cantici, che rappresentano l‘anima che<br />
parla con il suo Sposo Celeste, è espresso quanto le è permesso <strong>di</strong> trattare con Lui familiarmente<br />
e amabilmente. Le stesse espressioni <strong>di</strong> tenero affetto e <strong>di</strong> intimità sono piú lucidamente<br />
espresse negli scritti dei santi. Questi uomini e donne avevano un‘esperienza pratica <strong>di</strong> questi<br />
trasporti amorosi, e hanno cercato <strong>di</strong> dare alla Chiesa un‘idea <strong>di</strong> tutto questo; essi ci spingono,<br />
grazie ai colori piú forti dell‘amore dello Sposo Divino, ad infiammare le nostre anime con un<br />
desiderio bruciante per essere uniti a Lui 703 .<br />
In questo passaggio, il santo sente una grande gioia, al pensiero che si compie la volontà<br />
<strong>di</strong> Dio. In fin dei conti questo non <strong>di</strong>pende dall‘azione della volontà dell‘uomo. Questa è la<br />
consolazione suprema dei santi, che la volontà <strong>di</strong> Dio è sempre compiuta, e nessuna volontà<br />
perversa <strong>di</strong> uomini o <strong>di</strong> demoni potrà impe<strong>di</strong>re il suo compimento. Anche se non fosse compiuta<br />
in un altro modo, anche le volontà piú malvagie senza volerlo cooperano a questo compimento<br />
malgrado loro stessi 704 .<br />
Padre Giuseppe è d‘accordo con la Scienza dei santi, lui infatti ha approfon<strong>di</strong>to il Pater<br />
noster con il loro magistero. Oltre <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú, San Giovanni della Croce e <strong>Santa</strong><br />
<strong>Maria</strong> Maddalena de‘ Pazzi, ha citato Bernard <strong>di</strong> Clairvaux, il suo La scala dei reclusi, o<br />
700 GIOVANNI PAOLO II, Novo millenium ineunte, Lettera apostolica, ci invita a contemplare il mistero <strong>di</strong><br />
Cristo attraverso l‘indagine della teologia vissuta del santo, n. 27.<br />
701 G. FRASSINETTI, Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 15-16.<br />
702 Cfr. Ibid., 138.<br />
703 Cfr. Ibid., 188.<br />
704 Cfr. Ibid., 216.<br />
176
Metodo <strong>di</strong> preghiera, Columbine, Pietro <strong>di</strong> Alcantara e la sua Preghiera nell‟implorare l‟amore<br />
<strong>di</strong> Dio, Gertrude, Padre Paolo Segneri, Tommaso d‘Aquino e la sua Summa Theologica,<br />
Agostino e le sue Confessioni, e le figure <strong>di</strong> Paolo <strong>di</strong> Tarso e Giovanni Battista del Nuovo<br />
Testamento. Ha citato anche Padre Michele Go<strong>di</strong>nez dei Gesuiti, ha preso qualche istruzione nel<br />
libro Pratica della teologia mistica. Poi, ha dato lode a San Giovanni della Croce, come uno dei<br />
maestri della Scienza dei santi 705 . Una dei Loci Teologici <strong>di</strong> Frassinetti sono le vite e gli<br />
insegnamenti dei santi, insieme con San Alfonso <strong>Maria</strong> de‘ Liguori, San Francesco <strong>di</strong> Sales,<br />
Sant‘Ignazio <strong>di</strong> Loyola, San Francesco <strong>di</strong> Assisi, <strong>Santa</strong> Caterina da Genova 706 .<br />
B. L’apostolato mistico<br />
Il compito principale <strong>di</strong> Padre Giuseppe fu quello <strong>di</strong> insegnare a pregare ai suoi<br />
parrocchiani, e pertanto nelle spiegazioni del Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa è stato semplice e<br />
piano. Ha pubblicato anche altri libri sulla preghiera, ha formato piccoli gruppi che si possono<br />
definire, con termine moderno, scuole <strong>di</strong> preghiera, riuniti non occasionalmente ma in modo<br />
stabile, ha elaborato poi la dottrina delle Amicizie spirituali, molti santi si sono forgiati a questa<br />
scuola 707 . Educare il popolo <strong>di</strong> Dio alla preghiera lo considerò un suo dovere apostolico. Il<br />
Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina mutuò da <strong>Santa</strong> Teresa uno dei suoi originali insegnamenti cioè le<br />
amicizie spirituali e quin<strong>di</strong> formò gruppi <strong>di</strong> ―amici‖ come è riportato nel Il Libro della vita <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Teresa al capitolo se<strong>di</strong>cesimo. Lo scopo è quello <strong>di</strong> tendere insieme alla santità attraverso<br />
la correzione fraterna, in essa Frassinetti offre un metodo <strong>di</strong> vita per gli associati 708 .<br />
Ecco come lo descrive nell‘operetta de<strong>di</strong>cata alle ragazze che si vogliono consacrare<br />
senza entrare in convento, La monaca in casa, a cui è annessa anche la Regola delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> 709 .<br />
- al mattino e alla sera le preghiere <strong>di</strong> ogni cristiano<br />
- santa Messa quoti<strong>di</strong>ana<br />
- preghiera mentale per un quarto d‘ora<br />
- qualche lettura spirituale<br />
- una breve visita al Santissimo Sacramento<br />
- la <strong>terza</strong> parte del Rosario<br />
- confessione ogni otto giorni.<br />
Ponendo nel titolo ―Apostolato mistico‖ volevamo intendere proprio le amicizie<br />
spirituali. Diceva nella sua pre<strong>di</strong>cazione al popolo <strong>di</strong> Dio che insegnare a pregare è fare<br />
apostolato, ed egli lo fece con gli scritti e con l‘opera pastorale. Il Papa Giovanni Paolo II<br />
afferma che per una pedagogia alla santità è necessario un cristianesimo che si <strong>di</strong>stingua prima<br />
<strong>di</strong> tutto nell‘arte della orazione, che <strong>di</strong>venta parte viva <strong>di</strong> un programma pastorale 710 .<br />
Oggigiorno l‘importanza che la Chiesa attribuisce alla preghiera merita una seria<br />
considerazione; lo ve<strong>di</strong>amo nei documenti della Congregazione della Fede ―Orationis formas‖,<br />
nella quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica e in altre pubblicazioni. Questo è ben<br />
705<br />
San Giovanni della Croce è un esperto della Scienza dei santi; cfr. ibid., 75.<br />
706<br />
Questa lista <strong>di</strong> santi è stata compilata da Giuseppe Frassinetti; cfr. 1 G. FRASSINETTI, Opere Ascetiche,<br />
Introduzione e note <strong>di</strong> Renzi Giordano, I vol., Curia Generalizia dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>,<br />
Roma 1978, preso dalla Presentazione della Teologia spirituale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, 25.66. 2 M. F.<br />
PORCELLA, La consacrazione femminile, opera citata, 92-92. 3 M. E. POSADA, Storia e santità, opera<br />
citata, 86.<br />
707<br />
Cfr. M. F. PORCELLA, L‟amicizia spirituale nella pastorale <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, in Risonanze 72<br />
1998 6, 6-7.<br />
708<br />
Il metodo <strong>di</strong> vita è tipico della dottrina spirituale del Frassinetti; lo si può trovare in La monaca in<br />
casa, Le amicizie spirituali, Il religioso al secolo, Brevi parole ai sacerdoti fratelli.<br />
709<br />
M. E. POSADA, Storia e santità, opera citata, 122.<br />
710<br />
GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte, Lettera Apostolica, n. 30-34.<br />
177
confermato dal Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico 711 e nei documenti del Concilio Vaticano II 712 . Ogni<br />
battezzato è chiamato a essere in unione con Dio per mezzo della preghiera 713 .<br />
Frassinetti era anche un <strong>di</strong>rettore spirituale 714 , coach o allenatore verso la santità. Fu<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale <strong>di</strong> madri e giovani ragazze in Genova e in Mornese. Aveva piccoli gruppi<br />
nella parrocchia sia uomini sia donne consacrati e sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>; per i<br />
sacerdoti c‘era con lui che la animava la Congregazione del Beato Leonardo. Egli ha presentato<br />
a questi <strong>di</strong>versi gruppi <strong>di</strong>fferenti vie per raggiungere la santità, che Padre Giordano Renzi dei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> Postulatore della Causa <strong>di</strong> beatificazione ha enumerato e ha<br />
messo in luce l‘apporto che il Frassinetti ha dato nella presa <strong>di</strong> coscienza della comune santità<br />
nella Chiesa 715 .<br />
1. Desiderio <strong>di</strong> essere santi<br />
2. Purificazione della propria anima<br />
3. Offerta <strong>di</strong> se stessi al Signore<br />
4. Direzione spirituale<br />
5. Preghiera<br />
6. Comunione frequente ed anche quoti<strong>di</strong>ana<br />
7. Devozione alla Madre <strong>di</strong> Dio<br />
8. Esempio <strong>di</strong> Gesú modello e formatore <strong>di</strong> santità<br />
9. Verginità e celibato.<br />
In tali piccoli gruppi, caratterizzati dalle amicizie spirituali, molti hanno avuto<br />
esperienza <strong>di</strong> Dio nella fraternità e nella preghiera 716 . Questo metodo dei piccoli gruppi è attuale<br />
e praticato in alcuni movimenti e comunità.<br />
C. Giuseppe Frassinetti è un teologo spirituale?<br />
Il priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina era tomista in quanto a formazione dogmatica, alfonsiano nella<br />
teologia morale e teresiano per la teologia ascetica e mistica. Padre Giordano Renzi e Suor<br />
711 «Primo e particolare dovere <strong>di</strong> tutti i religiosi deve essere la contemplazione delle verità <strong>di</strong>vine e la<br />
costante unione con Dio nell‘orazione» CIC 663 § 1 Ve<strong>di</strong> anche le Cosituzioni dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, Roma 1989, n. 128.<br />
712 Nel Vaticano II troviamo che le espressioni ―l‟esperienza della <strong>di</strong>vina presenza‖ e ―l‟unione amorosa<br />
dell‟uomo con Dio nella preghiera‖ hanno un particolare senso per ogni persona nella Chiesa; ve<strong>di</strong> anche<br />
LG n. 41, AG n. 18, DV n. 8.<br />
713 Ve<strong>di</strong> questa e simili espressioni nei santi carmelitani: 1 SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico<br />
spirituale, B 16, 11; B 17,4; II, 13, 4; II, 16, 5; Fiamma B, 3, 79. 2 SANTA TERESA DI LISIEUX, Storia <strong>di</strong><br />
un‟anima, cap. XI. 3 ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Lettere, 141, 179, 213.<br />
714 ―Direttore spirituale‖ oppure ―allenatore‖ o anche ―mistagogo‖ sono titoli che si adattano al<br />
Frassinetti; il temine mistagogo, che potrebbe essere il piú azzeccato si trova in Jaun Martin Velasco,<br />
Carlo Laudazi, Silvio José Baez, Luigi Borriello, Jesús Castellano Cervera, Federico Ruiz, Ciro Garcia e<br />
Luis Jorge Gonzalez in Risvegliare l‟esperienza <strong>di</strong> Dio nell‟uomo, LEV, Città del Vaticano 2004.<br />
715 Cfr. G. RENZI, Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche, opera citata, 45-62; M. E. POSADA, Storia<br />
e santità, Estratto da note a pié <strong>di</strong> pagina n. 20, 87.<br />
716 «Il Frassinetti uomo <strong>di</strong> contemplazione e <strong>di</strong> azione, comunicatore attento, dotato <strong>di</strong> grande equilibrio<br />
spirituale, sollecito nel raggiungere e valorizzare la vocazione <strong>di</strong> ognuno, sa farsi allenatore <strong>di</strong> una santità<br />
personalizzata senza tralasciare <strong>di</strong> animare al gioco <strong>di</strong> squadra e <strong>di</strong> favorire le amicizie spirituali in<br />
piccoli gruppi. Quell‘arte l‘aveva appresa in famiglia, poi come <strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> Sant‘Antonio <strong>Maria</strong> Gianelli<br />
e quin<strong>di</strong> dall‘amicizia operosa con Tommaso Reggio, Salvatore Magnasco, Luigi Sturla, Giovan Battista<br />
Cattaneo, alla Beato Leonardo ed ancora dai maestri ai quali si ispirava attingeva come Sant‘Alfonso<br />
<strong>Maria</strong> de‘ Liguori, <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila, San Francesco <strong>di</strong> Sales, <strong>Santa</strong> Caterina da Genova, San<br />
Giovanni della Croce. Sebbene fosse un uomo umile e schivo, la sua voce e i suoi scritti risuonavano e<br />
attraevano. Ecco alcuni <strong>di</strong>scepoli tutti santi e beati: la sorella Paola, <strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello, Clelia<br />
Barbieri, Rosa Gattorno, Giacinto Bianchi, Eugenia Ravasco, Agostino Ruscelli e altri ancora». D.<br />
BRUZZONE-M. F. PORCELLA, a cura <strong>di</strong> in La formazione alla santità nella Chiesa genovese<br />
dell‟Ottocento. Il contributo <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, LAS, Roma 2004. Citazione dalla Presentazione del<br />
Superiore Generale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> P. Luigi Fain Binda, 9.<br />
178
<strong>Maria</strong> Ester Posada hanno elaborato l‘analisi della spiritualità frassinettiana e la risposta alla<br />
domanda se Frassinetti è un teologo spirituale.<br />
Da un punto <strong>di</strong> vista storico il 19.mo secolo fu il periodo della teologia ascetica e non è<br />
<strong>di</strong>fficile rintracciare i segni del <strong>di</strong>vorzio tra ascetismo e misticismo: la teologia spirituale ebbe<br />
una ripresa piuttosto ritardata. C‘è da aggiungere che Padre Giuseppe non aveva intenzione <strong>di</strong><br />
scrivere un trattato sulla perfezione cristiana. Secondo il Renzi e Posada, Frassinetti è privo <strong>di</strong><br />
un corpo <strong>di</strong> dottrina ascetico-mistica metodologico e sistematico. Non<strong>di</strong>meno egli ha trattato<br />
molti punti della teologia cristiana, come la <strong>di</strong>rezione spirituale, la pastorale della spiritualità, il<br />
metodo della preghiera e della perfezione cristiana 717 . Ha scritti opere e libretti <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione<br />
riguardanti il campo della teologia mistica, come Il Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa, Il Convito del<br />
<strong>di</strong>vino Amore, Osculetur me osculo oris tui, Pactum Pacis e molti altri.<br />
La teologia spirituale era formalmente chiamata ―Teologia ascetica e mistica‖ e nelle<br />
scuole <strong>di</strong> teologia rappresentava un argomento accessorio. Solo recentemente dopo il Vaticano<br />
II si è coniato il termine ―Teologia spirituale‖.<br />
Si crede opportuno <strong>di</strong> dare un fugace sguardo d‘insieme alla storia della teologia<br />
spirituale. Dal I all‘XI secolo la spiritualità formava un unico soggetto con la teologia in genere:<br />
con l‘esegesi, la pastorale e la teologia. Nel XII e XIII secolo accanto alla teologia scolastica<br />
nelle <strong>università</strong>, vi era una teologia biblica e <strong>di</strong> riflessione teologica esperienziale nei monasteri<br />
e comunemente era chiamata ―Teologia monastica‖. Nei secoli XIV e XV è presente la Devotio<br />
moderna, una reazione alla teologia scolastica, fondata soprattutto su una forma affettiva e<br />
devozionale nella relazione con il mistero <strong>di</strong>vino. Qui iniziò il <strong>di</strong>vorzio tra teologia e<br />
spiritualità. 718 . Nel secolo XVI e XVII i mistici e i maestri <strong>di</strong> vita spirituale spagnola profusero<br />
una abbondante conoscenza esperienziale e dottrinale <strong>di</strong> spiritualità per acquisire una ulteriore<br />
riflessione teologica sulla spiritualità. A questa è da aggiungere anche la spiritualità renana,<br />
fiamminga e la scuola francese. Nei secoli XVII e XVIII apparvero corsi e trattati e manuali <strong>di</strong><br />
teologia ascetica e mistica. Essi strutturarono le linee generali della teologia ascetica e<br />
mistica 719 . Ed infine nel secolo XX la spiritualità viene definita nel suo oggetto, fonti,<br />
metodologia e applicazioni 720 . Si hanno gli statuti in cui si inserisce la spiritualità negli <strong>stu<strong>di</strong></strong><br />
accademici e si creano cattedre <strong>di</strong> specializzazione <strong>di</strong> teologia spirituale 721 . Vi sono nuovi<br />
manuali <strong>di</strong> spiritualità e nuovi Istituti. La Congregazione per l‟Educazione cattolica nel 1979<br />
riafferma l‘importanza della teologia spirituale nei corsi istituzionali, nella licenza e nelle<br />
ulteriori specializzazioni.<br />
Padre Giuseppe era un pastore ed invitava ogni persona a vivere una vita santa. Era un<br />
seguace <strong>di</strong> San Francesco <strong>di</strong> Sales, ha ripetuto senza stancarsi che «ognuno è chiamato ad essere<br />
santo» (1 Pt 1,15-16, Lv 19,2). Nel Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa ha sottolineato che <strong>Maria</strong><br />
Maddalena e Paolo l‘apostolo dei gentili erano peccatori e furono chiamati a giungere alla<br />
santità cristiana 722 .<br />
717 «Per quanto riguarda la denominazione del Priore come teologo spirituale penso che convenga fare<br />
una <strong>di</strong>stinzione. Se per teologo spirituale si intende colui che in forma non solo meto<strong>di</strong>ca ma sistematica<br />
elabora e propone un corpus doctrinale, il Frassinetti non può essere detto teologo della scienza spirituale.<br />
Se invece è teologo spirituale colui che in modo non solo vitale ma teorico e meto<strong>di</strong>co, sebbene non<br />
sistematico, affronta temi <strong>di</strong> vita cristiana fondati su una solida e vasta dottrina, Giuseppe Frassinetti è<br />
teologo spirituale in senso vero e proprio. Egli non elaborò un corpus teologico spirituale non solo perché<br />
gli mancarono l‘intenzionalità e la sistematicità ma anche –a mio avviso- perché il momento teologico in<br />
cui visse non favorí l‘elaborazione <strong>di</strong> una sintesi teologico-spirituale non solo sistematica ma integrale».<br />
M. E. POSADA, Storia e santità. Opera citata, 85.<br />
718 H. U. VON BALTHASAR, Teologia e santità, opera citata, 200-212.<br />
719 Ve<strong>di</strong> il libri <strong>di</strong> Storia della Spiritualità: L. BOUYER – L. DATTRINO, La spiritualità dei Padri, in Storia<br />
della Spiritualità, Vol. 3/A, Bologna 1983; E. ANCILLI, Spriritualità me<strong>di</strong>oevale, Ed. Teresianum, Roma<br />
1983; C. BROVETTO – I. MEZZARO – F. FERRARIO – P. RICCA, La Spiritualità cristiana nell‟era moderna,<br />
vol. 5, Borla, Roma 1987.<br />
720 V. CODINA, De la ascetica y mistica a la vida según el Espiritu, in AA.VV. El Vaticano II veinte años<br />
después, Cristinidad, Madrid 1985, 271-291.<br />
721 SC, n. 16; OT, n. 16.<br />
722 G. FRASSINETTI, Saint Teresa‟s Pater noster…opera citata, 41.<br />
179
CONCLUSIONE<br />
La santità è la vocazione <strong>di</strong> ogni cristiano. «A immagine del Santo che vi ha chiamati,<br />
<strong>di</strong>ventate santi anche voi in tutta la vostra condotta; poiché sta scritto: Voi sarete santi perché io<br />
sono santo» (1 Pt 1,15-16). La chiamata universale alla santità in<strong>di</strong>ca una vita in comunione con<br />
la Santissima Trinità. Per questo, la preghiera è uno dei mezzi per conformarsi alla vita cristiana<br />
e questo è compito <strong>di</strong> ogni cristiano nella Chiesa. Pregare non è una teoria <strong>di</strong> carattere<br />
speculativo, <strong>stu<strong>di</strong></strong>ata nelle <strong>università</strong> pontificie, ma una situazione esperienzale che può essere<br />
considerato ―azione cristiana‖.<br />
Karl Ranher ―profetizzò‖ che nel futuro o il cristiano è un mistico o semplicemente non<br />
è nulla. Oggi tantissimi cristiani vanno in Chiesa per obbligo, senza mettere alcunché <strong>di</strong> proprio<br />
nella preghiera, nella me<strong>di</strong>tazione.<br />
I cristiani sono invitati a testimoniare l‘amore del Signore risorto, nei sacramenti,<br />
nell‘ascolto della Parola <strong>di</strong> Dio e nella preghiera personale. La Beata Vergine <strong>Maria</strong> è il modello<br />
perfetto dell‘ascoltatore della Parola <strong>di</strong> Dio, come lo testimoniò nella visita alla cugina<br />
Elisabetta. Pertanto la preghiera è un parlare con Dio e questo richiede capacità <strong>di</strong> ascolto come<br />
ha scritto il Sommo Pontefice Benedetto XVI nella sua prima enciclica Deus caritas est:<br />
«Amore <strong>di</strong> Dio e amore del prossimo sono inseparabili, sono un unico comandamento. Entrambi<br />
però vivono dell'amore preveniente <strong>di</strong> Dio che ci ha amati per primo. Cosí non si tratta piú <strong>di</strong> un<br />
―comandamento‖ dall'esterno che ci impone l'impossibile, bensí <strong>di</strong> un'esperienza dell'amore<br />
donata dall'interno, un amore che, per sua natura, deve essere ulteriormente partecipato ad altri»<br />
(n. 18). È per mezzo della relazione dell‘uomo con il mistero <strong>di</strong> Dio che il suo amore <strong>di</strong>venta<br />
nostro e ognuno è chiamato a coltivarlo. Il cristiano deve guardare a <strong>Maria</strong> e ai santi, come<br />
<strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila e San Giovanni della Croce e anche come Giuseppe Frassinetti, nel loro<br />
instancabile zelo nell‘insegnare all‘uomo la via della santità, che è una esperienza <strong>di</strong> preghiera<br />
profonda.<br />
Giuseppe Frassinetti, <strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila, ha presentato la preghiera<br />
come conversazione con Dio. È una elevazione amorosa della propria mente a Dio, una<br />
incessante melo<strong>di</strong>a che eleva il cuore e si ferma davanti al trono <strong>di</strong> Dio. Ed inoltre la descrizione<br />
ha un taglio cristologico e trinitario, un intimo <strong>di</strong>alogo con Gesú, il <strong>Figli</strong>o del Padre attraverso la<br />
forza dello Spirito Santo. Infatti nel Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa Frassinetti afferma che la<br />
sostanza <strong>di</strong> una simile preghiera è l‘incontro <strong>di</strong> due volontà quella dell‘uomo e quella <strong>di</strong> Dio.<br />
Chi si avventura in questa via maestra, incontrerà molte <strong>di</strong>fficoltà, ma esse sono ben<br />
ripagate da una incalcolabile ricompensa. Frassinetti aggiunge che nessuno si deve sgomentare<br />
o perdere coraggio nella vita <strong>di</strong> preghiera. Sempre deve riprovare, anche se avanza <strong>di</strong> un solo<br />
passo, la buona volontà è gra<strong>di</strong>ta a Dio, anzi Dio stesso dona a lui la grazia per poter avanzare.<br />
In questa opera l‘autore ha trattato un importante tema <strong>di</strong> Teologia Spirituale quale è la<br />
preghiera. Si può dunque affermare che Frassinetti è un propagatore e un apostolo della<br />
preghiera.<br />
A questo punto il ricercatore crede <strong>di</strong> aver compiuto lo scopo e il progetto del suo<br />
elaborato.<br />
Possa questo lavoro per coloro che si inoltrano nella conoscenza <strong>di</strong> questa materia avere<br />
una influenza positiva nell‘approfon<strong>di</strong>mento ulteriore del rapporto <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa e del Padre<br />
Frassinetti, e coglieri gli influssi del magistero <strong>di</strong> Sant‘Alfonso de‘ Liguori e San Francesco <strong>di</strong><br />
Sales, anche essi teresiani, a cui Frassinetti si ispirava.<br />
Il messaggio <strong>di</strong> Frassinetti è il seguente: ogni cristiano è chiamato alla santità, e quin<strong>di</strong><br />
ogni cristiano è chiamato alla preghiera; e ciò non è solo per alcuni eletti ma per tutti.<br />
È questa una tesi sostenuta e con<strong>di</strong>visa da Sua Santità Paolo VI, Giovanni Paolo II e dai<br />
professori del Teresianum.<br />
180
BIBLIOGRAFIA<br />
Tutte le citazioni bibliche <strong>di</strong> questo lavoro sono state desunte dalla Nuova Bibbia <strong>di</strong><br />
Gerusalemme, E<strong>di</strong>zione tipica, Darton Longman and Todd Ltd and Doubleday and Company,<br />
Inc., 1985.<br />
A. FONTI PRINCIPALI<br />
1. Documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II<br />
Sacrosanctum Concilium, Costituzione sulla Sacra Liturgia, 4 <strong>di</strong>cembre 1963.<br />
Lumen Gentium, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, 21 novembre 1964.<br />
Optatam Totius, Decreto sulla Formazione Sacerdotale, ottobre 1965.<br />
Dei Verbum, Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione, 18 novembre 1965.<br />
Gau<strong>di</strong>um et Spes, Costituzione pastorale sulla Chiesa e il mondo moderno, 7<br />
<strong>di</strong>cembre 1965<br />
Presbiterorum Or<strong>di</strong>nis, Decreto sul Ministero e la vita sacerdotale, 17(?) <strong>di</strong>cembre 1965.<br />
2. Altri documenti del Magistero<br />
BENEDICTUS XVI, Lettera Enciclica, Deus caritas est, LEV, (25 Dicembre 2005) Città del<br />
Vaticano 2006.<br />
Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Diritto Canonico.<br />
CATHOLIC BISHOP‘S CONFERENCE OF THE PHWIPPINES, Catechism of the Catholic Church,<br />
Word and Life Publications, Manila 1997.<br />
CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, IANUEN, Canonizationis servi Dei Josephi<br />
Frassinetti, Prioris Paroeciae S. Sabinae Ianuae, Fundatoris Congregationis Filiorum S.<br />
<strong>Maria</strong>e Immaculatae (1804-1868). Positio super viriutibus. Informatio, Romae 1981.<br />
CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, IANUEN, Canonizationis servi Dei Pauli Josephi<br />
<strong>Maria</strong>e Frassinetti, sacerdotis saecularis Parochi-Prioris Paroeciae S. Sabinae, Fundatoris<br />
Congregationis Filiorum S. <strong>Maria</strong>e Immaculatae (1804-1868). Relatio et Vota. Congressus<br />
peculiaris super virtutibus. Die 13 novembre An 1990 habiti, Tip. Guerra 1990 —Decretum<br />
(circa l‘eroicità delle virtú), Roma 1991.<br />
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ―Orationis formas‖ ai Vescovi della<br />
Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della me<strong>di</strong>tazione cristiana, (15 ottobre 1989), LEV, Città del<br />
Vaticano 1991.<br />
DENZINGER H., Enchiri<strong>di</strong>on Symbolorum, (a cura <strong>di</strong>) HÜNERMANN P., 37.a e<strong>di</strong>zione, EDB,<br />
Bologna 2001.<br />
GIOVANNI PAOLO II, Sanctiminialibus Carmelitis Discalceatis, IV expleto saeculo ab obitu<br />
Sanctae Theresiae a Iesu, AAS 74 (1982), 836-841.<br />
GIOVANNI PAOLO II, ―Novo millennio ineunte‖, Lettera Apostolica, Libreria E<strong>di</strong>trice Vaticana,<br />
Città del Vaticano 2000.<br />
181
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, Christifideles laici, (30 <strong>di</strong>cembre 1988), EDB,<br />
Bologna 1989.<br />
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, Pastores dabo vobis, (25 marzo 1992),<br />
ELLEDICI, Leumann (To) 1993.<br />
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica, Vita consecrata, (12 marzo 1996), L‘Osservatore<br />
Romano, Città del Vaticano 1996.<br />
GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica, Ecclesia de Eucaristia, (17 aprile 2003), ELLEDICI,<br />
Leumann (To) 2003.<br />
PAOLO VI, ―Homilia in basilica Vaticana habita postquam Summus Pontifex sanctam Teresiam<br />
de Avila, virginem, ecclesiae universalis Doctorem declaravit (<strong>di</strong>e 27 Septetnbris 1970)‖, AAS<br />
62 (1970), 590-596.<br />
3. Dizionari ed Enciclope<strong>di</strong>e<br />
ALVAREZ I., Amistad, in Diccionario de santa Teresa de Jesús, Monte Carmelo, Burgos, 2001,<br />
43-45.<br />
MUZZI L., Frassinetti Giuseppe, in AA.VV., Dictionaire de Spiritualite, Ascetiche et mystique,<br />
Dottrine et histoire, T V, Beauchesne, Paris 1964, 1138-1941.<br />
RAVASI G., Cantico dei Cantici, in ROSSANO P. - RAVASI G. - GHIRLANDA A. (a cura <strong>di</strong>), Nuovo<br />
Dizionario <strong>di</strong> Teologia Biblica, Ed. Paoiine, Milano 1988, 237-244.<br />
SACCO E. — REPETTO F., Frassinetti Giuseppe, in PELLICIA G. - ROCCA G. (a cura dí),<br />
Dizionario <strong>degli</strong> Istituti <strong>di</strong> Perfezione, vol IV, Ed. Paoline, Roma 1977, 586-587.<br />
VERBRUGGHE A., <strong>Maria</strong> Maddalena de‟ Pazzi (santa), in BORRIELLO L. - CARUANA E. - DEL<br />
GENIO M. R. - SUFFI N. (a cura <strong>di</strong>), Dizionario <strong>di</strong> Mistica, LEV, Città del Vaticano 1998, 788-<br />
790.<br />
WIILLKE J. C., Frassinetti Joseph, in New Catholic Encyclope<strong>di</strong>a. Vol. VI, washington e<strong>di</strong>tion,<br />
The Catholic University of America 1967, 81.<br />
4. Scritti <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti<br />
FRASSINETTI GIUSEPPE, Opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te, 13 Vol., Poliglotta Vaticana, Roma 1906-1913.<br />
FRASSINETTI GIUSEPPE, Opere Ascetiche. Introduzione e note <strong>di</strong> RENZI G., 2 vol., Curia<br />
Generale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Roma 1978.<br />
in particolare:<br />
1) FRASSINETTI GIUSEPPE, Il Pater noster <strong>di</strong> S. Teresa <strong>di</strong> Gesú, trattato della preghiera,<br />
Tip. Fiaccadori 1860.<br />
2) ID., Saint Teresa‟s Pater noster. A treatise on prayer, translated from the Italian by<br />
William Hutch, DD., Ninth e<strong>di</strong>tion, Bums Oathes and Washbourne 1887.<br />
3) ID., El Pater noster de santa Teresa de Jesús, tratado de la oraciòn, traducido al<br />
castellano por un padre de la Compania de Jesús, 2 ed., Nueva libr. de San José, 1888.<br />
- Le amicizie spirituali, imitazioni <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú e stimolo allo zelo per la salute<br />
182
delle anime <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Maddalena de„ Pazzi, Tip. Ligustico, Genova 1853.<br />
- Il Convito del <strong>di</strong>vino Amore, Tip. Gioventú, Genova 1867.<br />
- Alcuni effetti che fa nell„anima l‟amor Divino (Ricavati dall‘opusculo <strong>di</strong> S. Giovanni della<br />
Croce ―Fiamma <strong>di</strong> amor vivo‖), Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1912 [ed. postuma].-<br />
- Osculetur me osculi oris sui (Cant. 1,1) Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1912 [ed. postuma].<br />
- Pactum pacis, Poliglotta Vaticana, Roma 1912 [ed. postuma].<br />
- La <strong>di</strong>vozione illuminata: Manuale <strong>di</strong> preghiere, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1913.<br />
in generale:<br />
ID., Congregazione <strong>di</strong> ecclesiastici sotto la protezione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. , dei ss. Apostoli e del B.<br />
Leonardo da Porto Maurizio, Tip. Ferrando, Genova 1835.<br />
ID., Riflessioni proposte agli ecclesiastici, Tip. Ferrando, Genova 1837.<br />
ID., La santa verginità [La gemma delle fanciulle cristiane, ossia la santa verginità], Tip.<br />
Ferrando, Genova 1841.<br />
ID., La forza <strong>di</strong> un libretto, <strong>di</strong>aloghetti [La forza <strong>di</strong> un libretto. Dialoghi tra due amiche sopra<br />
l‟operetta La gemma delle fanciulle cristiane ossia la santa verginità, Tip. Ferrando, Genova<br />
1841.<br />
ID., Compen<strong>di</strong>o della Teologia Dogmatica [catechismo dogmatico], Tip. Ferrando, Genova<br />
1842.<br />
ID., Due parole all‟orecchio delle gentili signore. Tip. Ferrando, Genova 1842.<br />
ID., Il conforto dell„anima <strong>di</strong>vota, con un„appen<strong>di</strong>ce sul santo timor <strong>di</strong> Dio, Tip. Bettolo,<br />
Genova 1844.<br />
ID., Pia Unione delle amanti della santa modestia sotto l„invocazione della Purità, Genova<br />
1846.<br />
ID., Avviamento dei giovanetti alla <strong>di</strong>vozione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima, Tip. Monal<strong>di</strong>, Roma 1846.<br />
ID., Saggio intorno alla <strong>di</strong>alettica ed alla religione <strong>di</strong> Vincenzo Gioberti, Tip. Faziola, Genova<br />
1846.<br />
ID., <strong>Santa</strong> Sabina Martire, Tip. Ponthenier, Genova 1846.<br />
ID., Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú e compen<strong>di</strong>o della dottrina spirituale<br />
del B. Giovanni Colombini, Tip. Ligustico, Genova 1851.<br />
ID., Ricor<strong>di</strong> per un giovinetto cristiano, Tip. Ligustico, Genova 1851.<br />
ID., Gesú Cristo, regola dal Sacerdote, coll‟aggiunta <strong>di</strong> alcune regole <strong>di</strong> vita e quoti<strong>di</strong>ani<br />
esercizi del Beato Gregorio Barbarigo Vescovo <strong>di</strong> Padova e Car<strong>di</strong>nale, Tip. Cecchi, Firenze<br />
1852.<br />
ID., Regolamento per la Conferenza dei promotori della Pia Associazione per la conservazione<br />
ed incremento della fede cattolica, Tip. Ligustico, Genova 1853.<br />
ID., Pia Unione delle anime che desiderano farsi sante, Tip. Ligustico, Genova 1854.<br />
ID., Regola <strong>di</strong> vita per le <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ascritte alla Pia Unione <strong>di</strong>..., Tip. Ligustico, Genova<br />
1854.<br />
183
ID., L‟ossequio piú gra<strong>di</strong>to a <strong>Maria</strong> Santissima <strong>Immacolata</strong>, Tip. Ligustico, Genova 1855.<br />
ID., Pia Unione dell‟<strong>Immacolata</strong>, Tip. Ligustico, Genova 1855.<br />
ID., Parole <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima ai suoi <strong>di</strong>voti , Tip. Fassi-Como, Genova 1855.<br />
ID., Regolamento della Pia Associazione delle Signore per la conservazione ed incremento della<br />
Fede Cattolica in Genova, coll'aggiunta della Pia Associazione da promuoversi nelle<br />
parrocchie dell'Archi<strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> Genova ad onore <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. per lo stesso scopo, Tip. Fassi-<br />
Como, Genova 1856.<br />
ID., Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Tip. Fassi-Como, Genova 1856.<br />
ID., Ora <strong>di</strong> santa allegrezza, ossia <strong>di</strong> <strong>di</strong>vozione <strong>di</strong> cento allegrezze in onore della B. Vergine<br />
<strong>Maria</strong>, ed orazioni <strong>di</strong>verse, Tip. Ligustico, Genova 1856.<br />
ID., Regolamento per una conferenza <strong>di</strong> ecclesiastici collaboratori della Pia Opera <strong>di</strong> S.<br />
Raffaele e <strong>di</strong> S. Dorotea, Tip. Tasso, Oneglia 1857.<br />
ID., Le do<strong>di</strong>ci stelle, ossia le virtú della B. V. <strong>Maria</strong>, coll„aggiunta della coroncina<br />
dell'<strong>Immacolata</strong> e <strong>di</strong> una <strong>di</strong>vota corona a <strong>Maria</strong> ss. , Tip. Fassi-Como, Genova 1857.<br />
ID., Regolamento per l‟accademia del B. Leonardo, Tip. Tasso, Oneglia 1857.<br />
ID., Memorie intorno alla Congregazione del Beato Leonardo da Porto Maurizio, Tip. Tasso,<br />
Oneglia 1857.<br />
ID., Esercizi spirituali per i giovinetti d„ambo i sessi, Tip. Gioventú, Genova 1858.<br />
ID., Memorie sulla vita della pia zitella Rosa Cordone, morta in Genova ai 26 Novembre<br />
1858 [La Rosa senza spine, memorie sulla vita della pia zitella Rosa Cordone, morta in<br />
Genova ai 26 Novembre 1858, Tip. Paravia, Torino 1859.<br />
ID., La Via Matris, ricavata dalle riflessioni <strong>di</strong> S. Alfonso M. De‟ Liguorí sopra ciascuno dei<br />
sette dolori <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima me<strong>di</strong>tati in forma della Via Crucis, Tip. Fassi-Como, Genova<br />
1859.<br />
ID., La monaca in casa, con due appen<strong>di</strong>ci. 1. Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, 2. Le amicizie spirituali, imitazione <strong>di</strong> S. Teresa, Tip. Tasso, Oneglia 1859.<br />
ID., Industrie spirituali secondo il bisogno dei tempi, Tip. Paravia, Torino 1859.<br />
ID., Il modello della povera fanciulla Rosina Pedemonte, morta in Genova in età <strong>di</strong> 20 anni il <strong>di</strong><br />
30 Gennaio del 1860 [Memorie della vita della povera fanciulla Rosina Pedemonte della Pia<br />
Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> santa <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>], Tip. Paravia, Torino 1860.<br />
ID., Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. sotto il titolo della Purità, Tip. Caorsi, Genova 1860.<br />
ID., Novena in preparazione alla festa della Purità <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima, Tip. Fassi-Como,<br />
Genova 1961.<br />
ID., Proposta agli ecclesiastici, Tip. Letture Cattoliche, Pisa 1861.<br />
ID., Pia Unione delle vedove cristiane, Tip. Caorsi, Genova 1861.<br />
ID., Lettera sul celibato. De<strong>di</strong>cata a chiunque sia in posizione <strong>di</strong> poterlo promuovere nella<br />
cristiana società, Tip. Ghilini, Oneglia 1861.<br />
ID., Il Para<strong>di</strong>so in terra nel celibato cristiano, Tip. Paravia, Torino 1861.<br />
ID., L‟arte <strong>di</strong> farsi santi, Genova 1861.<br />
184
ID., Regola della Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ss. <strong>Immacolata</strong> sotto la protezione <strong>di</strong> S.<br />
Giovanni Evangelista e <strong>di</strong> S. Carlo Borromeo, Tip. Ghilini, Oneglia 1861.<br />
ID., Vita e Istituto <strong>di</strong> S. Angela Merici, Tip. Gioventú, Genova 1862.<br />
ID., Colloqui per la novena <strong>di</strong> S. Angela Merici, con orazione per la scelta dello stato, Tip.<br />
Gioventú, Genova 1862.<br />
ID., Laude a S. Ange/a Merici con orazione a S. Angela Merici per la scelta dello stato, Tip.<br />
Gioventú [s.d.], Genova.<br />
ID., Mazzolino <strong>di</strong> fiori pel mese <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, Tip. Arcivescovile, Milano 1862.<br />
ID., La missione delle fanciulle cristiane, racconti contemporanei, Tip. Ghilini, Oneglia 1863.<br />
ID., Manuale pratico del parroco novello, operetta utile anche agli altri ecclesiastici,<br />
specialmente confessori e pre<strong>di</strong>catori, Tip. Miglio, Novara 1863.<br />
ID., Regola della Pia Unione delle Nuove Orsoline, <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, sotto<br />
protezione <strong>di</strong> S. Orsola e <strong>di</strong> S. Angela Merici, Tip. Gioventú, Genova 1863.<br />
ID., Il religioso al secolo e Regola della Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Tip. della<br />
Gioventú, Genova 1864.<br />
ID., Proposta agli amanti <strong>di</strong> Gesú [Due gioie nascoste. Proposta agli amanti <strong>di</strong> Gesú], Tip.<br />
della Gioventú, Genova 1864.<br />
ID., Il giar<strong>di</strong>netto <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, Tip. Fassi-Como, Genova 1864.<br />
ID., Amiamo Gesú!, Tip. della Gioventú, Genova 1864.<br />
ID., Amiamo <strong>Maria</strong>!, Tip. della Gioventú, Genova 1864.<br />
ID., Amiamo Giuseppe!, Roma 1865.<br />
ID., Brevi parole ai sacerdoti fratelli, Tip. della Gioventú, Genova 1865.<br />
ID., Compen<strong>di</strong>o della Teologia Morale <strong>di</strong> S. Alfonso <strong>Maria</strong> de‟ Liguori, con apposite note e<br />
<strong>di</strong>ssertazioni, 2 volI., Tip. della Gioventú, Genova 1865-1866.<br />
ID., Frutti del mese <strong>Maria</strong>no, Tip. della Gioventú, Genova 1866.<br />
ID., La <strong>di</strong>vozione illuminata, Manuale <strong>di</strong> preghiere, Tip. della Gioventú, Genova 1867.<br />
ID., Il Convito del <strong>di</strong>vino Amore, Tip. della Gioventú, Genova 1867.<br />
ID., Catechismo al popolo sopra il Simbolo Apostolico e Istruzioni sulla sacramentale<br />
catechistica, Tip. della Gioventú, Genova 1870. [ed. postuma].<br />
ID., Memorie intorno alla vita del sac. Luigi Sturla, Tip. della Gioventú, Genova 1871. [ed.<br />
postuma].<br />
ID., Vita <strong>di</strong> S. Giuseppe sposo <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Vergine, Tip. della Gioventú, Genova 1871 [ed.<br />
postuma].<br />
ID., Spiegazione del Vangelo al popolo, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1906 e 1908, 2 voll. [ed.<br />
postuma].<br />
ID., Novene e <strong>di</strong>scorsi per le principali solennità, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1910 [ed.<br />
postuma].<br />
ID., Discorsi e novene per la festa <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima e dei Santi, Tip. Poliglotta Vaticana,<br />
Roma 1911 [ed. postuma].<br />
185
ID., Opere Pre<strong>di</strong>cabili, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1912 [ed. postuma].<br />
ID., Pie considerazioni e canzoncine spirituali ad uso delle religiose, Tip. Poliglotta Vaticana,<br />
Roma 1912 [ed. postuma].<br />
ID., Offerta <strong>di</strong> noi a Dio, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1912 [ed. postuma].<br />
Documenti e pubblicazioni su Giuseppe Frassinetti<br />
AA, VV., La formazione alla santità nella Chiesa genovese dell„Ottocento. Il contributo <strong>di</strong><br />
Giuseppe Frassinetti, D. BRUZZONE - M.F. PORCELLA (a cura <strong>di</strong>), LAS, Roma, 2004.<br />
FASSIOLO D., Memorie storiche intorno alla vita del sac. Giuseppe Frassinetti, Priore a S.<br />
Sabina in Genova, Tip. della Gioventú, Genova 1879.<br />
CACCIOTTI V., Due brevi saggi frassinettiani, Centro Vocazionale Giuseppe Frassinetti, Roma<br />
1968.<br />
DE ANGELIS A., The Venerable Joseph Frassinetti, Founder of the Sons of Holy Mary<br />
Immaculate, Quality Catholic Pubblications, Manila 1997.<br />
DE ANGELIS A., The Prior Joseph Frassinetti and the Spirituality of Genoa in the 19 th Century,<br />
Don Bosco Press, Makati City 2000.<br />
DE ANGELIS S., Il Frassinetti e il problema delle vocazioni ecclesiastiche, Tesi <strong>di</strong> Licenza<br />
presso la Pontificia Facoltà Teologica Urbaniana <strong>di</strong> Roma 1974-1975.<br />
DA VOLTRI T., Un prete rinnovatore. Ritratto <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, Opera ss. Vergine<br />
Pompei, Genova 1968.<br />
FALASCA M. P., Vita del Venerabile Giuseppe Frassinetti, Cantagalli, Siena 2004.<br />
FALASCA M. P., Storia <strong>di</strong> un parroco il Ven. Giuseppe Frassinetti, Fondatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong><br />
<strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Cantagalli, Siena 2006.<br />
FALDI E. F., Il Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina. Il Servo <strong>di</strong> Dio Don Giuseppe Frassinetti, Scuola<br />
Tipografica Don Bosco, Genova 1964.<br />
LUXARDO F., Giuseppe Frassinetti, pastore d„anime, autore <strong>di</strong> religiose istituzioni, scrittore <strong>di</strong><br />
opere sacre, in AA. VV., Saggio <strong>di</strong> Storia Ecclesiastica Ligure ossia Vite <strong>di</strong> alcuni Santi e <strong>di</strong><br />
altri uomini illustri, IV, Tip. Cristoforo Colombo, Genova 1884.<br />
MONJE E. A., L‟amore alla croce in Giuseppe Frassinetti, Tesina <strong>di</strong> Licenza in Teologia con<br />
specializzazione in Spiritualità in Teresianum, Roma 2001-2002.<br />
OLIVARI C., Il Servo <strong>di</strong> Dio Sacerdote Giuseppe Frassinetti, Tipografia Poliglotta Vaticana,<br />
Roma 1928.<br />
P. ERMANNO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO OCD., L‟unione con Dio secondo S. <strong>Maria</strong><br />
Maddalena de‟ Pazzi, Carmelitani, Roma 1957.<br />
P. GABRIELE DI S. MARIA MADDALENA, <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú, maestra <strong>di</strong> vita spirituale,<br />
Milano 1958.<br />
PORCELLA M. F., La Consacrazione Femminile. Pensieri e prassi in Giuseppe Frassinetti, LAS,<br />
Roma 1999.<br />
POSADA M. E., Storia e Santità. Influsso del Teologo Giuseppe Frassinetti sulla Spiritualità <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello, LAS, Roma 1992.<br />
186
PUDDU F., La Congregazione del Beato Leonardo a Genova nel quadro dell„antigesuitismo<br />
giobertiano (1831-1848), Tesi per la laurea in Lettere presso la Terza Università <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
Roma 1994.<br />
QUADRACCIA M., Fautore <strong>di</strong> Santi. Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, E<strong>di</strong>zione Risonanze,<br />
Roma 2004.<br />
SIRI G , Priore Giuseppe Frassinetti, Tipografia Don Guanella, Roma 1968.<br />
TABAL D., Spiritual Direction for Young Christians accor<strong>di</strong>ng to the spiriluality of Ven. Joseph<br />
Frassinetti, Tesi <strong>di</strong> licenza in teologia con specializzazione in Spiritualità presso l'Istituto<br />
Teologico Teresianum, Roma 2005-2006.<br />
VACCARI G., San Giovanni Bosco e il Priore Giuseppe Frassinetti, Porto Romano, [s.e] 1954.<br />
VAILATI V., Un maestro <strong>di</strong> vita sacerdotale. Il Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, Postulazione<br />
Generale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, Roma 1977.<br />
VRANCKEN S., Il Tempo della Scelta, <strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello sulle vie dell‟educazione,<br />
LAS, Roma 2000.<br />
B. Fonti secondarie<br />
AA. VV., Il mistero della preghiera cristiana, Teresianum, Roma 1960.<br />
AA. VV., Teresa de Jesús, E<strong>stu<strong>di</strong></strong>os Historico-Literarios; Stu<strong>di</strong> Storico-Letterari, Teresianum,<br />
Roma 1982.<br />
AA. VV., Teresa <strong>di</strong> Gesú Maestra <strong>di</strong> Santità (nel IV centenario della morte 1880), E<strong>di</strong>zione del<br />
Teresianum, Roma 1982.<br />
AA. VV., PONTIFICIO ISTITUTO LITURGICO SANT‘ANSELMO, Scientia Liturgica, Manuale <strong>di</strong><br />
Liturgia II, Liturgia Fondamentale, E<strong>di</strong>zioni Piemme, Casale Monferrato (AL) 1998.<br />
AA. VV., La teologia spirituale. Atti del Congresso Internazionale OCD, Roma 2001.<br />
AA. VV., Mistica e mistica carmelitana, Città del Vaticano 2002.<br />
AA. VV., Risvegliare l‟esperienza <strong>di</strong> Dio nell‟uomo, Libreria E<strong>di</strong>trice Vaticana, Città del<br />
Vaticano 2004<br />
ALVAREZ T., Gli occhi fissi su Cristo. L‟orazione <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‟Avila. E<strong>di</strong>zioni OCD,<br />
Firenze 1982.<br />
ALVAREZ T., Garrigou-Lagrange, Teologo spirituale, in: Angelicum 42 (1965), 39-40.<br />
ANCILLI E., Spiritualità me<strong>di</strong>oevale, Ed. Teresianum, Roma 1983.<br />
ANCILLI E., La Preghiera Cristiana. Bibbia, Teologia, Esperienze storiche, 2 vol., Ed. Città<br />
Nuova, Roma 1988.<br />
BALLESTRERO, A. A., “Dio è Dio e per me". Due guide per pregare. <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú, San<br />
Giovanni della Croce, E<strong>di</strong>zioni OCD, 1990.<br />
BALTHASAR H. U. VON, Prayer, tradotto da A.V. LITTIEDALE. SPCK, London 1961.<br />
BALTHASAR H. U. VON, Teologia e Santità, in Verbum Caro, Saggi Teologici I, Brescia 1968.<br />
BALTHASAR H. U. VON, Sorelle nello Spirito. Teresa <strong>di</strong> Lisieux ed Elisabetta <strong>di</strong> Digione, Jaka<br />
Book, Milano 1974.<br />
187
BARTH K., La preghiera, Paoline, Fossano (Cu) 1969.<br />
BARSOTTI D., Preghiera cristiana, E<strong>di</strong>zioni Messaggero, Padova 1970.<br />
BEATA ROSA GATTORNO, Memorie. Diario intimo delle esperienze mistiche. Trascritte da<br />
DEGETTO A. E., Introduzioni e note <strong>di</strong> L. IRIATE, Casa Generalizia delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> Sant‘Anna,<br />
Roma, 1996.<br />
BENEDETTO XVI, La Rivoluzione <strong>di</strong> Dio, LEV, Città del Vaticano 2005.<br />
BERNARD C. A., Teologia spirituale, E<strong>di</strong>zioni Paoline, Roma 1983.<br />
BORRIELLO L. - DELLA CROCE G.(a cura), Teresa d„Avila. Opere complete, Ed. Paoline,<br />
Milano 1988.<br />
BORRIELLO E. — DELLA CROCE G., Temi maggiori <strong>di</strong> spiritualità teresiana, 2 ed. OCD,<br />
Morena (RM) 2005.<br />
BORRIELO E. — DELLA CROCE G. -- SECONDIN B., Storia della spiritualità, La spiritualità<br />
cristiana nell„età contemporanea, Borla, Roma 1985.<br />
BOUYER L. - DATTRINO L., La spiritualità dei Padri in Storia della spiritualità, vol. 3/A,<br />
Bologna 1983.<br />
BROVETTO C.-MEZZARDI I.- FERRARIO F.- RICCA P., La spiritualità cristiana nell'età moderna,<br />
vol. 5, Borla, Roma 1987.<br />
CASTELLANO CERVEDA J., Carismi per il terzo millennio, i movimenti ecclesiali e le nuove<br />
comunità, E<strong>di</strong>zioni OCD, Roma Morena 2001.<br />
CASTELLANO CERVEDA J., Incontro al Signore, pedagogia della preghiera, E<strong>di</strong>zioni OCD,<br />
Roma Morena 2002.<br />
CASTELLANO CERVEDA J., Dottrina e messaggio <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú, dottore della Chiesa<br />
(pro manuscripto) Teresianum, Roma 2005.<br />
CODINA V., De la ascetica y mistica a la vida según el Espritu, in AA. VV., EI Vaticano II<br />
veinte anos después, Cristianidad, Madrid 1985, 271-291<br />
DANLELOU J., Origene, il Genio del Cristianesimo, E<strong>di</strong>zioni Arkeios, Roma 1991.<br />
DUBAY T., Fire within. Saint Teresa of Avila, Saint John of the Cross and the Gaspel, on<br />
prayer, Ignatius Press, San Francisco 1989.<br />
ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Opere, S. Paolo, Cinisello Balsamo 1993.<br />
FIOCCHI A. M., La Serva <strong>di</strong> Dio Rosa Gattorno, fondatrice delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Anna, Casa<br />
Generalizia delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Anna, Roma 1937.<br />
FIOCCHI A. M., Rosa Gattorno. Fondatrice (183 1-1900), a cura <strong>di</strong> DEGETO A. E.,<br />
Congregazione <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> Sant‘ Anna, Roma 1996.<br />
GASPARJNO A., Maestro, insegnaci a pregare, E<strong>di</strong>trice ELLEDICI, Leumann (Torino) 1993.<br />
GIOBERTI V., Del primato morale e civile <strong>degli</strong> Italiani, Meline-Cans, Bruxelles 1843.<br />
GIOBERTI V., Prolegomeni del primato morale e civile <strong>degli</strong> Italiani, Meline-Cans, Bruxelles<br />
1845.<br />
GOFFI T., La Spiritualità dell‟ottocento, EDB, Bologna 1989.<br />
GOYA B., Luce e guida nel cammino. Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione spirituale, EDB, Bologna 2004.<br />
GUARDINI R., Preghiera e verità, Morcelliana, Brescia 1973.<br />
188
HERRAIZ GARCIA M., Introducciòn al Camino de perfecciòn de Teresa de Jesús, Monte<br />
Càrmelo, Burgos 2001.<br />
HERRAIZ GARCIA M., , La preghiera una storia d„amicizia, EDB, Bologna 2001.<br />
HOWE L. T., Prayer in a secular world, Pilgrim Press, Philadelphia 1973.<br />
JOHN OF THE CROSS, The Collected Work of St. John of the Cross, ICS Publications,<br />
Washington DC. 1979.<br />
JIMENEZ HERNANDEZ E., Il Padre nostro, fede, preghiera e vita, Grafitalica E<strong>di</strong>trice, Napoli<br />
1999.<br />
LAZZATI G., La preghiera del cristiano, Ed AVE, Roma 1986.<br />
MAGRASSI M., Bibbia e preghiera, Ancora, Milano 1973.<br />
MARCHESELLI C.C., La preghiera in San Paolo, D‘Auria, Napoli 1974.<br />
MAROCCHI M., Spiritualità e vita religiosa tra cinquecento e novecento, E<strong>di</strong>trice Morcelliana,<br />
Brescia 2005.<br />
MARTINA G., Formazione del clero e cultura cattolica verso la metà dell„Ottocento, in AA.VV.,<br />
La Chiesa in Italia. Dall'Unità ai nostri giorni, GUERRIERO E. (a cura <strong>di</strong>), E<strong>di</strong>zioni San Paolo,<br />
Cinisello Balsamo (Milano) 1966, pp. 120-206.<br />
MARTINA G., Il clero italiano e la sua azione pastorale verso la metà dell„Ottocento, in AA.<br />
VV., Storia della Chiesa dalle origini fino ai giorni nostri, 21/2, SAlE, Torino 1969, 751-781.<br />
MARTINI C. M., Solo Dios basta. La preghiera nella vita del pastore, E<strong>di</strong>trice Ancora, Milano<br />
1995.<br />
MARTIMORT A. G., The Church at prayer, Volume l: Principles of the Liturgy, The Liturgical<br />
Press, Collegeville Minnesota 1986.<br />
MAZZANTI G., I sacramenti, simbolo e teologia. Introduzione generale, EDB, Bologna l997.<br />
MAZZANTI G., I sacramenti simbolo e teologia. Eucaristia, battesimo e confermazione, EDB,<br />
Bologna 1998.<br />
MAZZANTI G., Teologia sponsale e sacramento delle nozze. Simbolo e simbolismo nuziale,<br />
EDB, Bologna 2002.<br />
MAZZANTI G., , Mistero pasquale, mistero nuziale, EDB, Bologna 2003.<br />
MAZZANTI G., Persone nuziali, communio nuptialis, saggio teologico <strong>di</strong> antropologia, EDB,<br />
Bologna 2005.<br />
MILITELLO C., "Maschile e femminile: la sfida della identità ―, in MORICONI B. (a cura),<br />
Antropologia cristiana. Bibbia, teologia, cultura, Città Nuova, Roma 2001, 205-266.<br />
MILITELLO C., , La chiesa “il corpo crismato", ―, EDB, Bologna 2003.<br />
MOSCHNER F. M., Introduzione alla preghiera, Paoline, Roma 1969.<br />
NEDONCELLE M., Preghiera umana e preghiera <strong>di</strong>vina. Per una fenomenologia della preghiera,<br />
Ed SEI, Torino 1965.<br />
PACHO E., Temi fondamentali in San Giovanni della Croce, OCD, Roma 1989.<br />
PADILLA F., Facing the future, the vision and mission of couples for Christ in the third<br />
millennium, Flame Ministries, Inc., Mandaluyong City 2003.<br />
189
PADOVANI U., Vincenzo Gioberti ed il Cattolicesimo. Una pagina nella storia moderna della<br />
Chiesa. Con documenti ine<strong>di</strong>ti, Vita e Pensiero, Milano 1927.<br />
PUTTINI F., Introduzione a San Giovanni della Croce, OCD, Roma 1987.<br />
RAHNER K., Necessità e bene<strong>di</strong>zione della preghiera, Morcelliana, Brescia, 1964.<br />
RUIZ SALVADOR F., Caminos del Espiritu. Compen<strong>di</strong>o de teologia espiritual, V ed., Ed. de<br />
Espiritualidad, Madrid 1998.<br />
SAGUBAL S., Il Padre nostro nella catechesi antica e moderna, E<strong>di</strong>zioni Dehoniane, Roma<br />
1994.<br />
SANT'ALFONSO MARIA DE‘ LJGUORI, Opere, vol IV, Marietti, Torino 1847.<br />
SANTA TERESA DE LOS ANDES, Diario y Cartas, Introduccion, revision del texto y notas:<br />
MARINO PURROY REMON, 4a e<strong>di</strong>cion, E<strong>di</strong>ciones Carmelo Teresiano, Santiago Cile 1993.<br />
TERESA DI GESÚ BAMBINO E DEL SANTO VOLTO, Opere complete, Libreria E<strong>di</strong>trice Vaticana-<br />
E<strong>di</strong>zioni OCD, Roma 1997.<br />
TERESA OF AVILA, The collected works of St. Teresa of Avila, ICS Publications, Washington<br />
D.C. 1980.<br />
The Sacramentary: Catholic Book Publishing Co., New York 1985.<br />
THOMAS AQUINATIS, Summa Theologiae, (5 Vols). Maryland, Christian Classics 1981.<br />
ZOVATTO P., (ed)., Storia della spiritualità italiana, Città Nuova, Roma 2000.<br />
Jimmy Pantin<br />
190