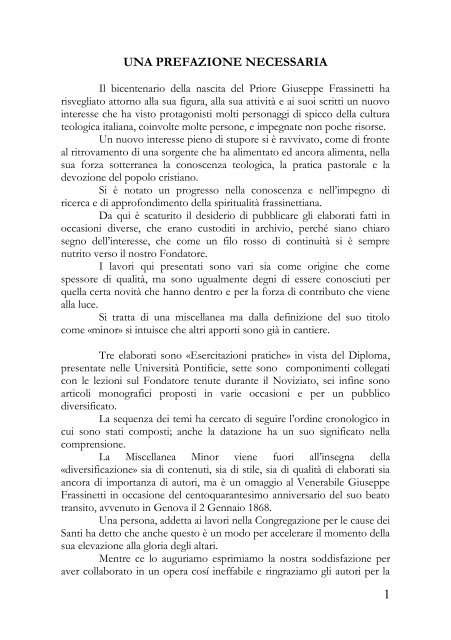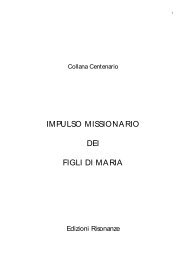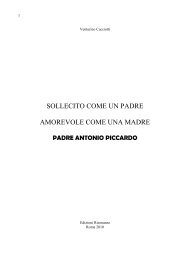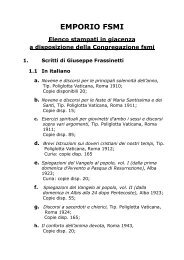1 UNA PREFAZIONE NECESSARIA - Figli di Santa Maria Immacolata
1 UNA PREFAZIONE NECESSARIA - Figli di Santa Maria Immacolata
1 UNA PREFAZIONE NECESSARIA - Figli di Santa Maria Immacolata
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>UNA</strong> <strong>PREFAZIONE</strong> <strong>NECESSARIA</strong><br />
Il bicentenario della nascita del Priore Giuseppe Frassinetti ha<br />
risvegliato attorno alla sua figura, alla sua attività e ai suoi scritti un nuovo<br />
interesse che ha visto protagonisti molti personaggi <strong>di</strong> spicco della cultura<br />
teologica italiana, coinvolte molte persone, e impegnate non poche risorse.<br />
Un nuovo interesse pieno <strong>di</strong> stupore si è ravvivato, come <strong>di</strong> fronte<br />
al ritrovamento <strong>di</strong> una sorgente che ha alimentato ed ancora alimenta, nella<br />
sua forza sotterranea la conoscenza teologica, la pratica pastorale e la<br />
devozione del popolo cristiano.<br />
Si è notato un progresso nella conoscenza e nell‘impegno <strong>di</strong><br />
ricerca e <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento della spiritualità frassinettiana.<br />
Da qui è scaturito il desiderio <strong>di</strong> pubblicare gli elaborati fatti in<br />
occasioni <strong>di</strong>verse, che erano custo<strong>di</strong>ti in archivio, perché siano chiaro<br />
segno dell‘interesse, che come un filo rosso <strong>di</strong> continuità si è sempre<br />
nutrito verso il nostro Fondatore.<br />
I lavori qui presentati sono vari sia come origine che come<br />
spessore <strong>di</strong> qualità, ma sono ugualmente degni <strong>di</strong> essere conosciuti per<br />
quella certa novità che hanno dentro e per la forza <strong>di</strong> contributo che viene<br />
alla luce.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una miscellanea ma dalla definizione del suo titolo<br />
come «minor» si intuisce che altri apporti sono già in cantiere.<br />
Tre elaborati sono «Esercitazioni pratiche» in vista del Diploma,<br />
presentate nelle Università Pontificie, sette sono componimenti collegati<br />
con le lezioni sul Fondatore tenute durante il Noviziato, sei infine sono<br />
articoli monografici proposti in varie occasioni e per un pubblico<br />
<strong>di</strong>versificato.<br />
La sequenza dei temi ha cercato <strong>di</strong> seguire l‘or<strong>di</strong>ne cronologico in<br />
cui sono stati composti; anche la datazione ha un suo significato nella<br />
comprensione.<br />
La Miscellanea Minor viene fuori all‘insegna della<br />
«<strong>di</strong>versificazione» sia <strong>di</strong> contenuti, sia <strong>di</strong> stile, sia <strong>di</strong> qualità <strong>di</strong> elaborati sia<br />
ancora <strong>di</strong> importanza <strong>di</strong> autori, ma è un omaggio al Venerabile Giuseppe<br />
Frassinetti in occasione del centoquarantesimo anniversario del suo beato<br />
transito, avvenuto in Genova il 2 Gennaio 1868.<br />
Una persona, addetta ai lavori nella Congregazione per le cause dei<br />
Santi ha detto che anche questo è un modo per accelerare il momento della<br />
sua elevazione alla gloria degli altari.<br />
Mentre ce lo auguriamo esprimiamo la nostra sod<strong>di</strong>sfazione per<br />
aver collaborato in un opera cosí ineffabile e ringraziamo gli autori per la<br />
1
loro <strong>di</strong>sponibilità ed incoraggiamento nel portare avanti questa piccola<br />
fatica.<br />
La Redazione<br />
2
INTRODUZIONE<br />
A centoquarant‘anni dalla sua morte, quale ere<strong>di</strong>tà permane della<br />
vita e delle opere del Fondatore <strong>di</strong> un Istituto religioso che possa essere<br />
risorsa e stimolo per quanti si sentono ancora chiamati a vivere lo stesso<br />
carisma apostolico?<br />
In questo insieme <strong>di</strong> piccoli saggi, scritti a partire dal 1968, non da<br />
professionisti del settore ma da suoi figli e figlie spirituali, possiamo<br />
trovare, almeno per quanto riguarda il nostro fondatore, il Venerabile<br />
Giuseppe Frassinetti, che reso lo spirito a Dio Padre il 2 gennaio 1868,<br />
risposta alla domanda.<br />
È interessante constatare come ognuno coglie una sfaccettatura<br />
<strong>di</strong>stinta della sua personalità, non tanto per comprendere l‘originalità della<br />
sua figura e della sua opera nel clima sociale, politico, culturale e spirituale<br />
del suo tempo, quanto per trarre alimento e sostegno nel cercare <strong>di</strong><br />
realizzare oggi quelle che furono le sue intuizioni dell‘operare dello Spirito<br />
Santo a favore della comunità cristiana.<br />
È confortante poter evidenziare dall‘insieme delle sottolineature<br />
che il Venerabile Frassinetti rifuggí dall‘essere un sacerdote intellettuale alla<br />
ricerca delle autoreferenzialità proprie <strong>di</strong> certi ambienti selezionati.<br />
Anzi è da annotare come riuscí a con<strong>di</strong>videre la sue ampie<br />
acquisizioni scritturistiche e ascetiche con i confratelli sacerdoti, come lui<br />
pastori <strong>di</strong> anime, ed anche con i fedeli <strong>di</strong> ogni con<strong>di</strong>zione.<br />
Cosí l‘esperto <strong>di</strong> teologia morale <strong>di</strong>venta in lui il me<strong>di</strong>co delle<br />
anime perché fa sperimentare loro che la misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Dio, aumenta a<br />
misura della debolezza e della fragilità del peccatore.<br />
Lo scrittore <strong>di</strong> pastorale non esorta soltanto a salvaguardare le<br />
norme giuri<strong>di</strong>che del <strong>di</strong>ritto canonico nell‘esercizio del ministero <strong>di</strong> parroco<br />
in una comunità cristiana, ma cerca <strong>di</strong> dare un‘anima e una esistenzialità a<br />
quanto potrebbe ridursi a essenziale ma vuota esemplarità per il gregge da<br />
condurre nella costruzione del Regno <strong>di</strong> Dio.<br />
La maturata sensibilità verso i giovani poveri, che desiderano<br />
rispondere positivamente alla chiamata del Signore non si limita solo a fare<br />
superare l‘ostacolo <strong>di</strong> tipo economico, ma <strong>di</strong>venta loro guida nello stu<strong>di</strong>o e<br />
nella formazione per aiutarli a non <strong>di</strong>staccare le nozioni tecniche acquisite<br />
tramite l‘insegnamento teologico, dalla vita concreta dei fedeli nella quale<br />
devono essere calate con l‘esercizio del ministero sacerdotale.<br />
L‘amore per la Chiesa trova manifestazione non solo nella sua<br />
<strong>di</strong>fesa dagli attacchi degli avversari, ma soprattutto nel fervore apostolico in<br />
<strong>di</strong>versi campi e nell‘obbe<strong>di</strong>enza anche dolorosa al Vescovo della sua<br />
<strong>di</strong>ocesi.<br />
3
L‘attenzione e la cura che pone nell‘istruzione catechistica e nella<br />
crescita spirituale degli adulti non lo <strong>di</strong>stoglie dall‘avere altrettanta<br />
de<strong>di</strong>zione ai bambini e ai giovani.<br />
La capacità <strong>di</strong> vivere intensamente la vita nelle Spirito è per lui<br />
prerogativa riconosciuta non solo alla sensibilità delle donna ma anche alla<br />
virilità degli uomini.<br />
La sua carità verso i bisognosi non lo porta a realizzare per loro<br />
gran<strong>di</strong> opere, ma ad esprimersi con una generosità personale <strong>di</strong> alta qualità,<br />
e con l‘esigenza <strong>di</strong> tutelare la loro <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> persone.<br />
Però al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> ogni singolo elogio, elaborato dai suoi figli e figlie<br />
spirituali negli scritti presentati in questa miscellanea, quello che rimane il<br />
punto <strong>di</strong> riferimento centrale per noi che viviamo nel terzo millennio, è il<br />
maestro <strong>di</strong> vita spirituale che scruta l‘interiorità degli uomini per volgerla a<br />
Dio.<br />
Seguendo il modo <strong>di</strong> vedere del Frassinetti, viene spontaneo<br />
collocare in primo piano lo sguardo che gli occhi <strong>di</strong> Dio riservano alla vita<br />
interiore del sacerdote, amministratore definitivo dei suoi doni, per capire<br />
anche l‘ardore che il Venerabile de<strong>di</strong>ca alla sua maturazione e crescita<br />
attraverso associazioni, incontri amichevoli e confronti <strong>di</strong> idee.<br />
Subito dopo si può collocare l‘affetto paterno verso i giovani e le<br />
giovani, che si vogliono de<strong>di</strong>care interamente a Dio, per insegnare loro la<br />
strada seguita da <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, per appartenere completamente e<br />
in<strong>di</strong>ssolubilmente a Gesú.<br />
E infine è rimarcabile la sua opera perché ognuno, nella propria<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vita, entri nel principio <strong>di</strong>namico che muove il popolo <strong>di</strong><br />
Dio, che è quello <strong>di</strong> sentirsi chiamati alla santità: in passato, oggi e sempre;<br />
e imparare insieme con <strong>Maria</strong> Santissima a ricercare la concordanza tra la<br />
nostra volontà e quella <strong>di</strong> Dio.<br />
P. Valter Palombi fsmi<br />
4
INFLUSSO DI SANT’ALFONSO SUL FRASSINETTI<br />
NELLA PASTORALE DELLA CONFESSIONE<br />
Esercitazione pratica <strong>di</strong> teologia morale<br />
Pontificia Università Urbaniana de Propaganda Fide<br />
Moderatore Giovanni Visser C.Ss.R.<br />
Anno scolastico 1966/67<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
SANT‘ALFONSO MARIA DE‘ LIGUORI:<br />
Theologia moralis, (L. Gaudé), Toma, Tip. Poliglotta Vaticana, 1909.<br />
Homo Apostolicus, A Saraceno, Torino, Tipografia Marietti, 1890.<br />
GIUSEPPE FRASSINETTI:<br />
Compen<strong>di</strong>o della Teologia Morale <strong>di</strong> S. Alfonso <strong>Maria</strong> de' Liguori., con apposite note e<br />
<strong>di</strong>ssertazioni, 3 ed., Genova, Tip. della Gioventú, 1867.<br />
Manuale pratico del Parroco Novello, 12 ed., Alba, ed. Paoline, 1964.<br />
Gesú Cristo regola del Sacerdote, 32 ed, Roma, Poliglotta Vaticana, 1966.<br />
CAN. POGGI, Della vita e delle Opere <strong>di</strong> G. Frassinetti, Genova, Tip. Caorsi,<br />
1868.FASSIOLO DOMENICO, Memorie storiche intorno alla vita <strong>di</strong> G. Frassinetti,<br />
Genova, Tip. della Gioventú, 1879.<br />
G. CAPURRO, G. Frassinetti e l’opera sua, Genova, Tip. della Gioventú, 1908.<br />
C. OLIVARI, Della vita e delle opere del servo <strong>di</strong> Dio G..Frassinetti, Roma,<br />
Poliglotta Vaticana, 1928.<br />
V. VAILATI, Un maestro <strong>di</strong> vita sacerdotale. Il servo <strong>di</strong> Dio G. Frassinetti, Alba,<br />
Ed. Paoline, 1947.<br />
5
SOMMARIO<br />
Prefazione<br />
Concordanza dell‘opera del Frassinetti con quella <strong>di</strong> S. Alfonso<br />
Metodo dell‘esercitazione<br />
Schema comparativo delle due opere<br />
Premessa<br />
Parte I: Trattato XVI — Capitolo VI: «Dell‘uffizio e dei. <strong>di</strong>versi obblighi del<br />
Confessore»<br />
Punto I: «Della scienza e <strong>di</strong> alcuni obblighi del Confessore»<br />
Parte II: Punto Il: «Come debba <strong>di</strong>portarsi il Confessore con coloro che sono<br />
in occasione prossima <strong>di</strong> peccato»<br />
Parte III: Punto III: «Come debba <strong>di</strong>portarsi il Confessore con gli abituati e<br />
reci<strong>di</strong>vi nel peccato»<br />
Parte IV: Dissertazione XIV: «Sull‘assoluzione da darsi agli abituati e reci<strong>di</strong>vi»<br />
Parte V: Dissertazione XV: «Sulla pratica <strong>di</strong> ascoltare le confessioni»<br />
Conclusione<br />
<strong>PREFAZIONE</strong><br />
―Non vi è dubbio che il Frassinetti è uno degli scrittori ascetici piú<br />
insigni dei nostri tempi. I suoi libri <strong>di</strong> ascetica eccellono per soli<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />
dottrina, per <strong>di</strong>screzione, per unzione, per squisitezza <strong>di</strong> buon senso, per<br />
facilità e scorrevolezza, per chiarezza ed anche per certa eleganza <strong>di</strong> stile.<br />
In essi aleggia quello Spirito incoraggiante che il Frassinetti attinse alle<br />
opere <strong>di</strong> S. Alfonso M. de‘ Liguori.<br />
Il Frassinetti però non fu solo uno scrittore ascetico, ma occupa<br />
anche uno dei primi posti quale scrittore <strong>di</strong> Teologia Morale, e Pastorale.<br />
Chi conosce la Teologia Morale del Frassinetti sa che non è esagerato <strong>di</strong>re<br />
che essa è il compen<strong>di</strong>o piú completo delle dottrine morali del Santo<br />
Dottore. Ma ciò che rende veramente grande ed insigne questa opera sono<br />
le <strong>di</strong>ssertazioni e le note numerose inserite nel testo. Leggendo queste<br />
<strong>di</strong>ssertazioni e queste note si è costretti ad esclamare: qui è proprio il buon<br />
senso che parla, il buon senso non solo naturale a anche il buon senso<br />
soprannaturale‖ 1.<br />
1 Card. P.BOETTO S. J, L'Apostolato della penna del Servo <strong>di</strong> Dio Priore G.<br />
Frassinetti in ―Tra i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>‖, Porto Romano, ed. Risonanze,<br />
1953, pp.29—30.<br />
6
Con queste alte parole il Car<strong>di</strong>nale Pietro Boetto, Arcivescovo <strong>di</strong><br />
Genova, metteva in luce la dottrina, la scienza, la praticità, la santità e<br />
rettitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> pensiero del nostro Venerabile Fondatore inserendolo nella<br />
schiera dei gran<strong>di</strong> maestri e benemeriti della Chiesa.<br />
Senza meno il Priore <strong>di</strong> S. Sabina, G, Frassinetti, ebbe una grande<br />
incidenza nella piú ampia <strong>di</strong>ffusione delle dottrine <strong>di</strong> S. Alfonso nel secolo<br />
scorso. Vissuto in un periodo piuttosto turbolento, sta sotto l‘aspetto<br />
religioso che politico, fu a capo <strong>di</strong> quella e1etta schiera <strong>di</strong> sacerdoti che<br />
nell‘Archi<strong>di</strong>ocesi Genovese cercavano, col far rivivere nel Clero l‘antica<br />
<strong>di</strong>sciplina, col ridestare nel popolo la pietà, <strong>di</strong> sollevare la Chiesa genovese<br />
dai gravi danni che l‘eresia giansenista prima, e poi le dottrine<br />
rivoluzionarie vi avevano arrecati 2.<br />
Forse fu particolare <strong>di</strong>sposizione della Provvidenza, che volle fin<br />
d‘allora risplendesse quasi lampada ardente e luminosa nella Casa <strong>di</strong> Dio,<br />
quell‘umile Priore che essa aveva suscitato a modello <strong>di</strong> zelo sacerdotale e<br />
maestro <strong>di</strong> vita spirituale, quale richiedevano i nuovi tempi.<br />
Concordanza dell‘opera del Frassinetti con quella <strong>di</strong> S. Alfonso.<br />
Tale concordanza è messa in risalto dal Frassinetti stesso nella<br />
prefazione del suo Compen<strong>di</strong>o in cui appunto afferma <strong>di</strong> seguire fedelmente<br />
il grande Teologo napoletano sull‘orme dell'Homo Apostolicus. In<br />
un primo tempo anzi, il Teologo genovese voleva stampare tale<br />
Compen<strong>di</strong>o senza alcuna aggiunta od osservazione particolare per servizio<br />
degli stu<strong>di</strong>osi <strong>di</strong> S. Alfonso; ma, riflettendo che arricchito <strong>di</strong> note e<br />
illustrato con alcune <strong>di</strong>ssertazioni riguardanti la pratica ed anche i tempi in<br />
cui viveva, avrebbe potuto riuscire <strong>di</strong> maggiore utilità specie ai Confessori<br />
novelli, scartò la prima idea e aggiunse molte note e <strong>di</strong>ssertazioni dove gli<br />
parevano opportune 3.<br />
Nonostante le sue molte note non si può <strong>di</strong>re che, ispiratore<br />
<strong>di</strong>retto del suo trattato morale non sia stato il grande Vescovo <strong>di</strong> S. Agata<br />
dei Goti, fondatore della Congregazione del S.S. Redentore.<br />
2 Cf. C. OLIVARI, Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio G. Frassinetti,<br />
Roma, Poliglotta Vaticana, 1928, pp. 7—8; 99—137.<br />
G. CAPURRO, G. Frassinetti e l’opera sua, Genova, Tip. della Gioventú,<br />
1908, pp. 6—13.<br />
Card. DOMENICO SVAMPA, Prefazione all’ ―Opera Omnia‖ del Frassinetti,<br />
Roma, Poliglotta Vaticana, 1906, pp. XX—XXII.<br />
3 Cf. G. FRASSINETTI, Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia Morale, Prefazione, Genova,<br />
Tip. della Gioventú, 1867, ed. IIIa, vol. I, p. 9.<br />
7
Infatti il Frassinetti afferma <strong>di</strong> seguire l'or<strong>di</strong>ne dei trattati e dei<br />
capitoli che è nell‘«Homo Apostolicus» in modo che il lettore volendo<br />
riscontrare qualche argomento, possa piú facilmente rinvenirlo. Tuttavia<br />
ciò che il Santo Dottore viene qua e là ripetendo, egli ha messo d‘or<strong>di</strong>nario<br />
una sola volta al proprio luogo cercando <strong>di</strong> essere il piú possibile<br />
schematico e pratico:<br />
―Nu1la però ho omesso (<strong>di</strong> S. Alfonso) neppure quelle cose che<br />
non sarebbero giu<strong>di</strong>cate ai nostri tempi <strong>di</strong> molta importanza; il che ho<br />
voluto fare, perché ciascuno possa star sicuro che questo mio lavoro<br />
contiene tutta quanta la teologia morale <strong>di</strong> S. Alfonso‖ 4.<br />
Metodo dell‘esercitazione<br />
In linea <strong>di</strong> massima, abbiamo voluto seguire parallelamente le<br />
dottrine dei due gran<strong>di</strong> Teologi senza aggiungere nulla <strong>di</strong> nostro per<br />
mettere maggiormente in risalto da una parte l‘incidenza <strong>di</strong> S. Alfonso sul<br />
mostro Fondatore, dall‘altra la grande libertà che ha usato il Frassinetti<br />
nello scrivere il suo trattato, liberandosi da ogni schematismo, ed evitando<br />
<strong>di</strong> essere un cieco ammiratore del suo grande maestro, permettendosi anzi<br />
talvolta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssentire apertamente da Lui, come risulta chiaro da alcune sue<br />
note e <strong>di</strong>ssertazioni.<br />
Schema comparativo delle due opere.<br />
FRASSINETTI : «Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia Morale»<br />
Trattato XVI<br />
«Del Sacramento della Penitenza»<br />
Cap. VI: «Dell‘uffizio e dei <strong>di</strong>versi obblighi del Confessore»<br />
nn. 440, 441, 442.<br />
443, nota 137 e 138.<br />
444, 445, 446.<br />
447, nota 139.<br />
448, nota 140.<br />
449, nota 141.<br />
450, 451, 452.<br />
453, nota 142.<br />
«Della carità e prudenza del Confessore»<br />
nn. 454, 455,<br />
456, nota 143, 457.<br />
4 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 10.<br />
8
S. ALFONSO — «Homo Apøstolicus»<br />
Trattato XVI<br />
«De Poenitentiae Sacramento»<br />
Cap. VI: «De officio et aliis muneribns confessarii»<br />
nn. 99, 100, 101, 102, 103.<br />
105, 106, 107, 108.<br />
109, 110, 111, 112.<br />
113, 114, 115, 116.<br />
117.<br />
118, 119.<br />
120.<br />
121, 122, 123.<br />
124, 125, 126, 127.<br />
Trattato XXI<br />
«De caritate et prudentia Cønfessarii» nn. 1, 2, 3, 4. 5, 6.<br />
«Come debba <strong>di</strong>portarsi il Confessore con <strong>di</strong>versi generi <strong>di</strong> persone»<br />
nn. 458, 459.<br />
460, nota 144, 461.<br />
462, nota 145.<br />
463, nota 146 e 147.<br />
«Come debba <strong>di</strong>portarsi il Confessore cogli abituati e reci<strong>di</strong>vi nel peccato»<br />
nn. 464, nota 148.<br />
465, nota 149.<br />
466, 467, 468.<br />
469, 470, nota 150.<br />
Dissertazione XIV<br />
«Sull‘assoluzione da darsi agli abituati e ai reci<strong>di</strong>vi»<br />
«Delle interrogazioni da farsi ai penitenti; e come debba <strong>di</strong>portarsi il<br />
Confessore con varie sorte <strong>di</strong> persone»<br />
nn. 471, 472, 473, 474, nota 151, e 152.<br />
Dissertazione XV<br />
«Sulla pratica <strong>di</strong> ascoltare le confessioni»<br />
Trattato Ultimo<br />
«Quomodo se gerere debeat Confossarius cum poenitentibus <strong>di</strong>versorum<br />
generum»<br />
nn. 1, 2a.<br />
2b, 3, 4, 5a.<br />
5b, 6, 7a.<br />
7b.<br />
9
«Quomodo se gerere debeat Confessarius cum habituatis et reci<strong>di</strong>vis»<br />
nn. 8.<br />
9a.<br />
9b, 10, 11, 12.<br />
14, 15, 16, 17.<br />
«De nonnullis peculiaribus interrogationibus facien<strong>di</strong>s a Confessariis parum<br />
meticulosae conscientiae poenitentibus»<br />
nn. 32, 33, 34, 35, 36.<br />
nn. 37, 38, 39, 42, 43, 54, 55<br />
Appen<strong>di</strong>x I: «Quomodo se gerere debeat Confessarius in <strong>di</strong>rigen<strong>di</strong>s<br />
animabus spiritualibus».<br />
PREMESSA<br />
―Fra i sacerdoti benemeriti che nel secolo XlX lavorarono con<br />
intelletto d‘amore a vantaggio della Chiesa, e che lasciarono un‘orma<br />
incancellabile della loro illuminata attività, tiene un posto nobilissimo e<br />
principale il celebre genovese Don Giuseppe Frassinetti. Vi è forse alcuno<br />
del clero che ne ignori il nome, e non possieda qualche opera scritta da lui,<br />
specialmente la sua opera principe «Il Compen<strong>di</strong>o della Teologia Morale»?<br />
Può <strong>di</strong>rsi con tutta verità che eg1i fu animato dallo spirito <strong>di</strong> S.<br />
Alfonso de‘ Liguori, e ne continuò nell‘Italia nostra la missione salutare...<br />
Zelantissimo della gloria <strong>di</strong> Dio, e tutto infiammato nel cuore dalla carità <strong>di</strong><br />
Gesú Cristo, il Frassinetti si adoperò interamente, come aveva fatto S.<br />
Alfonso, a far rifiorire la Morale cattolica, sia nella vita pratica dei fedeli, sia<br />
nell‘istruzione dottrinale dei. sacerdoti‖ 5.<br />
Con queste parole il Card. Svampa iniziava la sua Prefazione<br />
all‘«Opera Omnia» del Frassinetti, e la loro semplicità scevra da inutili e<br />
ampollose lo<strong>di</strong> è la riprova del valore teologico e soprattutto pastorale<br />
dell‘opera e della figura dell‘autore genovese.<br />
Quale poi sia l‘ammirazione, la de<strong>di</strong>zione e l‘affinità <strong>di</strong> spirito e <strong>di</strong><br />
idee che univa il Priore <strong>di</strong> S. Sabina al grande Dottore napoletano, lo<br />
possiamo facilmente dedurre dalla sua stessa Prefazione al «Compen<strong>di</strong>o»:<br />
―Ciò che inutilmente si era sempre desiderato, né forse si sperava <strong>di</strong> poter<br />
mai conseguire, si è finalmente per la <strong>di</strong>vina grazia ottenuto.<br />
Si vuol <strong>di</strong>re quel bell‘accordo <strong>di</strong> dottrine morali, me<strong>di</strong>ante il quale<br />
genera1mente i Confessori, seguendo gli stessi principi, vengono alle stesse<br />
conseguenze pratiche... Questo bell‘accordo è grazia della <strong>di</strong>vina<br />
Provvidenza, la quale ha <strong>di</strong>sposto che si <strong>di</strong>ffondessero quasi<br />
5 Card. DOMENICO SVAMPA, op. cit., p. XIX.<br />
10
universalmente le dottrine morali <strong>di</strong> S. Alfonso de' Liguori. Mi sarà<br />
permesso chiamare queste dottrine, un fiume <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione, che superato<br />
ogni ostacolo, si sparge ad innaffiare tutto il campo della <strong>Santa</strong> Chiesa‖ 6.<br />
In quello splen<strong>di</strong>do trattato <strong>di</strong> Teologia Pastorale che è il<br />
«Manuale del Parroco Novello» esortando la moderazione che deve avere il<br />
parroco, esponendo le dottrine della morale cristiana, Frassinetti. <strong>di</strong>ce:<br />
―Poiché il Signore ha mandato al mondo la bene<strong>di</strong>zione delle opere <strong>di</strong> S.<br />
Alfonso, morali ed ascetiche, il parroco non si valga ciecamente, per le<br />
istruzioni catechistiche, <strong>di</strong> qualunque autore anche riputato buono: se ne<br />
valga, se cosí vuole, per la <strong>di</strong>visione delle materie, per le parità, per gli<br />
esempi: ma a riguardo della moralità osservi bene, se le opinioni del libro<br />
sieno conformi alle dottrine <strong>di</strong> S. Alfonso, e trovandole sconcordanti, lasci<br />
quelle del suo autore, e vi sostituisca quello del santo‖ 7.<br />
Ma abbiamo parlato <strong>di</strong> affinità <strong>di</strong> spirito. Certamente il Frassinetti,<br />
sulle orme del suo grande maestro, il Liguori, fu propugnatore aperto del<br />
probabilismo, ma <strong>di</strong> un probabilismo bene inteso, e fu tra i primi che<br />
osasse con fine acume e logica stringente, a combattere le teorie opposte,<br />
sostenendo che quando nel conflitto <strong>di</strong> opinioni <strong>di</strong>verse, una sentenza è<br />
veramente probabile, cioè tale da avere i1 consenso <strong>di</strong> uomini prudenti, la<br />
si possa seguire nella pratica senza preoccuparsi del maggior o minor grado<br />
<strong>di</strong> probabilità che essa abbia in confronto della sentenza opposta.<br />
In questa sua posizione fondamentale che egli svolse<br />
magistralmente nella terza <strong>di</strong>ssertazione della sua Teologia morale, si<br />
riporta continuamente al pensiero e allo spirito <strong>di</strong> S. Alfonso e sente la<br />
sicurezza, pur nella sua profonda umiltà, <strong>di</strong> essere un interprete fedele,<br />
<strong>di</strong>staccandosi dalla troppo accesa e spesso inutile controversia tra<br />
probabilisti ed equoprobabilisti.<br />
Per certe sue risoluzioni che sembravano troppo benigne fu<br />
accusato anche da persone autorevoli <strong>di</strong> lassismo.<br />
Non fu forse altrettanto <strong>di</strong> S. Alfonso? Ecco un altro punto <strong>di</strong> incontro,<br />
ma questa censura non può essere fatta al Frassinetti. ―Le dottrine<br />
rilassate - egli <strong>di</strong>ce - non sono dottrine benigne, ma crudeli, che portano le<br />
anime a per<strong>di</strong>zione‖ 8.<br />
È vero che egli vuole che il confessore adempia il suo ufficio con<br />
soave «scioltezza <strong>di</strong> spirito», e che nel sacro tribunale compia le parti della<br />
6 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 7.<br />
7 G. FRASSINETTI, Manuale pratico del Parroco Novello, Alba, ed.<br />
Paoline, 1964, n. 256, p. 164.<br />
8 C. OLIVARI, Della vita e delle opere del servo <strong>di</strong> Dio G..Frassinetti, Roma,<br />
Poliglotta Vaticana, 1928, pag. 210.<br />
11
<strong>di</strong>vina misericor<strong>di</strong>a con carità senza recare peso alle coscienze e sgomento<br />
ai peccatori, ma insieme vuole che egli ―attenda assiduamente allo stu<strong>di</strong>o<br />
della Teologia Morale‖ cosí che, ―colui che chiaramente conoscesse <strong>di</strong><br />
essere inabile a confessare, peccherebbe mortalmente, non rinunziando a<br />
questo uffizio‖ 9. Se qualche fiducia poteva dargli la lunga pratica del<br />
ministero sacerdotale, non si fidava però affatto <strong>di</strong> sé.<br />
Sentiamo lui stesso: ―Mentre desidero <strong>di</strong> fare qualche bene, mi<br />
spaventa il solo pensiero <strong>di</strong> poter fare qualche male. È per questo che non<br />
ho voluto fidarmi per nulla dei lunghi anni <strong>di</strong> confessionale, ed in quella<br />
vece ho voluto chiedere lumi al Signore ogni volta che ho preso in mano la<br />
penna, ed oltre a ciò nulla, ho scritto che non abbia prima consultato con<br />
uomini dotti, e piú sperimentati‖ 10.<br />
Nella Prefazione al «Manuale del Parroco Novello» si legge: ―Non<br />
avverrà mai che io mi fi<strong>di</strong> del mio giu<strong>di</strong>zio; prometto <strong>di</strong> non mettere cosa<br />
che non abbia il suffragio <strong>di</strong> persone piú intelligenti ed esperte <strong>di</strong> me; e<br />
questa mia <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> animo, che col <strong>di</strong>vino aiuto non muterò, mi dà<br />
motivo grande a sperare, che se non riuscirò a fare un bene considerevole,<br />
non rimarrà pericolo che io faccia alcun male‖ 11.<br />
Chi potrebbe ancora accusare il Frassinetti <strong>di</strong> almeno intenzionale,<br />
lassismo dopo queste schiette attestazioni <strong>di</strong> umiltà e <strong>di</strong> sfiducia verso le<br />
proprie possibilità?<br />
A questo proposito sono interessanti le parole che il Car<strong>di</strong>nal<br />
Svampa proferisce sulla figura del Priore: ―L‘accordo armonioso della<br />
rigidezza del prete nel governare se stesso, colla dolcezza blanda e<br />
compassionevole nel regolare gli altri, si vide luminosamente nello stesso<br />
Frassinetti. La vita <strong>di</strong> lui fu improntata tutta al piú rigoroso esercizio della<br />
perfezione cristiana e sacerdotale. Orbene, uno dei preziosi frutti <strong>di</strong> questo<br />
austero costante esercizio <strong>di</strong> santità fu appunto la <strong>di</strong>screta e soavissima<br />
maniera con cui egli insegnò, svolse e applicò i principi della Teologia<br />
Morale a vantaggio dei fedeli‖ 12.<br />
Piú sotto il medesimo Car<strong>di</strong>nale con estrema decisione afferma:<br />
―Se trenta o quaranta anni fa - l‘autore scrive nel 1905 - alcuni si fecero<br />
lecito <strong>di</strong> considerare il Frassinetti come teologo lassista oggi, dopo che il<br />
suo Compen<strong>di</strong>o è stato profondamente stu<strong>di</strong>ato e largamente <strong>di</strong>ffuso, oggi<br />
9 G. FRASSINETTI, Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia morale, Genova, Tipografia<br />
della Gioventú, 1867, ed. 3, vol. II, pag. 545.<br />
10 G. FRASSINETTI, op. cit., vol. I, pag. 11.<br />
11 G. FRASSINETTI, Manuale pratico del Parroco Novello, Alba, ed.<br />
Paoline, 1964, p. 19.<br />
12 Card DOMENICO SVAMPA, op. cit., pp. XXVII-XXVIII.<br />
12
che <strong>di</strong> esso si sono fatte ben nove e<strong>di</strong>zioni tutte esaurite, oggi che a favore<br />
del Frassinetti si sono pronunciati molti vescovi e tutti i moderni scrittori<br />
<strong>di</strong> teologia morale, non credo che si trovi pur uno che ar<strong>di</strong>sca ripetere<br />
quell‘accusa.<br />
Il Frassinetti è stato un teologo ben equilibrato che allo stu<strong>di</strong>o<br />
accoppiava la pietà, all‘ingegno il criterio, alla teoria la pratica, e che alla<br />
scienza della morale seppe dare un nuovo impulso e un in<strong>di</strong>rizzo<br />
veramente moderno‖ 13.<br />
Questa comprensione della fragilità umana e questo sapersi<br />
mettere nella pelle del peccatore che sta per tornare a Dio, è una<br />
caratteristica tutta propria del Frassinetti.<br />
Ci piace perciò rilevarla specialmente oggi dopo che il Concilio<br />
Vaticano II ha sottolineato ancor piú la nobiltà e la preziosità della<br />
«persona» umana 14 anche quando è peccatrice, perché sempre figlia <strong>di</strong> Dio.<br />
Quanto abbiamo detto è piú che sufficiente a scagionare il<br />
Frassinetti da qualsiasi accusa <strong>di</strong> lassismo e <strong>di</strong> pochezza <strong>di</strong> idee, e ben a<br />
ragione si potrebbe applicare a lui stesso ciò che egli <strong>di</strong>ce con fine e pacata<br />
ironia, degli avversari <strong>di</strong> S. Alfonso: ―Se vi è qualche raro malinconico, che<br />
ancora si pregi dì combatterne, le dottrine e negarne l'autorità, si lasci<br />
abbaiare come i cani alla luna e si compatisce per sentimento <strong>di</strong> carità‖ 15.<br />
A questo punto in qualcuno, poco conoscitore <strong>di</strong> entrambi gli<br />
autori, potrebbe sorgere il dubbio che il Frassinetti non fosse altro, in<br />
definitiva, che un semplice traduttore e riduttore della Teologia Morale <strong>di</strong><br />
S. Alfonso; cieco espositore delle dottrine del maestro, schiavo della sua<br />
autorità. È sempre l‘Em.mo Card. Svampa che ci viene in aiuto con<br />
l‘autorità della sua profonda conoscenza del teologo genovese.<br />
―Lo stu<strong>di</strong>o - egli <strong>di</strong>ce - che il Frassinetti fece sulle opere <strong>di</strong> S.<br />
Alfonso non fu stu<strong>di</strong>o del tutto servile; poiché egli andò ricercando e<br />
verificando le fonti alle quali S. Alfonso aveva attinto, vagliò rigorosamente<br />
le ragioni delle sentenze da lui insegnate, e specialmente si addentrò nella<br />
scienza Tomistica, dalla quale S. Alfonso aveva desunto le linee maestre <strong>di</strong><br />
tutto il suo sistema morale. Questa accurata analisi dottrinale lo emancipò<br />
dalle pastoie <strong>di</strong> ogni gretta pedanteria, e gli <strong>di</strong>ede <strong>di</strong>ritto a sostenere<br />
liberamente qualche opinione che non concorda pienamente col santo<br />
Dottore‖ 16.<br />
13 Ibidem, pp. XXVII-XXVIII.<br />
14 Dignitatis Humanae, nn. 3, 11; Gau<strong>di</strong>um et spes, nn. 13, 21, 27, 28, 31,<br />
32, .35, 41.<br />
15 G. FRASSINETTI, op. cit., n. 256, pag. 165.<br />
16 Card. DOMENICO SVAMPA, op. cit., p. XXVIII.<br />
13
Egli stesso del resto lo confessa con leale candore nella<br />
Prefazione: ―Nelle note e <strong>di</strong>ssertazioni riguardanti la pratica e questioni del<br />
giorno, non mi scosto mai dai principi professati dal Santo. Avverrà<br />
tuttavia che qualche volta trattandosi <strong>di</strong> materie piú metafisiche che morali,<br />
e perciò filosofiche che teologiche, ed anche <strong>di</strong> casi particolari, io non<br />
concor<strong>di</strong> pienamente col Santo. La qual cosa voglio notare espressamente,<br />
affinché non si creda che io sia troppo cieco suo ammiratore, e che voglia<br />
mettere i suoi scritti al pari dei Concili Generali, e delle Bolle Dogmatiche,<br />
ove ogni sentenza è sacra e inviolabile‖ 17.<br />
Queste parole sono sintomatiche <strong>di</strong> tutto un sistema e <strong>di</strong> una<br />
personalità, basta pensare che sono pronunciate da quello stesso che<br />
nell'altra sua opera teologico-pastorale, «Il Manuale del Parroco Novello»,<br />
esortava decisamente i parroci ad abbandonare ogni libro anche se ritenuto<br />
buono, che <strong>di</strong>scordasse dalla dottrina <strong>di</strong> S. Alfonso.<br />
Leggendo poi quanto <strong>di</strong>ce nella terza <strong>di</strong>ssertazione sulla scelta<br />
delle opinioni, ―...nemmeno trattandosi <strong>di</strong> S. Alfonso, il Confessore deve<br />
farsi scrupolo <strong>di</strong> allontanarsi da qualche sentenza tenuta da lui come<br />
«probabiliore» ed anche come «certa», se la sentenza contraria ha il<br />
suffragio <strong>di</strong> teologi ortodossi da doversi giu<strong>di</strong>care sodamente probabile;<br />
che anzi non potrebbe mai obbligare il suo penitente a seguire l‘opinione<br />
del Santo, qualora volesse quegli seguirne una contraria veramente<br />
probabile‖ 18.<br />
Sarebbe il caso <strong>di</strong> ricordare l‘antico detto aristotelico: «amicus<br />
Plato, sed magis amica veritas».<br />
Trattato XVI<br />
Capitolo VI «Dell‘uffizio e dei <strong>di</strong>versi obblighi del Confessore».<br />
Parte I<br />
Punto I<br />
«Della scienza e <strong>di</strong> alcuni obblighi del Confessore»<br />
―Primo obbligo del Confessore è lo stu<strong>di</strong>o della Teologia Morale.<br />
Colui che chiaramente conoscesse <strong>di</strong> essere inabile a confessare,<br />
peccherebbe mortalmente non rinunziando a questo uffizio‖ 19.<br />
L'espressione del teologo genovese è categorica e non ammette<br />
repliche; il Frassinetti inoltre sull‘orme <strong>di</strong> S. Alfonso, ritiene necessaria la<br />
17 G. FRASSINETTI, Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia Morale, ed. 3, Genova, Tip,<br />
della Gioventú, 1867, vol. I, p. 10.<br />
18 G. FRASSINETTI, op. cit., vol. I, pp. 44-45.<br />
19 G. FRASSINETTI, op. cit., n. 440, p. 545.<br />
14
conoscenza profonda della coscienza del penitente da parte del<br />
Confessore.<br />
Tuttavia fa notare che l‘obbligo <strong>di</strong> esaminarsi è del penitente, ma il<br />
Confessore, illuminato e caritatevole, non mancherà <strong>di</strong> interrogare i<br />
penitenti, specie se rozzi, nel corso della confessione.<br />
―Il Confessore giu<strong>di</strong>chi che siano peccati mortali quelli che<br />
chiaramente appariranno tali, ed assolva gli altri come sono davanti a<br />
Dio‖ 20.<br />
Questa frase così incisiva, che viene ripresa quasi alla lettera da S.<br />
Alfonso 21, è determinante per le interrogazioni del Confessore, che deve si<br />
conoscere e giu<strong>di</strong>care il peccato ma deve altresí astenersi da ogni eccessiva<br />
e minuziosa indagine <strong>di</strong> esso.<br />
Ricalcando il pensiero <strong>di</strong> S. Alfonso il nostro teologo afferma:<br />
―Quando si tratta <strong>di</strong> cose necessarie alla salute eterna o riguardante il bene<br />
comune, <strong>di</strong>a gli opportuni avvisi, ancorché preveda che saranno<br />
infruttuosi‖ 22.<br />
Ma il Frassinetti non si accontenta <strong>di</strong> un‘espressione cosí generica,<br />
ama la chiarezza da cui sola trae origine la semp1icità e la praticità del<br />
giu<strong>di</strong>zio, perciò aggiunge una lunga nota riguardante il «bene comune».<br />
Sempre fedele, come abbiamo detto, a1la ricerca pratica, pone dei casi ben<br />
precisi <strong>di</strong> Superiori-Parroci, Cappellani ecc., soggetto <strong>di</strong> ignoranza<br />
colpevole per cause naturali (vecchiaia, malattia ecc.) e irrime<strong>di</strong>abili; ebbene<br />
non esita a posporre il pubblico bene, che deriverebbe dalla correzione <strong>di</strong><br />
mancanze <strong>di</strong> detti Superiori, alla buona fede del penitente, conoscendo che<br />
«hic et nunc» la correzione sarebbe del tutto inutile.<br />
Con decisione asserisce: ―Io pertanto <strong>di</strong>rei, che quando nel<br />
penitente si può supporre buona fede, e d‘altra parte si conosca vana, ed<br />
anzi per lui dannosa la correzione, si debba questa omettere in qualunque<br />
caso;...del resto il pubblico bene non avrebbe alcun danno<br />
dall‘omissione‖ 23.<br />
20 G. FRASSINETTI, op. cit., n. 442, p. 546.<br />
21 S. ALFONSO, Homo Apostolicus, tract 16, n. 104: ―Cum confessarius<br />
peccata au<strong>di</strong>verit tenetur iu<strong>di</strong>cium facere de gravitate, et numero eorum,<br />
quia licet, valide absolveat, sufficit ut peccatum cognoscat, saltem sub<br />
confusa ratione peccati; attamen ut licite absolveat, debet prudens<br />
formare iu<strong>di</strong>cium uniuscuisque culpae, saltem in iis quae comuniter<br />
occurunt; nam alias magis oscuras et munus usuales sufficit ut au<strong>di</strong>at et<br />
absovat, ut sunt coram Deo‖.<br />
22 G. FRASSINETTI, op. cit., nn. 443, p. 546.<br />
23 G. FRASSINETTI, op. cit., nota 138, p. 551.<br />
15
Aggiunge però: ―Che qualora vi fosse una qualche speranza <strong>di</strong><br />
frutto non dovrebbe omettersi giammai‖ 24.<br />
A proposito del dolore il Frassinetti, come S. Alfonso, cita il<br />
Rituale Romano: ―Si au<strong>di</strong>ta cønfessione (sacerdos) iu<strong>di</strong>caverit, neque in<br />
enumeran<strong>di</strong>s peccatis dìligentiam, nec in destan<strong>di</strong>s dolorem poenitentis<br />
omnino defuisse, absolvere poterit‖; ma non si ferma qui, nella sua nota 25<br />
dà maggior forza al Rituale stesso ―la cui dottrina - afferma è piú<br />
autorevole <strong>di</strong> quella che ci fosse proposta dai teologi, fossero pure i piú<br />
insigni, perché il rituale è il libro messo in mano ai Confessori dalla stessa<br />
Chiesa‖ 26.<br />
Con sicurezza infatti egli sostiene: ―Dicendo l‘antico Rituale che il<br />
Confessore «absolvere poterit» il penitente, qualora giu<strong>di</strong>chi che non gli sia<br />
mancata la <strong>di</strong>ligenza nel ricercare i peccati, e il dolore nel detestarli, quel<br />
«poterit» equivale al «debebit»; infatti, fatta la Confessione, il penitente ha<br />
vero <strong>di</strong>ritto che gli si <strong>di</strong>a l‘asso1uzione ogni volta che gli si possa dare.<br />
Ricorderà inoltre il Confessore che per il penitente in buona fede<br />
basta alla giustificazione un dolore che tolga l‘affetto al peccato; e perché il<br />
Sacramento coll‘efficacia che ha da Cristo, infonda la grazia‖ 27.<br />
Riguardo poi al penitente che vuole seguire un‘opinione teologica<br />
sodamente probabile, ritenuta falsa dal Confessore, il Frassinetti seguendo i<br />
teologi citati da S. Alfonso 28, afferma che questi non può negare<br />
l‘assoluzione al penitente, purché l‘opinione sia riconosciuta da buoni<br />
teologi.<br />
A questo punto il teologo genovese apre una interessante nota<br />
dalla quale traspare tutta la sua riverenza verso il grande Maestro, non priva<br />
però <strong>di</strong> una giusta e critica obiettività: ―Mettiamo per un esempio,<br />
l‘opinione <strong>di</strong> S. Alfonso e <strong>di</strong> altri teologi la quale insegna che colui il quale<br />
ha incen<strong>di</strong>ato la casa <strong>di</strong> Caio, credendo <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>are la casa <strong>di</strong> Sempronio<br />
non è obbligato a risarcire il danno a Caio. Se ho da <strong>di</strong>re il vero una tale<br />
24 Ibidem, p. 552.<br />
25 Ibidem, nota 139, pp. 552—553.<br />
26 Ibidem, p. 553.<br />
27 G. FRASSINETTI, op. cit., pp. 552—553.<br />
28 S. ALFONSO, op. cit., n. 118, ―Hic occurrit loqui de illa magna<br />
quaestione ho<strong>di</strong>e adeo controversa inter doctores an, confessarius possit<br />
et debeat absolvere eum qui vult sequi aliquam opinionem quam<br />
probabilem iu<strong>di</strong>cat etiamsi confessarius uti talem non habeat...negant<br />
aliqui. Sed sententia communis docet confessarium in eo casu posse et<br />
debere absolvere sub gravi. Ita Novar. Sot. Azor. Suar. Solm. Med.<br />
Castrop. Volent. Sayr. Vasquez etc.‖.<br />
16
opinione a me pare falsa, quanto pare falso, per così <strong>di</strong>re, che due piú due<br />
facciano cinque. Con tutto ciò, se un mio penitente, fosse pure<br />
ignorantissimo, volesse seguire in pratica quell‘opinione <strong>di</strong> S. Alfonso,<br />
potrei mai negargli l‘assoluzione? Par evidente che no, non avendo nessun<br />
<strong>di</strong>ritto a <strong>di</strong>rgli: se voi volete seguire l‘opinione dì S. Alfonso invece della<br />
mia, non vi do l‘assoluzione‖ 29.<br />
S. Alfonso al n. 120 del trattato XVI <strong>di</strong>ce: ―quod cum confessarius<br />
moraliter certum est poenitentem sacrilege occultare peccatum, non potest<br />
eum absolvere, sed voce submissa debet aliquam recitare orationem ad<br />
occultandam absolutionem quam ei denegat.‖<br />
Il Frassinetti riporta integralmente questo passo 30, però apre<br />
subito una nota nella quale appare chiara la sua posizione <strong>di</strong>vergente.<br />
Fra l‘altro <strong>di</strong>ce: ―Il Confessore, se non fosse veramente certo che il<br />
penitente tacesse quel peccato volontariamente in mala fede, dovrebbe<br />
dargli la assoluzione; (altrimenti il penitente, qualora fosse ben <strong>di</strong>sposto,<br />
lasciato senza assoluzione, rimarrebbe in peccato mortale, tra<strong>di</strong>to dal<br />
Confessore. È anche da notare che, non data l‘assoluzione, il penitente<br />
commetterebbe ugualmente un sacrilegio tacendo il peccato; e che d‘altra<br />
parte il Confessore sapendo una cosa sotto sigillo, è lo stesso che non la<br />
sapesse)‖ 31.<br />
Da queste sia pur poche pagine, già ci appare la caratteristica<br />
pastorale, in genere, del Frassinetti, aiutare e venire incontro al penitente,<br />
fino al limite del possibile, e piú oltre se si potesse.<br />
Parte III<br />
Punto II<br />
«Come debba <strong>di</strong>portarsi il Confessore con coloro che sono in occasione<br />
prossima <strong>di</strong> peccato».<br />
Secondo il suo metodo il Frassinetti segue quasi alla lettera la parte teorica<br />
del trattato ultimo dell‘«Homo Apostolicus» del Santo napoletano<br />
ampliando solo l‘argomento delle visite fra i fidanzati, adattando ai tempi lo<br />
sviluppo <strong>di</strong> tale dottrina 32.<br />
Toccando il problema delle opinioni, benigne o severe da seguirsi dai<br />
Confessori nella <strong>di</strong>rezione delle anime, il Frassinetti sviluppa in casi pratici<br />
29 G. FRASSINETTI, op. cit., n.140, pp. 553~554.<br />
30 Cf. G. FRASSINETTI, ibidem, n. 449, pp. 548-549.<br />
31 Ibidem, nota 141, p. 554. Il pensiero riportato fra parentesi è una<br />
aggiunta della IV.a e<strong>di</strong>zione curata da P. Antonio Ballerini nel 1869.<br />
32 G. FRASSINETTI, op. cit., nota 144, p. 561.<br />
17
il pensiero che S. Alfonso formula a riguardo, nel trattato XVI e ultimo<br />
dell‘«Homo Apostolicus»; mostrando 33 inoltre, una certa propensione<br />
verso le opinioni piú benigne; e per questo afferma: ―Qui è da attendere al<br />
proverbio: chi troppo vuole niente ha. Piú volte ho trovato anime, le quali<br />
per lungo tempo stettero lontane dai Sacramenti, perché il rigore del<br />
Confessore vietava ad essi recisamente ciò che con certe avvertenze e<br />
riguar<strong>di</strong> avrebbe potuto loro permettere‖ 34.<br />
Punto III:<br />
«Come debba <strong>di</strong>portarsi il Confessore con gli abituati o reci<strong>di</strong>vi nel<br />
peccato».<br />
Il Frassinetti include, come già ha fatto nel punto II, l‘argomento<br />
degli abituali e reci<strong>di</strong>vi che S. Alfonso mette nel Trattato Ultimo<br />
dell‘«Homo Apostolicus», in questo stesso Trattato XVI Cap. VI, per poter<br />
avere un‘organica e completa visione <strong>di</strong> tutto l‘argomento della Pastorale<br />
della Confessione.<br />
È dunque questione solo <strong>di</strong> praticità, e il teologo genovese che si<br />
proponeva appunto come uno degli scopi della sua opera, la rapi<strong>di</strong>tà e<br />
praticità <strong>di</strong> consultazione non si lascia sfuggire l‘occasione per convergere<br />
in un solo capitolo quella dottrina che S. Alfonso aveva sparso un po' qua e<br />
là nella sua Opera.<br />
Per gli abituati e reci<strong>di</strong>vi il Frassinetti traduce quasi alla lettera il<br />
pensiero del suo Maestro, ma subito dopo l‘affermazione del Santo che<br />
―...si habitus esset valde ra<strong>di</strong>catus, potest etiam confessarius ei <strong>di</strong>fferre<br />
absolutionem ad experiendum quomodo sit costans poenitens, in praxim<br />
deducendo me<strong>di</strong>a praescripta utque ipse de suo vitio maiorem concipiat<br />
horrorem...‖ 35, il nostro teo1ogo apre una nota nella quale con decisione<br />
afferma che: ―Sebbene il Santo approvi che talvolta si possa <strong>di</strong>fferire<br />
l‘assoluzione al penitente che si suppone ben <strong>di</strong>sposto a riceverla<br />
attualmente, io non <strong>di</strong> meno confesso che andrei molto cauto nel seguire<br />
questa dottrina, considerando quanto sia terribile e spaventoso lo stato <strong>di</strong><br />
un‘anima gravata <strong>di</strong> colpa mortale‖ 36.<br />
Ammette sí la necessità <strong>di</strong> negare talvolta l‘assoluzione, ma ripete<br />
con decisione: ―nell‘uso <strong>di</strong> questo rime<strong>di</strong>o, lo ripeto, andrei molto a<br />
33 S. ALFONSO, Homo Apostolicus, tract. 16, n. 112, tract. ultim, n. 7.<br />
34 G. FRASSINETTI, op. cit., nota 147, p. 565.<br />
35 S. ALFONSO, op. cit., tract. ult., n. 3.<br />
36 G. FRASSINETTI, op. cit., nota 148, pp. 568~569.<br />
18
ilento‖ 37, e fa notare quanto del resto lo stesso S. Alfonso <strong>di</strong>ce 38 nel suo<br />
Trattato Ultimo.<br />
Il Santo dottore al n. 11 e 12 <strong>di</strong> detto trattato elenca i segni<br />
straor<strong>di</strong>nari che ritiene sufficienti perché il Confessore possa dare subito<br />
l‘assoluzione ai reci<strong>di</strong>vi. Il nostro fondatore rivolgendosi al Confessore<br />
aggiunge con esperienza: ―Prego il Confessore ad osservare bene tutti i<br />
singoli segni straor<strong>di</strong>nari e a riflettere che è caso assai raro che nei reci<strong>di</strong>vi<br />
che si confessano non si trovi alcuno <strong>di</strong> questi segni o che almeno non si<br />
possa procurare che lo abbiano me<strong>di</strong>ante le riflessioni, e i suggerimenti, e le<br />
calde esortazioni che può e deve fare ai medesimi lo zelante ministro <strong>di</strong><br />
Dio quando sono ai suoi pie<strong>di</strong>; <strong>di</strong> modo che attendendo a questi segni detti<br />
straor<strong>di</strong>nari, vari dei quali sono assai ovvii e facili a trovarsi nei penitenti,<br />
pochi assai saranno i reci<strong>di</strong>vi ai quali non si debba dare subito<br />
l‘assoluzione; eccetto naturalmente, quelli che si trovano in occasione<br />
prossima e libera <strong>di</strong> peccato‖ 39.<br />
Parte IV<br />
Dissertazione XIV: «Sull‘assoluzione da darsi agli abituati e reci<strong>di</strong>vi».<br />
«De habituatis et reci<strong>di</strong>vis»: l‘argomento, possiamo <strong>di</strong>re, è il cavallo<br />
<strong>di</strong> battaglia <strong>di</strong> ogni moralista per la possibilità, anzi per la necessità che<br />
offre <strong>di</strong> manifestare chiaramente le proprie posizioni rigoriste, lassiste o<br />
moderate.<br />
Il Frassinetti sente l‘ostacolo e da buon teologo, e sopratutto da<br />
ottimo Sacerdote e Confessore qual‘era nella stima <strong>di</strong> tutti, clero e fedeli,<br />
non si trae in<strong>di</strong>etro né tanto meno si ripara prudentemente <strong>di</strong>etro le<br />
posizioni dì altri sia pure essi ottimi e santi, quali, ad esempio, il suo grande<br />
maestro S. Alfonso.<br />
Niente <strong>di</strong> tutto questo; egli, pur nella sua, grande umiltà che gli fa<br />
<strong>di</strong>re: ―Prometto <strong>di</strong> non mettere cosa che non abbia il suffragio <strong>di</strong> persone<br />
piú intelligenti ed esperte <strong>di</strong> me‖ 40, sa tuttavia <strong>di</strong> possedere una sicura<br />
visione nell‘arduo e complesso ministero della cura delle anime e per<br />
37 Ibidem, p. 569.<br />
38 S. ALFONSO, op. cit., tract. ult., n. 14: ―...<strong>di</strong>co cum sententia<br />
comunissima doctorum quod raro expe<strong>di</strong>t <strong>di</strong>fferre absolutionem reci<strong>di</strong>vo<br />
cum ille est <strong>di</strong>spositus: nam sperari debet magis gratiam Sacramenti,<br />
quam <strong>di</strong>lationem absolutionis illi prodesse posse‖.<br />
39 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 566.<br />
40 G. FRASSINETTI, Manuale pratico del parroco Novello, Alba, ed. Paoline,<br />
1964, p. 9.<br />
19
questo nel medesimo passo non esita a <strong>di</strong>re: ―Essendo ormai trent‘anni che<br />
io esercito il ministero <strong>di</strong> parroco, quantunque in molte cose ed anche in<br />
tutte io possa mancare <strong>di</strong> scienza speculativa, mi sembra non poter piú<br />
mancare <strong>di</strong> scienza sperimentale‖ 41.<br />
Allora affronta decisamente il problema degli abituati e reci<strong>di</strong>vi, e<br />
dopo aver esposto brevemente, come nella parte precedente abbiamo<br />
notato, la dottrina <strong>di</strong> S. Alfonso a riguardo, inserisce una magistrale<br />
Dissertazione sull‘argomento che manifesta chiaramente, non tanto per la<br />
sua lunghezza - ben 21 pagine — ma sopratutto per la sodezza e<br />
profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> idee, quanto gli stia a cuore il problema e quanto desideri<br />
istillare nell‘animo, specie dei Confessori novelli la necessità <strong>di</strong> una visione<br />
larga, umana e sopratutto ricca della misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong>vina, per risolvere, pur<br />
nella doverosa cautela e prudenza un punto tanto importante della<br />
pastorale della confessione che è una spina nel cuore sia dei penitenti,<br />
come dei Confessori.<br />
Il Frassinetti si pone innanzitutto il problema della <strong>di</strong>sposizione<br />
del penitente, e si domanda se il Confessore debba avere ragioni certe o è<br />
sufficiente che esse siano probabili per giu<strong>di</strong>care il penitente ben <strong>di</strong>sposto<br />
all‘assoluzione.<br />
Afferma senza esitare che essendo ―questa <strong>di</strong>sposizione cosa tutta<br />
interna e che solo si può riconoscere da in<strong>di</strong>zi piú o meno probabili,<br />
qualora si abbia una vera e soda probabilità che quella buona <strong>di</strong>sposizione<br />
sia nel penitente, gli si deve dare l‘assoluzione‖ 42.<br />
Tale affermazione è sancita con piú forza da un bell‘esempio in<br />
cui paragona il Confessore ad un me<strong>di</strong>co ed il Sacramento della Penitenza<br />
ad una me<strong>di</strong>cina. Il me<strong>di</strong>co potendo conoscere con assoluta certezza, la<br />
malattia dell‘inferno, gli darebbe una me<strong>di</strong>cina piú adatta per il suo stato;<br />
ma in realtà, dovendosi accontentare solo <strong>di</strong> probabili in<strong>di</strong>zi, or<strong>di</strong>na la<br />
me<strong>di</strong>cina che gli sembra piú opportuna al caso.<br />
Ugualmente il Confessore potendo leggere nel cuore del suo<br />
penitente la sua <strong>di</strong>sposizione potrebbe dargli o meno l‘assoluzione con<br />
assoluta certezza.<br />
―Ma poiché il confessore è precisamente nel caso del me<strong>di</strong>co che<br />
non può vedere dentro al suo malato, perché quando abbia in<strong>di</strong>zi<br />
sufficienti da poter supporre che probabilmente l‘assoluzione data da lui<br />
gioverà al penitente, la deve dare; e come mancherebbe al suo dovere il<br />
me<strong>di</strong>co, che, in caso <strong>di</strong> probabilità dì buon effetto, privasse l‘infermo della<br />
41 Ibidem, p. 9.<br />
42 G. FRASSINETTI, Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia Morale, ed. III.a, Genova, tip.<br />
Gìøventú, 1867, p. 572.<br />
20
me<strong>di</strong>cina, mancherebbe pure al suo dovere il Confessore, che in caso <strong>di</strong><br />
probabilità <strong>di</strong> buona <strong>di</strong>sposizione del suo penitente, lo privasse del<br />
benefizio della assoluzione‖ 43.<br />
Il Frassinetti, come aveva espresso nella Prefazione, assicura la<br />
fondatezza della sua dottrina con l‘autorità <strong>di</strong> insigni dottori; e qui, in<br />
questo secondo punto, riporta testi e affermazioni <strong>di</strong> San Tommaso e dei<br />
suoi <strong>di</strong>scepo1i fino al Suarez che confermano pienamente la sua posizione<br />
sulla <strong>di</strong>sposizione del penitente 44.<br />
Avendo parlato degli antichi teologi, e specie <strong>di</strong> S. Tommaso, il<br />
Frassinetti fa osservare come in nessuna delle loro opere essi parlino degli<br />
abituati e reci<strong>di</strong>vi. Ora, notando come ai loro tempi si amministrasse<br />
validamente il Sacramento della Penitenza, pur non considerando la<br />
<strong>di</strong>stinzione in abituati e reci<strong>di</strong>vi, il nostro teologo afferma che ben si<br />
potrebbe fare alla stessa maniera oggi giorno.<br />
Del resto, osserva ancora, S. Alfonso e gli altri teologi moderni,<br />
pur affermando la necessità <strong>di</strong> negare talvolta l‘assoluzione agli abituati e<br />
reci<strong>di</strong>vi, tuttavia ammettono che mai la si debba loro negare se presentino<br />
segni straor<strong>di</strong>nari <strong>di</strong> dolore 45.<br />
Segni che in fondo, osserva con acutezza il teologo genovese, non<br />
danno mai la certezza ma solo la probabilità della buona <strong>di</strong>sposizione del<br />
penitente; quin<strong>di</strong>: ―quasi <strong>di</strong>rsi che non sarebbe forse gran danno, se noi,<br />
ripigliando l‘antica usanza, quanto al dare o al negare l‘assoluzione, poco ci<br />
curassimo <strong>di</strong> osservare se i peccatori siano o non siano abituati o reci<strong>di</strong>vi,<br />
ma invece attendessimo, soltanto ad osservare se siano o non siano<br />
attualmente, «hic et nunc», pentiti delle loro colpe; e quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>stintamente<br />
a coloro che non ci dessero, e dai quali non potessimo ricavare probabili<br />
segni <strong>di</strong> pentimento, noi negassimo l‘assoluzione, ancorché non fossero né<br />
abituati né reci<strong>di</strong>vi; agli altri poi che ci dessero, o dai quali potessimo<br />
ricavare quei segni, dessimo l‘assoluzione, sebbene fossero abituati o<br />
reci<strong>di</strong>vi nei peccati‖ 46.<br />
43 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 572.<br />
44 Ibidem, pp. 572—573.<br />
45 S. ALFONSO, op. cit., tract, ult., n. 11: ―...ad absolvendos igitur<br />
reci<strong>di</strong>vos non sufficiunt or<strong>di</strong>naria signa doloris et propositi sed<br />
requiruntur extraor<strong>di</strong>naria: quas alias iuxta communem sententiam certe<br />
sufficiunt ad absolutionem impartiendam; illud enim extaor<strong>di</strong>narium<br />
signum aufert in<strong>di</strong>spositionis suspicionem, quae urget ratione<br />
relapsuum‖.<br />
46 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 575.<br />
21
Ed infatti il Frassinetti fa notare come poco importa per la loro<br />
giustificazione che i penitenti abbiano o non abbiano ancora contratto<br />
l‘abito del peccato; sono sufficienti le debite <strong>di</strong>sposizioni.<br />
―L‘abito del peccato, e le mille ricadute in esso, non possono<br />
ritardare dì un momento il perdono dei peccati. e la giustificazione al<br />
peccatore ben <strong>di</strong>sposto a ricevere l‘assoluzione‖ 47.<br />
All‘obiezione che gli abituati cadono sempre negli stessi peccati<br />
per continua mala volontà, il Frassinetti risponde che l‘abito cattivo non è<br />
sempre argomento <strong>di</strong> continuata mala volontà, ma piuttosto <strong>di</strong> frequente<br />
mala volontà; ―infatti l‘abituato generalmente non pecca per una continuata<br />
mala volontà, ma piuttosto per gli assalti della passione ai quali non sa<br />
resistere...È poi verissimo che l‘abito cattivo rende piú facili le ricadute; ma<br />
da ciò non viene <strong>di</strong> conseguenza che dunque non debba assolversi<br />
l‘abituato; piuttosto ne consegue che si debba assolvere ogni volta che<br />
mostra <strong>di</strong> essere attualmente <strong>di</strong>sposto a ricevere l‘assoluzione, per<br />
corroborarlo con la forza e l‘efficacia del Sacramento.<br />
Nessuno vorrà negare che l‘abituato piú facilmente cadrà,<br />
abbandonato a se stesso, che fortificato dalla grazia sacramentale‖ 48.<br />
Non è vero assolutamente parlando che le ricadute siano<br />
argomento <strong>di</strong> malfermo proposito nelle confessioni antecedenti; il<br />
Frassinetti <strong>di</strong>ce: «assolutamente parlando», in quanto sa benissimo che piú<br />
volte i peccatori ricadono per la ragione che si avvicinano alla Confessione<br />
senza il dovuto pentimento.<br />
Tuttavia egli insiste col <strong>di</strong>re che or<strong>di</strong>nariamente i peccatori, anche<br />
abituati, quando spontaneamente vanno a confessarsi con intenzione <strong>di</strong><br />
riconciliarsi con Dio, <strong>di</strong>staccano veramente il loro cuore dal peccato e sono<br />
decisi <strong>di</strong> non piú ricadervi. Questa volontà <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco dal male si ha assai<br />
facilmente, presupposta la grazia <strong>di</strong> Dio, senza la quale nessuno può<br />
pentirsi salutarmente dei suoi peccati.<br />
Il Frassinetti dopo aver ricordato la dottrina della Chiesa secondo<br />
la quale Dio perdona i peccati a quelli che <strong>di</strong> vero cuore si pentono, non ha<br />
<strong>di</strong>fficoltà a comprendere tra questi anche gli abituati e i reci<strong>di</strong>vi; e, citando<br />
S. Giovanni della Croce, afferma che Dio opera da Dio; e come sono<br />
incomprensibili le opere della sua giustizia, lo sono pure quelle della sua<br />
misericor<strong>di</strong>a.<br />
Sarebbe perciò nostra presunzione voler conoscere adesso quali<br />
numero <strong>di</strong> peccati e quale frequenza <strong>di</strong> ricadute voglia Dio perdonare al<br />
peccatore. Di conseguenza il Confessore <strong>di</strong> fronte al penitente, sia esso<br />
47 Ibidem, p. 575.<br />
48 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 577.<br />
22
eci<strong>di</strong>vo o no, deve contentarsi <strong>di</strong> osservare solo se sia ben <strong>di</strong>sposto con<br />
attuale dolore e proponimento; quin<strong>di</strong> deve assolverlo in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dalle sue precedenti e numerose ricadute.<br />
A coloro poi che potrebbero obiettargli le espressioni S.<br />
Ambrogio, S. Gregorio e S. Isidoro 49, che presi alla lettera proverebbero<br />
che ogni ricaduta è argomento <strong>di</strong> falsa penitenza, il Frassinetti risponde che<br />
questa interpretazione altro non è che la dottrina dei Novaziani e dei<br />
Giansenisti secondo i quali, essendo falsa la penitenza <strong>di</strong> chiunque ricade in<br />
peccato, nessuno, neanche dopo <strong>di</strong>eci o venti anni potrebbe fidarsi della<br />
sua penitenza; e poiché la ricaduta è sempre possibile, non potrebbe fidarsi<br />
della sua penitenza fino al giorno della sua morte.<br />
Ora, essendo chiaro l‘errore <strong>di</strong> questa dottrina, chi affermerà che<br />
come la ricaduta dopo venti, <strong>di</strong>eci, un solo anno non può essere argomento<br />
<strong>di</strong> confessioni mal fatte, lo debba essere invece la ricaduta dopo un mese,<br />
dopo una settimana dopo un giorno?<br />
Il genovese torna quin<strong>di</strong> a sottolineare la sua posizione: ―Nessuno<br />
potrà dubitare, che se il penitente è ben <strong>di</strong>sposto al momento<br />
dell‘assoluzione, riceve il perdono dei peccati; e che se, cangiando <strong>di</strong><br />
volontà, ricadesse non dopo un giorno, ma dopo un minuto, questa<br />
ricaduta non guasterebbe nulla la confessione ultimata un minuto prima‖ 50.<br />
Infine, dopo aver dato la retta interpretazione dei passi dei Santi<br />
Padri, <strong>di</strong> cui sopra, seguendo S. Tommaso 51, precisa che non è sua<br />
intenzione affermare che le ricadute non siano assolutamente causate da<br />
mancanza <strong>di</strong> buone <strong>di</strong>sposizioni in coloro che si confessano, ―ma si vuol<br />
<strong>di</strong>re soltanto che le ricadute per sé non sono, anzi non possono essere<br />
argomento della mancanza <strong>di</strong> buone <strong>di</strong>sposizioni; in quella guisa appunto<br />
che il vedere che uno passeggia, non sarebbe e non potrebbe essere<br />
argomento che egli non fosse prima seduto‖ 52.<br />
Brevemente il Priore <strong>di</strong> S. Sabina osserva che, generalmente<br />
parlando, il Confessore deve credere al penitente, quando seriamente,<br />
senza riserva e titubanza asserisce <strong>di</strong> essere pentito dei suoi peccati e <strong>di</strong><br />
avere fermo proposito <strong>di</strong> non tornare a commetterli.<br />
Il nostro teologo fa notare che questa sua asserzione non può<br />
essere confusa con la proposizione 60 tra le condannate da Innocenzo<br />
49 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 580.<br />
50 Ibidem, p. 581.<br />
51 S. TH. III, q. 84, a, 10, ad 4um.<br />
52 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 581.<br />
23
XI 53; ricordando che quando una proposizione è condannata, si deve<br />
intendere condannata interamente; mentre invece l‘asserto del Frassinetti<br />
non contiene tutta intera la proposizione condannata da Innocenzo XI e<br />
perciò non va soggetta a condanna.<br />
―Bisogna poi osservare <strong>di</strong> piú che nel nostro asserto non v‘ha<br />
nemmeno una parte della proposizione condannata, mentre che noi neppur<br />
<strong>di</strong>ciamo doversi dare l‘assoluzione quando «emendationis spes nulla<br />
appareat» 54.<br />
Prima <strong>di</strong> tutto infatti, il Frassinetti mostra come nel suo asserto<br />
egli voglia porre l‘accento sulla serietà del proposito <strong>di</strong> emendarsi del<br />
penitente; mentre al contrario la proposizione condannata parla, nella<br />
seconda parte, <strong>di</strong> apparente pentimento espresso solo con la bocca; la qual<br />
cosa il nostro teologo non solo reputa empia e falsa, ma anche stolta; infatti<br />
egli <strong>di</strong>ce: ―Qual <strong>di</strong>sposizione potrà essere per il ricevimento<br />
dell‘assoluzione il <strong>di</strong>re semplicemente con la bocca, come potrebbe <strong>di</strong>rlo<br />
un pappagallo: «Mi pento dei miei peccati, e propongo <strong>di</strong> non cadervi piú»?<br />
Un atto cosí materiale <strong>di</strong> bocca, in contrad<strong>di</strong>zione dei sentimenti del cuore,<br />
sarebbe una bugia, una impostura, che non potrebbe aver altro effetto, se<br />
non la profanazione del Sacramento‖ 55.<br />
Messo ben in chiaro questo punto il Frassinetti passa a parlare<br />
dell‘assoluzione in sé considerata e ne mostra l‘importanza data dal fatto<br />
che essa è il mezzo piú efficace <strong>di</strong> giustificazione che possa aversi.<br />
I penitenti potrebbero rimettersi nello stato <strong>di</strong> grazia con la<br />
contrizione; ma questa si trova nei peccatori, piú raramente e piú<br />
<strong>di</strong>fficilmente che l‘attrizione, la quale sola basta a giustificare nel<br />
Sacramento della Penitenza.<br />
―Ora se un me<strong>di</strong>co avesse in pronto un rime<strong>di</strong>o piú efficace al<br />
risanamento del suo malato, potrebbe mai omettere <strong>di</strong> applicarlo, e lasciare<br />
che il suo malato provvedesse da per sé al suo bisogno con rime<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
minore sicurezza ed efficacia? Nessuno perdonerebbe al me<strong>di</strong>co tale<br />
omissione; né noi lo perdoneremmo al Confessore‖ 56.<br />
Di qui, insiste il Frassinetti l‘obbligatorietà per il Confessore <strong>di</strong><br />
dare sempre l‘assoluzione eccetto nei rari casi in cui non si potesse<br />
53 ―Poenitenti habenti consuetu<strong>di</strong>nem peccan<strong>di</strong> contra legem Dei,<br />
Naturae, aut Ecclesiae, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est<br />
deneganda nec <strong>di</strong>fferenda absolutio, dummodo ore proferat se dolore et<br />
proponere emendationem‖.<br />
54 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 582.<br />
55 Ibidem, nota 149, p. 570.<br />
56 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 583.<br />
24
assolutamente, come per esempio se, il peccatore fosse in occasioni libere<br />
<strong>di</strong> peccato che non volesse lasciare.<br />
Come conferma della sua dottrina, il Frassinetti in<strong>di</strong>ca come essa<br />
sia applicata dai Confessori dei luoghi dove piú facilmente si trovano<br />
abituati e reci<strong>di</strong>vi, come carceri, ergastoli etc.<br />
Tali zelanti Confessori infatti negano o meglio <strong>di</strong>fferiscono sí<br />
l‘assoluzione quando trovano i penitenti non <strong>di</strong>sposti al Sacramento;<br />
tuttavia non assegnano loro una lunga <strong>di</strong>lazione.<br />
A tutti gli altri poi, sebbene abituati e reci<strong>di</strong>vi, quando li trovano<br />
ben <strong>di</strong>sposti, danno subito l‘assoluzione anche se prevedono che<br />
ricadranno nuovamente.<br />
Tale poi non è soltanto la pratica <strong>di</strong> Confessori zelanti, che<br />
amministrano il Sacramento della Penitenza a coloro che maggiormente ne<br />
abbisognano; ma tale era pure la pratica dei Santi come per esempio San G.<br />
Crisostomo, San Filippo Neri etc.<br />
A questo punto il Frassinetti nota l‘anacronistica sentenza del<br />
Bellarmino: ―Non esset tanta facilitas peccan<strong>di</strong> si non esset tanta facilitas<br />
absolven<strong>di</strong>‖. Sentenza che poteva essere ottima ai suoi tempi data la grande<br />
ignoranza della maggior parte del clero, ma che adesso, data una generale<br />
profonda conoscenza della morale da parte <strong>di</strong> tutto il clero, il Bellarmino<br />
stesso muterebbe, a <strong>di</strong>re del Frassinetti, in quest‘altra: ―Maior esset<br />
concursus peccatorum ad Sacramenturn poenitentiae, si esset maior<br />
facilitas absolven<strong>di</strong>‖ 57, sentenza che concorda con quella<br />
dell‘Eminentissimo Gousset: ―quanto piú la fede si è indebolita fra noi,<br />
tanto piú è necessario far uso <strong>di</strong> con<strong>di</strong>scendenza verso i peccatori che<br />
ritornano a Dio‖ 58.<br />
Il teologo genovese conclude infine questa Dissertazione con un<br />
tratto del Catechismo romano che conferma la sua tesi con l‘autorità del<br />
Concilio <strong>di</strong> Trento, e brevemente riepiloga la propria posizione: ―Dopo le<br />
quali cose dovremo persuaderci, che quando il Confessore probabilmente<br />
può giu<strong>di</strong>care che il suo penitente «hic et nunc» sia <strong>di</strong>sposto all‘assoluzione,<br />
ancorché sia abituato o reci<strong>di</strong>vo, purché non sia in occasione prossima e<br />
libera <strong>di</strong> peccato che non voglia abbandonare, lo debba assolvere tolto il<br />
caso in cui la <strong>di</strong>lazione dell‘assoluzione si dovesse tentare come estremo<br />
rime<strong>di</strong>o per scuoterlo da un funesto letargo, da cui per altro modo non si<br />
volesse risvegliare‖ 59.<br />
57 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 589.<br />
58 Cf. Ibidem, p. 589.<br />
59 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 590.<br />
25
A conclusione <strong>di</strong> questa Dissertazione, sembrerebbe ovvio fare un<br />
bilancio <strong>di</strong> questo accostamento fra il pensiero del grande Vescovo <strong>di</strong> S.<br />
Agata dei Goti e quello, senza pretese forse, ma non meno profondo del<br />
«Liguori ligure» 60 come qualcuno ha voluto chiamare il Frassinetti.<br />
Ma noi anche in questa parte abbiamo voluto seguire il metodo<br />
precedente, cioè <strong>di</strong> presentare ed accostare i due pensieri, le due dottrine<br />
cosí come si presentano senza voler fare una vera e propria analisi critica,<br />
conservando cosí l‘unità del pensiero e la freschezza delle immagini e del<br />
linguaggio. Tuttavia balza imme<strong>di</strong>atamente agli occhi lo spirito<br />
sinceramente e pastoralmente paterno del nostro Fondatore che si getta<br />
allo sbaraglio per <strong>di</strong>fendere e salvare i suoi figli. E qui i suoi figli sono i<br />
peccatori; reci<strong>di</strong>vi o no, per il nostro venerabile Padre essi sono dei<br />
penitenti da curare, da salvare, subito, fino al limite del possibile per non<br />
rendere vana la grazia misericor<strong>di</strong>osa del Cristo.<br />
È l' «hic et nunc» ripetuto assai frequentemente nelle pagine del<br />
Frassinetti che costringe il Direttore <strong>di</strong> spirito a riflettere intensamente sulla<br />
assoluta necessità <strong>di</strong> rimandare purificata, libera, risorta, ogni anima —<br />
fatte le debite e rare eccezioni — reci<strong>di</strong>va o no, che a lui chiede salvezza,<br />
che a lui si rivolge come all‘unica sorgente <strong>di</strong> vita.<br />
Ed ecco allora come risuonano profondamente vere le parole del<br />
Frassinetti frutto <strong>di</strong> una me<strong>di</strong>tata e sofferta esperienza: ―Un sacerdote<br />
intollerante dai mo<strong>di</strong> rozzi e villani delle persone ineducate, delle caparbietà<br />
e bizzarrie dei cervelli balsani, dell‘incostanza dei reci<strong>di</strong>vi; un sacerdote che<br />
si abbandonasse a un continuo scrupoleggiare su tutti i dubbi ed<br />
apprensioni che gli vengono in capo, sempre sospettoso che il penitente si<br />
confessi male, sempre dubbioso <strong>di</strong> non interrogare sufficientemente, etc.,<br />
come potrebbe reggere a confessare le lunghe ore? anzi <strong>di</strong>co <strong>di</strong> piú, come<br />
potrebbe confessare con frutto?‖ 61.<br />
Parte V<br />
Dissertazione XV «Sulla pratica <strong>di</strong> ascoltare le Confessioni».<br />
Il Frassinetti seguendo il suo scopo, cioè dare ai Confessori un<br />
manuale pratico e <strong>di</strong> facile consultazione, raggruppa in questa<br />
Dissertazione, piú o meno rielaborati alla luce della sua grande esperienza,<br />
60 Cf. G. CAPURRO, G. Frassinetti e l’opera sua, Genova, tip. della<br />
Gioventú, 1908, pp. 4—5, 13.<br />
61 G. FRASSINETTI, Manuale pratico del Parroco Novello, Alba, ed.<br />
Paoline, 1964, pp. 25—26.<br />
26
vari punti, trattati da S. Alfonso in <strong>di</strong>verse parti, specie nel Trattato Ultimo<br />
dell‘ «Homo Apostolicus» 62.<br />
Paragrafo I «Sull‘assiduità al Confessionale»<br />
―Nel confessionale il ministro <strong>di</strong> Dio può fare il maggior bene,<br />
perché quivi è dove sì sra<strong>di</strong>cano i vizi dalle anime cristiane, e dove si<br />
inseriscono le virtú. La conversione dei peccatori e il progresso nella<br />
santificazione dei giusti si opera segnatamente nel confessionale‖ 63.<br />
Cosí inquadrata l‘importanza della missione del Confessore, il<br />
nostro autore, oltre ad esortare i suoi confratelli ad una assiduità al<br />
confessionale, scioglie alcuni loro dubbi, specie quelli riguardanti la loro<br />
vita spirituale.<br />
A coloro, ad esempio, che insistono sulla necessità della<br />
me<strong>di</strong>tazione e delle altre pratiche da farsi in modo meto<strong>di</strong>co, che deve cioè<br />
passare avanti anche alle richieste dei penitenti, il Frassinetti subito<br />
risponde: ―Una lunga esperienza mi ha insegnato, e mi ha fatto toccare con<br />
mano, che la mancanza <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tazione meto<strong>di</strong>ca non impe<strong>di</strong>sce né ai<br />
sacerdoti, né ai secolari, <strong>di</strong> adempiere bene ai doveri del loro stato, o <strong>di</strong><br />
aspirare con buon successo a vita <strong>di</strong> perfezione‖ 64.<br />
In altra sua opera <strong>di</strong> carattere prettamente pastorale quale il<br />
«Manuale pratico del Parroco Novello», compen<strong>di</strong>a la sua opinione a<br />
riguardo con un bellissimo esempio tolto, come è nel suo stile, dal vivere<br />
comune, dall‘esperienza quoti<strong>di</strong>ana: ―La pietà meto<strong>di</strong>ca e misurata non fa<br />
pei parroci, come un vivere regolare e compassato non fa per le madri.<br />
È necessario che le madri mangino, dormano, si <strong>di</strong>ano un po‘ <strong>di</strong><br />
sollievo; ma fanno tutto ciò in una specie <strong>di</strong> <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne, e quando l‘assidua<br />
cura dei figlioli loro lo permette; ciò non ostante, godono salute<br />
prosperosissima, piú che non la godano tante altre donne che fanno vita<br />
assai regolata.<br />
Similmente, i parroci devono provvedersi dell‘alimento e riposo<br />
spirituale, che sta in gran parte nell‘orazione interiore, ma quando loro lo<br />
permette la cura delle anime e spesso poco regolarmente: né per questo è<br />
da credere, che sarà in loro minor fortezza o pingue<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> spirito che negli<br />
altri. ecclesiastici piú regolari e meto<strong>di</strong>ci.<br />
62 Cf. ―Schema comparativo dell'esercitazione‖, p. 7.<br />
63 G.FRASSINETTI, op. cit., p. 594.<br />
64 G. FRASSINETTI, op. cit., pag. 594.<br />
27
E che? Si dovrà supporre che la grazia provveda meno al bisogno<br />
spirituale del parroco, <strong>di</strong> quello che la natura provveda al bisogno corporale<br />
della madre‖ 65.<br />
Paragrafo 2 «Avvertenze per la confessione degli uomini»<br />
Come abbiamo precedentemente notato, il Frassinetti fa sua e<br />
rielabora alla luce della propria esperienza, norme pratiche <strong>di</strong> pastorale sulla<br />
Confessione degli uomini.<br />
Prima <strong>di</strong> tutto il Confessore non deve farli attendere e inoltre deve<br />
preferire le loro confessioni a quelle delle donne, e <strong>di</strong> anime devote, come<br />
S. Alfonso stesso consiglia 66.<br />
―Le seconda avvertenza è <strong>di</strong> accoglierli sempre in modo non solo<br />
urbano, ma allegro e festivo, quasi li riesca <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>to trattenimento<br />
ascoltarne le confessioni... Quanto l‘ilarità e il parlare festivo e amorevole è<br />
sempre da evitarsi dai ministri <strong>di</strong> Dio, si abbiano a parlare con le donne;<br />
tanto per lo contrario è sempre da adoperarsi da essi con gli uomini‖ 67.<br />
Infine il Confessore, evitando <strong>di</strong> suggerire agli uomini. regole <strong>di</strong><br />
perfezione, dovrà accontentarsi <strong>di</strong> inculcare nei loro cuori l‘o<strong>di</strong>o al peccato<br />
mortale e l‘adempimento dei precetti, mostrandosi con essi franco,<br />
<strong>di</strong>sinvolto, indulgente e benigno.<br />
Paragrafo III «Avvertenza per la Confessione delle donne».<br />
Il Priore <strong>di</strong> S. Sabina segue in tale argomento, il pensiero <strong>di</strong> S.<br />
Alfonso 68, esortando il Confessore a tenere, per superare, questo scoglio<br />
delle Confessioni delle donne, dando consigli pratici sul sistema migliore<br />
per esplicare <strong>di</strong>ligentemente il ministero conservando ―quella in<strong>di</strong>fferenza<br />
ed insensibilità, che non si può bastantemente apprezzare‖ 69.<br />
65 G. FRASSINETTI, Manuale pratico del Parroco Novello, p. 269.<br />
66 S. ALFONSO, op. cit., tract. ult., n. 55; ―Deinde confessarius non adeo<br />
mulierum confessionibus sit ad<strong>di</strong>ctus, ut per hoc homines ad se venientes<br />
au<strong>di</strong>re recuset...unde fit, ut isti, non invenientes cui sua peccata<br />
confiteantur, vivant per tot menses et annos sine Sacramentis, et sine<br />
Deo‖.<br />
67 G. FRASSINETTI, Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia Morale, p. 597.<br />
68 S. ALFONSO, op. cit., tract. ult. n. 55.<br />
69 G. FRASSINETTI, ibidem, p. 598.<br />
28
Paragrafo IV «Avvertenze per la Confessione dei fanciulli»<br />
È interessante notare come il Frassinetti prende tanto a cuore il<br />
problema dei fanciulli a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> molti altri teologi e sacerdoti, lo<br />
stesso S. Alfonso sbriga la questione senza <strong>di</strong>lungarsi eccessivamente né<br />
<strong>di</strong>stinguere sufficientemente.<br />
Il nostro venerabile Padre lo fa notare senza reticenza ed impugna<br />
con energia un problema <strong>di</strong> fondamentale importanza.<br />
Certamente questa sua cura per i fanciulli gli derivava dalla loro<br />
conoscenza <strong>di</strong>retta lungo tutti i suoi trenta anni <strong>di</strong> attività parrocchiale. A<br />
convincersi <strong>di</strong> questo basta scorrere le numerose pubblicazioni da lui fatte<br />
per la cura dei ragazzi.<br />
Non possiamo <strong>di</strong>menticare inoltre la grande amicizia e i contatti<br />
che egli ebbe con il piú grande apostolo della gioventú del secolo XIX:<br />
Don Bosco. Ma certamente tanta de<strong>di</strong>zione verso i piccoli gli veniva da un<br />
assiduo quanto profondo stu<strong>di</strong>o della vita del Cristo e non poteva non<br />
sentire continuamente risuonare alle sue orecchie il monito evangelico: ―se<br />
non <strong>di</strong>venterete come fanciulli non entrerete nel regno dei cieli‖ 70. Ed è<br />
proprio su questo ammonimento del Divino Maestro che si basa tutto lo<br />
slancio pastorale che pervade queste pagine del Frassinetti.<br />
―Il Confessore zelante ed illuminato fa molto conto delle<br />
confessioni dei fanciulli, s‘intende anche <strong>di</strong> quelli che non sono ancora<br />
ammessi alla <strong>Santa</strong> Comunione. Li confessa quin<strong>di</strong> volentieri e dà loro la<br />
sacramentale assoluzione‖ 71.<br />
Questa precisazione del Frassinetti <strong>di</strong> assolvere anche i fanciulli<br />
non ancora ammessi alla S. Comunione è molto pertinente data la tendenza<br />
<strong>di</strong> alcuni dottori del tempo, che si basavano sulla dottrina <strong>di</strong> S. Alfonso, <strong>di</strong><br />
rimandare tali fanciulli con una semplice bene<strong>di</strong>zione.<br />
Il Priore <strong>di</strong> S. Sabina non esita a schierarsi nettamente contro il<br />
suo stesso grande Maestro e talvolta non risparmia termini forti, ―Vuol<br />
<strong>di</strong>re dunque secondo quanto essi (dottori) pensano che allora importa aver<br />
l‘anima pura dai peccati quando si abbia a ricevere il S. Sacramento, e che<br />
in caso <strong>di</strong>verso importi nulla tenerla macchiata <strong>di</strong> colpa.<br />
Dicono col fatto: non vi è pericolo <strong>di</strong> Comunione sacrilega<br />
dunque si può risparmiare l‘assoluzione, si può lasciare l‘anima in peccato.<br />
Ma Cristo ha istituito il Sacramento della Penitenza perché i<br />
cristiani possano con questo riacquistare la <strong>di</strong>vina grazia, se l‘hanno<br />
perduta; o l‘ha istituito soltanto perché non facciano Comunioni<br />
70 Mt 18,3.<br />
71 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 600.<br />
29
sacrileghe? L‘irragionevolezza <strong>di</strong> tale pratica dovrebbe capirsi non solo dai<br />
confessori che hanno stu<strong>di</strong>ato teologia, ma dagli stessi fanciulli che hanno<br />
stu<strong>di</strong>ato appena il piccolo Catechismo?.<br />
Inoltre è cosa ben da notare che i piú rigorosi in morale, sono<br />
quelli che tante volte, per meglio accertarsi <strong>di</strong> non commettere errori ne<br />
commettono in gran numero; per evitare ogni pericolo <strong>di</strong> dare ai fanciulli<br />
qualche assoluzione indebita si mettono nella certezza <strong>di</strong> negare loro tutte<br />
le assoluzioni debite‖ 72.<br />
Continuando la sua Dissertazione, il nostro teologo confuta<br />
facilmente alcune ragioni ritenute valide dai teologi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferente opinione<br />
per negare l‘assoluzione ai fanciulli non ancora comunicati, e pone<br />
nuovamente l‘accento sulla assoluta necessità <strong>di</strong> assolvere i ragazzi come gli<br />
adulti ogni volta che si confessano, se sono <strong>di</strong>sposti o <strong>di</strong>sponibili.<br />
Il Frassinetti, anima ardentemente portata e de<strong>di</strong>ta all‘educazione e<br />
cura della gioventú, se ne fa tenace <strong>di</strong>fensore, provando che il vero motivo<br />
dell‘agire <strong>di</strong> dotti teologi è fondato su ben altra obiezione ―che, in verità,<br />
non saprebbe sciogliere con ragioni neppure S. Tommaso‖ 73, cioè che<br />
NON SI VUOL PERDERE TEMPO CON I FANCIULLI.<br />
―Se si ha da dar loro l‘assoluzione, è necessario attendere<br />
all‘integrità della Confessione, eccitarli al dolore, proponimento, etc.; tutte<br />
cose che si possono tralasciare se si ha da dare una semplice bene<strong>di</strong>zione;<br />
quin<strong>di</strong> col dar loro la semplice bene<strong>di</strong>zione si sbrigano assai piú presto.<br />
Perciò è da pregare il Signore che ci conceda zelo illuminato; ed ottenuto<br />
questo zelo, arderemo della brama <strong>di</strong> giovare alla piú cara porzione del<br />
popolo cristiano, quali sono i fanciulli riguardati al lume della fede 74.<br />
72 G. FRASSINETTI, op, cit., p. 603.<br />
73 Ibidem, p. 608.<br />
74 Quanto questo argomento stia a cuore al Frassinetti lo si può vedere da<br />
molti suoi altri scritti, fra l’altro in ―Gesú Cristo Regola del Sacerdote‖,<br />
32 ed., Roma, 1966, p. 34, mette sulle labbra <strong>di</strong> Nostro Signore questa<br />
calda esortazione al Sacerdote:<br />
―Tu farai cosa doverosa e sommamente a me grata, sviluppando in<br />
quelle vergini anime i sentimenti dell’amor mio, perché miei siano i primi<br />
affetti dei loro cuori, Essi sono le primizie che voglio: atten<strong>di</strong> bene<br />
affinché non ne resti defraudato...<br />
Ora lascio pensare a te che cosa dovrei <strong>di</strong>re a quegli orgogliosi, tanto<br />
stupi<strong>di</strong>, che credono quasi <strong>di</strong> avvilirsi, occupandosi dell’istruzione e della<br />
cura dei fanciulli, Ohimè, vi sono <strong>di</strong> tali anche tra i pastori delle anime!‖.<br />
30
Quin<strong>di</strong> non crederemo <strong>di</strong> perdere il tempo ascoltandone pazientemente e<br />
<strong>di</strong>ligentemente le confessioni‖ 75.<br />
Nella seconda parte <strong>di</strong> questa Dissertazione il Frassinetti sviluppa<br />
la Pastorale della Confessione dei fanciulli e si riallaccia, dopo la breve<br />
schermaglia <strong>di</strong> idee precedenti, con il metodo usato da S. Alfonso 76.<br />
Paragrafo V «Avvertenze per le confessioni delle persone pie»<br />
Ricalcando la dottrina del Santo Dottore napoletano 77, il<br />
Frassinetti dà norme pratiche sul modo <strong>di</strong> confessare le persone pie<br />
insistendo che la cura <strong>di</strong> queste deve essere particolarmente moderata per<br />
attendere sopratutto alle Confessioni dei peccatori, che hanno molto piú<br />
bisogno del Sacramento della Penitenza,<br />
Paragrafo VI «Sulla <strong>di</strong>rezione delle anime che hanno grazie straor<strong>di</strong>narie da<br />
Dio»<br />
È interessante osservare lo spirito <strong>di</strong> umiltà che anima il nostro<br />
autore ad affidarsi in tale questione all‘esperienza <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> Santi, come S.<br />
Alfonso e S. Teresa: ―Vorrei che il Confessore stu<strong>di</strong>asse almeno la breve<br />
appen<strong>di</strong>ce che ha scritto S. Alfonso annettendola alla sua Morale:<br />
Appen<strong>di</strong>x 1: Quomodo se gerere debeat confessarius in <strong>di</strong>rigen<strong>di</strong>s<br />
animabus spiritualibus‖ 78.<br />
Veramente è poca cosa ed estremamente concisa; tuttavia non<br />
lascia che il Direttore, sia del tutto <strong>di</strong>giuno della scienza mistica.<br />
―Vorrei pure che leggesse le opere <strong>di</strong> S. Teresa, dalle quali<br />
ricaverebbe molti lumi e un pascolo singolare del proprio spirito. Si <strong>di</strong>rebbe<br />
che queste opere non si possano leggere da alcuno senza che ne ricavi assai<br />
frutto‖ 79.<br />
CONCLUSIONE<br />
Questo nostro lavoro cosí frammentario e incompleto sarebbe<br />
certamente <strong>di</strong> quasi nessun aiuto per chi volesse conoscere il Frassinetti e<br />
l‘opera sua; ci consola però il fatto <strong>di</strong> avere iniziato un lavoro che non ha<br />
75 G. FRASSINETTI, Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia Morale, p. 603.<br />
76 S. ALFONSO, Homo Apostolicus, tract, ult., nn. 33—39.<br />
77 S. ALFONSO, op. cit., tract. ult., nn. 43—44.<br />
78 Ibidem, Appen<strong>di</strong>x 1, nn. 1—38.<br />
79 G. FRASSINETTI, op. cit., p. 621.<br />
31
precedenti ma che sicuramente merita <strong>di</strong> essere continuato. Certamente<br />
non si potrebbe dare cosí in succinto un‘idea chiara e precisa dello opere<br />
molteplici e varie del venerato Priore: ci vorrebbe ben altro e piú ampio<br />
lavoro.<br />
Abbiamo spesso notato come il Priore <strong>di</strong> S. Sabina sia fedelissimo<br />
al Santo Dottore napoletano e ne segua costantemente la dottrina<br />
aggiungendo però importantissime e quanto mai opportune note e<br />
<strong>di</strong>ssertazioni che rivelano come l‘autore, immedesimatosi completamente<br />
nello spirito del suo grande Maestro ne abbia però sviluppato, allargato,<br />
precisato e talvolta corretto i lineamenti della sua opera secondo una piú<br />
larga visione derivatagli dallo stu<strong>di</strong>o profondo della dottrina della Chiesa e<br />
dalla possibilità <strong>di</strong> avere sott‘occhio le conseguenze, i risultati pratici del<br />
grande impulso dato alla Morale Cattolica dal Santo Vescovo napoletano.<br />
I raffronti fra S. Alfonso e il Frassinetti sono frequenti negli<br />
stu<strong>di</strong>osi specie della fine del secolo XIX e dei primi decenni del XX<br />
secolo. 80<br />
Il Capurro nel suo «Stu<strong>di</strong>o storico—critico» dell‘opera del teologo<br />
genovese, <strong>di</strong>ce con trasporto: ―Come nel secolo <strong>di</strong> Voltaire, malaugurato<br />
corifero dell‘anticristianesimo, la Provvidenza suscitava un S. Alfonso; cosí<br />
al secolo <strong>di</strong> Mazzini e <strong>di</strong> Gioberti, giu<strong>di</strong>chiamo, donasse la stessa<br />
Provvidenza <strong>di</strong>vina un Frassinetti‖ 81.<br />
È interessante un accostamento del nostro venerato Padre al S.<br />
Curato d‘Ars da parte del gesuita P. Miraboau, nella prefazione alla sua<br />
traduzione francese del libretto del Frassinetti, «Gesú Cristo Regola del<br />
Sacerdote» (Paris 1881): ―Il fut au delà des Alpes comme un autre Curé<br />
d‘Ars; et si la France a le droit de se glorifier du Vénerable J. B. Marie<br />
Vianney, l‘Italie peut aussi a juste titre se glorifier du regretté Prieur de<br />
Sainte Sabine‖ 82.<br />
Ma senza dubbio, l‘accostamento piú naturale è quello con S.<br />
Alfonso; anzi per meglio comprendere come possa essere ragionevole il<br />
confronto, pren<strong>di</strong>amo dal Capurro il seguente specchietto che rivela come<br />
80 Cf. SCAVINI, Theologia Moralis Universa, Milano 1865.<br />
GURY—BALLERINI, Compen<strong>di</strong>um Theologiae Moralis, 2a ed., Roma—<br />
Torino 1869.<br />
BERARDI, Praxis Confessariorum, 3a ed., Faventiae 1899.<br />
E. GENICOT, Casus Conscientiae, 6a ed., Bruxelles, 1909.<br />
81 G. CAPURRO, G. Frassinetti e l’opera sua, Genova, tip. della Gioventù,<br />
1903, p. 4.<br />
82 Cf. G. CAPURRO, Ibidem, p. 4, nota 2.<br />
32
il Frassinetti abbia lavorato, si può <strong>di</strong>re, quasi sulle tracce del Santo<br />
Vescovo <strong>di</strong> S. Agata dei Goti.<br />
Molte delle opere del Frassinetti portano quasi lo stesso titolo <strong>di</strong><br />
quelle del Liguori. Fra le tante ne citiamo solo alcune.<br />
S. ALFONSO G. FRASSINETTI<br />
Pratica della perfezione<br />
Arte <strong>di</strong> farsi santi<br />
Trattato della preghiera Il Pater noster <strong>di</strong> S. Teresa ossia<br />
trattato sulla preghiera<br />
Consigli <strong>di</strong> confidenza per anima Conforto dell‘anima <strong>di</strong>vota<br />
desolata<br />
Avvertimenti per sacerdoti sulla Gesú Cristo regola del sacerdote<br />
Messa e l‘Officio<br />
Le glorie <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Avviamento dei giovinetti alla<br />
devozione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>. Ora <strong>di</strong><br />
allegrezza. Le do<strong>di</strong>ci stelle<br />
Sullo stato religioso<br />
Scelta <strong>di</strong> uno stato<br />
Teologia morale<br />
Visite al Santissimo<br />
Verità della fede<br />
Pratica <strong>di</strong> amare Gesú Cristo<br />
Visita a <strong>Maria</strong><br />
Teologia morale<br />
Convito del Divino Amore<br />
Catechismo dogmatico<br />
Amiamo Gesú<br />
Amiamo <strong>Maria</strong><br />
Devozione a San Giuseppe Amiamo S. Giuseppe. Vita <strong>di</strong> S.<br />
Giuseppe<br />
Riflessioni ai vescovi Proposte agli ecclesiastici<br />
Brevi parole ai sacerdoti fratelli<br />
Manuale pratico del parroco<br />
novello<br />
33
Monaca santa La monaca in casa.<br />
Religioso al secolo 83<br />
Anche le «Letture Cattoliche» <strong>di</strong> Genova 84, scrivevano a proposito<br />
del suo libretto «Amiamo S. Giuseppe»: ―Esso è scritto in quello stile piano<br />
e facile che fa del Frassinetti un altro Liguori, come un altro Liguori può<br />
<strong>di</strong>rsi per la varietà degli scritti da esso lasciati‖.<br />
Un altro rilevante punto <strong>di</strong> incontro lo abbiamo dalla lotta senza<br />
quartiere che entrambi scatenarono contro il Giansenismo.<br />
È universalmente nota la tremenda quanto provvidenziale e<br />
decisiva «mazzata» che S. Alfonso seppe dare con la sua dottrina al<br />
Giansenismo e al Gallicanesimo imperanti nel secolo XVIII; ma non meno<br />
energiche e provvidenziali furono le dottrine del Frassinetti che concorsero<br />
mirabilmente a far scomparire dalla terra e dalla Liguria in particolare i<br />
residui <strong>di</strong> sí erronee teorie.<br />
Ma prima che con le opere, egli fece la confutazione <strong>di</strong> quegli<br />
errori con la sua vita che fu tutta stretto rigore nel regolare se stesso e tutta<br />
dolcezza blanda e compassionevole per gli altri.<br />
―Il piú bel trattato contro il Giansenismo — afferma il già citato<br />
Capurro — è la vita del Frassinetti!‖. E ancora: ―I giansenisti toglievano a<br />
Dio la paternità, e il Frassinetti invece, come già il pio vescovo <strong>di</strong> S. Agata,<br />
fu tra coloro che restituirono a Dio l‘aureola <strong>di</strong> padre amoroso, cioè la sua<br />
somma bontà‖ 85.<br />
Piú sotto infine parlando dell‘importanza nella lotta<br />
antigiansenistica della «Teologia Morale» del Frassinetti, trattato-commento<br />
all‘«Homo Apostolicus» <strong>di</strong> S. Alfonso afferma senza esitare che ―egli ha<br />
spianato ancora <strong>di</strong> piú, sempre sulla scorta del suo grande maestro, la via al<br />
confessionale; in luogo del rigore vi ha stabilito la bontà, e a <strong>di</strong>r tutto con<br />
una sola frase, a fianco del giu<strong>di</strong>ce vi ha collocato il padre‖ 86.<br />
È questo l‘aspetto forse piú interessante e attraente <strong>di</strong> tutte le<br />
opere, morali e ascetiche, e <strong>di</strong> tutta la vita del nostro amato Fondatore e<br />
meriterebbe uno stu<strong>di</strong>o tutto particolare 87. Noi conclu<strong>di</strong>amo questo nostro<br />
83 G. CAPURRO, op. cit., p. 4.<br />
84 Letture Cattoliche, Genova, 1870, p. 97.<br />
85 G. CAPURRO, op. cit., p. 14.<br />
86 G. CAPURRO, op. cit., p. 16.<br />
87 Bastano questo parole <strong>di</strong> esortazione ai Confessori per mostrarci<br />
chiaramente come il Frassinetti considerasse la virtú della carità come<br />
l'anima della morale. Egli fa <strong>di</strong>re al Signore:<br />
34
lavoro, purtroppo troppo scolastico per essere attraente, con una<br />
esortazione ai Sacerdoti, che il Frassinetti mette sulle labbra <strong>di</strong> Gesú:<br />
―Questo poi ti raccomando sommamente: accogli i peccatori con tutta<br />
carità e con maniere amorevoli, affinché non si spaventino e non si ritirino<br />
da te, che devi essere il loro me<strong>di</strong>co…<br />
Anche tu sei peccatore e hai bisogno della mia misericor<strong>di</strong>a;<br />
secondo la mia promessa, tanta ne userò con te quanta ne avrai usata con i<br />
peccatori tuoi fratelli: ―Eadem mensura qua mensi fueritis, rementietur<br />
vobis‖ (Lc 6,38)‖ 88.<br />
Luciano Bosia fsmi<br />
Luigi Pagliantini fsmi<br />
―Atten<strong>di</strong> specialmente ad accogliere con maniera caritatevole i poveri<br />
peccatori, quando si presentano ai tuoi pie<strong>di</strong> per confessare le loro colpe:<br />
siano queste anche gravissime, siano i peccatori tuttora mal <strong>di</strong>sposti, tu<br />
ricevili con somma carità, come comporta il loro bisogno...<br />
I miei ministri devono pensare che i peccatori, quanto più sono rei, e<br />
meno <strong>di</strong>sposti, tanto piú meritano compassione e carità maggiore; e<br />
pensino che poi domanderò loro conto della rovina <strong>di</strong> quelle anime‖,<br />
Gesú, Cristo regola del sacerdote, 32e, ed., Roma 1966, p. 81.<br />
88 G. FRASSINETTI, Gesú Cristo regola del sacerdote, pp 78-79.<br />
35
IL FRASSINETTI E LO ZELO CATECHISTICO<br />
Porto – Fiumicino<br />
Noviziato 1967/68<br />
SOMMARIO<br />
Il suo zelo catechistico<br />
Capitolo Primo<br />
La sua azione catechistica verso i bambini<br />
Capitolo Secondo<br />
La sua azione catechistica verso i giovani<br />
Capitolo Terzo<br />
Il suo zelo catechistico verso gli adulti<br />
Capitolo Quarto<br />
Il catechismo nei suoi scritti<br />
Conclusione<br />
IL SUO ZELO CATECHISTICO<br />
In quest‘anno in cui ricorre il primo centenario della morte del<br />
Sac. Giuseppe Frassinetti, è bene far risaltare la sua grande figura mettendo<br />
in luce qualche elemento del suo vasto apostolato. Dai suoi scritti e da<br />
tutto il complesso della sua attività, appare chiaramente che egli si de<strong>di</strong>cò<br />
con grande zelo e spirito <strong>di</strong> sacrificio all‘insegnamento del Catechismo. Egli<br />
era talmente penetrato dell‘importanza e della sublimità <strong>di</strong> quest‘opera, da<br />
considerarla la base del suo sacerdozio e da promuoverla con qualsiasi<br />
mezzo.<br />
Infatti, per non parlare <strong>di</strong> tutta la pre<strong>di</strong>cazione da lui svolta, scrisse<br />
tre volumi <strong>di</strong> «Istruzioni Catechistiche» e tanti altri opuscoli per trasmettere<br />
e fomentare questo suo zelo anche nel clero che purtroppo non era sempre<br />
all‘altezza <strong>di</strong> fronteggiare questo grave problema. A poche persone<br />
giungeva la dottrina, proprio perché molti sacerdoti non sapevano<br />
avvicinarsi a loro nel modo <strong>di</strong> parlare, <strong>di</strong> pensare e si <strong>di</strong>lungavano troppo<br />
nelle loro esposizioni senza andare al concreto delle cose. Il Frassinetti,<br />
consapevole <strong>di</strong> questo grave errore si era formato delle norme pratiche per<br />
l‘insegnamento del Catechismo a tutte le categorie della società.<br />
36
CAPITOLO I<br />
LA SUA AZIONE CATECHISTICA VERSO I BAMBINI<br />
Per i bambini il Frassinetti aveva molta cura e li coltivava come i<br />
fiori del suo giar<strong>di</strong>no per farli crescere robusti, profumati e intatti nel loro<br />
candore. Essi non costituivano una preoccupazione per molti parroci che,<br />
impegnati in altre opere <strong>di</strong> apostolato, li abbandonavano tanto piú che per<br />
essi non vi era il catechismo in preparazione alla S. Comunione.<br />
Per questa situazione i bambini, specialmente quelli <strong>di</strong> famiglie<br />
poco buone e povere, erano abbandonati a se stessi, non avevano nessuno<br />
che insegnasse loro nemmeno le norme principali dell‘educazione; <strong>di</strong>nanzi<br />
a loro si prospettava un avvenire triste e burrascoso.<br />
Il Frassinetti cercò a poco a poco nell‘ambito della sua parrocchia<br />
<strong>di</strong> radunare questi bambini e <strong>di</strong> farli affezionare alla Chiesa. Diede loro<br />
nozioni <strong>di</strong> educazione, fece del tutto per renderli felici e riempí il vuoto del<br />
loro cuore con l‘amore <strong>di</strong> Gesú e <strong>Maria</strong>.<br />
Parlando una volta a dei sacerdoti circa l‘istruzione da farsi ai<br />
bambini, manifesta i suoi punti base che si fondano sulle principali norme<br />
pedagogiche:<br />
1. Usare tanta comprensione verso tutti i fanciulli, ma<br />
specialmente verso quelli trasandati e negligenti, avvicinandoli e<br />
parlando loro in modo da interessarli alla scuola catechistica.<br />
2. Nella scuola non deve regnare un clima rigoroso, ma<br />
piuttosto paterno, poiché i bambini se si sentono ben voluti<br />
corrispondono al loro maestro con l‘attenzione e la frequenza.<br />
3. Non rimproverarli mai con rigore se non quando non<br />
possa riprenderli <strong>di</strong> peccato, cioè <strong>di</strong>re al fanciullo: Ti sgrido e ti<br />
castigo perché tu hai fatto una cosa che il farla è peccato.<br />
4. Adattarsi a loro per tutto quello che è possibile, esponendo<br />
le verità in modo semplice e frammischiate da buoni racconti e<br />
massime morali adatte alla loro intelligenza.<br />
5. L‘insegnamento della dottrina non deve essere un<br />
insegnamento nudo e secco delle verità della fede, ma deve essere<br />
sugoso, cosí mentre illumina la mente, forma il cuore. 89<br />
Nel suo terzo volume <strong>di</strong> «Istruzioni catechistiche al popolo» parla<br />
con chiarezza delle norme da instillare nei fanciulli, affinché già da piccoli<br />
possano assimilare i concetti piú importanti della fede.<br />
89 Cf CARLO OLIVARI, Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe<br />
Frassinetti, Roma, 1928, pag. 298.<br />
37
Eccole brevemente esposte:<br />
1. Dio ci ha messo al mondo non per mangiare e <strong>di</strong>vertirci, ma per<br />
conoscerlo, amarlo e raggiungerlo in para<strong>di</strong>so.<br />
2. La grazia <strong>di</strong> Dio è l‘unico vero tesoro che vi è nel mondo.<br />
3. La peggior cosa <strong>di</strong> questo mondo è il peccato, il quale ci priva<br />
della grazia <strong>di</strong> Dio.<br />
4. ―Sarebbe meglio tenere un serpente vivo in seno che un peccato<br />
nell‘anima‖.<br />
5. Un vero devoto della Madonna non è mai dannato.<br />
―Bisogna istillare nel cuore dei fanciulli questa devozione tenera e<br />
fervente, procurando che considerino <strong>Maria</strong> come la piú buona madre e a<br />
Lei ricorrano in tutti i bisogni.<br />
Se queste massime entreranno nel cuore dei fanciulli e dei giovani,<br />
ai quali si insegna la dottrina cristiana, essi si formeranno al bene e alla<br />
pietà molto facilmente, e queste buone massime, impresse nella loro prima<br />
età, non si cancelleranno mai piú in avvenire‖ 90.<br />
Queste norme che riassumono il comportamento del catechista<br />
verso i bambini, rivelano nel Frassinetti un insegnante modello, che sa<br />
comprendere i bambini, sa amarli ed avviarli nella strada della vita.<br />
CAPITOLO II<br />
LA SUA OPERA CATECHISTICA VERSO I GIOVANI<br />
Se per i fanciulli il Frassinetti si preoccupava tanto, affinché un<br />
domani potessero <strong>di</strong>venire dei buoni cristiani, tanto piú gli adolescenti e i<br />
giovani che incominciavano ad affrontare la vita e dovevano decidere<br />
definitivamente sul loro avvenire.<br />
Egli fu infatti un provvidenziale apostolo della gioventú genovese,<br />
animato dagli stessi ideali che fecero grande e santo Giovanni Bosco. Dalle<br />
sue opere e dai suoi scritti ci appare con tutte le qualità del buon educatore<br />
e padre spirituale; un‘anima cioè che si mette a contatto con altre anime,<br />
che non agisce secondo schemi artificiali o astratti della vita, ma piuttosto<br />
secondo una visione chiara e completa del complicatissimo essere che è<br />
l‘uomo.<br />
―È necessario che coltiviamo con premura particolare la gioventú:<br />
ad essa procuriamo buoni libri, onde si formi con veri e retti principi <strong>di</strong><br />
90 Cf GIUSEPPE FRASSINETTI, Istruzioni catechistiche al popolo, vol. III,<br />
Roma, 1912, pag. 347-349.<br />
38
onestà e <strong>di</strong> religione; correggiamo con amorevole maestria la leggerezza e<br />
l‘incostanza, affinché non degeneri dalle salutari istituzioni; facciamole<br />
gustare il bene e le pratiche <strong>di</strong> pietà, in modo che in esse si ra<strong>di</strong>chi e si<br />
asso<strong>di</strong>; guar<strong>di</strong>amola dai pericoli con vigile cautela; ren<strong>di</strong>amola sottomessa<br />
ed obbe<strong>di</strong>ente a chi la deve governare e <strong>di</strong>rigere‖ 91.<br />
Egli pensava che con i giovani il catechismo si dovesse svolgere in<br />
modo pratico, ma molto piú efficace, attraverso la soluzione dei loro<br />
problemi e attraverso un in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> vita da svolgere secondo la morale e i<br />
comandamenti cristiani. Leggendo la sua vita ci si imbatte spesso in belle<br />
brigate <strong>di</strong> giovani, i quali, accorrevano a lui come figli carissimi intorno al<br />
padre. Il Frassinetti sapeva farsi amare e con la fiaccola dell‘amore<br />
illuminava l‘innocenza <strong>di</strong> uno come anche purificava la miseria dell‘altro.<br />
Pur potendolo fare per le sue alte doti, non imponeva, non voleva<br />
sviluppare in essi una personalità <strong>di</strong>versa da quella che Dio aveva dato a<br />
ciascuno. Trascurava la consolazione dei risultati improvvisi, preferiva<br />
coltivare i suoi figli uno per uno, cercando <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>arli come erano in realtà;<br />
e si sa come lo stu<strong>di</strong>o dell‘animo umano, specialmente dei giovani, non è<br />
sempre semplice e facile da intuire. La sua era un‘educazione forte e<br />
generosa; un‘educazione anche gioiosa fondata su un sano ottimismo delle<br />
risorse e vicende umane per tutto ciò che può costituire effusione <strong>di</strong> bontà.<br />
Era in sostanza una formazione alla virtú eroica, non all‘eroismo delle<br />
piazze e della pubblicità, ma a quello semplice e luminoso del proprio<br />
dovere sempre ben compiuto.<br />
Le sue norme pedagogiche erano il frutto della sua esperienza<br />
personale che costituisce ancor oggi una ricchezza non comune; nessuna<br />
infatti <strong>di</strong> esse procede a priori, ma tutte si susseguono in una armoniosa<br />
ascesa. L‘anima <strong>di</strong> esse, sebbene fosse tutta spirituale e spiccatamente<br />
sacramentale, tuttavia non tralascia nessuno <strong>di</strong> quei dati positivi e negativi<br />
che ognuno porta nella sua natura. In particolare in evidenza egli metteva<br />
due punti: comunione e purezza, punti complementari, inscin<strong>di</strong>bili, soli<strong>di</strong><br />
valori della formazione morale della gioventú <strong>di</strong> ogni tempo.<br />
Abbattendo infatti le barriere che il Giansenismo aveva innalzate<br />
intorno al sacramento dell‘Eucaristia, il Frassinetti fu l‘apostolo della<br />
comunione frequente come mezzo <strong>di</strong> perfezione spirituale. All‘Eucaristia<br />
affidava dunque l‘educazione dei giovani, affinché il contatto con le carni<br />
verginali <strong>di</strong> Gesú generasse nei loro cuori un amore e un desiderio della<br />
vita cristiana e della santità.<br />
91 GIOVANNI PARODI, Il Frassinetti e i giovani, in Risonanze, Genova,<br />
1960, n. 4, pag. 5.<br />
39
Egli sapeva bene, poi, che nell‘anima del giovane, l‘unico ostacolo<br />
alla vita cristiana e alla santità è il peccato impuro ed ancor meglio<br />
conosceva che un animo puro e casto è il tabernacolo piú adatto e piú<br />
splen<strong>di</strong>do dell‘amore <strong>di</strong> Dio. Per questo egli creò intorno a sé una schiera<br />
<strong>di</strong> angeli in terra che lo seguivano nella via dell‘eroismo.<br />
―Particolarmente la gioventú ba<strong>di</strong> a custo<strong>di</strong>re gli occhi. Né mi<br />
state a <strong>di</strong>re: Non sarà peccato il guardarla, altrimenti non la lascerebbero<br />
qui. Quante persone che dovrebbero avere giu<strong>di</strong>zio e timore <strong>di</strong> Dio e non<br />
l‘hanno? Quando potete supporre che quell‘immagine, quella statua vi può<br />
essere <strong>di</strong> tentazione, abbassate gli occhi e ritiratevi‖ 92.<br />
Un impegno particolare poneva il Frassinetti nell‘avviare i giovani<br />
alla devozione a <strong>Maria</strong> Santissima, ben sapendo che ogni educazione<br />
cristiana raggiunge perfezione e stabilità solo nella devozione e nella<br />
protezione della Madonna. Nelle sue istruzioni catechistiche che faceva<br />
apposta per i giovani, infondeva in essi un profondo spirito <strong>di</strong> sacrificio,<br />
non come fine a se stesso, bensí come forza della volontà e mortificazione<br />
delle passioni. Faceva comprendere che nel sacrificio nasceva la gioia,<br />
come altresí insegnava che lo stesso cristianesimo e tutta la vita è gioia.<br />
Prospettava <strong>di</strong>nanzi ai loro occhi gli ideali spirituali piú elevati, con<br />
il raggiungimento dei quali il giovane trova appagamento alla sua brama <strong>di</strong><br />
conquiste e al suo desiderio <strong>di</strong> eccellere.<br />
―Leggendo i numerosi scritti de<strong>di</strong>cati a questi argomenti ed<br />
in<strong>di</strong>rizzati ai giovani, non sai se ammirare <strong>di</strong> piú la parola semplice ed<br />
affettuosa o lo splendore e la sublimità degli ideali morali a cui incita i<br />
giovani‖ 93.<br />
Egli per mezzo <strong>di</strong> questo zelo ed attività catechistica ed insieme<br />
educativa, seppe in quel secolo in cui i giovani erano inghiottiti dagli errori<br />
<strong>di</strong> un‘epoca miscredente, asciugare tante lacrime, rimarginare tante ferite,<br />
accendere sui volti spenti tanti nuovi sorrisi.<br />
92<br />
GIUSEPPE FRASSINETTI, Istruzioni catechistiche al popolo, Roma, 1912,<br />
vol. II, pag. 22.<br />
93<br />
GIOVANNI PARODI, Il Frassinetti e i giovani, in Risonanze, Genova,<br />
1960, n. 4, pag. 6.<br />
40
CAPITOLO III<br />
IL SUO ZELO CATECHISTICO VERSO GLI ADULTI<br />
Anche per gli adulti, il Frassinetti aveva una cura particolare. Essi,<br />
infatti, centro vitale della società, con<strong>di</strong>zionano il buono e i cattivo<br />
andamento <strong>di</strong> essa secondo l‘istruzione che ricevono. La cosa principale<br />
che cercò dunque <strong>di</strong> fare fu quella <strong>di</strong> istruirli sulle principali verità religiose,<br />
sui dogmi della Chiesa ed ammonirli degli errori. Questa istruzione la<br />
svolgeva la maggior parte delle volte nelle pre<strong>di</strong>che, ma si serviva anche<br />
degli scritti.<br />
―Il vangelo le domeniche e i catechismi erano sua principalissima<br />
cura; e si adoperava con ogni mezzo perché i suoi parrocchiani non vi<br />
mancassero‖ 94.<br />
Il suo atteggiamento non era rigoroso come quello <strong>di</strong> molti<br />
pre<strong>di</strong>catori del tempo, infatti si era ben accorto che tale metodo non<br />
avrebbe mai portato utili risultati. Al contrario cercava <strong>di</strong> adoperare tutta la<br />
sua possibile benignità per non incorrere nel rischio <strong>di</strong> allontanare sempre<br />
piú dalla religione i traviati e pericolanti dagli errori del tempo moderno.<br />
―Quanto piú la fede si è indebolita tanto piú è necessario far uso<br />
<strong>di</strong> con<strong>di</strong>scendenza verso i peccatori‖ 95.<br />
Nelle sue esposizioni catechistiche cercava anche <strong>di</strong> inculcare e <strong>di</strong><br />
promuovere nell‘animo dei fedeli l‘amore ai sacramenti. Come abbiamo già<br />
visto nei capitoli precedenti, egli ribatteva su questi, poiché era<br />
profondamente penetrato della loro importanza ed efficacia, infatti<br />
costituiscono il nucleo principale della nostra spiritualità.<br />
Egli stesso era sempre <strong>di</strong>sposto a dare la comunione e quando<br />
c'era bisogno stava delle lunghe ore in confessionale dove accorrevano<br />
fedeli anche dalle parrocchie vicine.<br />
―Il suo confessionale era sempre assiepato <strong>di</strong> penitenti tanto che si<br />
<strong>di</strong>ceva che a Quinto vi era sempre missione‖ 96.<br />
La sua parrocchia era insomma un vero focolaio <strong>di</strong> amore per<br />
Cristo e per la Madonna, Madre amorosa <strong>di</strong> tutte le genti. L‘opera<br />
catechistica che il Frassinetti svolgeva fra il popolo si <strong>di</strong>stingueva da<br />
94<br />
CARLO OLIVARI, Della vita e delle opere del servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe<br />
Frassinetti, Roma, 1928, pag. 44.<br />
95<br />
GIUSEPPE FRASSINETTI, Manuale del parroco novello, Roma, 1928, pag.<br />
211.<br />
96<br />
CARLO OLIVARI, Della vita e delle opere del servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe<br />
Frassinetti, Roma, 1928, pag. 43.<br />
41
gruppo a gruppo e non si deve quin<strong>di</strong> pensare che egli facesse « <strong>di</strong> ogni<br />
erba un fascio ». Assisteva con una meto<strong>di</strong>ca e continua <strong>di</strong>rezione spirituale<br />
quelli che a lui ricorrevano per consiglio e da essi esigeva una continua<br />
presenza alle funzioni parrocchiali ed una piú viva partecipazione alla vita<br />
dei Sacramenti.<br />
Era poi molto favorevole alle associazioni, anzi lui steso le ideava,<br />
approvava le loro norme e s‘impegnava a guidarle nelle prime <strong>di</strong>fficoltà.<br />
Faceva questo perché contribuissero insieme a lui ad una piú organizzata<br />
opera pastorale tra il popolo e con il loro esempio attirassero altre persone.<br />
―Sommamente poi importa che in ciascuna parrocchia siavi due<br />
congregazioni formate a coltivare lo spirito <strong>di</strong> pietà tra il popolo‖ 97.<br />
CAPITOLO IV<br />
IL CATECHISMO NEI SUOI SCRITTI<br />
Il Frassinetti dove non poteva arrivare con la sua opera arrivava<br />
con i suoi scritti. Non si deve attribuire questa necessità che lui sentiva alla<br />
mancanza <strong>di</strong> testi catechistici, ma alla inadeguatezza <strong>di</strong> essi: infatti si<br />
<strong>di</strong>lungavano troppo e non descrivevano l‘uomo ideale ma l‘uomo ipotetico.<br />
Si rifacevano poi troppo alla teologia dogmatica e morale e se<br />
questa poteva essere compresa con <strong>di</strong>fficoltà dagli stu<strong>di</strong>osi, tanto meno dal<br />
popolo che non ne ricavava la minima utilità pratica. Il suo stile non si<br />
<strong>di</strong>stingue per una certa eleganza; procede sempre con semplicità e<br />
chiarezza ammirabile, affinché il <strong>di</strong>vino insegnamento fosse accessibile e<br />
proficuo per tutte le menti e tutti i cuori.<br />
I libri catechistici che hanno avuto piú successo sono stati i tre<br />
volumi « Istruzioni catechistiche al popolo ». Lo stesso Frassinetti nella<br />
prefazione espone dettagliatamente le norme che ha seguito in questa<br />
opera che si può definire un compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> tutta la dottrina cristiana.<br />
Egli innanzitutto non intende ingannare il popolo o far nascere<br />
scrupoli su opinioni appoggiate a probabili ragioni anche se sostenute da<br />
buoni autori, ma che tuttavia « non possono far legge ». È piuttosto<br />
ristretto nell‘accennare alle varie questioni teologiche, poiché il popolo<br />
sentendo <strong>di</strong>re che certi teologi la pensano a un modo ed altri in un altro,<br />
97 GIUSEPPE FRASSINETTI, Manuale del parroco novello, Alba, 1938, pag.<br />
155.<br />
42
potrebbe perdere il concetto della dottrina cristiana e ne resterebbe anche<br />
scandalizzato 98.<br />
―Il catechista non deve insegnare al popolo la teologia, non deve<br />
mai toccare le questioni teologiche; deve solo esporre le dottrine certe, che<br />
essendo comuni a tutti i teologi, si possono <strong>di</strong>re le vere dottrine della <strong>Santa</strong><br />
Chiesa‖ 99.<br />
È ammirabile poi la sua prudenza nell‘accennare agli errori contro<br />
le verità della fede. Infatti egli considera solo gli errori piú popolari e<br />
grossolani per i quali ha una confutazione facile e convincente, per non<br />
incorrere nel rischio <strong>di</strong> entrare in ragionamenti fini e che non sono la<br />
maggior parte delle volte alla portata dell‘intelligenza <strong>di</strong> tutti.<br />
Che <strong>di</strong>re poi dei Vangeli cioè dei suoi « Commenti ai Vangeli »?<br />
Egli non li pubblicò, li lasciò manoscritti. Forse se gli fosse bastata la vita li<br />
avrebbe ritoccati e completati. Egli se ne serviva come traccia <strong>di</strong><br />
pre<strong>di</strong>cazione e li sviluppava piú o meno secondo che lo zelo e l‘opportunità<br />
gli suggerivano.<br />
Eppure anche se essi sono semplicemente abbozzati racchiudono<br />
sodezza <strong>di</strong> dottrina e conoscenza delle Sacre Scritture e dei Padri e si<br />
<strong>di</strong>stinguono per quel senso pratico per cui gli insegnamenti del vangelo<br />
vanno applicati ai casi pratici della vita.<br />
CONCLUSIONE<br />
In questo breve lavoro, sono stati considerati solo alcuni aspetti<br />
dell'opera catechistica del Frassinetti, altri non sono stati nemmeno<br />
accennati; tuttavia lo stu<strong>di</strong>o del Frassinetti può esser paragonato ad un<br />
campo nel quale piú si semina e piú si miete.<br />
Il Frassinetti fu come l‘aurora che con la sua luce illumina il vasto<br />
orizzonte e segna l‘inizio <strong>di</strong> un nuovo giorno piú splendente e pieno <strong>di</strong><br />
nuove speranze.<br />
Novizio Rime<strong>di</strong>o Antonio fsmi<br />
98 GIUSEPPE FRASSINETTI, Istruzioni catechistiche al popolo, Roma, 1910,<br />
vol. I, pag. 6.<br />
99 Ivi.<br />
43
IL PRIORE GIUSEPPE FRASSINETTI<br />
E LA SPIRITUALITÀ<br />
DELL’OTTOCENTO GENOVESE<br />
Pontificio Ateneo «Antonianum»<br />
Istituto Pedagogico - Roma<br />
Tesi per il conseguimento del <strong>di</strong>ploma in:<br />
«Scienze dell‘educazione»<br />
Moderatore: Prof. Bruno Giordani<br />
Anno Accademico 1984/85<br />
SOMMARIO<br />
Presentazione<br />
Cenni biografici<br />
Abbreviazioni<br />
Parte prima: Giuseppe Frassinetti ed il clero<br />
Capitolo Primo<br />
L‘ambientazione storico spirituale della figura del Frassinetti<br />
Capitolo Secondo<br />
La situazione spirituale del Clero<br />
Capitolo Terzo<br />
Il Frassinetti per il Clero<br />
a) L‘attività e<strong>di</strong>toriale<br />
b) Realizzazioni sul piano pratico<br />
Parte seconda Il ministero pastorale del Frassinetti tra i fedeli<br />
Preliminari<br />
Capitolo Primo<br />
L‘attività catechistica<br />
Capitolo Secondo<br />
Cura della gioventú<br />
Capitolo Terzo<br />
Pastorale generale<br />
Conclusione<br />
Bibliografia<br />
44
PRESENTAZIONE<br />
Da qualche tempo l‘attenzione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>osi, specialmente<br />
dell‘Ottocento ligure, si è rivolta, con particolare attenzione, alla figura del<br />
Sac. Giuseppe Frassinetti (1804-1 868) . Priore-parroco <strong>di</strong> S. Sabina in<br />
Genova. rilevandone la statura <strong>di</strong> teologo e <strong>di</strong> forgiatore <strong>di</strong> anime, in uno<br />
dei piú tormentati perio<strong>di</strong> della storia della Chiesa italiana, quale fu<br />
l‘Ottocento.<br />
Ci è quin<strong>di</strong> sembrato molto utile continuare, su una linea<br />
d‘impegno, l‘approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> questa figura <strong>di</strong> santo e dotto sacerdote,<br />
specialmente sotto il profilo <strong>di</strong> un attento osservatore della spiritualità del<br />
suo tempo e <strong>di</strong> un apostolo che agí <strong>di</strong> conseguenza.<br />
Dato un breve cenno biografico e fatta una sintetica inquadratura<br />
storica della spiritualità dell‘Ottocento italiano e genovese in particolare,<br />
siamo passati a prendere in esame l‘opera del Servo <strong>di</strong> Dio come <strong>di</strong> colui<br />
che attento ai segni dei tempi, si è de<strong>di</strong>cato con ardentissimo zelo a far<br />
rifiorire la spiritualità cristiana nel suo tempo.<br />
Il Priore aveva subito compreso che per ridare un afflato <strong>di</strong> vita<br />
spirituale al gregge <strong>di</strong> Dio, bisognava darlo prima ai suoi pastori.<br />
Perciò tutte le sue premure furono rivolte al clero, prima perché<br />
ne fossero rinvigorite le file — si era aperta infatti una crisi vocazionale <strong>di</strong><br />
estrema gravità - poi perché ne fossero elevate la spiritualità e la cultura,<br />
purtroppo allora fattesi largamente scadenti.<br />
Opera certo <strong>di</strong>fficile e impegnativa, che però egli ha svolto con<br />
grande efficacia, agendo su un duplice piano: quello dell‘e<strong>di</strong>toria su vasta<br />
scala, cioè dal semplice foglio all‘opera in volumi, densi <strong>di</strong> dottrina e <strong>di</strong><br />
eccezionale equilibrio pastorale; e quello pratico con la creazione <strong>di</strong> Pie<br />
Unioni, Congregazioni, Associazioni che promuovessero stu<strong>di</strong> con una<br />
<strong>di</strong>dattica organica, con aggiornamenti e incontri spirituali sostanziati <strong>di</strong><br />
preghiera.<br />
Questo particolare aspetto della sua attività operativa meritava<br />
certo un‘attenzione piú approfon<strong>di</strong>ta nel particolare. e collocata in un‘ottica<br />
ecclesiale <strong>di</strong> piú vasti orizzonti. Ci ripromettiamo, piacendo a Dio, <strong>di</strong> farlo<br />
in successivi lavori.<br />
Abbiamo poi seguito la sua azione nel campo pastorale tra il<br />
popolo e ciò per due ragioni: la prima, quasi a verifica, sul piano pratico, <strong>di</strong><br />
ciò che andava scrivendo in decine <strong>di</strong> pubblicazioni; la seconda, a testimonianza<br />
del suo influsso sulla spiritualità del suo tempo e della sua capacità<br />
<strong>di</strong> esercitarlo.<br />
45
Questa seconda parte l‘abbiamo esaminata con cura, perché fonte<br />
<strong>di</strong> illuminato insegnamento per la nostra azione pastorale <strong>di</strong> oggi.<br />
L‘abbiamo infatti sentita molto attuale.<br />
E, sebbene con rammarico, l‘abbiamo dovuta trattare in poche<br />
pagine, l‘abbiamo tuttavia considerata in tre capitoli: 1 La catechesi. 2 La<br />
cura della gioventú. 3 La pastorale generale. non certo esaustivi della sua<br />
azione pastorale, ma sufficienti tuttavia per offrire al lettore un‘idea piú<br />
vicina al vero della complessa sua attività.<br />
Il nostro lavoro vuol essere infine, pur nella sua modestia, un<br />
invito ad una continuazione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> ricerca sul Frassinetti e sulla<br />
spiritualità dell‘Ottocento italiano e <strong>di</strong> quello genovese in particolare.<br />
CENNI BIOGRAFICI<br />
Il Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, nacque a Genova il 15<br />
<strong>di</strong>cembre 1804 ed ivi morí il 2 gennaio 1868, dopo quarantun‘anno <strong>di</strong> santo<br />
e fecondo apostolato, tale da essere chiamato un nuovo Curato d‘Ars.<br />
È conosciuto e venerato per la santità della vita, per la sicura<br />
dottrina delle opere ascetiche e morali e per le fondazioni sgorgate dal suo<br />
gran cuore sacerdotale, specie per quella che s‘intitola «Opera dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>».<br />
Il Frassinetti fu uno degli scrittori ascetici piú insigni del 1800. I<br />
suoi libri eccellono per soli<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> dottrina, per <strong>di</strong>screzione, per squisitezza<br />
<strong>di</strong> buon senso, per facilità e scorrevolezza, per chiarezza ed anche per una<br />
certa eleganza e semplicità <strong>di</strong> stile che ne rende gra<strong>di</strong>ta la lettura.<br />
La fama della santità del Frassinetti è sempre cresciuta dalla sua<br />
morte. Molte grazie sono state ottenute per sua intercessione. Gran<strong>di</strong> santi,<br />
come S. Pio X, hanno esaltato la sua sublime pietà e singolare dottrina. Il<br />
processo <strong>di</strong> beatificazione è bene avviato.<br />
ABBREVIAZIONI<br />
A.F. Archivio Frassinettiano presso la Postulazione Generale della Causa,<br />
Via del Mascherone, 55 - Roma.<br />
O.A. Opere Ascetiche <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, in due volumi, e<strong>di</strong>te dalla<br />
Postulazione Generale della Causa, Roma 1978.<br />
46
O.O. Opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, e<strong>di</strong>te in 13 volumi,<br />
Tip. Poliglotta Vaticana, Roma 1913.<br />
PARTE PRIMA<br />
GIUSEPPE FRASSINETTI E IL CLERO<br />
CAPITOLO PRIMO<br />
L’AMBIENTAZIONE STORICO-SPIRITUALE DELLA FIGURA<br />
DEL FRASSINETTI<br />
Non è semplice <strong>di</strong>re della spiritualità dell‘Ottocento italiano ed in<br />
particolare dell‘Ottocento genovese, nel quale operò Giuseppe Frassinetti e<br />
che continua ad impegnare tanti stu<strong>di</strong>osi italiani ed esteri. 100<br />
100 Benché potrebbe esulare dall’impegno del presente lavoro, tuttavia<br />
accenniamo qui, per una maggiore ricchezza <strong>di</strong> documentazione sul<br />
controverso e fecondo momento risorgimentale italiano, un breve<br />
riferimento bibliografico <strong>di</strong> alcuni stu<strong>di</strong>, che da posizioni <strong>di</strong>verse ne<br />
rappresentano delle interpretazioni da un punto <strong>di</strong> vista storico—civile e<br />
storico—ecclesiastico:<br />
AA. VV., a cura <strong>di</strong> Ettore Rota, Questioni <strong>di</strong> Storia del Risorgimento e<br />
dell’Unità d’Italia, Torino 19A8;<br />
A.C. JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino 1948;<br />
W. MATURI, Interpretazione del Risorgimento, Torino 1962;<br />
L. SALVATORELLI, Prima e dopo il 1848, Torino 1948.<br />
Per quanto si riferisce alla vita ecclesiale del periodo frassinettiano ed in<br />
particolare alla sua spiritualità si rimanda a:<br />
R. AUBERT, in AA. VV., Storia della Chiesa dalle origini fino ai nostri<br />
giorni, Torino, S.A.I.E.1969, Il Pontificato <strong>di</strong> Pio IX (1846—1878), vol.<br />
XXI/2;<br />
AA. VV., Storia della Chiesa, (<strong>di</strong>retta da H. Je<strong>di</strong>n), Iaca Book, 1975, vol.<br />
VII, specialmente i capitoli XVIII, XIX, XXVI;<br />
A. COLLETTI, La Chiesa durante la Repubblica ligure, Genova, AGIS,<br />
1959;<br />
AA. VV., Chiesa e spiritualità dell’Ottocento italiano, Verona 1971.<br />
47
Fu infatti un secolo <strong>di</strong> vicende tormentate e controverse; basti<br />
pensare alla complessa vicenda napoleonica sia nella fase ascensionale sia in<br />
quella ancor piú terribilmente conclusiva, con tutte le conseguenze<br />
particolarmente serie per Genova, che vi perse la sua plurisecolare<br />
in<strong>di</strong>pendenza e la sua tranquillità interna, per l‘accendersi <strong>di</strong> opposte<br />
ardenti passioni.<br />
L‘Ottocento fu inoltre per l‘Italia l‘epoca del suo Risorgimento,<br />
caratterizzato, nel confronto con la Chiesa, da quella che fu chiamata la<br />
«questione romana» e da una mentalità profana e laica, con cui si<br />
considerava tutto quello che vi avesse, a ragione o no, qualche rapporto.<br />
Da questo nacque un vivace anticlericalismo, che movendo da espressioni,<br />
talvolta brutali e volgari, irrompeva poi quasi sempre audace e protervo<br />
nella vita privata e pubblica del nascente Stato italiano. 101<br />
I movimenti filosofici poi d‘oltr‘Alpe, importati allora nella<br />
Penisola, esercitarono il loro influsso, piú che altro suscitando delle<br />
opinioni, il cui incontro non ebbe però mai una accentrazione, per poi<br />
sfociare in un grande alveo <strong>di</strong> pensiero italico. Comunque bastò il fondo<br />
illuministico—razionalista con buone note <strong>di</strong> materialismo, che soggiaceva<br />
a quei movimenti, per alimentare o ad<strong>di</strong>rittura per determinare prese <strong>di</strong><br />
posizione teoriche e pratiche.<br />
Queste venivano poi propagandate con ogni mezzo per<br />
<strong>di</strong>sorientare e traviare il clero e per <strong>di</strong>struggere la fede e la morale del<br />
popolo 102.<br />
101 ―Prima — scriveva il Frassinetti — era cosa onorifica parlare ed<br />
operare da cristiani cattolici; adesso invece si reputa cosa onorifica il<br />
parlare e operare da miscredenti. Adesso i delitti contro la religione o non<br />
sono più delitti o sono delitti privilegiati che eccitano l’interesse<br />
universale a favore <strong>di</strong> chi ha i’ar<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> farsene colpevole‖. Cfr. 0.0.,<br />
Vol. Il, p. 326.<br />
102 Il Priore cosí, per esempio, denunciava la nequizia della stampa:<br />
―Come si potrà mettere un qualche argine al <strong>di</strong>luvio e alla piena dei libri<br />
cattivi, che inondano la cristianità, spiantano ogni santo fondamento<br />
della santa Fede, smuovono e trasportano ogni riparo del buon costume e<br />
<strong>di</strong>struggono ogni <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>vino e umano?‖. (Ai cristiani, O.A., voi. Il, p.<br />
332)<br />
48
CAPITOLO SECONDO<br />
LA SITUAZIONE SPIRITUALE DEL CLERO<br />
Il clero risentí molto dello spirito razionalista e liberalrivoluzionario<br />
del secolo.<br />
Era in sé <strong>di</strong>viso e la passione politica lo rendeva non<br />
infrequentemente acerbo e perfino rissoso, poco attento certo ai doveri<br />
pastorali. La sua, formazione culturale e spirituale era scadente e la<br />
<strong>di</strong>sciplina notevolmente rilassata.<br />
Questo fenomeno colpiva particolarmente i chierici, ormai in<br />
numero assai ridotto, e costituiva ―un gravissimo problema ed un punto <strong>di</strong><br />
principalità per la stessa vita della Chiesa‖ 103.<br />
Tra le cause della penosa situazione spirituale. culturale e<br />
<strong>di</strong>sciplinare della Chiesa genovese è certo da annoverare anche quella<br />
derivante dalla lunga vacanza della sede vescovile dopo la morte dell‘arcivescovo<br />
Card. Ta<strong>di</strong>ni nel 1847, durata ben cinque anni. Essa appesantí la<br />
gravissima situazione, i cui strascichi si fecero sentire per alcuni anni<br />
ancora.<br />
―Ne sono testimonianza i documenti ine<strong>di</strong>ti conservati a Moútiers<br />
nell‘archivio de l‘Académie de la Val d‘lserre, che gettano luce in special<br />
modo sulle opposizioni <strong>di</strong> alcuni ecclesiastici genovesi insofferenti <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sciplina, appoggiati anche da qualche prelato residente nella <strong>di</strong>ocesi‖ 104.<br />
CAPITOLO TERZO<br />
L’OPERA DEL PRIORE VERSO IL CLERO<br />
Il Frassinetti si consacrò al grave problema con tutte le sue energie<br />
ed il suo ardente zelo, fin da quando era giovane sacerdote: ―appena - egli<br />
afferma - fui or<strong>di</strong>nato sacerdote s‘impossessò del mio cuore una brama<br />
forte <strong>di</strong> giovare per quanto potessi nella mia nullità al giovine clero‖ 105<br />
La sua azione si svolse su due piani: l‘uno e<strong>di</strong>toriale e l‘altro <strong>di</strong><br />
or<strong>di</strong>ne pratico.<br />
103 Cfr. RENZI GIORDANO, Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche,<br />
Roma 1979, Vol 2, P. ll.<br />
104 ORESTE, Mons. Andrea Charvaz, estratto dal «Bollettino ligustico»,<br />
3/4, Annata XXII, 1970, Genova 1971, p. 13.<br />
105 A.F., Vol. Il, p. 12, in Frassinetti, Rischiarimenti sul mio passato.<br />
49
Occorre notare subito, a proposito della sua attività, che egli non<br />
volle <strong>di</strong> proposito occuparsi <strong>di</strong> politica.<br />
Potrebbe essere espressione <strong>di</strong> tutta, l‘impostazione del suo<br />
lavoro, soprattutto della sua forma mentis, quanto egli scrisse in occasione<br />
delle elezioni politiche del 1867, in cui molti del clero cosiddetto «liberale»<br />
si attendevano una presa <strong>di</strong> posizione da lui a loro favore: ―Io sto colla S.<br />
Sede e con tutti i suoi organi‖ 106.<br />
Ed ancora in modo piú energico: ―Io non sono mai stato né sono<br />
né voglio essere cattolico con qualche aggiunta (inten<strong>di</strong> «liberale» - nota<br />
nostra -). Sono sempre stato e sono e spero che sempre sarò cattolico<br />
semplicemente‖ 107.<br />
Il Car<strong>di</strong>nal G. Siri affermerà: ―Fu tutto, solo e, per i suoi tempi,<br />
ar<strong>di</strong>tamente prete‖ 108. E non valsero minacce 109 ne l‘esilio a farlo deflettere.<br />
Ma fu proprio questo suo deciso atteggiamento,che gli valse la<br />
stima ed il rispetto <strong>di</strong> molti 110.<br />
Noi cre<strong>di</strong>amo che egli abbia assunto e <strong>di</strong>chiarato una cosí precisa e<br />
coraggiosa presa <strong>di</strong> posizione, perché fosse richiamo esemplare per il clero,<br />
che la passione politica per l‘una o l‘altra parte teneva <strong>di</strong>viso e soprattutto<br />
<strong>di</strong>straeva dai supremi doveri sacerdotali.<br />
a) L‘attività e<strong>di</strong>toriale.<br />
Il Frassinetti propugnò nei suoi scritti che il sacerdote deve mirare<br />
ad essere santo, poi può considerare il resto. Ma prima deve essere santo.<br />
Nel 1852 donò al clero quell‘aureo libretto «Gesú Cristo Regola<br />
del sacerdote» 111, in cui presentava, come <strong>di</strong>vino modello, Gesú.<br />
La forza singolarmente penetrante e trascinatrice del libretto sta<br />
nella <strong>di</strong>mensione contemplativa della vita <strong>di</strong> unione <strong>di</strong> Gesú col Padre, del<br />
suo «come» si è donato alla cura della singola anima e del suo comporta-<br />
106 G. FRASSINETTI, Appen<strong>di</strong>ce sulle elezioni politiche in Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
Teologia Morale, 3a e<strong>di</strong>z., Genova 1867, Tip. della Gioventú, p. 770.<br />
107 Ivi.<br />
108 SIRI G., Priore Giuseppe Frassinetti, <strong>di</strong>scorso commemorativo riferito<br />
da ―Risonanze‖, Tip. Guanella, Roma 1968, p. 4.<br />
109 G. FRASSINETTI, Appen<strong>di</strong>ce, o.c., p. 770.<br />
110 Ivi.<br />
111 Dopo la I e<strong>di</strong>zione del 1852 se ne fecero, vivente l’autore, ben altre<br />
se<strong>di</strong>ci in varie parti d’Italia.<br />
Oggi il libretto ha raggiunto la 33.a e<strong>di</strong>zione. Fu tradotto con varie<br />
e<strong>di</strong>zioni nelle più importanti lingue europee e, tra gli orientali, in lingua<br />
armena.<br />
50
mento nel sociale del suo tempo e del suo ambiente. Pagine che penetrano<br />
fin nel profondo con forza e soavità.<br />
È in esso considerata tutta la vita del sacerdote, privata e pubblica.<br />
È introdotto Gesú stesso parlante col «suo» sacerdote con squisito amore,<br />
ma nel contempo con esigente chiarezza in or<strong>di</strong>ne alla sua vita, che deve<br />
essere intemerata, al suo zelo per la salvezza delle anime, che deve essere<br />
ardente, generoso ed illuminato, alla sua stessa vocazione, che se costituisce<br />
un privilegio per la sua eccellenza e sublimità, richiede pure una risposta<br />
adeguata <strong>di</strong> abnegazione amorosa e <strong>di</strong> ferma volontà.<br />
Quel libretto fu <strong>di</strong>chiarato «un tesoro», una «novella imitazione <strong>di</strong><br />
Cristo». Noi vi ascoltiamo il canto orante <strong>di</strong> un‘anima sacerdotale<br />
affascinata ed irresistibilmente attratta da Cristo sacerdote 112.<br />
Con altri due scritti intervenne in or<strong>di</strong>ne alla riforma ed elevazione<br />
del clero, scritti che ebbero particolare risonanza ed efficacia; inten<strong>di</strong>amo<br />
riferirci a «Riflessioni proposte agli ecclesiastici» del 1837 e «Brevi parole ai<br />
sacerdoti fratelli» del 1865. Col primo sostenne che ogni teologia ed ogni<br />
prassi pastorale devono poggiare sulla Chiesa <strong>di</strong> Roma, «immobile colonna<br />
della cattolica verità». Essa, egli afferma, deve essere ―la gioia del nostro<br />
cuore e, <strong>di</strong>rei, l‘estasi dell‘anima nostra‖ 113.<br />
Queste espressioni non erano certo in quel tempo enfatiche né<br />
retoriche. Erano un coraggioso orientare tanti intelletti smarriti 114; un voler<br />
stringere il clero intorno alla cattedra <strong>di</strong> Pietro, col rimuoverlo da ideologie<br />
imperanti, che, affondando le loro ra<strong>di</strong>ci nel razionalismo illuministico,<br />
tendevano a far scemare, a turbare ed evertere la sua fede ed a separarlo<br />
dall‘obbe<strong>di</strong>enza al Papa.<br />
Dopo poco piú <strong>di</strong> trent‘anni sarà proclamata, in un clima storico<br />
ancora molto inquieto e <strong>di</strong>fficile, l‘infallibilità pontificia.<br />
Fu uno scritto esplosivo che gli procurò guerra da molte parti<br />
anche del clero, ma non da Roma, la quale era pur stata sollecitata a<br />
condannare l‘operetta 115.<br />
Ma l‘effetto voluto sul clero fu ottenuto. Era quanto l‘Autore si<br />
era proposto.<br />
112 Ve<strong>di</strong> le belle pagine che del libretto ha recentemente scritto mons. V.<br />
VAILATI in Un Maestro <strong>di</strong> Vita sacerdotale, Giuseppe Frassinetti , pp. 39—<br />
66, Roma 1977.<br />
113 FRASSINETTI G., Riflessioni proposte agli ecclesiastici, in O.A., Vol. Il,<br />
p. 536.<br />
114 ―Tempi d’infedeltà e <strong>di</strong> confusione‖ li <strong>di</strong>ce il Frassinetti; ivi, pag. 522.<br />
115 Cfr. OLIVATI C., Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio sac. Giuseppe<br />
Frassinetti, Poliglotta Vaticana, Roma 1928, pp. 72 e ss.<br />
51
Col secondo «Brevi parole ai sacerdoti fratelli», dopo aver<br />
sottolineato le ragioni per cui un sacerdote deve tendere alla santità ed aver<br />
detto, con accorate parole, suggeritegli dalla gravità dell‘ora, quale deve<br />
essere ed è la missione specifica ed essenziale del prete, invita tutto il clero<br />
all‘unità, necessaria per realizzare una pastorale comune aggiornata ai tempi<br />
ed alle esigenze del momento.<br />
Unione, egli vuole, <strong>di</strong> animi, d‘intenti e d‘azione. Mette in guar<strong>di</strong>a<br />
dai pericoli e dalla inutilità dell‘isolamento. ―Quanto potremmo fare che<br />
non facciamo, se fosse tra noi maggiore unione!‖ E dunque ―procuriamola<br />
con tutto lo zelo‖ 116.<br />
Il Frassinetti precorreva in tal modo il Decreto «Presbyterorum<br />
or<strong>di</strong>nis» del Vaticano II, nei numeri 7 e 8.<br />
Accusa poi <strong>di</strong> zelo infingardo ―coloro che si limitano a lamenti e<br />
poi non muovono un <strong>di</strong>to. Dallo zelo «infingardo» non possono procedere<br />
che ―esclamazioni, previsioni, pre<strong>di</strong>zioni, parole, insomma parole, sempre<br />
parole inutili‖ ed esorta con forza: ―Operiamo piuttosto con efficacia‖ 117.<br />
Queste parole vere ed infuocate dovettero scuotere tante anime<br />
sacerdotali, forse prima intimorite dalla stessa aria che si respirava.<br />
L‘appello all‘unione, su cui il Frassinetti sempre insisterà, era<br />
veramente efficace per dare saldezza nella carità.<br />
Il centro poi <strong>di</strong> tutta l‘attività apostolica - scrive ancora - deve<br />
essere Gesú Cristo, il capo ed il maestro deve essere il Romano<br />
Pontefice 118.<br />
Non pare <strong>di</strong> sentire echeggiare le parole incitatrici <strong>di</strong> S. Bernardo<br />
nel suo «De vita solitaria ad fratres de Monte Dei» ?<br />
Piú sensibile era il <strong>di</strong>sorientamento e la <strong>di</strong>visione tra il clero<br />
nell‘esercizio ministeriale del Sacramento della Penitenza, per il permanere<br />
ancora <strong>di</strong> una certa mentalità rigoristico—giansenista in alcuni sacerdoti ai<br />
quali non piaceva affatto (e lo pre<strong>di</strong>cavano a chiare note) quello che essi<br />
chiamavano il «benignismo» <strong>di</strong> S. Alfonso <strong>Maria</strong> de‘ Liguori.<br />
A ciò si aggiunga l‘insistente, capillare azione del liberalismo, che<br />
tentava non solo <strong>di</strong> sconcertare le anime, ma <strong>di</strong>struggere in esse ogni<br />
convinzione religiosa.<br />
Consapevole <strong>di</strong> tutto questo e <strong>di</strong> quanta rovina per le anime ne<br />
seguiva, il Servo <strong>di</strong> Dio scrisse il «Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia morale», Genova<br />
1865.<br />
116 G. FRASSINETTI, Brevi parole ai sacerdoti fratelli, O.A., vol. 11, p. 601.<br />
117 G. FRASSINETTI, Brevi parole ai sacerdoti fratelli, O.A., Vol. II, p. 601.<br />
118 Ivi.<br />
52
Esso fu il colpo <strong>di</strong> maglio al giansenismo. Lo storico Roger<br />
Aubert ha scritto che con quell‘ «opera eccellente» si combatterono ―con<br />
successo gli ultimi resti del giansenismo ligure.‖ 119<br />
Ed il P. Cacciatore 120 affermò che essa contribuí efficacemente<br />
―all‘estirpazione della semente giansenistica‖ 121.<br />
Il Compen<strong>di</strong>o era inoltre e piú ―un vero tesoro <strong>di</strong> pietà e <strong>di</strong><br />
scienza‖ 122 , un ―lume <strong>di</strong> scienza morale.‖ 123<br />
La Civiltà Cattolica, quando ne venne alla luce la IX e<strong>di</strong>zione,<br />
scrisse: ―La dottrina profonda e sicura, la prudente saggezza nella soluzione<br />
delle questioni anche le piú scabrose rendono la presente opera preziosa<br />
come lettura e come manuale <strong>di</strong> consultazione per i confessori e per le<br />
guide spirituali delle anime‖ 124<br />
Il Compen<strong>di</strong>o fece un gran bene, eliminando quasi totalmente<br />
incertezze e <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> nella prassi confessionale, donando serenità<br />
ai confessori e gioiosa fiducia ai penitenti. Dalla Germania il teologo<br />
Hundegger gli scriveva: ―La morale (. . .) è conosciuta dal clero della<br />
Germania ( ... ). Tutti la bene<strong>di</strong>cono della gran carità che ha avuto a<br />
119 Cfr. AUBERT R., Storia della Chiesa, vol. XXI/2, 2 Ed. ital., S.A.I.E.,<br />
Torino 1970, p. 786.<br />
120 Citato da FREDIANI F., Il Santo <strong>di</strong> ferro, Orbis Catholicus, Roma<br />
1951, p. 94.<br />
121 È noto quanto il giansenismo, pur nel suo morire, abbia nociuto alla<br />
spiritualità ligure. Infatti, ai tempi del Nostro, era ancora vivo in Liguria<br />
e non pochi sacerdoti esercitavano il ministero della Penitenza con criteri<br />
rigoristici. ―Perseguitavano la libertà della frequente comunione‖ —<br />
come scriveva l’amico e confidente del Frassinetti S. Antonio M. Gianelli<br />
nel 1843 (cfr. Fre<strong>di</strong>ani, Il Santo <strong>di</strong> ferro, o.c.. p.92) e gettavano le anime<br />
nello sconforto e nella paura, quando non nel terrore <strong>di</strong> Dio, cosicché il<br />
Sacramento, che sarebbe dovuto essere il Sacramento della gioia per la<br />
riconciliazione che operava, si era trasformato, per le anime, in un vero<br />
dramma.<br />
122 Lettera del Card. Ferrata del 3/3/1910, conservata nell’archivio della<br />
Postulazione della Causa <strong>di</strong> Canonizzazione del Frassinetti, in Roma, via<br />
del Mascherone, 55.<br />
123 CAPECELATRO A., Vita della Serva <strong>di</strong> Dio Paola Frassinetti, Desclée,<br />
Roma 1900, p. 58.<br />
124 Civiltà Cattolica, Serie XVII, p. 543, anno 1898.<br />
53
pubblicare questo «fulcrum conscientiarum» (...) Già <strong>di</strong>latavit cor a piú che<br />
un confessore sacerdote‖ 125.<br />
Il Servo <strong>di</strong> Dio, P. Rocco Ferroni, l‘assiduo e santo confessore <strong>di</strong><br />
Verona, celebrò tutto il merito che il Frassinetti si era acquistato in questo<br />
ambito della vita pastorale, ripetendo, quasi come un ritornello: ―Se non si<br />
frassinetta, l‘anima non si netta‖ 126.<br />
Veramente dunque il Priore aveva conseguito il fine che si era<br />
proposto <strong>di</strong> aiutare i confessori novelli e <strong>di</strong> far comprendere che la santità è<br />
conseguibile da tutti, perché tutti sono chiamati da Dio ad essere santi.<br />
Il Priore era parroco. è vero, <strong>di</strong> una modesta parrocchia. anche se<br />
sita nel cuore della città <strong>di</strong> Genova, ma per l‘esperienza che egli aveva<br />
acquistato, essendo la sua chiesa <strong>di</strong> S. Sabina <strong>di</strong>ventata un vero centro dei<br />
migliori sacerdoti genovesi e non genovesi 127 (tra questi ultimi è da<br />
ricordare S. Giovanni Bosco); per l‘afflusso dei penitenti <strong>di</strong> ogni ceto e<br />
con<strong>di</strong>zione sociale ed ecclesiastica, che l‘occupavano in confessione per<br />
lunghe ore nel giorno 128; per la corrispondenza epistolare che aveva coi<br />
vescovi, sacerdoti e laici, egli era <strong>di</strong>ventato un vero maestro <strong>di</strong> vita spirituale.<br />
129<br />
Il <strong>di</strong>segno dunque che aveva concepito <strong>di</strong> aiutare coloro che erano<br />
in cura <strong>di</strong> anime o in giovane età fu davvero provvidenziale e benedetto e<br />
valse a completare la sua vasta opera in vantaggio dei suoi confratelli nel<br />
sacerdozio.<br />
Nessun settore della sua vita pastorale dovette sfuggire alla sua<br />
attenta vigilanza ed al suo zelo illuminato.<br />
Nel 1863 infatti dette alla luce il «Manuale pratico del Parroco<br />
Novello» in cui, come ne scrisse il Ballerini: ―tutto quello che riguarda<br />
qualunque dovere del parroco è trattato con pienezza <strong>di</strong> sapienza e<br />
prudenza, sostenuto da una soavissima e massima carità, dottrina solida,<br />
<strong>di</strong>uturna esperienza, gran<strong>di</strong>ssima <strong>di</strong>screzione‖ 130.<br />
125 Lettera al Frassinetti del 13 Giigno 1867, conservata nell’Archivio<br />
della Postulazione.<br />
126 VEZZANI F., Vita del P. Rocco Ferroni, Quinzano — Verona 1951, p.<br />
175.<br />
127 RENZI G. , Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche, o.c., pp. 22—23.<br />
128 FASSIOLO D., Memorie storiche, o.c., p. 45.<br />
129 Il Vailati così intitolò il suo pregevole stu<strong>di</strong>o sul Frassinetti: ―Un<br />
Maestro <strong>di</strong> vita sacerdotale‖, o.c.<br />
130 Citato da RENZI G., Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche, o.c., p.<br />
101.<br />
54
―Ha prodotto un gran bene‖ <strong>di</strong>sse il Vescovo <strong>di</strong> Molins. Meglio e<br />
<strong>di</strong> piú non poteva <strong>di</strong>rsi.<br />
La gran<strong>di</strong>ssima fortuna e<strong>di</strong>toriale ottenuta, documenta da se stessa<br />
quanto il clero avesse gra<strong>di</strong>to una opera <strong>di</strong> tal fatta per la sua formazione<br />
pastorale.<br />
b) Realizzazioni sul piano pratico.<br />
Era impressionante al suo tempo (e al nostro?), la deficienza delle<br />
vocazioni ecclesiastiche. Come rinvigorire le file dei consacrati? Fu l‘ansia<br />
del suo animo sacerdotale.<br />
I biografi tutti sono concor<strong>di</strong> nel riconoscere la molteplicità,<br />
l‘intensità, l‘ardore delle sue iniziative in merito.<br />
Stando all‘economia del nostro lavoro, <strong>di</strong>remo solo che negli<br />
scritti, in cui il problema vocazionale era da lui prospettato 131, si sforzò,<br />
vorremmo meglio <strong>di</strong>re gridò, per convincere tutti - clero e fedeli - che<br />
questo era «il grande problema» dell‘ora, il problema «vitale», il «supremo<br />
bisogno del giorno», l‘«urgente bisogno».<br />
Ne analizzò le cause, ne propose i rime<strong>di</strong>, ne in<strong>di</strong>cò le gravi<br />
ragioni che urgevano per la sua soluzione.<br />
Si leggano le appassionate pagine <strong>di</strong> «Sulla deficienza delle<br />
vocazioni allo stato ecclesiastico» con le note che vi furono aggiunte<br />
postume, sempre dallo stesso Frassinetti, per capire come egli vivesse il<br />
problema 132.<br />
Ma certo non poté contentarsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere opere e opuscoli, che<br />
raggiungessero città e campagne, suscitando benefiche ed ampie risposte 133,<br />
ma aiutò in modo impegnato le vocazioni anche adulte, persino offrendo<br />
un alloggio ai giovani ed agli uomini maturi aspiranti al sacerdozio nella sua<br />
stessa canonica e, quando questa era tutta occupata, perfin nel campanile<br />
della chiesa. Del resto agiva proprio come lui stesso aveva insegnato. 134<br />
Promosse inoltre Associazioni e Pie Unioni da cui potessero<br />
germinare vocazioni religiose e sacerdotali, come <strong>di</strong> fatto avvenne.<br />
Tra queste ci è grato ricordare la «Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>», da lui fondata in S. Sabina nel 1860, la quale successivamente<br />
131 Sia qui sufficiente ricordare gli scritti seguenti: Sulla deficienza delle<br />
vocazioni allo stato ecclesiastico, Lucca 1867,<br />
Brevi parole ai sacerdoti fratelli, Genova 1865<br />
132 O.O., vol. XIII, pp. 293 e ss.<br />
133 C. OLIVARI, Della vita e delle opere, o.c. p.213 e ss<br />
134 Sulla deficienza delle vocazioni..., o.c. p.313 e p.348.<br />
55
si evolse nella Congregazione religiosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pontificio dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S.<br />
<strong>Maria</strong> immacolata 135.<br />
Dalla Pia Unione — ―creazione spiritualmente meravigliosa‖ 136,<br />
come la <strong>di</strong>sse il Card. Lercaro, uscirono decine e decine <strong>di</strong> sacerdoti, <strong>di</strong> cui<br />
molti insigni per virtú e dottrina. 137<br />
Oltre a ciò, per piú <strong>di</strong>rettamente ed efficacemente operare per la<br />
formazione ed elevazione spirituale del clero e per aggiornarne la cultura,<br />
fondò con il Sac. Luigi Sturla la Congregazione del Beato Leonardo da<br />
Porto Maurizio.<br />
Retta da un regolamento molto impegnativo, aveva il fine <strong>di</strong><br />
formare un giovane clero zelante, unito, fedele, come buono strumento<br />
nelle mani <strong>di</strong> Dio, come lo stesso Frassinetti aveva <strong>di</strong>chiarato 138.<br />
E poiché ―la scienza è cosí annessa all‘idea <strong>di</strong> un ecclesiastico, da<br />
non potersi concepire l‘idea <strong>di</strong> un ecclesiastico ignorante, se non come idea<br />
mostruosa‖ 139, non contento della formazione culturale che veniva<br />
impartita ai giovani della Congregazione, in seno ad essa fondò<br />
l‘Accademia <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> ecclesiastici. Questa era aperta non solo ai giovani<br />
chierici, ma a qualunque sacerdote che chiedesse <strong>di</strong> farne parte, al fine <strong>di</strong><br />
aggiornare la propria cultura.<br />
Si raggiungeva in tale maniera quella istruzione permanente. <strong>di</strong> cui<br />
il Priore era un valido assertore e <strong>di</strong> cui oggi si parla tanto. L‘insegnamento<br />
aveva come oggetto le <strong>di</strong>scipline storiche e teologiche.<br />
In breve tempo la Congregazione e l‘Accademia polarizzarono i<br />
migliori spiriti ed i piú acuti intelletti del clero genovese, che vi furono<br />
insigni maestri. Tra questi, oltre naturalmente il Nostro, furono il Cattaneo<br />
(a cui si dovrà il rior<strong>di</strong>namento ed il risanamento del Seminario, ridotto in<br />
con<strong>di</strong>zioni spirituali, morali e <strong>di</strong>sciplinari che oggi sarebbero incre<strong>di</strong>bili e<br />
che allora costarono lacrime amare a ben tre Arcivescovi); il Magnasco ed il<br />
Reggio, che <strong>di</strong>ventarono poi entrambi Arcivescovi <strong>di</strong> Genova: l‘Alimonda<br />
futuro car<strong>di</strong>nale Arcivescovo <strong>di</strong> Torino, il Gentile poi vescovo <strong>di</strong> Novara.<br />
135 C. OLIVARI, Della vita e delle opere...,o.c, cap. XIV e XV.<br />
136 Card. LERCARO G., Priore Giuseppe Frassinetti, in «Risonanze» Roma<br />
1968, p. 5.<br />
137 Cfr. Sulla deficienza delle vocazioni...,o.c., p. 347 note.<br />
138 Cfr. FRASSINETTI, Idea della Congregazione <strong>di</strong> Ecclesiastici, O.O., vol.<br />
XII, p. 586.<br />
139 Cfr. FRASSINETTI, Osservazioni sugli stu<strong>di</strong> ecclesiastici, O.O., vol. XIII,<br />
p. 222.<br />
56
Abbiamo voluto menzionare esplicitamente questi uomini insigni<br />
per dottrina e piú per santità <strong>di</strong> vita, per dare un‘idea piú adeguata<br />
dell‘importanza operativa che ebbero le due istituzioni 140.<br />
Da esse uscirono chierici e sacerdoti esemplari, tra cui non<br />
possiamo non ricordare il Servo <strong>di</strong> Dio, Don Agostino Roscelli, fondatore<br />
delle Suore dell‘<strong>Immacolata</strong>, il quale con il Priore ―formò un cuore solo‖ e<br />
―un‘anima sola‖ 141<br />
Gran<strong>di</strong>ssima fu inoltre l‘influenza delle due istituzioni che in<br />
notevolissima parte cambiarono il volto della spiritualità genovese e ligure,<br />
con ampie risonanze nella nostra Italia, raggiunta dalla <strong>di</strong>ffusione delle<br />
opere del Servo <strong>di</strong> Dio e dei suoi collaboratori.<br />
PARTE SECONDA<br />
IL MINISTERO SACERDOTALE DEL FRASSINETTI TRA I<br />
FEDELI<br />
PRELIMINARI<br />
Facciamo ora un accenno all‘azione <strong>di</strong> rinnovamento spirituale che<br />
il Frassinetti svolse tra le masse popolari. Se infatti fu un prete<br />
«rinnovatore» 142 della vita spirituale e della cultura del clero, lo fu anche<br />
della fede e della morale del Popolo <strong>di</strong> Dio.<br />
Egli era parroco <strong>di</strong> una modesta parrocchia <strong>di</strong> Genova-centro. Ma<br />
ben presto il suo ministero pastorale superò quell‘area angusta per<br />
estendersi all‘Italia ed oltre.<br />
140 Il Frassinetti stesso ebbe poi ad enumerare le benemerenze del la<br />
Congregazione, che ebbe naturalmente vita <strong>di</strong>fficile, come era allora da<br />
attendersi, in ―Schiarimenti sul mio passato‖ O.O pp.15 e 16.<br />
141 Cfr. SUOR M.R., Grandezza <strong>di</strong> un umile — Don Agostino Roscelli—<br />
fondatore delle Suore dell’<strong>Immacolata</strong>, Demos, Genova, 1951 pp. 31 e ss. e<br />
FALDI EMILIO, Il Servo <strong>di</strong> Dio Don Agostino Rascelli, Libreria<br />
Arcivescovile, Genova, 1976, op.59,72,1l5.<br />
142 P. TEODOSIO DA VOLTRI, Un prete rinnovatore – Ritratto <strong>di</strong> G.<br />
frassinetti, Genova, 1968.<br />
57
Ebbe inizio dall‘alba del suo sacerdozio e si protrasse fino al suo<br />
tramonto, senza soluzione <strong>di</strong> continuità e soprattutto senza che il suo<br />
ardore apostolico venisse meno.<br />
Il Priore ebbe perciò agio <strong>di</strong> conoscere bene le necessità spirituali<br />
e i problemi della sua gente, come ci mostra attraverso quelle ra<strong>di</strong>ografie<br />
della situazione morale e spirituale che ha eseguito qua e là nei suoi scritti.<br />
Ciò era ovviamente necessario per lui, per poter poi determinare<br />
una focalizzata ed efficace azione pastorale, con apertura <strong>di</strong> lavoro quasi in<br />
ogni settore della popolazione a lui affidata.<br />
Non fa perciò meraviglia la varietà e molteplicità delle sue<br />
iniziative pastorali, che si susseguirono nel tempo. Anzi si rimane ammirati<br />
della tempestività e opportunità dei suoi illuminati interventi.<br />
Viva era e bene organizzata infatti l‘azione dei nemici della Chiesa,<br />
che aprivano brecce con dovizia <strong>di</strong> mezzi e nefasta intelligenza operativa.<br />
Quin<strong>di</strong> si richiedeva altrettanta rapi<strong>di</strong>tà per contenere l‘urto. Da uomo<br />
risoluto e pratico ―a idea contrapponeva idea. A prassi, prassi. A metodo,<br />
metodo. A mezzo, mezzo. Subito‖ 143.<br />
Con risolutezza affermò che suo dovere e inten<strong>di</strong>mento era<br />
―promuovere la gloria <strong>di</strong> Dio con ogni mezzo che mi si presentò alle mani:<br />
anzi è mia intenzione cercarne‖ 144.<br />
L‘economia del presente lavoro purtroppo ci costringe solo a<br />
brevi cenni; d‘altronde, la statura stessa dell‘Uomo <strong>di</strong> Dio non ci permette<br />
altro. Ve<strong>di</strong>amo dunque solo alcuni aspetti.<br />
CAPITOLO PRIMO<br />
L’ATTIVITÀ CATECHISTICA<br />
―L‘Ottocento — ha scritto lo Stella - è il secolo che oltre al<br />
peccato contro i costumi deplora i peccati contro la fede (...); in mano agli<br />
operai contempliamo perio<strong>di</strong>ci e libri anticlericali, antireligiosi, blasfemi‖ 145.<br />
143 Cfr. RENZI G., Giuseppe Frassinetti e le sue Opere Ascetiche, o.c.,p.19.<br />
Riman<strong>di</strong>amo inoltre il lettore alle ardenti pagine <strong>di</strong> ―Riflessioni proposte<br />
agli ecclesiastici‖, (O.A., 20, ~ 524 e ss.) per meglio comprendere il<br />
programma ed il metodo del lavoro frassinettiano.<br />
144 FRASSINETTI G., Rischiarimenti...,o.c., p.34.<br />
145 STELLA P., Don Bosco nella storia della religiosità cattolica. Mentalità<br />
religiosa e spiritualità, Vol. II, p. 505, Roma 1981.<br />
58
Il Priore lo sa bene. E proprio dalla considerazione <strong>di</strong> questi mali<br />
muove e si qualifica la sua strategia pastorale. Moltiplica ed intensifica<br />
l‘azione catechistica al popolo, secondo le età, le con<strong>di</strong>zioni sociali ed i<br />
livelli culturali.<br />
Nella sua parrocchia riserva a sé le spiegazioni del vangelo, che si<br />
tenevano a mezzo mattino, ed il catechismo agli adulti dei pomeriggi<br />
festivi. Quando poi porge il catechismo ai fanciulli, lo espone in modo da<br />
coinvolgervi anche gli adulti, che in verità l‘andavano ad ascoltare proprio<br />
per il modo piano dell‘esposizione.<br />
Non vi era inoltre solennità liturgica che egli non facesse<br />
precedere da un triduo o da una novena con pre<strong>di</strong>cazione, né festività <strong>di</strong><br />
santi, che non lo facesse salire sul pulpito per ammaestrare.<br />
Sapeva bene quanto fosse efficace l‘arma della parola. E la sua era<br />
breve, facile, piana. suadente, tale insomma da conquistare gli animi. 146<br />
Gli argomenti che trattava erano tali, per la sodezza <strong>di</strong> dottrina e<br />
ricchezza <strong>di</strong> prove, che convincevano e trascinavano a Dio. Ma era<br />
soprattutto l‘interno ardore che li animava ―quella celeste unzione che trae<br />
l‘anima e ne piega al bene la volontà, che avvinceva i suoi ascoltatori‖. 147<br />
Annotano concor<strong>di</strong> i suoi biografi che la chiesa <strong>di</strong> S. Sabina non<br />
era sufficiente a contenere i fedeli che accorrevano ad ascoltare la parola <strong>di</strong><br />
Dio, che egli sapeva rendere piana ed adatta alle intelligenze <strong>di</strong> tutte le<br />
persone, anche le piú ignoranti ―le quali — soleva <strong>di</strong>re - hanno il <strong>di</strong>ritto ed<br />
il bisogno <strong>di</strong> intendere il pre<strong>di</strong>catore, quando loro annunzia la Parola <strong>di</strong><br />
Dio‖ 148.<br />
146 Cfr. OLIVARI C., Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio..., o.c., p. 302.<br />
Esortato a dare alle stampe un Corso <strong>di</strong> Istruzioni Catechistiche, affinché<br />
potessero essere <strong>di</strong> aiuto agli aventi cura <strong>di</strong> anime, ne pubblicò tre<br />
volumi, premettendo note metodologiche e pastorali che oggi appaiono<br />
nel documento della C.E.I.. «Il rinnovamento della Catechesi».<br />
La pubblicazione postuma poi delle sue «Spiegazioni del Vangelo al<br />
popolo» — contenenti sempre piú <strong>di</strong> due o tre schemi — rimane sempre<br />
una grande fonte per la pre<strong>di</strong>cazione, anche se oggi sono mutati molti<br />
testi della S. Scrittura. Quelle pagine rivelano, come annotano gli<br />
E<strong>di</strong>tori, ―quell’assiduo e coscienzioso lavoro con cui egli andò nei lunghi<br />
anni della sua carriera pastorale stu<strong>di</strong>andosi <strong>di</strong> annunciare al suo popolo<br />
nel modo migliore la <strong>di</strong>vina parola‖ (Prefazione, p. V, vol. I <strong>di</strong><br />
Spiegazioni del Vangelo al popolo, Poliglotta Vaticana, Roma 1906.<br />
147 OLIVARI C., Della vita e delle opere ..., o.c., p.3O2.<br />
148 Ivi, p. 297. È opportuno leggere il capitolo IV, per comprendere come<br />
il Frassinetti sia stato un rinnovatore della eloquenza sacra.<br />
59
Non dovremmo mai <strong>di</strong>menticare queste severe parole ammonitrici<br />
anche noi moderni, che ci lasciamo prendere da mode, da sfoggi <strong>di</strong><br />
eru<strong>di</strong>zione, da vezzi che nocciono tanto alla chiarezza e semplicità con cui<br />
dovremmo annunciare la <strong>di</strong>vina Parola.<br />
Alla cura pastorale <strong>di</strong> massa non era <strong>di</strong>sgiunta quella settoriale e<br />
specifica che svolgeva nelle Congregazioni, Associazioni, Pie Unioni che<br />
andava fondando, secondo che ne vedeva le necessità. L‘istruzione<br />
catechistica vi aveva sempre il primo posto, magari con la lettura <strong>di</strong> qualche<br />
buon libro, come faceva in S. Sabina dopo il rosario quoti<strong>di</strong>ano, quando<br />
dal pulpito leggeva una me<strong>di</strong>tazione in luogo <strong>di</strong> tenere una pre<strong>di</strong>ca.<br />
CAPITOLO SECONDO<br />
CURA DELLA GIOVENTÚ<br />
Cura particolare ebbe della gioventú, che era la piú minacciata<br />
dalla nequizia dei tempi. ―Si osservi - egli ammoniva — che l‘apostolato<br />
degli empi si adopera specialmente al sovvertimento della gioventú;<br />
perciocché essi, non senza qualche speranza <strong>di</strong> riuscirvi, aspirano a formare<br />
all‘empietà tutta la sorgente generazione‖ 149.<br />
―Ora noi, incalzava, dobbiamo opporre una generazione pia e<br />
morigerata‖ 150<br />
Entro questo campo d‘azione è da collocarsi la sua attiva<br />
propaganda e, saremmo tentati <strong>di</strong> <strong>di</strong>re, la sua istituzione degli esercizi<br />
spirituali ai fanciulli. Occorreva infatti una maggiore preoccupazione <strong>di</strong><br />
offrire la parola <strong>di</strong> Dio alla gioventú ―alla quale — lamentava il Priore —<br />
non si parla quasi mai <strong>di</strong>rettamente: le pre<strong>di</strong>che, le spiegazioni del Vangelo,<br />
i catechismi riguardano quasi esclusivamente gli adulti, in modo che<br />
raramente i giovanetti ascoltano la parola <strong>di</strong> Dio che si confaccia ai loro<br />
particolari bisogni‖ 151.<br />
149 FRASSINETTI G., Riflessioni proposte agli ecclesiastici, Vol. II, p. 529.<br />
Ve<strong>di</strong> pure le accorate pagine 579 e ss. <strong>di</strong> Gesú Cristo regola del Sacerdote,<br />
O.A., Vol. 11.<br />
E tra i giovani raccomandava che si prendesse cura con «zelo<br />
singolarissimo» <strong>di</strong> quelli che aspirano al sacerdozio. E come e quanto egli<br />
sia stato maestro <strong>di</strong> gioventú e <strong>di</strong> questa gioventú in modo speciale, ve<strong>di</strong><br />
lo stu<strong>di</strong>o del VAILATI V. Un maestro <strong>di</strong> vita sacerdotale, o.c. pp. 133 e ss.<br />
150 Ivi.<br />
151 FRASSINETTI G., O.O. vol. VIII, prefazione pp. 3 e ss.<br />
60
Gli esercizi ai fanciulli erano da lui stesso pre<strong>di</strong>cati e furono cosí<br />
evidenti i buoni frutti che ne raccoglievano, che ne volle rendere partecipi i<br />
suoi confratelli, pubblicando «Gli esercizi spirituali per giovinetti d‘ambo i<br />
sessi» (Tip. della Gioventú, Genova 1858). Quando videro la luce, ebbero<br />
elogi incon<strong>di</strong>zionati dalla Civiltà Cattolica (Serie IV, vol. IV, p.596).<br />
È ovvio che ne seguirono altre e<strong>di</strong>zioni che ebbero certo il merito<br />
<strong>di</strong> far rivolgere una piú vigile attenzione al settore fanciulli—ragazzi<br />
d‘ambedue i sessi.<br />
E chi non sa che uno dei mo<strong>di</strong> piú efficaci per conquistare e<br />
muovere le famiglie dal <strong>di</strong> dentro è proprio la cura dei fanciulli?<br />
Per verità a Genova il catechismo ai fanciulli, all‘epoca <strong>di</strong> cui<br />
parliamo, era una realtà pastorale ad opera delle Congregazioni dei<br />
Missionari Urbani e dei Franzoniani, a cui il Nostro aveva dato subito il<br />
suo nome, appena or<strong>di</strong>nato sacerdote: ma lo sviluppo che egli vi <strong>di</strong>ede con<br />
lo Sturla provocò il movimento <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> adolescenti 152 poiché il<br />
metodo d‘insegnamento era impostato in modo piú confacente alla fantasia<br />
e mentalità del fanciullo. Il <strong>di</strong>scorso era piano, facile, illustrato da esempi<br />
che imprimevano in modo vivido le verità esposte ed esercitavano un certo<br />
potere <strong>di</strong> attrazione sulle anime dei giovanetti, sempre aperte all‘imitazione<br />
<strong>di</strong> quanto le conquista.<br />
CAPITOLO TERZO<br />
PASTORALE GENERALE<br />
Il suo zelo si rivolse inoltre ai carcerati, agli operai, alle<br />
donne perdute, alle ragazze pericolanti, alle dame.<br />
Basterà dare uno sguardo alle Associazioni, alle Pie Unioni . . . da<br />
lui fondate, per ammirare l‘ampiezza del suo ministero e del suo zelo. Fu<br />
veramente un agitatore <strong>di</strong> anime.<br />
La sua attività investiva moltissimi ceti del popolo, poiché là dove<br />
non giungeva la sua dolce e viva parola, giungevano i suoi fogli, gli<br />
opuscoli, le pagelle, i libri. Ben piú <strong>di</strong> cento sono i titoli a noi pervenuti.<br />
152 Cfr. FASSIOLO D., Memorie storiche..., o.c., pp.26 e ss.<br />
61
A questo punto del nostro argomento come non citare il suo<br />
«Catechismo dogmatico» 153 «Dialoghetti sui comandamenti della<br />
chiesa» 154, la «Divozione illuminata» 155.<br />
Gli storici ed i biografi hanno concordemente sottolineato il suo<br />
vasto e profondo impegno, per riparare le lacerazioni operatesi nell‘anima<br />
popolare per lo influsso del razionalismo invadente e per la mentalità<br />
giansenista ancora perdurante, specialmente nella pratica dei sacramenti<br />
della Riconciliazione e dell‘Eucaristia.<br />
Reagí in modo semplicissimo, ma con pari vigore contro l‘uno e<br />
contro l‘altra proclamando che la vita soprannaturale della grazia era aperta<br />
a tutti, quin<strong>di</strong> possibile e facile per tutti; che la santità era la meta naturale<br />
del battezzato 156.<br />
Fece piovere questa dottrina nel cuore, imbevuta <strong>di</strong> confidenza<br />
nella <strong>di</strong>vina misericor<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> serena fiducia nell‘aiuto <strong>di</strong>vino. Anzi sembra<br />
che questo sia l‘elemento caratterizzante della sua spiritualità e della<br />
conseguente sua azione pastorale: l‘insistenza da una parte sulla confidenza<br />
assoluta in Dio, l‘insistenza dall‘altra sulla energica decisione della volontà<br />
nell‘impegno <strong>di</strong> dare la propria risposta alla vocazione alla santità.<br />
Quando egli parla della volontà, sembra che l‘uomo debba<br />
compiere tutto da solo; quando parla della fiducia nella grazia sembra che<br />
l‘uomo debba aspettarsi tutto da Dio.<br />
Il Frassinetti con tale strategia spirituale richiamava all‘uomo del<br />
suo tempo l‘altissima sua <strong>di</strong>gnità e vocazione a figlio <strong>di</strong> Dio e gli dava in<br />
153 Un libretto <strong>di</strong> 239 pagine. È una lucida e breve esposizione del dogma<br />
cattolico. La Civiltà Cattolica (31 gennaio 1882) scriveva: ―Cre<strong>di</strong>amo non<br />
vi possa essere catechismo più utile ed opportuno‖.<br />
Le e<strong>di</strong>zioni si moltiplicarono in Italia e all’estero, anche ad insaputa<br />
dell’Autore. La Tipografia salesiana nel 1903 dava alla luce la 26a<br />
e<strong>di</strong>zione.<br />
154 Uscirono alle stampe nel 1837. Se ne impossessarono le Letture<br />
Cattoliche <strong>di</strong> Don Bosco, che le pubblicarono a più riprese.<br />
155 La prima e<strong>di</strong>zione è del 1867 in 375 pagine. ―La Divozione illuminata<br />
è un meraviglioso manuale <strong>di</strong> pietà (...) ammaestra (...) e presenta un<br />
pascolo saluberrimo‖. Cosí la ricordava nella Prefazione <strong>di</strong> tutte le Opere<br />
(Cfr. O.O., vol. I, pp. XXI e ss.) il Car<strong>di</strong>nale Svampa.<br />
156 Citiamo per queste idee e le seguenti le eccellenti sue opere: Il conforto<br />
dell’anima devota (O.A., Vol. I, pp 3 e ss); L’arte <strong>di</strong> farsi santi (O.A. vol. I,<br />
pp. 83 e ss.); Il Pater Noster <strong>di</strong> S. Teresa <strong>di</strong> Gesú, (O.A., voi. I, pp.143 e<br />
ss.).<br />
62
pari tempo testimonianza del suo vero umanesimo, quello cristiano cioè,<br />
che riconosceva l‘altezza della sua umana <strong>di</strong>gnità.<br />
Difese con ardore <strong>di</strong> argomenti la frequenza anche quoti<strong>di</strong>ana<br />
dell‘Eucaristia 157, perché <strong>di</strong>ventasse centro dell‘amore e della vita del<br />
cristiano. E lo fece con tanto ardore che fu ed è salutato tra i piú ardenti,<br />
tenaci, valorosi apostoli dell‘Eucaristia in Italia.<br />
La sua opera «Il Convito del Divino Amore» fu definita da una<br />
nota rivista teologica tedesca (Teologisch — pratiksche Quartaischrift.,<br />
fasc. Il, pp. 368): ―Un frutto veramente prezioso maturato al sole del<br />
Divino Amore‖ 158.<br />
Furono inoltre altre due le idee forza dei suo ministero pastorale:<br />
la tenera devozione alla Madonna e l‘esaltazione della virtú della purezza e<br />
dello stato <strong>di</strong> verginità, che egli giustamente riteneva e pre<strong>di</strong>cava essere<br />
fonte <strong>di</strong> vocazioni alla vita consacrata 159.<br />
Non si stancava d‘infondere queste idee. Basta dare uno sguardo<br />
alle sue Opere Pre<strong>di</strong>cabili, ai nomi delle sue Congregazioni e Associazioni,<br />
ai titoli dei suoi scritti, per avere un‘idea dell‘impegno del suo lavoro<br />
pastorale e della vastità <strong>di</strong> esso, per permeare anche capillarmente il Popolo<br />
<strong>di</strong> Dio illuminandolo su questi punti della vita cristiana.<br />
A tutto ciò si aggiunga il ministero del confessionale e la sua<br />
esemplare vita <strong>di</strong> preghiera e si capirà perché la chiesa <strong>di</strong> S. Sabina fosse<br />
<strong>di</strong>venuta centro propulsore <strong>di</strong> spiritualità e desse davvero spettacolo <strong>di</strong> vita<br />
cristiana vissuta con sincera pietà e convinzione <strong>di</strong> fede.<br />
Ed è da quegli uomini che si erano iscritti alla «Pia Unione dei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>» che nacquero i «<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
157 Dissertazione sulla Comunione frequente, che pubblico inserita nel<br />
Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia Morale e poi a sé con i tipi della Tip.. della<br />
Gioventú, Genova 1867; Il Convito del Divino Amore, (O.A., vol. I, p. 329<br />
e ss.); Due gioie nascoste, O.A., vol. I, p. 619 e ss.).<br />
158 La dottrina della comunione frequente gli sollevò non poche obiezioni,<br />
ma dopo non molti anni ebbe un’esaltante conferma dal celebre Decreto<br />
del 16/12/1905 <strong>di</strong> S. Pio X, che schiuse le porticine dei tabernacoli anche<br />
ai fanciulli.<br />
159 Citiamo solo tra i tanti scritti <strong>di</strong> lui: Amiamo <strong>Maria</strong>, (O.A., vol. 11,<br />
pp. 341 e ss.); Avviamento dei giovinetti nella <strong>di</strong>vozione a <strong>Maria</strong><br />
Santissima, (O.A., vol. II, pp. 365 e ss.); La gemma delle fanciulle<br />
cristiane, (O.A., vol. II, pp. 507 e ss.); La forza <strong>di</strong> un libretto, (O.A., vol.<br />
II, pp. 545 e ss.); La monaca in casa, (O.A., voi. I, pp. 3 e ss.); Il religioso<br />
al secolo,(O.A., vol. II, pp. 89 e ss.).<br />
63
<strong>Immacolata</strong>», i quali donarono alla Chiesa decine e decine <strong>di</strong> pii e dotti<br />
sacerdoti come già abbiamo detto sopra.<br />
Se la persona del Frassinetti non andò mai oltre una sessantina <strong>di</strong><br />
chilometri da Genova, la sua dottrina però, il suo movimento <strong>di</strong> spiritualità<br />
valicò agevolmente la Liguria, le Alpi.<br />
Abbiamo dovuto tralasciare <strong>di</strong> celebrare altri aspetti del suo zelo e<br />
della sua personalità. Ma ci auguriamo <strong>di</strong> aver almeno fatto conoscere un<br />
sacerdote secondo il cuore <strong>di</strong> Dio e del quale si valse la Provvidenza per<br />
scuotere la spiritualità <strong>di</strong> un‘Italia, che stentava a schiudersi alla grazia<br />
salvifica <strong>di</strong> Dio.<br />
CONCLUSIONE<br />
I1 fine, che ci si era proposto e che ha guidato il presente lavoro,<br />
mirava a porre in evidenza l‘effettivo influsso esercitato dal Priore-Parroco<br />
Giuseppe Frassinetti sulla spiritualità dell‘Ottocento italiano e genovese in<br />
particolare.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fonti e <strong>di</strong> Autori ci pare abbia a noi permesso <strong>di</strong><br />
averlo sufficientemente messo in luce.<br />
Certo la figura eminente dell‘Uomo <strong>di</strong> Dio, la mole dei suoi scritti,<br />
la varietà e molteplicità dei suoi interventi nel tessuto della vita ecclesiale,<br />
avrebbero meritato un <strong>di</strong>scorso piú ampio e piú approfon<strong>di</strong>to <strong>di</strong> quello che<br />
abbiamo potuto far noi sia per le nostre deboli forze sia per l‘economia<br />
stessa del lavoro.<br />
Abbiamo visto, esaminando le linee della sua molteplice attività<br />
pastorale, come sia stata sua prima preoccupazione ed azione quella <strong>di</strong><br />
rinvigorire le file del clero e <strong>di</strong> elevarne la cultura e la spiritualità, e poi<br />
quella <strong>di</strong> consacrarsi tutto alla cura dei fedeli.<br />
Ottimo piano <strong>di</strong> lavoro: poiché come elevare, nutrire, coltivare la<br />
spiritualità dei fedeli se il clero non è all‘altezza della sua missione?<br />
Certamente non sarà poi sfuggito come il Frassinetti abbia esaltato<br />
l‘eccellenza del celibato e della virtú della purezza proprio come fonte <strong>di</strong><br />
Vocazioni e non solo come virtú che genera nelle anime l‘incantamento<br />
dell‘Agnello e la forza imitativa della SS. Vergine.<br />
Quando con tali idee, nutrite dalla frequenza anche quoti<strong>di</strong>ana alla<br />
SS. Eucaristia e sostenute da una tenera devozione a <strong>Maria</strong>, si lavora per<br />
l‘elevazione delle anime, non si può fallire. Per questo la sua opera fu<br />
certamente efficace.<br />
Durante la stesura della seconda parte del lavoro, ci è venuta<br />
spontanea varie volte la brama <strong>di</strong> ringraziare li buon Dio, che si è servito<br />
64
del nostro Padre, per ridonare al Popolo <strong>di</strong> Dio una grande fiducia nella<br />
Divina Misericor<strong>di</strong>a e per schiudere a tutti i cristiani la via della santità,<br />
mostrandola non come impossibile a percorrersi da tutti, come andavano<br />
ancora blaterando gli ultimi epigoni dei giansenismo, ma come facile ed<br />
aperta a tutti, secondo le con<strong>di</strong>zioni del proprio stato, e come voluta da<br />
Dio.<br />
Forse mi si potrà chiedere perché io abbia scelto questo soggetto<br />
per il mio lavoro <strong>di</strong> conclusione <strong>di</strong> un ciclo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>.<br />
Io appartengo alla Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, che ripete le sue origini da Lui, e perciò, iniziando un<br />
cammino serio <strong>di</strong> nuovi stu<strong>di</strong>, ho sentito la necessità spirituale e, <strong>di</strong>rei,<br />
affettiva <strong>di</strong> offrirgli questo primo fiore, che tutto timido, vuole spuntare tra<br />
le erbe <strong>di</strong> un prato, presagio e voto perché altri piú vali<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> ricerca e<br />
<strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento offrano, nell‘orizzonte degli stu<strong>di</strong> sul mio Padre e sulla<br />
spiritualità dell‘Ottocento italiano, ulteriori stu<strong>di</strong> e scoperte <strong>di</strong> nuove<br />
ricchezze.<br />
1. FONTI<br />
A) INEDITE<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
1.FRASSINETTI G., Rischiarimenti sul mio passato.<br />
Mn. originale autografo <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, custo<strong>di</strong>to<br />
nell‘Archivio della Postulazione Generale della Congregazione<br />
dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S .<strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> (Via del Mascherone, 55 Roma).<br />
2. Notizie cronologiche del Seminario <strong>di</strong> Genova dal 1803 al 1846.<br />
Mn. originale autografo <strong>di</strong> Giovanni Battista Cattaneo, custo<strong>di</strong>to<br />
nel Seminario Arcivescovile <strong>di</strong> Genova.<br />
B) EDITE<br />
Opere del Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti<br />
a) per il clero (riferite in or<strong>di</strong>ne cronologico):<br />
Riflessioni proposte agli ecclesiastici, Tip. Ferrando Genova, 1837.<br />
Osservazioni sopra gli stu<strong>di</strong> ecclesiastici proposte ai chierici, Tip. Pellas,<br />
Genova, 1839.<br />
Gesú Cristo Regola del Sacerdote, Firenze, 1852.<br />
Memorie intorno alla Congregazione del Beato Leonardo da Porto Maurizio,<br />
Tip. Tasso, Oneglia, 1857.<br />
65
Proposte agli ecclesiastici, Tip.Letture Cattoliche, Pisa, 1861<br />
Manuale pratico del Parroco novello, Tip. Miglio, Novara, 1863.<br />
Compen<strong>di</strong>o della Teologia Morale <strong>di</strong> S. Alfonso <strong>Maria</strong> de’ Liguori, con<br />
apposite note e <strong>di</strong>ssertazioni, Tip. della Gioventú, Genova, 1865—1866.<br />
Brevi parole ai sacerdoti fratelli, Tip. della Gioventú Genova, 1865.<br />
Sulla deficienza delle vocazioni allo stato ecclesiastico, Tip. Lan<strong>di</strong>, Lucca,<br />
1867.<br />
Propositi fatti per sé ed alcuni amici, Tip. della Gioventú, in Memorie<br />
storiche del sac. Giuseppe Frassinetti <strong>di</strong> D. FASSIOLO, Genova, 1879.<br />
Discorsi a sacerdoti e chierici, in O.O., Vol. VIII, Roma, 1912.<br />
b) per i fedeli<br />
La gemma delle fanciulle cristiane ossia la santa verginità, Tip. Ferrando,<br />
Genova 1837.<br />
La forza <strong>di</strong> un libretto — Dialoghi tra due amiche sopra l’operetta La<br />
gemma delle fanciulle cristiane ossia la santa verginità, Tip. Ferrando, Genova,<br />
1841.<br />
Catechismo Dogmatico, Tip. Ferrando, Genova, 1842.<br />
Avviamento dei giovanetti nella <strong>di</strong>vozione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> Santissima, Tip.<br />
Monal<strong>di</strong>, Roma, 1846.<br />
Ai fedeli devoti del SS. Sacramento, Tip. Como, Genova, 1851.<br />
Il conforto dell’anima <strong>di</strong>vota con un’appen<strong>di</strong>ce sul santo timor <strong>di</strong> Dio, Tip.<br />
Bettole, Genova, 1844.<br />
La monaca in casa, Tip. Tasso, 1859.<br />
Il Pater noster <strong>di</strong> S. Teresa <strong>di</strong> Gesú — Trattato della preghiera, Tip.<br />
Fiaccadori, Parma, 1860.<br />
Lettera sul celibato, Tip. Ghilini, Oneglia, 1861.<br />
Il para<strong>di</strong>so in terra nel celibato cristiano, Tip. Paravia, Torino, 1861.<br />
L’arte <strong>di</strong> farsi santi, Genova, 1861.<br />
Dialoghetti sui comandamenti della Chiesa, Tip. Oratorio S. Francesco<br />
<strong>di</strong> Sales, Torino, 1837.<br />
Il Religioso al secolo e Regola della Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, Tip. della Gioventú, Genova, 1864.<br />
Due gioie nascoste, Tip. della Gioventú, Genova, 1864.<br />
Amiamo Gesú, Tip. della Gioventú, Genova, 1864.<br />
Amiamo <strong>Maria</strong>, Tip. della Gioventú, Genova, 1864.<br />
La <strong>di</strong>vozione illuminata — Manuale <strong>di</strong> preghiere, Tip. della Gioventú,<br />
Genova, 1867.<br />
Il convito del Divino Amore, Tip. della Gioventú, Genova, 1867.<br />
66
2. Stu<strong>di</strong> e biografie piú importanti<br />
A) Sul Servo <strong>di</strong> Dio<br />
TEODOSIO DA VOLTRI, Un prete rinnovatore, Ritratto <strong>di</strong> Giuseppe<br />
Frassinetti, Tip. Opera SS. Vergine <strong>di</strong> Pompei, Genova, 1968.<br />
FALDI EMILIO, Il Priore <strong>di</strong> S. Sabina, il Servo <strong>di</strong> Dio Don Giuseppe<br />
Frassinetti, Tip. Scuola grafica don Bosco, Genova, 1967.<br />
FASSIOLO DOMENICO, Memorie storiche intorno alla vita del sac.<br />
Giuseppe Frassinetti, Priore <strong>di</strong> S. Sabina in Genova, Tip. della Gioventú,<br />
Genova, 1879.<br />
LERCARO CARD. GIACOMO, Priore Giuseppe Frassinetti,Tip. Don<br />
Guanella, Roma, 1968.<br />
LUXARDO FEDELE, Giuseppe Frassinetti, Pastore d’anime autore <strong>di</strong><br />
religiose istituzioni, scrittore <strong>di</strong> opere sacre in «Saggio <strong>di</strong> Storia Ecclesiastica Ligure<br />
ossia Vite <strong>di</strong> alcuni santi e <strong>di</strong> altri uomini illustri», vol. IV, Tip. C. Colombo,<br />
Genova, 1884.<br />
OLIVARI CARLO, Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe<br />
Frassinetti, Priore <strong>di</strong> S. Sabina in Genova, Fondatore dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, Tip. Poliglotta Vaticana 1928.<br />
PARENTE CARD. PIETRO, Il Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti in<br />
Osservatore Romano, 31 ottobre 1966.<br />
RENZI GIORDANO, Giuseppe Frassinetti e le sue opere ascetiche, Tip.<br />
Don Guanella, Roma, 1968.<br />
SIRI CARD.GIUSEPPE, Priore Giuseppe Frassinetti, Tip. Don<br />
Guanella, Roma, 1968.<br />
VAILATI VALENTINO, Un Maestro <strong>di</strong> vita sacerdotale, il Servo <strong>di</strong> Dio<br />
Giuseppe Frassinetti, Tip. Olimpica, Roma, 1977.<br />
B) Stu<strong>di</strong> vari<br />
COLLETTI A., La Chiesa durante la Repubblica Ligure, Genova, 1950.<br />
FREDIANI G., Il Santo <strong>di</strong> ferro, Roma, Orbis Catholicus, 1951.<br />
MARTINA G., Chiesa e Mondo moderno, Roma, Stu<strong>di</strong>um, 1977.<br />
Il Clero italiano e la sua azione pastorale verso la metà dell’Ottocento, in<br />
AA.VV., Storia della Chiesa dalle Origini fino ai giorni nostri, XXI/2, Torino,<br />
SAIE, 1969.<br />
MONTALE B., Il clero genovese nel 1848 in Rassegna storica della Liguria<br />
(1974) 1, 81—84.<br />
SALVATORELLI L., Prima e dopo il 1848, Torino, De Silva, 1948.<br />
N.B.: L‘elenco delle Opere E<strong>di</strong>te ed Ine<strong>di</strong>te dei Priore Giuseppe Frassinetti<br />
può aversi in O.A., vol. II, pp. 665—693.<br />
Augusto De Angelis fsmi<br />
67
IL FRASSINETTI<br />
E IL PROBLEMA DELLE VOCAZIONI<br />
ECCLESIASTICHE<br />
Pontificia Università Urbaniana de Propaganda Fide<br />
Roma<br />
Tesi <strong>di</strong> Licenza in S. Teologia dell‘alunno<br />
Anno accademico 1974 — 1975<br />
Moderatore: Prof. Mario Puccinelli<br />
SOMMARIO<br />
a) Brevi cenni biografici e tempo in cui visse<br />
b) Il Sacerdote<br />
c) Lo Scrittore<br />
d) Problema vocazionale<br />
Capitolo I<br />
Il Frassinetti e la formazione del giovane clero<br />
Capitolo II<br />
- Il Frassinetti e la pastorale delle vocazioni.<br />
- I <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong><br />
e) Conclusione<br />
BREVI CENNI BIOGRAFICI E TEMPO IN CUI VISSE<br />
Giuseppe Frassinetti, è nato a Genova nel 1804, or<strong>di</strong>nato<br />
Sacerdote nel 1827, fu zelante Sacerdote fino alla morte (1868), prima<br />
parroco a Quinto, poi Priore a <strong>Santa</strong> Sabina in Genova.<br />
Nell‘esercizio del suo ministero egli visse il dramma del suo tempo<br />
inquieto e assaporò anche il dramma dell‘esilio.<br />
Per <strong>di</strong>mensionare l‘uomo bisogna rendersi conto del tempo in cui<br />
visse.<br />
Siamo all‘indomani della vicenda <strong>di</strong> Napoleone, che era riuscito ad<br />
imbrigliare l‘impeto scomposto della rivoluzione francese con l‘ormai<br />
anacronistico scettro imperiale, che serví però a <strong>di</strong>ffondere per tutta<br />
l‘Europa gli esplosivi principi del 1789.<br />
Sul piano politico—sociale attecchisce e si sviluppa la concezione<br />
68
del Rousseau, che pone nel popolo la fonte dell‘autorità e, subor<strong>di</strong>nando<br />
alla volontà del popolo la funzione e la sorte dello stato, apre la via alle piú<br />
svariate esperienze, ivi compresa anche la via democratica, almeno sul piano<br />
formale.<br />
Sul piano filosofico trionfa il razionalismo <strong>di</strong> Emmanuel Kant, che<br />
insieme all‘illuminismo, presta le armi al liberalismo areligioso o irreligioso<br />
del secolo seguente.<br />
Sul piano letterario a artistico corrono due linee <strong>di</strong>stinte e<br />
contrastanti: il Classicismo che si ricollega al Rinascimento e<br />
all‘Umanesimo, e il Romanticismo, che, pur ispirandosi all‘ideale cristiano<br />
dominante nel Me<strong>di</strong>o Evo, si imbeve mano mano delle correnti nuove a<br />
carattere rinnovatore e anche rivoluzionario.<br />
Dopo lo sconvolgimento napoleonico, il pesante trattato <strong>di</strong><br />
Vienna e la conseguente <strong>Santa</strong> Alleanza, fecero con violenza il vano sforzo<br />
<strong>di</strong> stroncare il corso della storia, ritornando allo spirito e alle forme del<br />
passato.<br />
E <strong>di</strong>fatti il clima o<strong>di</strong>oso della <strong>Santa</strong> Alleanza suscitò una reazione<br />
prima clandestina e poi aperta che domina tutto l‘ottocento.<br />
Purtroppo le istanze irreligiose della rivoluzione francese<br />
influiscono sulle correnti opposte e ne fanno confluire il movimento verso<br />
un atteggiamento comune ostile alla Chiesa.<br />
E la Chiesa che aveva sofferto al tempo della rivoluzione continuò<br />
a soffrire sotto Napoleone e dopo <strong>di</strong> lui non ebbe miglior sorte, anzi si<br />
trovò <strong>di</strong> fronte due nemici da una parte l‘assolutismo artificioso restaurato<br />
dalla <strong>Santa</strong> Alleanza, dall‘altra il liberalismo innovatore erede della<br />
rivoluzione francese.<br />
Nel seno stesso della Chiesa si determina un <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o tra<br />
conservatori e liberali.<br />
Presto il conservatorismo rigido si polarizzò intorno alla<br />
Compagnia <strong>di</strong> Gesú, ritornata in vita (dopo l‘abolizione decretata da<br />
Clemente XIV ) per volontà <strong>di</strong> Pio VII.<br />
Si spiegano cosí la presenza e l‘azione <strong>di</strong> Sacerdoti, come il<br />
Gioberti e il Rosmini, accanto a Sacerdoti e laici nemici <strong>di</strong> ogni<br />
innovazione.<br />
I Papi Gregorio XIV e Pio IX presero posizione contro il<br />
razionalismo e il liberalismo, che erano alla base del movimento politico<br />
sociale.<br />
Pio IX tentò da principio un‘apertura sul piano politico, salva la<br />
dottrina cattolica; ma dovette subito in<strong>di</strong>etreggiare <strong>di</strong> fronte all‘abuso, fino<br />
al punto <strong>di</strong> promulgare il famoso Sillabo, che sollevò come un muro <strong>di</strong><br />
bronzo contro ogni tendenza liberale e innovatrice.<br />
69
Il Frassinetti nacque e visse in questo agitato periodo storico in cui<br />
maturò anche il Risorgimento italiano.<br />
Come detto sopra, nacque a Genova nel 1804, da Giovanni<br />
Battista e Angela Viale, modesti commercianti e piissimi cristiani.<br />
Dei suoi fratelli, Francesco, canonico lateranense, fu Parroco a<br />
nostra Signora Incoronata a Genova; Raffaele e Giovanni, sacerdoti,<br />
furono suoi collaboratori nel ministero sacerdote e Paola fu fondatrice<br />
delle suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea e venne beatificata da Pio XI l‘otto luglio<br />
1930.<br />
Il giovane Giuseppe frequenta, come esterno, le scuole del<br />
seminario <strong>di</strong> Genova , ove ha come maestro S. Antonio M. Gianelli.<br />
Il 22 settembre del 1827 è or<strong>di</strong>nato Sacerdote in Savona. Nel 1831<br />
è nominato Prevosto <strong>di</strong> S. Pietro a Quinto, parrocchia <strong>di</strong> circa duemila<br />
pescatori e marinai; poi, il primo giugno del 1839, <strong>di</strong>venta Priore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong><br />
Sabina in Genova, ove resterà parroco fino alla morte, avvenuta il 2<br />
gennaio 1868.<br />
Dal 15 aprile del 1934 la sua salma riposa nella Casa genovese dei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, la Congregazione religiosa erede del suo<br />
spirito<br />
IL SACERDOTE<br />
Pur non essendo vissuto in seminario, come interno, il Frassinetti<br />
percorse la via verso l‘altare alla luce <strong>di</strong> una vocazione cosciente maturando<br />
con rara <strong>di</strong>ligenza la sua formazione sul duplice piano dello stu<strong>di</strong>o e della<br />
pietà.<br />
Arrivò all‘Altare con una bella cultura letteraria e teologica, e, quel<br />
che piú conta, con vivo sentimento <strong>di</strong> fede e <strong>di</strong> devozione a Dio e alla sua<br />
Chiesa.<br />
La sua era una pietà profonda, frutto della grazia e della generosa<br />
cooperazione del giovane.<br />
Tutta la sua vita è una luminosa testimonianza della sua matura<br />
formazione sacerdotale.<br />
Dopo l‘or<strong>di</strong>nazione, si <strong>di</strong>ede subito all‘apostolato del<br />
confessionale e del catechismo. Si può <strong>di</strong>re che passò tutta la sua vita come<br />
semplice parroco.<br />
Nell‘una e nell‘altra sede fu un modello e<strong>di</strong>ficante <strong>di</strong> pietà e <strong>di</strong><br />
zelo, lavorando instancabilmente a far rifiorire la fede illangui<strong>di</strong>ta e i buoni<br />
costumi insi<strong>di</strong>ati dal libertinaggio, che accompagnava spesso il movimento<br />
rivoluzionario.<br />
70
Gli eventi politici non lo <strong>di</strong>strassero dal suo campo <strong>di</strong> lavoro, ma<br />
ne eccitavano maggiormente lo zelo.<br />
Alla silenziosa <strong>di</strong>rezione delle anime aggiungeva la pre<strong>di</strong>cazione e<br />
la catechesi nutrite <strong>di</strong> soda e sicura dottrina.<br />
Altro segno del suo spirito aperto e quasi profetico è la sua sollecitu<strong>di</strong>ne<br />
nel fomentare e realizzare il metodo associativo e comunitario.<br />
La <strong>di</strong>sgrazia, egli scrive, del partito dei buoni è l‘isolamento<br />
(Riflessioni: vol. III. pag.73).<br />
E altrove afferma: Chi lavora da solo non può far gran bene. Egli<br />
intuì e affermò la necessità della vita associata e organizzata oltre che tra i<br />
Sacerdoti, tra i laici e conseguentemente sostenne il dovere dei Sacerdoti <strong>di</strong><br />
dare a tali unioni, associazioni, organizzazioni <strong>di</strong> laici, vita e assistenza, e la<br />
convenienza per i laici <strong>di</strong> unirsi ed agire secondo le loro possibilità e lo<br />
spirito dì ogni associazione.<br />
Non tutte le associazioni ebbero uguale successo, né tutte<br />
sopravvissero a lui, ma tutte restano prova che il Frassinetti, precorrendo i<br />
tempi, sentí l‘urgenza <strong>di</strong> unire i buoni laici perché nell‘unione trovassero<br />
<strong>di</strong>fesa della loro fede e della loro vita cristiana.<br />
Questa sua brama <strong>di</strong> unione e <strong>di</strong> associazione del laicato cattolico<br />
è da lui esplicitamente manifestata in un «Appello ai fervorosi cristiani»<br />
scritto verso il 1850 e non pubblicato, ma che, ad oltre un secolo <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stanza, serba tutta l‘urgenza e concretezza delle idee che non tramontano.<br />
Per quanto riguarda il suo lavoro nel campo delle vocazioni<br />
sacerdotali lo vedremo in seguito.<br />
LO SCRITTORE<br />
Il Frassinetti ha scritto molto, attenendosi sempre ad argomenti <strong>di</strong><br />
indole morale ed ascetica.<br />
Tra i libri ed opuscoli da lui stesso pubblicati si contano<br />
ottantanove opere; altre nove videro la luce dopo la sua morte; <strong>di</strong>versi sono<br />
i manoscritti ancora ine<strong>di</strong>ti.<br />
Nel 1908 e anni seguenti la Poliglotta Vaticana raccoglieva il<br />
meglio della produzione in 13 volumi.<br />
Senza dubbio l‘opera <strong>di</strong> maggior rilievo, anche per carattere<br />
scientifico, è il «Manuale <strong>di</strong> Teologia Morale» in due volumi.<br />
In tutti i suoi scritti l‘autore <strong>di</strong>mostra perspicacia <strong>di</strong> ingegno,<br />
copiosa cultura, decoro e semplicità <strong>di</strong> stile, purezza <strong>di</strong> lingua notevole per<br />
la sua epoca.<br />
71
Egli non scrive per scrivere, ma per comunicare efficacemente<br />
idee maturate nello stu<strong>di</strong>o, nell‘esperienze e nelle preghiere; perciò riesce a<br />
tener desta l‘attenzione del lettore, inducendolo a riflettere.<br />
Partecipò vivamente con gli scritti ai problemi del tempo. Anche<br />
in Italia era arrivato il Giansenismo; non è il caso <strong>di</strong> rifare la storia <strong>di</strong><br />
questo movimento, ci porterebbe molto lontano.<br />
Inoltre ci troviamo al primo Risorgimento, nel periodo della<br />
persecuzione dei Gesuiti, <strong>di</strong> fronte a personaggi come il Gioberti che<br />
scriveva il suo «Gesuita moderno».<br />
Il Frassinetti vide nel Gioberti non solo un nemico dei Gesuiti, ma<br />
anche della Chiesa e scrisse contro <strong>di</strong> lui il libro: «Saggio intorno alla<br />
<strong>di</strong>alettica e alla religione <strong>di</strong> V. Gioberti».<br />
In esso con garbata ironia metteva in evidenza le incoerenze e le<br />
contrad<strong>di</strong>zioni che seguono tutta la vita e l‘attività del filosofo torinese. E<br />
Gioberti rispose con l‘accento iroso proprio del suo carattere, coprendolo<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>sprezzo.<br />
Il Frassinetti non era contrario al movimento per l‘unificazione<br />
dell‘Italia, ma, fedele alla sua vocazione sacerdotale, non poteva tollerare<br />
che il movimento degenerasse in una rivoluzione laicistica e antireligiosa.<br />
Per questo deplorò i mo<strong>di</strong> incomposti sul terreno politico—<br />
sociale e combatté il giansenismo sotto il duplice aspetto della rivoluzione<br />
atea e <strong>di</strong> nemico della dottrina cattolica.<br />
Di conseguenza doveva <strong>di</strong>fendere i Gesuiti. E con <strong>di</strong>gnità serena<br />
tradusse il suo atteggiamento nei suoi scritti.<br />
Sul piano strettamente religioso egli combatté il Giansenismo<br />
seguendo le orme <strong>di</strong> S. Alfonso de‘ Liguori e scrisse il suo Manuale <strong>di</strong><br />
Teologia Morale, dove adotta il Probabilismo, che tutela la libertà <strong>di</strong> fronte<br />
alla legge dubbia.<br />
Molto egli parla della necessità <strong>di</strong> adeguare l‘apostolato all‘esigenza<br />
dei tempi, deplorando quei sacerdoti e laici che vivono <strong>di</strong> nostalgia per il<br />
passato e si lasciano prendere dal panico <strong>di</strong> fronte a ogni novità.<br />
Egli ha un vivo senso storico della vita e perciò non solo sa<br />
adattarsi alle esigenze della sua epoca, ma precorre i tempi con felice<br />
intuizione e con coraggiose iniziative. (Note prese dal Card. Parente, citato<br />
nella bibliografia).<br />
72
PROBLEMA VOCAZIONALE<br />
Verso la metà dell‘ottocento, periodo <strong>di</strong> forti crisi e rivoluzioni in<br />
tutti i campi, nella Chiesa era fortemente sentita la crisi delle vocazioni<br />
ecclesiastiche, forse anche in maniera piú urgente <strong>di</strong> oggi.<br />
Ma la Chiesa seppe trovare in se stessa la forza <strong>di</strong> poter uscire da<br />
tale crisi; prova ne sono le gran<strong>di</strong> figure <strong>di</strong> Sacerdoti della seconda metà del<br />
secolo passato e dell‘inizio <strong>di</strong> questo. Il Signore assiste sempre la sua<br />
Chiesa, ma vuole le nostra collaborazione.<br />
Il Frassinetti nelle «Brevi parole ai Sacerdoti fratelli» ne dava<br />
l‘allarme <strong>di</strong>cendo: «Questo è il supremo bisogno del giorno».<br />
E riportava la statistica dei sacerdoti or<strong>di</strong>nati e morti nella <strong>di</strong>ocesi<br />
<strong>di</strong> Genova, nel decennio dal 1856 al 1865, in cui risultava esser morti 247<br />
sacerdoti e gli or<strong>di</strong>nati 85, una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> nove or<strong>di</strong>nati e venticinque morti<br />
per anno.<br />
Cosí, se non peggio, ovunque.<br />
Le cause <strong>di</strong> tale crisi le aveva già: accennate nel suo «Para<strong>di</strong>so in<br />
terra»: l‘incredulità che si estende, l‘immoralità sempre crescente, che ne è<br />
la conseguenza; la seduzione dei teatri e dei festini, tanto moltiplicati e facili<br />
alla gioventú, le passioni politiche che non furono mai cosí ardenti,<br />
formano una società tutta imbevuta <strong>di</strong> sentimenti carnali e terreni, tutta<br />
aliena alle cose dello spirito, in modo che i sensi della avita pietà vanno<br />
fortemente scemando nelle famiglie cristiane; quin<strong>di</strong> le vocazioni<br />
ecclesiastiche ad<strong>di</strong>vengono rare oltremodo, e queste poche vengono<br />
soffocate dalla universalità delle leve militari e dallo scoraggiamento che<br />
proviene da una specie <strong>di</strong> avversione al clero.<br />
Da Lucca il Canonico Almerico Guerra scrisse al Frassinetti<br />
perché scrivesse e operasse qualcosa in merito.<br />
Nella lettera <strong>di</strong> risposta del Frassinetti, poi pubblicata, troviamo<br />
alcune in<strong>di</strong>cazioni su come risolvere ed affrontare il problema.<br />
Egli non vede altra strada che rivolgersi ai buoni parroci e<br />
confessori ―in specie delle ville, perché, conoscendo i fanciulli <strong>di</strong> buone<br />
speranze, invoglino i genitori ad educarli al sacerdozio, se si sviluppi in essi<br />
alcun probabile in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> vocazione ecclesiastica, e cerchino <strong>di</strong> appianare<br />
per quanto possibile ogni <strong>di</strong>fficoltà.<br />
Trovato un giovinetto <strong>di</strong> buona indole e pieghevole alla pietà, lo si<br />
coltivi con particolare impegno, avviandolo alla pratica della vita devota,<br />
sovra tutto alla pratica dei santi Sacramenti, innamorandolo sovra tutto<br />
della <strong>Santa</strong> Comunione, perché è dalla Comunione assai frequente che si<br />
infonde nelle anime l‘amore alla castità, oltre la forza per conservarla.<br />
73
I giovani che si determinano a vivere in castità hanno la miglior<br />
<strong>di</strong>sposizione per il Sacerdozio.<br />
Coltivi ogni buon parroco nella sua cura una congregazione <strong>di</strong><br />
giovinetti: potrà essere come un semenzaio donde potrà ritrarre alcune<br />
pianticelle da trapiantare nel giar<strong>di</strong>no del Santuario.<br />
E quando abbia trovato alcun giovinetto che mostri vocazione, si<br />
adoperi che sia messo agli stu<strong>di</strong>; se povero lo aiuti del suo o colla carità <strong>di</strong><br />
pie persone‖.<br />
―Insomma — aggiunge — non ci illu<strong>di</strong>amo che i tempi si facciano<br />
migliori, preveniamo le terribili conseguenze della deficienza dei giovani<br />
aspiranti al sacerdozio; preveniamo l‘inazione; si formi un‘associazione tra i<br />
buoni per avvisare e mettere in opera i mezzi a provvedere una necessità<br />
cosí urgente‖.<br />
Concludendo invita il Guerra a scrivere qualcosa <strong>di</strong> urgente su<br />
questo problema. Ma gli raccomanda: ―<strong>di</strong> instare sovrattutto sulla necessità<br />
<strong>di</strong> una associazione che unisca tutte le forze sparse e le moltiplichi,<br />
svegliando i dormienti‖.<br />
In questa lettera c‘è tutto un abbozzo <strong>di</strong> programma <strong>di</strong> lavoro che<br />
oggi ritroviamo attuale.<br />
Anche oggi si mette in risalto il valore della parrocchia nella ricerca<br />
delle vocazioni.<br />
Solo oggi, almeno a parole, si è arrivati a un Centro Nazionale<br />
Vocazioni, con lo scopo <strong>di</strong> riunire tutte le forze.<br />
Il Frassinetti ne aveva vista la necessità un secolo prima!<br />
CAPITOLO PRIMO<br />
IL FRASSINETTI E LA FORMAZIONE DEL GIOVANE CLERO<br />
Il Frassinetti appena or<strong>di</strong>nato Sacerdote, sentì subito la necessità<br />
<strong>di</strong> lavorare per il giovane clero, aiutandolo nella perseveranza della<br />
vocazione e nella formazione culturale ed ascetica.<br />
Scrive egli stesso: ―Appena fui or<strong>di</strong>nato Sacerdote si impossessò<br />
del mio cuore una brama forte <strong>di</strong> giovare, per quanto potessi nella mia<br />
nullità, confidando unicamente nel <strong>di</strong>vino aiuto, al giovane clero, e mi<br />
pareva che molto si sarebbe potuto fare a suo pro‖. 160<br />
160 G. FRASSINETTI, Schiarimenti sul mio passato, manoscritto citato da<br />
D. Fassiolo, Memorie storiche intorno alla vita del Sac. G. Frassinetti, Tip.<br />
della Gioventú, 1879, Genova.<br />
74
1) Per attuare questo proposito, il Frassinetti tiene pre<strong>di</strong>cazioni, ritiri,<br />
esercizi spirituali e conferenze formative ai seminaristi; su invito del rettore<br />
del Seminario Mons. De Gregori, il Frassinetti, benché fosse prete<br />
giovanissimo, accettò <strong>di</strong> tenere in seminario la spiegazione del Vangelo ai<br />
Chierici interni ed esterni.<br />
In queste spiegazioni, unite ad alcune conferenze che si trovano<br />
scritte per esteso, si vede la sua umiltà e quella fede viva che lo animava in<br />
tutte le circostanze ed azioni. 161<br />
Sappiamo dai titoli e dagli argomenti delle «conferenze» suddette<br />
che egli pre<strong>di</strong>cò in Seminario anche ritiri ed esercizi spirituali. 162<br />
2) Il Frassinetti matura l‘idea <strong>di</strong> fondare un‘unione <strong>di</strong> sacerdoti per aiutarsi<br />
vicendevolmente alla santificazione.<br />
Cosí avvenne quando nel 1829, sacerdote da tre anni, volle<br />
mettere in atto un‘idea già da tempo maturata: formare un‘unione <strong>di</strong><br />
giovani ecclesiastici i quali si proponessero una speciale cultura del proprio<br />
spirito e vi si animassero e se ne dessero conto vicendevolmente e poi si<br />
de<strong>di</strong>cassero in modo specialissimo a coltivar la gioventú. 163<br />
Visto che lo Sturla, altra nobile figura del clero genovese e suo<br />
intimo amico, ―simile cosa andava con altri trattando, si uní ad essi‖.<br />
La Congregazione ebbe inizio e fu intitolata all‘inizio, «Conferenza<br />
<strong>di</strong> Ecclesiastici collaboratori nella pia opera <strong>di</strong> S. Raffaele e S. Dorotea».<br />
Egli stesso ne stilò il piccolo regolamento ―da tanto tempo<br />
me<strong>di</strong>tato‖ (conferenza ogni 15 giorni per Sacerdoti e Chierici, con<br />
me<strong>di</strong>tazioni, confessioni, consigli, stu<strong>di</strong> etc. ).<br />
Questa conferenza fu chiamata poi piú comunemente<br />
«Congregazione del Beato Leonardo». Probabilmente si scelse S. Leonardo<br />
da Porto Maurizio per le caratteristiche proprie del Santo: attività<br />
apostolica, spirito <strong>di</strong> fede; ancora vivente fu chiamato l‘Apostolo dell‘Italia.<br />
3) Visto che la Congregazione cresceva in numero, ma si rattiepi<strong>di</strong>va nel<br />
fervore, il Frassinetti e lo Sturla ―<strong>di</strong>visarono <strong>di</strong> formare un drappello a<br />
parte il quale mantenesse quanto fosse possibile il primo fervore e<br />
formasse come l‘anima della Congregazione.<br />
Stesero un regolamento e si posero ad attuarlo: un‘ora <strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong>tazione quoti<strong>di</strong>ana, speciali atti <strong>di</strong> mortificazione, esercizi <strong>di</strong> S. Ignazio<br />
161 D. FASSIOLO, opera citata, pagina 28.<br />
162 G. FRASSINETTI, Opera Omnia, vol. VIII, pag. 257 e seg.: sono<br />
riportate <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> queste conferenze per Ritiri ed Esercizi spirituali ai<br />
seminaristi.<br />
163 G. FRASSINETTI, Notizia della Congregazione <strong>di</strong> Ecclesiastici detta del<br />
B. Leonardo, in Opera Omnia, vol. XIII, pag. 521 sg.<br />
75
ogni anno, pratica viva della povertà, riunione ogni settimana, non piú <strong>di</strong><br />
sette ore e mezzo <strong>di</strong> sonno ogni notte, mezz‘ora <strong>di</strong> ringraziamento dopo la<br />
Messa etc.‖.<br />
Di questo drappello il Frassinetti fu sempre l‘anima e quasi sempre<br />
il «Superiore».<br />
In tal modo la Congregazione ottenne ottimi frutti nella perseveranza e<br />
spiritualità del giovane clero genovese e, con le norme date dal Frassinetti,<br />
si estese anche ad altre Diocesi.<br />
4) Tutto preso dal suo amore al Sacerdozio e dal desiderio <strong>di</strong> essere sempre<br />
piú utile al giovane clero, il Frassinetti nel 1834 pensò che sarebbe stata<br />
cosa utilissima stabilire una Accademia <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> ecclesiastici, col pensiero<br />
che ―tirando ad essa il fiore dei Chierici, da cui infallibilmente deve venire il<br />
fiore del clero, e proseguendo la stessa cultura per i Sacerdoti che<br />
rimangono in città si sarebbe fatto un bene incalcolabile‖.<br />
L‘idea gli parve tanto buona e la cosa tanto importante da non<br />
doversi domandare consiglio, né <strong>di</strong>fferire.<br />
Mandò or<strong>di</strong>ne pertanto ai suoi compagni che al primo prossimo<br />
lunedí si desse cominciamento a questa Accademia‖ 164. Cosí dunque il<br />
Frassinetti la costituí, stendendone il regolamento. Leggiamo al primo<br />
capitolo riguardo al fine degli stu<strong>di</strong>:<br />
―Il fine degli stu<strong>di</strong> è che i giovani Sacerdoti e i Chierici si uniscano<br />
nel riconoscere e provvedersi <strong>di</strong> quei sani principi che sono come le basi<br />
sopra le quali dovranno fondare il loro stu<strong>di</strong>o quando poi vi si daranno<br />
loro stessi ex professo‖ 165.<br />
L‘Accademia cominciò con molto fervore e presto raccolse i<br />
migliori ecclesiastici, chierici e sacerdoti novelli.<br />
Per comprendere meglio quanto il Frassinetti si prefiggeva può<br />
essere utile riportare quanto poi scrisse sul «Triplice fondamento su cui fu<br />
eretta la Congregazione del Beato Leonardo».<br />
―Quando l‘uomo ha buona intenzione e prega e si consiglia, nelle<br />
sue operazioni è sicuro, perché nulla piú può da lui esigere Dio e <strong>di</strong>etro le<br />
sue benigne promesse è obbligato a se stesso e non permettere che costui<br />
erri.<br />
La buona intenzione, la preghiera, il consiglio sono il triplice<br />
fondamento su cui venne eretta la nostra Congregazione e questo ci dà una<br />
gran sicurezza <strong>di</strong> averla e<strong>di</strong>ficata con Dio.<br />
164 G. FRASSINETTI, op. cit., pag. 535.<br />
165 G. FRASSINETTI, Regolamento per l’Accademia del B. Leonardo, in<br />
Opera Omnia, vol. XIII, pag. 605.<br />
76
.....Il triplice fondamento della Congregazione, procuriamo che sia<br />
pure il fondamento della nostra vita ecclesiastica, del nostro agire particolare,<br />
e questo ci dà molta confidenza <strong>di</strong> riuscire al nostro scopo finale che è<br />
in sostanza quello <strong>di</strong> vedere in noi e da noi eseguita la volontà <strong>di</strong> Dio‖ 166.<br />
5) Seguendo la vita dei giovani sacerdoti della Congregazione del Beato<br />
Leonardo, il Frassinetti s‘accorge che avrebbe dovuto aiutare <strong>di</strong> piú quelli<br />
che — trasferiti lontano dal centro — non potevano piú partecipare alle<br />
riunioni e alla vita spirituale dell‘Associazione.<br />
Cosí, a poco a poco, maturò l‘idea <strong>di</strong> seguirli con scritti, utili anche<br />
a Sacerdoti <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>ocesi.<br />
Nel 1837 scrive «L‘esortazione agli ecclesiastici» da leggersi nelle<br />
riunioni della Congregazione.<br />
Queste pagine sono pubblicate per iniziativa del Marchese<br />
Durazzo con il titolo «Riflessioni proposte agli Ecclesiastici».<br />
Come <strong>di</strong>chiarò poi egli stesso al Car<strong>di</strong>nale Arcivescovo <strong>di</strong> Genova,<br />
voleva fossero semplici esortazioni, da fratello a fratello.<br />
In esse fa capire con forza e convinzione che il miglior modo <strong>di</strong><br />
rispondere ai nemici della Chiesa è che i Sacerdoti siano puri, sinceri,<br />
schietti, coraggiosi, virtuosi, zelanti nel ministero, tutti protesi alla<br />
perfezione, uniti dai loro pastori e alla santa Chiesa <strong>di</strong> Roma che bisogna in<br />
modo specialissimo <strong>di</strong>fendere e amare.<br />
L‘idea chiave <strong>di</strong> tutto il libro è questa: ―la nostra condotta sia<br />
talmente irreprensibile da poter servire a modello al popolo cristiano‖.<br />
Il libro scandalizzò, per l‘ar<strong>di</strong>re, alcuni pochi conservatori a tinta<br />
giansenistica, ma per la vita spirituale <strong>di</strong> moltissimi Sacerdoti fu motivo <strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong>tazione profonda e <strong>di</strong> rinnovamento spirituale.<br />
Dal libro egli ebbe molte sofferenze, ma lo ristampò con note egli<br />
stesso e lo <strong>di</strong>fese fino alla morte (confronta «Rischiarimenti sul mio<br />
passato») perché gli apparve sempre come una doverosa testimonianza e<br />
una chiara visione spirituale dell‘autentico Sacerdozio cattolico.<br />
Per questo libro — che anche nello stile riflette la convinzione e la<br />
passione con cui fu scritto — fu per <strong>di</strong>versi anni come segno <strong>di</strong><br />
contrad<strong>di</strong>zione e un fondamento vivo <strong>di</strong> riflessione per quei giovani<br />
sacerdoti che nella loro vita credevano all‘autentico e all‘impegno.<br />
Nel 1839, per i giovani chierici scrive le «Osservazioni sopra gli<br />
stu<strong>di</strong> ecclesiastici».<br />
Raccogliendo, come egli stesso <strong>di</strong>ce, in poche pagine il meglio che<br />
trovò sparso in molti libri, intese con questo libretto porgere ai giovani<br />
ecclesiastici norme pratiche e sicure per evitare ad un tempo la superfi-<br />
166 G. FRASSINETTI, op. cit., pag. 592—593.<br />
77
cialità e la smania <strong>di</strong> in<strong>di</strong>fferenza e <strong>di</strong> novità: due scogli funesti che fanno<br />
errare facilmente dal retto sentiero le giovani intelligenze.<br />
Nel libro insiste sovente sul fine che debbono avere sempre<br />
innanzi nell‘approfon<strong>di</strong>re ogni sacra dottrina: l‘amore a Dio e la salvezza<br />
dei fratelli.<br />
Il lavoro del Frassinetti per la formazione del giovane clero dava<br />
ben presto i suoi frutti.<br />
Lo riconoscevano il Car<strong>di</strong>nale Arcivescovo (che lo aveva elevato<br />
alla sede parrocchiale <strong>di</strong> S. Sabina) insieme ai migliori Vescovi ed<br />
Ecclesiastici della Liguria.<br />
Commenta l‘Olivari: ―Si era visto in pochi anni rifiorire nei<br />
giovane clero la pietà.., si ammirava nei chierici e nei novelli sacerdoti uno<br />
zelo singolare in ammaestrare i fanciulli nella dottrina cristiana, nello indurli<br />
alla frequenza dei Sacramenti e alla pratica della virtú.<br />
Si ammirava la loro carità verso i poveri detenuti, per consolarli,<br />
istruirli, prepararli. a ricevere i Santi Sacramenti.<br />
E il bene che operavano in tutta la Diocesi uomini ispirati a questo<br />
zelo sacerdotale era incalcolabile.<br />
Di questo risveglio si consolava piú che altri il Frassinetti che vedeva<br />
attuarsi in qualche parte il suo sogno generoso‖ 167.<br />
Nel 1852, il Frassinetti pubblica per la formazione del clero «Gesú<br />
Cristo regola del Sacerdote»<br />
Le sofferenze avute dalle calunnie e dall‘esilio (per quanto riguarda<br />
l‘esilio ve<strong>di</strong> nota a fine capitolo) non lo <strong>di</strong>stolsero dal perseguire la<br />
missione che si era prefisso nella sua or<strong>di</strong>nazione sacerdotale: la formazione<br />
del clero.<br />
Anzi le prove e le sofferenze che lo hanno portato alla maturità<br />
spirituale e a veder sempre piú chiaramente l‘or<strong>di</strong>ne dei valori della vita del<br />
consacrato, lo convincono ancor piú che se il Sacerdote vuol vivere<br />
gioiosamente la sua vocazione deve tendere con tutta l‘anima alla<br />
perfezione e imitare il modello <strong>di</strong>vino Gesú Cristo, sommo ed eterno<br />
Sacerdote.<br />
Con questo libretto, frutto <strong>di</strong> una elevazione spirituale altissima,<br />
invita appunto a questo itinerario spirituale i suoi confratelli nel sacerdozio,<br />
con <strong>di</strong>re sobrio, modesto, spontaneo e penetrante, lasciando parlare lo<br />
stesso Gesú Cristo.<br />
L‘imme<strong>di</strong>atezza, l‘unità <strong>di</strong> ispirazione e lo stile adeguato lo fanno,<br />
nel suo genere, un piccolo capolavoro.<br />
167 C. OLIVARI, Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio G. Frassinetti,<br />
Roma, Tip. Poliglotta Vaticana, 1928, pag. 84.<br />
78
―Sacerdote mio ministro, io ti ho scelto <strong>di</strong> mezzo al mio popolo<br />
affinché in mio nome e in mia autorità tu ammaestri le anime redente col<br />
mio sangue, le sciogli dai peccati, offra per esse il sacrificio eucaristico, con<br />
le tue preghiere e sacri ministeri le santifichi e le ricolmi delle celesti<br />
bene<strong>di</strong>zioni.<br />
Per la qual cosa, nel popolo cristiano, tu devi rappresentare la mia<br />
persona e, per quanto ti è possibile, ricopiarla in te me<strong>di</strong>ante una fedele<br />
imitazione.<br />
Se tu mi stu<strong>di</strong>, non hai bisogno <strong>di</strong> altro libro per imparare ad<br />
essere buon sacerdote. Osserva la mia vita <strong>di</strong>vina e ricopiale in te‖ 168.<br />
In questa breve introduzione possiamo scorgere un programma <strong>di</strong><br />
vita assai semplice, ma impegnativo al massimo grado.<br />
Esso rispecchia fedelmente la personalità e il metodo del<br />
Frassinetti; cioè la perfezione sacerdotale esposta con grande semplicità,<br />
limpida spontaneità, senza drammatizzare; ma nello stesso tempo una<br />
perfezione che tocca le vette piú alte e impegna il sacerdote proprio in tutta<br />
la sua vita.<br />
Dirò che nelle pagine del Frassinetti anche la perfezione, l‘eroismo<br />
ha un tono familiare, un volto molto bonario che non spaventa nessuno,<br />
pur essendo tesa verso un modello inarrivabile per la perfezione umana. È<br />
<strong>di</strong>fatti Gesú regola della vita sacerdotale. In Lui tutto si incentra e da Lui<br />
tutto si apprende.<br />
A chi legge l‘opuscolo citato, appare subito ben chiara la linea<br />
programmatica tracciata dall‘autore ai suoi confratelli; la vita interiore ed<br />
esteriore, le virtú, l‘operosità, tutto deve essere regolato secondo Gesú<br />
Cristo.<br />
Gesú Cristo conosciuto ed amato, seguito con una passione<br />
sempre crescente e coerente a se stessa, è la regola del sacerdote. Tutto<br />
viene in<strong>di</strong>rizzato a Lui così come tutto da Lui deve partire.<br />
Certamente questo programma è invitante, né il sacerdote che si<br />
impegni ad attuarlo con la grazia <strong>di</strong> Dio può trovarsi comunque a <strong>di</strong>sagio,<br />
anzi s‘accende in lui una fiamma d‘amore, alimentata dalla fede in Cristo,<br />
capace <strong>di</strong> attingere le mete piú alte.<br />
Ho già affermato che il Frassinetti ha il dono <strong>di</strong> semplificare anche<br />
le idee piú sublimi; ciò si può verificare anche nel presente argomento, ché<br />
lo stu<strong>di</strong>o che egli fa <strong>di</strong> Gesú Cristo, regola del sacerdote, è cosí spontaneo,<br />
cosí convincente, che il lettore rimane persuaso <strong>di</strong> aver ricevuto degli<br />
in<strong>di</strong>rizzi davvero efficaci.<br />
168 G. FRASSINETTI, Gesú Cristo regola del Sacerdote, Opera Omnia vol.<br />
III, pag. 9.<br />
79
S‘aggiunga che egli stesso lascia netta l‘impressione che Cristo,<br />
regola del sacerdote, sia argomento <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, sia come imitazione è<br />
inesauribile.<br />
Piú che un testamento da godere, è una miniera da sfruttare incessantemente,<br />
buona a tutte le necessità, preziosa per ogni giorno della vita,<br />
cosí che il sacerdote non solo si orienta verso Cristo, ma si impegna<br />
seriamente con Lui, mostrandosi alle genti in senso pieno suo ministro. 169<br />
Proprio nei giorni tristi dell‘esilio (1848) —ve<strong>di</strong> nota — mentre<br />
lavora all‘idea del libretto «Gesú Cristo, regola del sacerdote», dà inizio a<br />
due opere <strong>di</strong> piú vasta mole ed impegno, quasi a reagire al dolore provato<br />
per la fine imposta alla Congregazione del Beato Leonardo (1847).<br />
Se i nemici del bene troncano le opere che vengono da Dio—<br />
pensa il Frassinetti — il miglior modo <strong>di</strong> reagire è <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>arne ed attuarne<br />
altre nuove.<br />
Nasce cosí l‘idea del «Manuale del Parroco novello» e del<br />
«Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia morale» (Opere citate in seguito). All‘una e<br />
all‘altra de<strong>di</strong>cherà ogni briciola <strong>di</strong> tempo libero per quasi vent‘anni.<br />
Del 1861 è «La proposta agli Ecclesiastici» scritta e pubblicata in<br />
brevi pagine. L‘idea centrale che informava le «Riflessioni» e lo «Statuto<br />
della Congregazione del Beato Leonardo» percorre anche questo scritto<br />
che è accorato ―invito ai Sacerdoti desiderosi della propria ed altrui salute<br />
spirituale perché si uniscano in santa unione con speciali propositi da<br />
coltivare cioè il proprio spirito e incitarsi a vicenda allo zelo per il popolo<br />
cristiano‖.<br />
Nel 1863, per la formazione pastorale dei giovani Parroci il<br />
Frassinetti pubblica il «Manuale pratico del Parroco Novello». ―Io lo<br />
presento ai parroci novelli con la libertà <strong>di</strong> un fratello anziano che loro può<br />
<strong>di</strong>re: voi, freschi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>, mi avanzerete nelle cognizioni teoriche, ma nelle<br />
pratiche io necessariamente mi avvantaggio su <strong>di</strong> voi‖ 170.<br />
Dal tono della prefazione sono manifestate le doti <strong>di</strong> cor<strong>di</strong>alità,<br />
semplicità, franchezza dell‘autore, cosí come appare il dominio della<br />
materia <strong>di</strong> cui darà prova in tutto il libro.<br />
L‘autore infatti riesce sempre con sobrietà e precisione <strong>di</strong><br />
ammaestramenti <strong>di</strong> sapienza prudenziale unita a carità a guidare il giovane<br />
sacerdote nell‘arte <strong>di</strong> reggere una parrocchia.<br />
Nello stesso tempo riesce a nutrirlo spiritualmente per la stessa<br />
vita interiore con uno stile e un modo che possono esser detti «fraterni».<br />
169 V. VAILATI, Un maestro <strong>di</strong> vita sacerdotale, ed. Paoline, Alba, 1947.<br />
170 G. FRASSINETTI, Manuale del Parroco Novello, Prefazione.<br />
80
Note caratteristiche dell‘insegnamento dell‘Autore sono la fiducia<br />
e l‘ottimismo cristiano, che egli cerca <strong>di</strong> trasmettere ai pastori <strong>di</strong> anime; sa<br />
bene, infatti, che la piú grande tentazione per un buon pastore è il<br />
rattristarsi, il <strong>di</strong>sanimarsi del proprio ufficio sembrandogli sterile lavoro e<br />
troppo gran<strong>di</strong> le <strong>di</strong>fficoltà.<br />
L‘efficacia del libro fu molto superiore a quella che il Frassinetti<br />
sperava: <strong>di</strong>verse e<strong>di</strong>zioni in Italia (già 10 nel 1902), traduzioni in Francia, in<br />
Germania, in Spagna, in Svizzera, in Austria, in Inghilterra hanno portato il<br />
manuale in casa <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> giovani parroci (La biografia dell‘Olivari<br />
purtroppo non riporta le varie e<strong>di</strong>zioni nelle lingue straniere; l‘ultima in<br />
Italia è del 1964, delle E<strong>di</strong>zioni Paoline, do<strong>di</strong>cesima e<strong>di</strong>zione curata da G.<br />
Pistoni).<br />
Si legge nella presentazione dell‘ultima e<strong>di</strong>zione (E. P.) italiana:<br />
―Il Manuale del Parroco novello si impose, fin dal suo apparire,<br />
come un amico prezioso per chi è addetto alla cura delle anime: frutto <strong>di</strong><br />
profonda pietà e <strong>di</strong> ardente zelo, illuminato dalla miglior sapienza degli<br />
antichi, univa a queste doti due rari pregi: una esperienza trentennale<br />
dell‘autore in parrocchie <strong>di</strong>versissime per popolazione ed ambiente, svolta<br />
in tempi <strong>di</strong>fficili come i nostri, ed una moderazione e <strong>di</strong>screzione<br />
ammirevoli.<br />
La preghiera e lo stu<strong>di</strong>o conciliarono al Manuale la stima e la<br />
simpatia del clero, allora particolarmente allarmato e <strong>di</strong>ffidente. Ora, dopo<br />
un secolo, l‘Opera si presenta nell‘integrità del testo quale lo volle l‘autore,<br />
ed aggiornata in copiose ed opportunissime note che da un lato<br />
lumeggiano il perenne rinnovarsi della Chiesa e delle istituzioni<br />
ecclesiastiche e dall‘altro sono prova della perennità sostanziale del volume:<br />
parecchie sue pagine sembrano, nel tono e nel contenuto, precorritrici<br />
dell‘insegnamento pastorale <strong>di</strong> Giovanni XXIII e <strong>di</strong> Paolo VI.<br />
Nutriamo fiducia che la presente e<strong>di</strong>zione trovi l‘accoglienza delle<br />
precedenti, che i Sacerdoti, sia novelli che provati da lungo ministero,<br />
trovino fiducia e guida in quello che il Card. Svampa definí: Un trattato <strong>di</strong><br />
teologia pastorale che, con alcune aggiunte per le nuove esigenze sociali,<br />
potrebbe adottarsi come testo nelle scuole dei nostri seminari‖ 171.<br />
Dopo 18 anni <strong>di</strong> riflessione e <strong>di</strong> lavoro, negli anni 1865—1866, il<br />
Frassinetti pubblica il «Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Teologia Morale <strong>di</strong> S. Alfonso M. de<br />
Liguori, con apposite note e <strong>di</strong>ssertazioni».<br />
Lo scrive presentandolo ai confessori, specialmente novelli: — per<br />
togliere l‘incertezza e la <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> tanti meto<strong>di</strong> nella pratica della<br />
171 G. FRASSINETTI, Manuale del Parroco novello, Ed. Paoline, Alba 1964<br />
Prefazione. Do<strong>di</strong>cesima e<strong>di</strong>zione curata da G. Pistoni.<br />
81
confessione; — per far conoscere (chiarendo semplicemente,<br />
approfondendo) la dottrina <strong>di</strong> S. Alfonso M. de‘ Liguori; — per inculcare<br />
nei sacerdoti che ―quanto piú la fede è indebolita fra noi, tanto piú è<br />
necessario far uso <strong>di</strong> con<strong>di</strong>scendenza verso i peccatori che ritornano a Dio<br />
―( cfr. Prefazione alla Morale):<br />
per rendere piú brevi, semplici e fruttuose le confessioni;<br />
per far sí che i Sacerdoti riprendano piú gioiosamente la via del<br />
Confessionale e le fatiche dell‘Apostolato.<br />
Questi fini egli raggiunge con la sua scienza profonda, buon senso<br />
e col suo <strong>di</strong>scorrere da amico (specie nelle note e Appen<strong>di</strong>ci) entrando non<br />
solo nella mente ma nel cuore dei Sacerdoti.<br />
L‘idea madre del libro mi pare appunto un profondo senso del<br />
primato della misericor<strong>di</strong>a nel Cristianesimo.<br />
Il libro fu cosí anche una definitiva testimonianza contro i residui<br />
del Giansenismo pratico che ancora serpeggiava per certe cattedre<br />
confessionali d‘Italia.<br />
La prima e<strong>di</strong>zione ebbe un rapido smercio, la terza, del 1867 fu<br />
ancora corretta e accresciuta dall‘autore.<br />
―Ebbe ampie lo<strong>di</strong> da teologi e Vescovi che la <strong>di</strong>chiararono «Opera<br />
in<strong>di</strong>spensabile»‖ 172.<br />
Del libro si fecero <strong>di</strong>verse e<strong>di</strong>zioni e traduzioni (tedesco, francese,<br />
spagnolo, portoghese), l‘ultima italiana della SEI (Torino) è del 1944.<br />
Nella prima e<strong>di</strong>zione della Morale, come Appen<strong>di</strong>ce nel primo<br />
volume appariva lo scritto «Brevi parole ai Sacerdoti fratelli»; ma il<br />
Frassinetti volle pubblicarla anche a parte per <strong>di</strong>ffonderla gratuitamente<br />
come soleva fare per molti suoi opuscoli.<br />
È un‘altro colloquio fraterno coi sacerdoti perché restino sal<strong>di</strong><br />
nella fede e tendano alla perfezione sacerdotale con una vita immacolata,<br />
orazione perseverante, S. Messa celebrata con amore, spirito apostolico.<br />
Insiste ancora una volta sulla necessità che i sacerdoti si uniscano<br />
per aiutarsi fraternamente a progre<strong>di</strong>re nella virtú.<br />
Possiamo in sede consuntiva <strong>di</strong> questo breve curriculum del<br />
Frassinetti scrittore, concludere che il Frassinetti si curò <strong>di</strong> tradurre in<br />
realtà il forte desiderio che si era impossessato del suo cuore appena<br />
or<strong>di</strong>nato Sacerdote giovare, per quanto potesse, al giovane clero.<br />
Questo <strong>di</strong>visamento lo tradusse non solo nell‘azione ma anche<br />
negli scritti; si può <strong>di</strong>re che egli si preoccupò prima <strong>di</strong> tutto della sua<br />
perseveranza nella vocazione, della sua formazione spirituale e della sua<br />
172 S. CAPURRO, G. Frassinetti e l’opera sua, Genova 1907, Appen<strong>di</strong>ce pag.<br />
22.<br />
82
cultura, passando poi alla sua preparazione specifica per i compiti <strong>di</strong><br />
maggior responsabilità pastorale: ministero della Parrocchia e ministero del<br />
Confessionale.<br />
In questo apostolato operò sempre nella prospettiva <strong>di</strong><br />
promuovere la santificazione del clero <strong>di</strong>ocesano e <strong>di</strong> tutti i fedeli affidati<br />
ad esso da Gesú Cristo, centro e regola <strong>di</strong> tutta la vita sacerdotale.<br />
NOTA SULL’ESILIO<br />
La lotta che il Gioberti scatenò contro i Gesuiti con il suo<br />
«Gesuita moderno» coinvolse non solo la Compagnia <strong>di</strong> Gesú, ma anche<br />
tutti coloro che <strong>di</strong> essa si mostrarono simpatizzanti.<br />
Il Frassinetti poi con il suo «Saggio intorno alla <strong>di</strong>alettica e alla<br />
religione <strong>di</strong> V. Gioberti» si era esposto ed aveva manifestato chiaramente il<br />
suo pensiero.<br />
Negli ultimi mesi del 1847 vide cadere la Congregazione del Beato<br />
Leonardo. Nel marzo del 1848 la cacciata dello Sturla, che trascorse il suo<br />
esilio a Aden accolto dal Massaia, fu un monito anche per il Frassinetti.<br />
Cosí il 18 marzo del 1848 dovette fuggire da Genova. Trovò<br />
ospitalità presso il Priore Gerolamo Campanella nella sua villa <strong>di</strong> San<br />
Cipriano in Val Polcevera e vi si tenne nascosto per tre<strong>di</strong>ci mesi sotto il<br />
nome <strong>di</strong> Prete Viale.<br />
CAPITOLO II<br />
IL FRASSINETTI E LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI<br />
Il Frassinetti vive il preoccupante problema della mancanza <strong>di</strong><br />
sacerdoti: con vibranti scritti attira su <strong>di</strong> esso l‘attenzione e ne prospetta<br />
nuove soluzioni.<br />
Di questo problema si era interessato sempre; negli ultimi anni<br />
però se ne angustiava in modo particolare, cercando <strong>di</strong> richiamare su <strong>di</strong><br />
esso l‘attenzione <strong>di</strong> tutti coloro che amavano la Chiesa <strong>di</strong> Cristo.<br />
Cosí nelle «Brevi esortazioni ai Sacerdoti Fratelli» (1861) poneva<br />
questa esortazione: ―Specialmente procuriamo <strong>di</strong> coltivare quei giovinetti <strong>di</strong><br />
83
uona indole che danno speranza <strong>di</strong> ecclesiastica vocazione. Questo è il<br />
supremo bisogno del giorno‖ 173.<br />
Si rivolgeva poi, nelle stesse pagine, ai confessori e ai parroci che<br />
piú <strong>di</strong> tutti possono far germogliare le vocazioni, affinché si dessero con<br />
amore a questo apostolato.<br />
Sullo stesso argomento ritorna nel 1867, scrivendo la celebre<br />
lettera al Canonico Guerra (la seconda e<strong>di</strong>zione stampata a Oneglia nel<br />
1870 è arricchita da preziose note dell‘autore e porta il titolo: «Sulla<br />
deficienza delle vocazioni allo stato ecclesiastico» 174.<br />
Già ho parlato nell‘introduzione <strong>di</strong> tale lettera; ora, per vedere<br />
meglio i fondamenti della sua pastorale delle vocazioni converrà vedere gli<br />
aspetti piú importanti.<br />
Nella prefazione il Frassinetti confessa stargli sommamente a<br />
cuore questo problema, specialmente perché ―sembra non vi si ponga<br />
mente abbastanza; e che, quin<strong>di</strong>, si fa poco o nulla per mettervi riparo‖.<br />
Considerate le tristi conseguenze spirituali che verrebbero alla vita<br />
cristiana se questo fenomeno continuasse, il Frassinetti esclama: «bisogna<br />
reagire», bisogna promuovere lo sviluppo delle vocazioni ecclesiastiche.<br />
Per questo si appella ai Parroci e ai Confessori, in<strong>di</strong>cando sagge<br />
norme <strong>di</strong> pastorale delle vocazioni.(Sono riportate in seguito).<br />
Per questo chiede ai Rettori dei seminari e ai Vescovi <strong>di</strong> facilitare<br />
l‘avvio al sacerdozio <strong>di</strong> molti ragazzi poveri permettendo che alcuni<br />
frequentino il seminario come esterni.<br />
Propone e caldeggia una Associazione delle Vocazioni a carattere<br />
nazionale, <strong>di</strong> cui si dovrebbero far promotori i singoli Vescovi con lo<br />
scopo <strong>di</strong>:<br />
cercare soggetti idonei;<br />
scegliere poi tra questi coloro che sembrano chiamati;<br />
coltivarli nella pietà e nello stu<strong>di</strong>o, formandoli nei rispettivi luoghi<br />
<strong>di</strong> origine;<br />
trovare mezzi per aiutare i ragazzi poveri perché anch‘essi possano<br />
prepararsi al sacerdozio.<br />
Egli insiste con particolare vigore sulla necessità <strong>di</strong> questa unione:<br />
è solo riunendo le forze che si potrà superare la grande crisi delle<br />
vocazioni.<br />
173 G. FRASSINETTI, Brevi parole ai sacerdoti fratelli, in Opera Omnia, vol.<br />
XI, pag. 105 sg.<br />
174 G. FRASSINETTI, Sulla deficienza delle vocazioni alla stato ecclesiastico<br />
in Opera Omnia, vol. XIII, pag.295 sg.<br />
84
E nota con entusiasmo: ―Se questa unione si farà, sarà benedetta<br />
da tutti i buoni, sarà accolta da tutti i Vescovi, sarà approvata incoraggiata<br />
dal S. Padre, provvederà al bisogno della Chiesa in Italia‖ 175.<br />
E nelle «note», rispondendo a prudenziali riserve <strong>di</strong> qualcuno <strong>di</strong>ce:<br />
―Mi pare bisogno troppo urgente il fare qualche cosa e cominciare<br />
senza indugio; e troppo temo che una falsa prudenza concorra al<br />
proseguimento del comodo far nulla‖.<br />
―Amore è quello che mi fa parlare, amore per la santa Chiesa, per<br />
uno dei piú vitali dei suoi interessi‖ 176.<br />
Dopo questa premessa, preso dall‘idea che non basta lamentarsi<br />
per la mancanza dei sacerdoti ma che occorre porsi tutti a far qualcosa <strong>di</strong><br />
concreto, si rivolge ai Parroci e Confessori e traccia loro le linee per<br />
un‘efficace ed organica pastorale delle vocazioni, che qui sintetizzo usando<br />
spesso le sue parole. 177<br />
1. Parlare spesso della <strong>di</strong>gnità del sacerdozio cattolico: ―È cosa molto<br />
rilevante che il parroco nelle sue istruzioni ammaestri il popolo, dove<br />
sono genitori e figli, sulla <strong>di</strong>gnità, onore e santità del<br />
sacerdozio....Meglio conosciuto il sacerdozio, i genitori piú facilmente<br />
s‘indurranno a consacrare qualche loro figlio al Santuario e i figlioli piú<br />
facilmente s‘invoglieranno ad abbracciare quel nobile e santo stato‖.<br />
2. Parlar sovente dei pregi della verginità e del celibato: ―Senza <strong>di</strong> che<br />
non possono aversi sacerdoti‖, combattendo il pregiu<strong>di</strong>zio della grande<br />
<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> conservare questa virtú.<br />
3. Essere attenti a cogliere i primi segni <strong>di</strong> vocazione vedendo<br />
fanciulli <strong>di</strong> buone speranze…<br />
4. Con amabile e <strong>di</strong>screto colloquio illustrare a coloro che<br />
«presentino segni», la possibilità della vocazione e dar loro i primi<br />
consigli. ―Trovandone alcuno si dovrebbe interrogare se fosse alieno<br />
allo aspirare allo stato ecclesiastico...., dando quello a vedere che non<br />
sarebbe contrario, si dovrebbe esortare a speciali preghiere e ad altri atti<br />
<strong>di</strong> pietà per conoscere quale fosse su <strong>di</strong> lui la <strong>di</strong>vina volontà;<br />
raccomandandogli il silenzio coi parenti e compagni, prima <strong>di</strong> avere<br />
meglio fermato la sua determinazione‖.<br />
5. Prendere contatto con la famiglia <strong>di</strong> chi veramente si sente<br />
«invogliato» al sacerdozio, perché i genitori <strong>di</strong>ano il consenso, sentano<br />
buoni incoraggiamenti, capiscano <strong>di</strong> dover educare il loro figliolo al<br />
sacerdozio se si sviluppasse in lui alcun probabile in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> vocazione.<br />
175 G. FRASSINETTI, op. cit., pag. 317.<br />
176 G. FRASSINETTI, op. cit., pag.351.<br />
177 G. FRASSINETTI, op. cit., in Opera Omnia, vol. XIII, pag. 295 ss.<br />
85
6. Si man<strong>di</strong> il nome al presidente della Congregazione. ―Questa<br />
sarebbe cosa importante per sapere sopra quanti giovinetti si potessero<br />
avere speranze <strong>di</strong> vocazione per domandar conto del loro progresso,<br />
riuscimento etc.‖<br />
7. I Parroci e i Confessori intanto abbiano cura assidua <strong>di</strong> questi<br />
ragazzi in cui sembra germogli la vocazione, formandoli nella pietà e<br />
negli stu<strong>di</strong>. Si avviino perciò nei primi stu<strong>di</strong>, anche se costerà loro sacrificio<br />
<strong>di</strong> tempo e <strong>di</strong> riposo. E specialmente i Confessori li avviino<br />
imme<strong>di</strong>atamente alla cultura dello spirito.<br />
―Un giovinetto <strong>di</strong> buona indole è sempre pieghevole alla pietà e quin<strong>di</strong><br />
sarà cosa facile, a chi ne <strong>di</strong>rige lo spirito, farlo amante della preghiera e<br />
buone letture e frequente ai santi Sacramenti (ascolti ogni giorno la S.<br />
Messa, faccia qualche visita al SS. Sacramento, etc.).<br />
8. Si avviino a una particolare devozione alla <strong>Santa</strong> Vergine e<br />
all‘Angelo Custode.<br />
9. Avvicinarli sempre piú ai S. Sacramenti. Soprattutto ―se vuolsi<br />
istradare un giovanetto al sacerdozio e perciò a santità <strong>di</strong> vita,<br />
soprattutto, lo ripeto,si dovrà procurare che sia frequente alla S.<br />
Confessione e anche alla S. Comunione‖.<br />
10. Far loro amare la S .Eucaristia, che per sua forza intrinseca<br />
santifica i giovani che aspirano al sacerdozio. ―Essa santifica e mette in<br />
avvertenza <strong>di</strong> evitare il peccato... La comunione frequente infonde nelle<br />
anime l‘amore alla S. Castità‖.<br />
11. Specialmente il confessore sappia condurli alla via della perfezione<br />
cristiana, procurando che coltivino bene tutte le virtú<br />
12. ―Di ognuno <strong>di</strong> questi ragazzi procuri <strong>di</strong> fare un angelo nella<br />
castità, della quale avrà poi supremo bisogno e contro la quale dovrà<br />
poi sostenere la lotta piú forte, perché <strong>di</strong>venuto sacerdote dovrà essere<br />
<strong>di</strong> meno che un angelo in terra .<br />
13. Esiga da lui la massima custo<strong>di</strong>a dei sentimenti.<br />
14. Sappia con intelligenza e spirito <strong>di</strong> fede renderlo a poco a poco<br />
idoneo ad entrare in seminario, sicuro della vocazione.<br />
15. Il Parroco abbia nella propria «Cura» gruppi <strong>di</strong> buoni giovani dove<br />
possa con sollecitu<strong>di</strong>ne particolare coltivare il loro spirito.<br />
16. Il parroco occupi nel servizio, della Chiesa qualcuno tra essi che<br />
mostri maggior devozione, prendendolo a casa sua come chierico,<br />
provvedendo cosí ai suoi stu<strong>di</strong> e mantenimento.<br />
17. Avvii al seminario, coloro che manifestano il desiderio e qualità <strong>di</strong><br />
essere sacerdote.<br />
18. Cerchi <strong>di</strong> superare le <strong>di</strong>fficoltà delle famiglie.<br />
86
19. Se sono poveri cerchi <strong>di</strong> mantenerli, almeno in parte, nel seminario<br />
o in buone famiglie, come seminaristi interni.<br />
20. Bisogna aver cura delle vocazioni adulte. Bisogna non solo<br />
cercarle e guidarle, ma incoraggiarle come facevano i primi apostoli, i<br />
quali ―sceglievano fra i cristiani convertiti alla fede quegli uomini che<br />
mostravano piú zelo per la gloria <strong>di</strong> Dio, con una vita casta ed<br />
intemerata‖. Li istruivano, li avvicinavano gradualmente al loro<br />
ministero e li consacravano. E ciò continuò almeno per alcuni secoli.<br />
(Qui il Frassinetti in<strong>di</strong>ca anche il <strong>di</strong>verso trattamento che<br />
dovrebbe tenersi per loro, sia negli stu<strong>di</strong> sia nella <strong>di</strong>sciplina). Per il che<br />
mi pare che sia buon consiglio, fin d‘ora, anche prima che<br />
un‘inesorabile necessità a ciò costringe cercare dei buoni secolari cultori<br />
<strong>di</strong> casta vita, frequenti ai santi Sacramenti, impegnati a promuovere le<br />
opere buone, savi e prudenti, coloro i quali hanno possibilità <strong>di</strong><br />
attendere agli stu<strong>di</strong> strettamente necessari al ministero ecclesiastico, e<br />
questi invitare ed esortare nelle file del sacerdozio. 178<br />
21. ―Sarebbe conveniente che alcuni ecclesiastici e anche secolari<br />
convenissero insieme e contribuendo del proprio procurassero <strong>di</strong><br />
mettere agli stu<strong>di</strong> alcuni giovinetti poveri, <strong>di</strong> buon ingegno, d‘intemerati<br />
e religiosi costumi i quali dessero probabili in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> ecclesiastica<br />
vocazione. A far questo altro non ci vorrebbe che la volontà <strong>di</strong> un<br />
accordo.<br />
In Genova vi fu la volontà <strong>di</strong> questo accordo, l‘opera fu<br />
iniziata, quasi potrebbe <strong>di</strong>re senza che nessuno ne abbia saputo nulla.<br />
Comincia adesso e già mantiene agli stu<strong>di</strong> sei poveri giovanetti che<br />
danno buona speranza <strong>di</strong> vocazione ecclesiastica. 179<br />
Certamente queste in<strong>di</strong>cazioni vanno prese valutandole nel tempo<br />
in cui il Frassinetti le scrisse.<br />
Sono ancora valide?<br />
Da buon Parroco il Frassinetti vedeva chiara la funzione della<br />
Parrocchia e della comunità anche nel campo delle vocazioni.<br />
Oggi da piú parti si sente <strong>di</strong>re che ogni vocazione deve essere<br />
frutto della fede della comunità, questo nel Frassinetti già c‘era.<br />
Infatti si rivolge ai Parroci e Confessori e cerca <strong>di</strong> impegnare<br />
anche i laici per il mantenimento dei seminaristi.<br />
178 G. FRASSINETTI, op. cit., pag. 325.<br />
179 G. FRASSINETTI, op. cit., pag. 357.<br />
87
Ma l‘idea piú attuale è quella che impegna il parroco e con lui la<br />
parrocchia a seguire nel proprio ambiente questi ragazzi. Vadano in seminario<br />
quando sono già pronti.<br />
Oggi che i seminari minori sono in crisi ciò mi sembra<br />
attualizzabile.<br />
Purtroppo fin‘ora la prima preparazione, quella che doveva venire<br />
in parrocchia, avveniva nel seminario minore.<br />
Inoltre parla <strong>di</strong> creare un centro nazionale che si occupi del<br />
problema; ci siamo arrivati solo dopo il Concilio, oggi esiste il Centro<br />
Nazionale Vocazioni, ma certamente sono ancora troppi gli interessi privati<br />
per farlo funzionare come dovrebbe.<br />
Scrive il Fassiolo: ―Il Priore G. Frassinetti con tutto l‘impegno si<br />
faceva a promuovere le vocazioni allo stato ecclesiastico e aiutava coi<br />
consigli e con l‘opera quei giovani che vi aspiravano‖ 180.<br />
Ve<strong>di</strong>amo brevemente come operò in questo apostolato.<br />
a. Attraeva al Sacerdozio con la testimonianza della sua<br />
meravigliosa vita sacerdotale. Senza voler qui elencare tutte le sue<br />
virtú, ecco gli aspetti della sua vita che, secondo testimoni oculari<br />
degni <strong>di</strong> fede maggiormente si manifestavano in lui e dovevano<br />
colpire i giovani:<br />
era sempre sereno e sorridente, contento del suo sacerdozio 181,<br />
coerente, amabile 182 sempre eguale a se stesso 183, modesto e<br />
composto nel suo esteriore 184, franco nell‘operare. 185<br />
In Chiesa lo trovavano sempre in preghiera 186 presso il<br />
confessionale o in adorazione presso il SS. Sacramento con tanta<br />
180 D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vita del Sac. G. Frassinetti,<br />
Tip. della Gioventú, 1879, Genova.<br />
181 Testimonianza <strong>di</strong> E. Peiranch: ―Posso attestare che il suo carattere era<br />
sempre sorridente‖ cfr. Atti..., del processo per l’introduzione della causa <strong>di</strong><br />
beatificazione del Servo <strong>di</strong> Dio G. Frassinetti, pag. 240.<br />
182 Testimonianza del Sac. Gambino: ―L’impressione che ne rimase a me,<br />
dopo averlo visto fu ad<strong>di</strong>rittura incancellabile per la sua compostezza e<br />
amabilità‖ cfr. Atti...,... pag..134.<br />
183 Testimonianza <strong>di</strong> G. Chiola: ―Era un uomo sempre eguale a se stesso‖<br />
cfr. Atti...,...pag. 125 sg. e testimonianza <strong>di</strong> Antonio Isola sacerdote:<br />
―Ogni volta avvicinai il Frassinetti lo trovai sempre sereno tranquillo,<br />
mite nel tratto‖.<br />
184 Cfr. Testimonianza precedente.<br />
185 Testimonianza Angela Pedemonte, cfr. Atti..., pag. 130.<br />
186 Testimonianza <strong>di</strong> Don Borragini, cfr. Atti..., pag. 132.<br />
88
devozione che dovevano <strong>di</strong>re sovente ―Guarda come prega il<br />
Priore‖. 187 Alla celebrazione della Messa lo vedevano col massimo<br />
raccoglimento, come trasfigurato. 188<br />
Traspariva in lui una pratica eroica della purezza 189, una fede<br />
vivissima 190, un amore evidente a straor<strong>di</strong>nario alla S. Eucarestia 191.<br />
Lo vedevano ovunque semplice, povero nell‘abito e<br />
nell‘abitazione 192, frugalissimo 193, generosissimo coi poveri 194,<br />
pazientissimo coi peccatori 195, molto solerte e paterno coi malati 196.<br />
Lo sentivano insegnare e pre<strong>di</strong>care con grande semplicità e<br />
convinzione 197 specialmente della bontà <strong>di</strong> Dio, della sua infinita<br />
misericor<strong>di</strong>a e, sempre con grande amore, della virtú della speranza 198.<br />
187 Testimonianza <strong>di</strong> Nicoletta Piccardo, cfr. Atti..., pag. 175.<br />
188 Testimonianza <strong>di</strong> Nicoletta Piccardo, Atti...,…, pag. 172—173.<br />
189 Tra le varie testimonianze notare quella <strong>di</strong> Enrichetta Paro<strong>di</strong>: ―Posso<br />
attestare, per quel che ho osservato io stessa, che il Servo <strong>di</strong> Dio aveva un<br />
contegno esteriore mirabile e specialmente rivelava una purezza che<br />
infondeva negli altri solo al guardarlo; tanto che io credo che nemmeno<br />
l’uomo piú <strong>di</strong>ssoluto avrebbe usato, alla presenza de1 Servo <strong>di</strong> Dio,<br />
compiere un atto men che riguardoso‖, Atti...,…, pag. 225.<br />
190 Testimonianza Angela Pedemonte, Atti..., pag. 129; test. <strong>di</strong> Giovanna<br />
Sanguinetti, Atti..., pag. 127, e numerose altre.<br />
191 Testimonianza <strong>di</strong> Don Lavagetto, Atti..., 190, Cerese, Gambino e i 5<br />
fogli ine<strong>di</strong>ti del Fassiolo presentati al processo dal Sac. A. Tarigallo,<br />
Atti..., pag. 356 sg.<br />
192 Testimonianza <strong>di</strong> Angela Pedemonte Atti..., pag. 130, test. Giovanna<br />
Sanguinetti Atti..., pag. 328 e altri (Isola, Stronello, Vagetto, N.<br />
Riccardo etc.).<br />
193 Testimonianza del Sac. Sante Lavagetto, Atti..., 236, <strong>di</strong> Giovanna<br />
Sanguinetti <strong>Maria</strong>nna Giodanino e Sac. Andrea Masnada, Atti..., pag.<br />
239.<br />
194 Testimonianza del Sac. Maggiolo, Atti..., pag. 136, <strong>di</strong> N. Riccardo,<br />
Atti..., pag. 190, Angela Pedemonte, Atti..., pag. 195, Berta Bassino,<br />
Atti..., 196 e Agostino Vignola, Atti..., 203.<br />
195 Testimonianza <strong>di</strong> Berta Bassino, Atti..., pag. 199, Nicoletta Piccardo,<br />
pag. 189.<br />
196 Testimonianza del Sac. Masnada: “Accorreva con uno zelo speciale al<br />
letto degli infermi, specie se rozzi e plebei e aveva una arte particolare<br />
nell’istruirli e <strong>di</strong>sporli a ricevere i Sacramenti, Atti..., pag. 207.<br />
197 Testimonianza Di Francesca Paro<strong>di</strong>, Atti…, pag. 80.<br />
89
Erano conquistati dal suo profondo ottimismo cristiano e<br />
dalla sua totale de<strong>di</strong>zione alla Santità e all‘apostolato 199. Vedevano<br />
quanto si interessasse dei giovani, ovunque, anche per le strade 200.<br />
Lo trovavano sempre pronto a ridar loro la gioia e a<br />
rassicurarli, con efficaci consigli 201, a intrattenerli nelle riunioni ed<br />
esortarli alla purezza 202 e alla Comunione quoti<strong>di</strong>ana onde amassero<br />
piú profondamente Gesú Cristo 203.<br />
In una parola: trovavano in lui un modello che valeva la pena<br />
<strong>di</strong> imitare e seguire perché ―era un vero sacerdote‖ 204.<br />
b. Pregava incessantemente e faceva pregare il Signore perché si<br />
degnasse <strong>di</strong> mandare sante vocazioni 205.<br />
c. Parlava sovente ai fedeli della nobiltà del sacerdozio e del celibato<br />
cattolico 206.<br />
d. Con la sua <strong>di</strong>rezione spirituale, con istruzioni e con scritti sapeva<br />
creare le premesse logiche alla possibile chiamata <strong>di</strong> Dio.<br />
Raccomandava cosí alle mamme <strong>di</strong> consacrare fin dalla<br />
nascita i loro figli alla Madonna, <strong>di</strong> affezionarli a Lei fin dalla piú<br />
tenera infanzia con mezzi pratici, e <strong>di</strong> convincerli poi ad offrirgli il<br />
198 Testimonianza <strong>di</strong> N. Piccardo: ―Parlava sempre con grande amore<br />
della virtú della speranza‖ Atti..., pag. 165.<br />
199 Testimonianza del Sac. Firpo G. : “Si vedeva che i suoi pensieri erano<br />
rivolti ad ogni opera buona‖, Atti...,…, pag. 49.<br />
200 Testimonianza <strong>di</strong> N. Piccardo, Atti..., pag. 188: ―I suoi fratelli mi<br />
<strong>di</strong>cevano che egli faceva ogni cosa con grande fervore e che si occupava<br />
dei giovani anche per le vie, invitandoli al bene, cioè alla frequenza della<br />
Chiesa, dei Sacramenti, ad ascoltare la S. Messa e anche ve li conduceva<br />
in sua compagnia‖, Atti...,…, pag. 188.<br />
201 Testimonianza <strong>di</strong> N. Piccardo, Atti..., pag. 192.<br />
202 Testimonianza <strong>di</strong> Giovanna Sanguinetti, Atti..., pag. 256.<br />
203 Testimonianza <strong>di</strong> Antonio Isola, Atti..., pag. 141.<br />
204 Testimonianza <strong>di</strong> Firpo: ―Ho sempre osservato in Lui un contegno da<br />
vero Sacerdote, come traspariva anche dallo sguardo e dal modesto<br />
portamento‖, Atti..., pag. 49.<br />
205 D. FASSIOLO, op. cit., pag. 156.<br />
206 Anche nell’Opera Omnia, Istruzione catechistica al popolo, Vol. I, pag.<br />
437, sono riportati alcuni <strong>di</strong>scorsi sull’Or<strong>di</strong>ne e sui compiti dei Sacerdozio<br />
Cattolico.<br />
90
proprio cuore. Le esorta ad affidarli a <strong>Maria</strong> affinché particolarmente<br />
li conservi innocenti 207.<br />
Raccomandava sovente ai ragazzi <strong>di</strong> conservare una fede viva<br />
in Dio, <strong>di</strong> manifestarla sempre, ovunque, a viso aperto, <strong>di</strong> stare in<br />
guar<strong>di</strong>a dalle amicizie pericolose, <strong>di</strong> amare la custo<strong>di</strong>a della purezza, <strong>di</strong><br />
abituarsi alla preghiera (breve, raccolta, fiduciosa, sovente) <strong>di</strong> crescere<br />
nell‘autentico amore <strong>di</strong> Dio, <strong>di</strong> accettare le sue ispirazioni e nutrire<br />
filiale devozione alla Mamma celeste 208.<br />
e. Approfon<strong>di</strong>va la formazione spirituale dei ragazzi e dei giovani<br />
abituandoli a porsi il problema della vocazione.<br />
In altro prezioso libretto 209 incitava i ragazzi ad offrire il loro<br />
cuore alla Madonna impegnandosi a tre speciali ossequi in suo onore<br />
(Obbe<strong>di</strong>enza, Purezza, Comunione quoti<strong>di</strong>ana) invitandoli d‘altra<br />
parte a chiederle tre grazie importantissime:<br />
o <strong>di</strong> non commettere peccato mortale<br />
o <strong>di</strong> non commettere peccato veniale<br />
o <strong>di</strong> far loro conoscere lo stato in cui Dio li chiama.<br />
―La terza grazia che voi chiederete a <strong>Maria</strong> — scrive il Frassinetti—<br />
sarà quella <strong>di</strong> conoscere lo stato cui Dio vi chiama, grazia da cui<br />
<strong>di</strong>pende in tanta parte la vostra salvezza.....Se Dio vi chiamerà ad<br />
eleggervi uno stato <strong>di</strong> perfezione....Voi incontrerete gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà<br />
da superare e avrete bisogno che <strong>Maria</strong> vi impetri altra grazia non<br />
meno importante e necessaria che è quella della costanza del buon<br />
proposito‖ 210.<br />
f. Specialmente ai giovani prospettava ripetutamente la bellezza e<br />
la felicità del celibato nella pratica della perfetta castità 211 e con parole<br />
suadenti tendeva a farli innamorare ad essa.<br />
Insisteva perciò nel ricordare che ognuno può aspirare a<br />
questo stato, fonte delle piú alte gioie spirituali; scioglieva le <strong>di</strong>fficoltà<br />
207 G. FRASSINETTI, Avviamento dei giovinetti nella <strong>di</strong>vozione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong><br />
SS.ma. Appen<strong>di</strong>ce: aggiunta <strong>di</strong> alcuni avvertimenti ad una madre <strong>di</strong><br />
famiglia per l’avviamento dei figlioli nella devozione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> SS.ma, in<br />
Opera Omnia, Vol. XI, pag. 195 sg.<br />
208 cfr. G. FRASSINETTI, Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> un giovanetto cristiano, Opera Omnia<br />
Vol. XI, pag. 307 sg.<br />
209 G. FRASSINETTI, op. cit., in Opera Omnia, Vol. XI pag. 159 sg.<br />
210 Ibid, pag. 190—191.<br />
211 G. FRASSINETTI, Lettera sul celibato, in Opera Omnia, Vol. XI, pag.<br />
359 sg., G. FRASSINETTI, Il para<strong>di</strong>so in terra, Opera Omnia, Vol. V, pag.<br />
329.<br />
91
<strong>di</strong> chi pensa impossibile restare sempre onesto in tale stato, faceva<br />
capire che la Chiesa ha bisogno <strong>di</strong> anime consacrate, anche<br />
specialmente per l‘esercizio del sacerdozio 212.<br />
Nel «Convito del <strong>di</strong>vino amore» (in Opera Omnia) fa vedere<br />
chiaramente l‘intima connessione <strong>di</strong> alcune azioni spirituali:<br />
o chi ama Gesú pratica la comunione frequente e<br />
quoti<strong>di</strong>ana, alimento <strong>di</strong> tutta la vita interiore;<br />
o chi si avvicina frequente alla santa Comunione è<br />
portato sempre piú ad amare e a praticare la santa castità;<br />
o praticando la castità si è in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
ascoltare sovente la chiamata alla perfezione e al sacerdozio.<br />
Scrive egli stesso: ―Se molti saranno coloro i quali me<strong>di</strong>ante<br />
l‘efficacia della comunione frequente e quoti<strong>di</strong>ana, abbracceranno lo<br />
stato <strong>di</strong> castità perfetta, si svilupperanno fra questi numerose le<br />
vocazioni allo stato ecclesiastico, e la Chiesa sarà meglio provveduta<br />
<strong>di</strong> Sacerdoti‖ 213.<br />
g. Poneva attivamente i giovani <strong>di</strong> fronte al problema della vocazione<br />
quando ne intuiva la chiamata.<br />
Riferisce Don Isola: ―Personalmente venni a conoscere il<br />
Frassinetti per istrada. Fu lui stesso che mi avvicinò e mi chiese se lo<br />
conoscessi. Risposi <strong>di</strong> no. Mi domandò allora se avessi mai sentito<br />
parlare <strong>di</strong> lui. Risposi <strong>di</strong> si; ma che non lo conosceva.<br />
Sono io — aggiunse— e mi <strong>di</strong>sse se voleva accompagnarlo a<br />
far parte della sua Congregazione. Risposi che i miei doveri mi<br />
vincolavano troppo e che non potevo perciò aderire al suo invito.<br />
Cosí avevo risposto altra volta a Don Luigi Sturla. Lo incontrai poi<br />
per strada altre volte e mi accompagnava e mi rinnovava l‘invito.<br />
Morto che fu il mio principale e rimasi alquanto piú libero <strong>di</strong> me<br />
cominciai a frequentare detta congregazione‖.<br />
L‘Isola <strong>di</strong>ventò così un santo Sacerdote 214.<br />
h. Curava in modo particolare i chierichetti cosicché germogliavano<br />
fra essi belle vocazioni.<br />
Luigia Grillo testimoniò: ―Io so che il Servo <strong>di</strong> Dio favoriva<br />
le vocazioni dei giovani al Sacerdozio e so che a volte si vedevano dei<br />
212 cfr. Lettera sul celibato, Opera Omnia, Vol. XI, pag. 366.<br />
213 G. FRASSINETTI, Il convito del Divin Amore, Opera Omnia, Vol. IX,<br />
pag. 329.<br />
214 Atti..., pag. 4 ( Catalogus testium et Scentia singulorum).<br />
92
chierichetti che dopo un qualche tempo sparivano dalla Chiesa <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> Sabina, perché il Servo <strong>di</strong> Dio li mandava in seminario‖ 215.<br />
Ciò fu confermato da Virginia Galletto: ―Si notava che dei<br />
chierichetti della Chiesa <strong>di</strong> S. Sabina qualcuno finiva sempre per<br />
prendere l‘abito ecclesiastico e darsi al sacerdozio‖ 216.<br />
E Giuseppe Chiola aggiungeva: ―Conobbi chierichetti <strong>di</strong> S.<br />
Sabina Don Fassiolo e Don Rapallo, che stavano compostissimi<br />
all‘altare poi mentre erano vivacissimi fuori <strong>di</strong> là (atti, pag. 165)‖.<br />
i. Si interessava delle vocazioni adulte, aiutandole nella via al<br />
sacerdozio. Il canonico Arecco testimoniò: ―Anche i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong><br />
concretavano un‘idea comune al Frassinetti e a Don Bosco: facilitare,<br />
cioè, la vocazione ecclesiastica a quei soggetti a cui questa si fosse<br />
manifestata ad età già avanzata.<br />
Dà affidamento — <strong>di</strong>ceva il Frassinetti — <strong>di</strong> maggior serietà<br />
che nei giovani, e quin<strong>di</strong> è doppia carità occuparsene 217.<br />
Fu appunto merito del Frassinetti se Don Nicolò Daste, che<br />
era un povero falegname e già avanti negli anni, <strong>di</strong>ventò sacerdote,<br />
dando prove e<strong>di</strong>ficanti <strong>di</strong> zelo e <strong>di</strong> attività (testimonianza <strong>di</strong> Don<br />
Boraggini) 218.<br />
j. Teneva sempre presso <strong>di</strong> sé, gratuitamente, almeno un<br />
giovanetto povero per inviarlo in seminario.<br />
Scrive il Fassiolo: ―Il Frassinetti volle sempre in casa un<br />
giovinetto che dovesse servire la Chiesa in qualità <strong>di</strong> Chierico;<br />
procurava <strong>di</strong> scandagliarne bene le intenzioni, <strong>di</strong> vigilare sulla sua<br />
condotta; e ove poi avesse veduto alcun segno probabile <strong>di</strong><br />
ecclesiastica vocazione facea in modo che entrasse in seminario. A<br />
questo modo poté ottenere <strong>di</strong> dare alla Chiesa alcuni sacerdoti, e<br />
questi furono in numero <strong>di</strong> cinque‖ 219.<br />
Notiamo che fra questi ci fu lo stesso Fassiolo che ebbe poi<br />
per il Frassinetti riconoscenza ed affetto <strong>di</strong> figlio e ne scrisse tra i<br />
primi le memorie storiche.<br />
Dice infatti nella prefazione: ―Io avrò la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong><br />
veder letta la vita <strong>di</strong> colui che mi fu maestro e guida nella mia<br />
giovinezza col quale vissi piú anni, nel qual tempo ho u<strong>di</strong>to le sue<br />
215 Atti..., pag. 153.<br />
216 Atti..., pag. 109.<br />
217 Atti..., pag. 96.<br />
218 Atti..., pag. 97.<br />
219 D. FASSIOLO, op. cit., pag. 50 — 51.<br />
93
parole, ammirate le sue opere, le quali non si cancelleranno piú dalla<br />
mia mente‖ 220.<br />
Ciò è confermato da <strong>di</strong>verse testimonianze rese al processo<br />
<strong>di</strong> beatificazione il canonico Ludovico Remaggi, Don Giovanni<br />
Battista Boraggini che dal marzo 1865 al novembre del 1866 fu<br />
chierico a S. Sabina e abitò nella canonica del Priore e il sacerdote<br />
Giovanni Maggiolo che aggiunge un curioso particolare: ―per la<br />
ristrettezza della canonica qualcuno <strong>di</strong> essi alloggiava nel campanile.<br />
Fu uno <strong>di</strong> costoro il Rev. Giacomo Profumo <strong>di</strong> Livellato che fu<br />
or<strong>di</strong>nato sacerdote in età matura‖ 221. Interessante fu la testimonianza<br />
<strong>di</strong> Don Santo Lavaggetto: ―Posso testimoniare che Don Rapallo,<br />
defunto prevosto <strong>di</strong> S. Siro conviveva da seminarista col Frassinetti<br />
nella canonica <strong>di</strong> S. Sabina, d‘onde si recava a scuola in seminario, e<br />
credo che vi abbia vissuto anche il Fassiolo che poi fu parroco ad<br />
Arenzano.<br />
Ricordo che quando il Frassinetti si ammalò dell‘ultima<br />
malattia il Rapallo, allora alunno interno del seminario, si mostrava<br />
tutto piangente, deplorando <strong>di</strong> non poter uscire per assistere in<br />
qualche modo il morente‖ 222.<br />
k. Aiutava negli stu<strong>di</strong> i giovani poveri che volevano farsi sacerdoti.<br />
Sappiamo, per esempio, che per <strong>di</strong>verso tempo insegnò gratuitamente<br />
latino e filosofia a un giovane finché non si fece Cappuccino. 223<br />
l. Inviava vocazioni in seminario aiutando i piú poveri. questa è la<br />
testimonianza <strong>di</strong> Nicoletta Piccardo: ―Gli stessi suoi fratelli riferivano<br />
che il Servo <strong>di</strong> Dio era zelante nel formare dei preti che promovessero<br />
la gloria <strong>di</strong> Dio; e questo faceva avviando buoni giovani al Seminario<br />
e aiutandoli anche finanziariamente‖ 224.<br />
Cosí riferisce don Giacomo Gambino: ―Posso <strong>di</strong>re che sono<br />
io stesso una prova dello zelo del Servo <strong>di</strong> Dio per provvedere la<br />
Chiesa <strong>di</strong> Sacerdoti. Infatti, come già riferii, la marchesa Fieschi,<br />
saputo il mio desiderio <strong>di</strong> abbracciare lo stato ecclesiastico, mi rimise<br />
al Frassinetti: credo <strong>di</strong> essere stato accolto nei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> pel suo<br />
interessamento, tant‘è vero che potei entrare nell‘Istituto appena un<br />
220 D. FASSIOLO, op cit., pag. 2.<br />
221 Atti..., pag. 105; 13; 74; 84; 204.<br />
222 Atti..., pag. 94.<br />
223 D. FASSIOLO, op. cit., pag. 41.<br />
224 Atti..., pag. 82.<br />
94
mese dopo la morte <strong>di</strong> lui: e ciò nonostante la povertà somma<br />
dell‘Istituto stesso‖ 225.<br />
Ancora Antonietta Piccardo: ―I fratelli del Servo <strong>di</strong> Dio mi<br />
<strong>di</strong>cevano che egli era sempre intento a far delle monache e dei<br />
sacerdoti.<br />
Ricordo che in S. Sabina praticavano certo Rapallo che poi<br />
morì parroco a S. Siro e un certo Fassiolo; morto parroco ad<br />
Arenzano.<br />
Il Rapallo era figlio <strong>di</strong> un povero falegname <strong>di</strong> Sestri, e<br />
abitava ad<strong>di</strong>rittura in canonica, il Fassiolo aveva un padre ricco, ma lo<br />
contrariava nella vocazione ecclesiastica, perché irreligioso e nemico<br />
dei preti tantoché il giorno che il Fassiolo celebrò la sua prima Messa<br />
in S. Fede, il padre insieme con un‘altro figlio, stando in fondo alla<br />
Chiesa, schernivano il novello sacerdote. Lo stesso padre del Fassiolo<br />
<strong>di</strong>sse che non poteva vedere il Frassinetti, perché questi voleva che<br />
fossero tutti preti o monache.<br />
Del resto il Fassiolo aveva anche contro sua madre. Accadde<br />
poi che il Fassiolo padre, caduto in miseria, fu accolto in casa ad<br />
Arenzano dal figlio sacerdote e trattato con ogni affetto fino alla<br />
morte che fu come mi <strong>di</strong>sse Don Raffaele Frassinetti, una morte<br />
cristiana‖ 226.<br />
I fratelli del Servo <strong>di</strong> Dio raccontavano che egli aveva aiutato<br />
molti altri giovani, chiamati allo stato ecclesiastico, provvedendo ai<br />
poveri e dando esempio ai fratelli stessi (tutti sacerdoti) dai quali Don<br />
Raffaele per sua confessione, riuscí sull‘esempio accennato a formare<br />
ben ventotto sacerdoti.<br />
m. Convinceva i suoi migliori giovani a interessarsi delle vocazioni<br />
sacerdotali. Don Boraggini narrò al processo:<br />
―...Delle istituzioni fondate dal Servo <strong>di</strong> Dio ricordo i<br />
«religiosi al secolo». Indusse poi quattro o cinque <strong>di</strong> detti buoni<br />
secolari a far vita comune pur attendendo ognuno alle proprie<br />
occupazioni e a coltivare e aiutare nel contempo qualche giovinetto<br />
che ne avesse vocazione a raggiungere lo stato ecclesiastico. Cosí<br />
nacquero i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>‖ 227.<br />
Don Isola dal canto suo spiega: ―....Si <strong>di</strong>ceva allora<br />
comunemente che v‘era scarsezza <strong>di</strong> clero, e si <strong>di</strong>ceva pure che il<br />
Frassinetti aveva istituito una specie <strong>di</strong> Congregazione <strong>di</strong> buoni<br />
225 Atti..., pag. 102.<br />
226 Atti..., pag. 84.<br />
227 Atti..., pag. 95.<br />
95
secolari provvisti <strong>di</strong> mezzi e <strong>di</strong>sposti a soccorrere giovani poveri ma<br />
chiamati allo stato ecclesiastico, perché potessero conseguire questo<br />
stato medesimo.<br />
Questa comunità doveva vivere a modo <strong>di</strong> famiglia e<br />
cominciò ad alloggiarsi in poche stanze dell‘Istituto Montebruno degli<br />
Artigianelli, che per celia erano dette «l‘arca».<br />
Di lí, quando la comitiva cominciò a crescere, si trasferirono<br />
in via Lata, nella casa Fieschi, occupandone il primo piano e il piano<br />
terreno. 228<br />
Particolari piú precisi (eccetto la <strong>di</strong>scordanza sulla prima<br />
casa) ci dà la testimonianza <strong>di</strong> Don Lavaggetto:<br />
―....Conobbi poi, come già <strong>di</strong>ssi, la Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
Marta scelti dal Frassinetti tra giovani e uomini <strong>di</strong> vita morigerata e<br />
religiosa, <strong>di</strong>sposti a vivere come religiosi al secolo e che si proponevano,<br />
valendosi dei loro beni e delle loro parsimonie, <strong>di</strong> favorire e<br />
aiutare dei giovanetti <strong>di</strong> buona indole che si mostrassero inclinati allo<br />
stato ecclesiastico.<br />
La prima casa <strong>di</strong> questi si stabilì in via Lata, entro poche<br />
stanzette, per passare poi in via Milius e poi nell‘attuale residenza.<br />
Posso <strong>di</strong>re <strong>di</strong> essere certo che il Frassinetti abbia assistito alla apertura<br />
della prima casa, poiché negli ultimi tempi che egli viveva, il Semino,<br />
che era stato accolto in detta casa dall‘Olivari e che frequentava come<br />
esterno il seminario, mi riferiva che era stato incaricato dal Frassinetti<br />
<strong>di</strong> cercare un sacerdote <strong>di</strong>sposto ad assumere la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> quei<br />
giovani e mi <strong>di</strong>sse poi d‘aver trovato a tal uopo il vivente Don<br />
Piccardo, che non era ancora sacerdote, ma che ricevette<br />
l‘or<strong>di</strong>nazione sacerdotale nel 1868, pochi mesi dopo la morte del<br />
Frassinetti, la quale accadde ai due <strong>di</strong> gennaio <strong>di</strong> detto anno. Altro<br />
non so.<br />
Quanto al mantenimento <strong>di</strong> quest‘opera io credo che il<br />
Frassinetti s‘affidasse al contributo delle persone, che, come già <strong>di</strong>ssi,<br />
aveva unite in Congregazione a tal scopo‖ 229.<br />
I FIGLI DI MARIA<br />
Nel 1855 il Frassinetti aveva preparato la regola per la Unione<br />
delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>.<br />
228 Atti..., pag. 66.<br />
229 Atti..., pag. 73.<br />
96
Secondo il P. Carlo Olivari questa unione era nata cosí: In<br />
Mornese, piccola terra del Monferrato, una pia giovane <strong>di</strong>ciottenne, certa<br />
Angela Maccagno, determinò <strong>di</strong> darsi interamente a Dio senza abbracciare<br />
la vita religiosa, rimanendo al secolo.<br />
―E considerando che molte altre giovani, le quali non possono e<br />
non amano professare vita claustrale, piú facilmente si darebbero a Dio se<br />
vi fosse un mezzo che a loro rendesse piú agevole il conseguimento della<br />
vita cristiana in mezzo al mondo, pensò che questo mezzo sarebbe stato<br />
appunto una compagnia <strong>di</strong> <strong>Figli</strong>e che con regola apposita aspirassero a farsi<br />
sante, vivendo secolari nelle loro famiglie‖ 230.<br />
Don Pestorino, parroco <strong>di</strong> Mornese e primo collaboratore della<br />
Maccagno in quest‘opera, pensò al Frassinetti per le regole.<br />
La pia unione ebbe presto un notevole sviluppo; S. <strong>Maria</strong><br />
Domenica Mazzarello, che con Don Bosco fondò le figlie <strong>di</strong> <strong>Maria</strong><br />
Ausiliatrice, era nel primo gruppo <strong>di</strong> giovani che si accodarono alla<br />
Maccagno.<br />
Il Frassinetti che aveva lungamente me<strong>di</strong>tato e fervorosamente<br />
pregato prima <strong>di</strong> stendere la regola per la Pia Unione, poi vide sempre piú<br />
prender forma nella sua mente la grande importanza che avrebbe assunto<br />
per le giovani che ad essa si sarebbero ascritte, ma anche i benefici <strong>di</strong> quel<br />
nuovo genere <strong>di</strong> apostolato religioso, specie dopo la approvazione della<br />
legge Rattazzi contro gli Istituti religiosi, che aboliva le corporazioni<br />
religiose, eccettuate quelle che avevano compiti educativi e <strong>di</strong> assistenza.<br />
L‘organizzazione <strong>di</strong> questa pia unione anticipava l‘orientamento che in<br />
seguito la Chiesa avrebbe preso col canonico riconoscimento degli istituti<br />
secolari con la Costituzione Apostolica: «Provvida Mater Ecclesia» del 2<br />
febbraio l947. 231<br />
Le regole scritte dal Frassinetti vennero a conoscenza <strong>di</strong> tutti nel<br />
1859, per esser poste alla fine dell‘opera «La monaca in casa» e poi nel 1860<br />
per averne dato cenno nella vita <strong>di</strong> Rosina Pedemonte, della stessa unione,<br />
morta il 30 gennaio 1860.<br />
Sull‘esempio delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> il Frassinetti pensò a qualcosa <strong>di</strong><br />
simile per gli uomini.<br />
Come iniziò l‘opera, lo narra egli stesso, con quella semplicità che<br />
era tutta sua:<br />
230 D. FASSIOLO, op. cit., pag. 156— 159. Inoltre vedere la testimonianza<br />
<strong>di</strong> Don Boraggini, Atti..., pag. 13.<br />
231 OLIVARI CARLO, Della vita e delle Opere del Servo <strong>di</strong> Dio G. Frassinetti,<br />
Poliglotta Vaticana, Roma, 1926.<br />
97
―Uscito — egli <strong>di</strong>ce — alle stampe il «Modello delle povere<br />
fanciulle, Rosina Pedemonte», pia giovane morta il 30 gennaio nell‘età <strong>di</strong> 20<br />
anni, fanciulla che fu segnalatissima nella Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, un giovinetto <strong>di</strong> 14 anni, lette le sua memorie, mi domandava<br />
perché non si potesse fare dai ragazzi ciò che si faceva con tanto successo<br />
dalle fanciulle.<br />
Io, che conoscevo il suo spirito molto vivace e intraprendente, gli<br />
rispondeva come già da sei anni si era impiantata la Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e<br />
<strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, la quale andavasi mirabilmente <strong>di</strong>ffondendosi, nulla vietava che se<br />
ne impiantasse un‘altra che fosse dei <strong>Figli</strong> della <strong>Immacolata</strong> Madre, i quali<br />
per maggior influenza che avrebbero nella società, potrebbero operare<br />
maggior bene che le fanciulle; che si accingesse all‘opera e si cercasse alcuni<br />
compagni, i quali volessero emulare le <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, che in tal modo<br />
anche l‘unione dei <strong>Figli</strong> si sarebbe formata.<br />
Il giovinetto accolse la mia proposta, e poco stante trovò alcuni<br />
altri giovani tutti a se maggiori <strong>di</strong> età, risoluti a vivere per Id<strong>di</strong>o, e fu<br />
formata l‘unione.<br />
Essa a poco a poco, crescendo, ebbe in Genova una cinquantina<br />
<strong>di</strong> iscritti. Fu poi stabilita in vari altri luoghi; e non voglio tacere Mornese, il<br />
castello del Monferrato, dov‘era sorta l‘unione summentovata delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong><br />
<strong>Maria</strong>‖.(cfr. Olivari, vita del Servo <strong>di</strong> Dio G. Frassinetti, pag.129).<br />
Di questa nuova istituzione lui era l‘anima, guida e consigliere.<br />
Anche per loro scrisse una regola, che fu approvata da Monsignor A.<br />
Gentile, Vescovo <strong>di</strong> Novara, e il Frassinetti scrisse il suo «Religioso al<br />
secolo», come per le altre aveva scritto «La monaca in casa».<br />
Però questa seconda istituzione non ebbe la fortuna della prima,<br />
perché con la morte del Frassinetti l‘opera pian piano morí, ―non senza<br />
però che prima uscisse da lei un vigoroso germoglio che doveva aver vita<br />
religiosa e feconda <strong>di</strong> molto bene: l‘opera per lo avviamento dei giovinetti<br />
poveri alla carriera ecclesiastica‖. 232<br />
Il Frassinetti la vide appena nascere.<br />
―Era il gennaio 1866, la domenica che segue l‘Epifania, giorno<br />
sacro per i genovesi alle glorie <strong>di</strong> nostra Signora della Provvidenza, e tre<br />
bravi giovani salivano <strong>di</strong> buon mattino al Santuario della Madonnetta per<br />
fare le loro <strong>di</strong>vozioni. Eran tre <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, che dopo aver implorato la<br />
bene<strong>di</strong>zione della Madre Celeste, dovevano raccogliersi in quel giorno a far<br />
vita comune in alcune stanzucce attigue alla canonica <strong>di</strong> S. Sabina‖.<br />
(Olivari,op. cit. pag 220).<br />
232 Op .cit.<br />
98
Pietro Olivari, uno dei tre, aveva la <strong>di</strong>rezione della piccola<br />
comunità.<br />
E il Frassinetti pre<strong>di</strong>ligeva questo piccolo cenacolo dove, alla<br />
scuola dell‘Olivari, vedeva ben trasfuso il suo spirito.<br />
―Frequentava in quel tempo la sacrestia <strong>di</strong> S. Sabina un ragazzetto,<br />
certo Nicolò Ferretti <strong>di</strong> Monteghirfo, che mostrava desiderio <strong>di</strong> avviarsi al<br />
Sacerdozio.<br />
Ma egli era povero; come fare? Il Frassinetti ne tenne parola con<br />
l‘Olivari, perché lo raccomandasse al <strong>di</strong>rettore degli Artigianelli che lo<br />
volesse accogliere nel suo istituto.<br />
Ma l‘Olivari, fosse un moto del suo cuore generoso, fosse per<br />
ispirazione del cielo «Possiamo — <strong>di</strong>sse — prenderlo con noi e mantenerlo<br />
dei nostri risparmi».<br />
Il Frassinetti aderì <strong>di</strong> buon grado a quella proposta, e quel<br />
giovanetto morì poi missionario negli Stati Uniti, dopo lunghi anni spesi<br />
alla salute delle anime‖ 233.<br />
Al primo ragazzo se ne aggiunsero presto altri e si sentí la<br />
necessità <strong>di</strong> un luogo piú ampio.<br />
Da principio pensarono all‘istituto degli Artigianelli, ove l‘Olivari<br />
lavorava come <strong>di</strong>rettore della tipografia.<br />
Il primo luglio 1867 presero in affitto un appartamento in via Lata<br />
e vi trasferirono la piccola comunità.<br />
Il Frassinetti scrisse un apposito regolamento e vi si recava in<br />
giorni determinati per conferenze e istruzioni.<br />
―Se non ché, crescendo la comunità, si parve conveniente avesse a<br />
<strong>di</strong>rettore un Sacerdote che tutto si de<strong>di</strong>casse al suo governo, non potendo<br />
il Frassinetti per le cure della Parrocchia attendervi in quel modo che<br />
avrebbe voluto; non volendo l‘Olivari durare in un ufficio che la sua qualità<br />
<strong>di</strong> secolare e le occupazioni della tipografia gli rendevano incompatibili.<br />
―Gli fu proposto il Diacono Antonio Piccardo, allora prefetto in<br />
seminario.<br />
Al Frassinetti piacque la scelta, e il giovane <strong>di</strong>acono accettò <strong>di</strong><br />
buon grado l‘incarico. Solo si aspettava che fosse consacrato sacerdote. Ma<br />
in quel mezzo il Frassinetti morì.<br />
Egli che aveva gittato il seme benedetto non doveva vedere che i<br />
primi germogli. Ben vide dal cielo grandeggiare e ne esultò nel Signore‖ 234.<br />
233 Op. cit.<br />
234 Op. cit.<br />
99
L‘opera prese grande sviluppo, e nel 1891 si cominciò a parlare <strong>di</strong><br />
una vera e propria Congregazione <strong>di</strong>ocesana per assicurare la vitalità<br />
dell‘opera stessa.<br />
Nel 1895 Don Piccardo, restando sempre a capo dell‘Opera, viene<br />
nominato rettore del Seminario Arcivescovile <strong>di</strong> Genova.<br />
In questo ultimo trentennio del 1800 l‘Opera e il Seminario<br />
formano in <strong>di</strong>ocesi circa 300 sacerdoti.<br />
Nel 1902 il Piccardo viene invitato a Roma ad aprire un Istituto<br />
per accogliervi i chierici esterni, che venivano a Roma per ragioni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
e che alloggiavano presso famiglie private.<br />
Nel 1904, con soli 9 membri già sacerdoti, Pio X, il 21 maggio<br />
concede il «Decretum lau<strong>di</strong>s», che erige l‘opera in Congregazione religiosa,<br />
il cui fine speciale era ed è: promuovere, coltivare le vocazioni allo stato<br />
ecclesiastico.<br />
Con l‘espansione o il cambiamento dei tempi si perde un po‘ del<br />
fine primario della Congregazione che è il promuovere e coltivare le<br />
vocazioni allo stato ecclesiastico e religioso, nell‘Istituto stesso, nei<br />
seminari, nelle case del clero e nella pastorale vocazionale.<br />
Attualmente i suoi religiosi sono al lavoro in 14 centri parrocchiali,<br />
6 scuole, e il fine speciale viene realizzato per quello che è possibile in 3<br />
Aspirandati e in 1 Istituto Ecclesiastico.<br />
Nell‘America Latina (Argentina e Cile) si attendono 6 parrocchie e<br />
due istituti <strong>di</strong> insegnamento.<br />
Grande è la mole <strong>di</strong> lavoro e poche le forze per poterlo realizzare<br />
come i tempi nuovi della vita della Chiesa lo esigono.<br />
Infatti da qualche anno l‘Istituto non è sfuggito a questa ondata <strong>di</strong><br />
crisi e <strong>di</strong> penuria <strong>di</strong> vocazioni che sta affliggendo la Chiesa quasi dovunque.<br />
La situazione è allarmante sopratutto per le nuove leve.<br />
Infatti si può affermare che, grazie a Dio, si è passati indenni dalla<br />
crisi riformistica e da quel travaglio tanto penoso e doloroso qual‘è la<br />
defezione dei membri già consacrati dell‘Istituto stesso.<br />
Negli Aspirantati invece viene meno il numero degli alunni e <strong>di</strong><br />
conseguenza calano quelli che dovrebbero entrare in noviziato e i nuovi<br />
professi.<br />
Nel 1969 si è tenuto a Roma il Capitolo Generale speciale, voluto<br />
dalla Chiesa per tutti i religiosi, per la revisione delle Costituzioni.<br />
Confrontando le nuove Costituzioni con le precedenti si trova che<br />
il fine speciale dell‘istituto è restato lo stesso; si legge infatti al quarto<br />
articolo: ―L‘apostolato specifico dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> è:<br />
100
promuovere, curare, sostenere, assistere la vocazioni religiose e<br />
sacerdotali<br />
attendere inoltre all‘orientamento, alla educazione ed istruzione<br />
della gioventú al ministero apostolico.<br />
Nelle vecchie costituzioni si legge al secondo articolo:<br />
―Fine speciale della Congregazione è <strong>di</strong> promuovere, preparare,<br />
coltivare le vocazioni allo stato ecclesiastico. Attenderà inoltre alla<br />
educazione della gioventú in genere‖.<br />
Come si vede, confrontando i due articoli, il fine speciale è restato<br />
lo stesso.<br />
Però c‘è da notare una piccola <strong>di</strong>fferenza, che poi non è tanto<br />
trascurabile: nelle nuove costituzioni l‘articolo si <strong>di</strong>vide in due parti senza<br />
dare priorità a una delle due.<br />
Nelle vecchie non era così, pare che il fine specifico fosse ben<br />
determinato. Certamente nelle nuove costituzioni si è voluta tener presente<br />
la situazione attuale della Congregazione, giustificandola anche con le<br />
costituzioni.<br />
Ma non so se ciò abbia contribuito a farci riscoprire quella che<br />
dovrebbe essere la nostre missione nella Chiesa.<br />
I primi padri della Congregazione avevano molto chiaro il fine<br />
dell‘opera stessa.<br />
―Un cenno speciale merita la grave questione dello scopo della<br />
nostra Congregazione. Giova premettere che il patrimonio della<br />
Congregazione è quasi interamente costituito dal patrimonio dell‘opera dei<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, che l‘ha raccolto per proseguire il suo scopo <strong>di</strong><br />
«avviamento <strong>di</strong> giovinetti poveri allo stato ecclesiastico».<br />
Detto scopo fu nell‘opera esclusivo del suo inizio (1866), fino al<br />
1898, quando si incominciò a farvi uno strappo ammettendo anche alcuni<br />
delle scuole tecniche nel collegio <strong>di</strong> Rivarolo.<br />
Nelle prime costituzioni, per influenze esterne ai primi congregati,<br />
si dovette sanzionare questo strappo aggiungendo alla seguente formula<br />
―educazione ed istruzione della gioventú ecclesiastica‖ anche questa ―non<br />
esclusa la gioventú in genere‖.<br />
Per circostanze che in verità rendevano piú <strong>di</strong>fficili restare fedeli al<br />
nostro scopo, e per aver cosí aperta la via, presto la nostra Congregazione<br />
si trovò ad avere un solo collegio fedele al suo scopo principale e questo<br />
con pochi alunni e sterile <strong>di</strong> vocazioni, mentre tre collegi dell‘opera<br />
avevano prima del 1903 dato oltre 300 sacerdoti.<br />
Nelle nuove costituzioni lo scopo e annunciato con una formula<br />
ancora piú empia, cioè prestare l‘opera «all‘educazione ed istruzione della<br />
101
gioventú ecclesiastica ed adoperarsi altresì alla colture morale ed<br />
intellettuale della gioventú in genere».<br />
―A quale proposito, si osserva, è lecito deviare un valore morale <strong>di</strong><br />
una istituzione e gran parte del suo patrimonio per scopi <strong>di</strong>versi da quello<br />
per cui fu fondato e il patrimonio le fu affidato? Le non in<strong>di</strong>fferenti per<strong>di</strong>te<br />
avute e le miserie che ci stringono, non possono essere castighi <strong>di</strong> Dio per<br />
richiamarci al dovere?<br />
Questi brevissimi cenni scritti senza malanimo verso qualcuno e<br />
senza ricercare responsabilità, possano servire nei <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Dio a<br />
mandarci il rime<strong>di</strong>o ai nostri mali e incamminarci su una via <strong>di</strong> vita migliore<br />
e <strong>di</strong> piú fecondo lavoro. Siamo pochi, ma pur non mancano tra noi dei<br />
buoni elementi.<br />
Una mente che conosca la tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> quest‘opera che nata dal<br />
cuore del Frassinetti è rimasta cosí feconda <strong>di</strong> bene per oltre 30 anni, che<br />
conosca le forme e la sostanza della vita religiosa, ma soprattutto una mano<br />
ferma e forte che sappia rimetterci nel buon cammino, potrebbe non<br />
<strong>di</strong>fficilmente creare tra noi quella realtà <strong>di</strong> fecondo apostolato che fu il caro<br />
sogno del sottoscritto e <strong>di</strong> altri che con lui <strong>di</strong>vidano i medesimi ideali e le<br />
medesime speranze.‖ (Questo scritto del P. Olcese non è datato, ma<br />
dovrebbe risalire al 1916; si trova nella cartella «Documenti e memorie»<br />
dell‘archivio generale della Congregazione).<br />
Praticamente a soli 10 anni dalla formazione già in qualche modo<br />
ci si era allontanati dal nostro fine specifico e ciò dava modo a questa<br />
amara riflessione del P. Olcese, uno dei primi nove membri che iniziarono<br />
l‘Istituto.<br />
A mio parere il motivo principale <strong>di</strong> tale mancanza va ricercata<br />
nelle con<strong>di</strong>zioni storiche in cui si vennero a trovare.<br />
Non c‘è da <strong>di</strong>menticare che quando Pio X la elevò a Congregazione<br />
erano solo 9 membri e la preoccupazione piú imme<strong>di</strong>ata fu quella<br />
della sopravvivenza e dell‘affermazione dell‘Istituto.<br />
Cosí in teoria il fine specifico è rimasto sempre vivo, ma nella<br />
pratica si è sviluppato sempre piú quello della educazione della gioventú in<br />
genere.<br />
Nel <strong>di</strong>cembre del 1964 un contributo chiaro sul problema delle<br />
vocazioni fu portato dall‘Opera «Amici degli Aspiranti» che in un‘inchiesta<br />
fra i confratelli della Congregazione, in vista del X Capitolo Generale,<br />
chiedeva ai confratelli chiare proposte. Dalle 76 risposte pubblicate (cfr. Il<br />
nostro fine speciale primario, Cagliari 1964, pro manuscripto) appare<br />
chiaro che il problema è molto sentito dai confratelli.<br />
Però come al solito è mancata l‘attuazione <strong>di</strong> ciò che si era scritto.<br />
102
Certamente oggi l‘Istituto è con<strong>di</strong>zionato nelle sue scelte dalle<br />
opere che si trova a portare avanti. Ma non so se ciò sia nello spirito del<br />
Fondatore che era tanto <strong>di</strong>sponibile alle necessità della Chiesa.<br />
Dovremmo avere, come Istituto, piú coraggio nelle nostre scelte.<br />
Se la ricerca del nostro compito nell‘ambito della Chiesa, richiede delle<br />
scelte precise e a volte anche dolorose da prendere, bisogna avere il<br />
coraggio <strong>di</strong> farle, essere piú <strong>di</strong>sponibili alla voce dello Spirito che ci si<br />
manifesta in vari mo<strong>di</strong>.<br />
Abbiamo scuole, parrocchie, dove meglio fondare centri <strong>di</strong><br />
educazione vocazionale?<br />
Se la vitalità e la testimonianza <strong>di</strong> un istituto si devono misurare<br />
dalle vocazioni che hanno, veramente dovremmo fare una sincera<br />
autocritica e riflessione sul nostro compito nel popolo <strong>di</strong> Dio.<br />
CONCLUSIONE<br />
Il Frassinetti <strong>di</strong>ede il meglio <strong>di</strong> se stesso per il lavoro delle<br />
vocazioni, tenendo presente, per tutta la vita, il proposito fatto da<br />
sacerdote novello — riportato all‘inizio — <strong>di</strong> giovare alle vocazioni.<br />
Leggendo le conclusioni del Convegno Nazionale Vocazioni<br />
(Roma, Domus Pacis, 2—5 gennaio l975) si possono trovare alcune<br />
in<strong>di</strong>cazioni a cui il Frassinetti era già arrivato:<br />
―…I laici vi sono particolarmente coinvolti, se il loro nome <strong>di</strong>ce<br />
essenzialmente responsabilità a far crescere il regno <strong>di</strong> Dio nel mondo. La<br />
vocazione coniugale — familiare e quella secolare costituiscano la parte del<br />
volto della Chiesa che ancora oggi sembra in ombra e talora persino<br />
malformata‖. (In Rogate ergo, o. 2; citato nella nota 66. Tutte le citazioni<br />
del convegno sono prese da tale rivista).<br />
―La Pia unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> era composta <strong>di</strong> soli laici e il suo<br />
fine primario era appunto: <strong>di</strong> avviare giovinetti poveri che mostrino<br />
inclinazione allo stato ecclesiastico, agli stu<strong>di</strong> propri <strong>di</strong> questo stato,<br />
coltivarne la vocazione‖ (Olivari, op. cit. 220)<br />
Come abbiamo visto, punto vitale per la ricerca e la formazione<br />
delle vocazioni per il Frassinetti era la parrocchia.<br />
Questo oggi si va riscoprendo. L‘azione pastorale si affida<br />
anzitutto e si appoggia fondamentalmente su tutta la via pastorale della<br />
comunità cristiana evangelizzata ed evangelizzante per missione.<br />
―La comunità parrocchiale resta il luogo piú consono per una<br />
evangelizzazione testimoniale e quin<strong>di</strong> per una realizzazione della<br />
vocazione cristiana ed un orientamento delle vocazioni...<br />
103
Solo una comunità, parrocchiale e <strong>di</strong>ocesana, che imposti un piano<br />
pastorale organico <strong>di</strong> evangelizzazione, orienta alla vocazione e specifica,<br />
or<strong>di</strong>nandovi, secondo la propria parte tutti i soggetti <strong>di</strong> pastorale, può avere<br />
modo piú efficace <strong>di</strong> render feconde le iniziative per le vocazioni.<br />
La stanchezza e le delusioni si notano là dove un parroco da solo<br />
od alcune persone, o alcune iniziative spora<strong>di</strong>che, <strong>di</strong> gruppi sparuti si<br />
addossano tutta la responsabilità e l‘iniziativa su <strong>di</strong> un problema cosí<br />
complesso e oggi cosí piú <strong>di</strong>fficile, come è quello delle vocazioni.<br />
È in<strong>di</strong>spensabile che, a monte <strong>di</strong> ogni buona volontà e <strong>di</strong> ogni<br />
buona intenzione <strong>di</strong> alcuni, si apra evangelizzante, una pastorale <strong>di</strong> tutta la<br />
comunità locale che si riproponga l‘aria dove il respiro <strong>di</strong> chi ha il germe<br />
della vocazione sia possibile. Ci possono essere circostanze e tempi, per<br />
parlare e operare accentuatamente in or<strong>di</strong>ne alle vocazioni, ma importante<br />
è una stabile e generale pastorale evangelizzatrice e vocazionale.<br />
Infine il matrimonio cristiano realizza una «famiglia<br />
evangelizzatrice» e il primo seminario delle vocazioni.<br />
La scoperta della famiglia per l‘evangelizzazione; l‘esperienza della<br />
Chiesa domestica è luogo privilegiato <strong>di</strong> coltivazione vocazionale.<br />
È chiaro che sono in modo accentuatissimo compromessi gli<br />
operatori vocazionali con gli strumenti organizzativi che hanno.<br />
Essi debbono portare sussi<strong>di</strong>, persone, iniziative, inserendosi nella<br />
pastorale delle comunità cristiane, per esservi animatori specializzati <strong>di</strong> una<br />
evangelizzazione inclusiva del problema vocazionale‖. (Convegno C.N.V.)<br />
È facile in tutto ciò vedere alcuni punti in comune col Frassinetti<br />
quando nella lettera al Guerra parla dell‘importanza della parrocchia, del<br />
dovere del parroco e dei confessori <strong>di</strong> occuparsi del problema; quando<br />
consiglia i parroci <strong>di</strong> aver una cura speciale delle famiglie, rivolgendosi alle<br />
mamme.<br />
Ma l‘idea fondamentale che oggi è stata realizzata è quella del<br />
Centro Nazionale Vocazioni, che lui consigliava al Guerra <strong>di</strong> promuovere,<br />
per poter fare un lavoro comune in Italia.<br />
Naturalmente bisogna tener presente il mutamento delle situazioni,<br />
non <strong>di</strong>menticando che il Frassinetti visse nell‘800. Ma molte delle sue<br />
idee restano attuali.<br />
Anche oggi ci troviamo in un momento <strong>di</strong> crisi, forse non ancora<br />
così forte e ra<strong>di</strong>cale come quella della seconda metà dell‘800.<br />
Ma senz‘altro la Chiesa riuscirà a superare questa crisi se saprà<br />
riscoprire, nei suoi fedeli, la sua vera identità e missione tra gli uomini.<br />
Nel secolo scorso si è superata la crisi delle vocazioni attraverso la<br />
testimonianza e l‘apostolato <strong>di</strong> tanti santi sacerdoti che fiorirono nella<br />
104
Chiesa, e il Frassinetti nella sua Chiesa <strong>di</strong> Genova è stato un innovatore<br />
fecondo in questo campo.<br />
Senz‘altro anche oggi il Signore assiste la sua Chiesa.<br />
Diceva il Papa ai congressisti del Centro Nazionale Vocazioni,<br />
nell‘u<strong>di</strong>enza del 4 gennaio 1975, ―Abbiate una grande fiducia in Dio,<br />
perché le vocazioni, prima <strong>di</strong> essere opera dell‘uomo, sono opera<br />
principalmente <strong>di</strong> Dio, e in nessun modo dobbiamo dubitare che Dio non<br />
voglia provvedere ai bisogni della sua Chiesa, cui ha promesso assistenza<br />
sino alla fine dei tempi (cfr. Mt. 28,20).<br />
Ma soprattutto mantenetevi sempre in stretta comunione col<br />
Padrone della messe me<strong>di</strong>ante il mezzo fondamentale e insostituibile della<br />
preghiera, essendo la vocazione dono dello Spirito da implorarsi, come ci è<br />
stato insegnato dal Signore‖ (cfr. Giov 4,35; Mt 9,38) 235.<br />
Ed anche in questo il Frassinetti ci è <strong>di</strong> esempio.<br />
BIBLIOGRAFIA GENERALE<br />
OLIVARI CARLO, Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti,<br />
Poliglotta Vaticana, Roma, 1928<br />
V. VAILATI, Un maestro <strong>di</strong> vita sacerdotale, Ed. Paoline, Alba, 1947<br />
Atti causa <strong>di</strong> beatificazione del Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, Roma, Scuola<br />
tipografica Pio X, 1947<br />
a cura <strong>di</strong> MORELLi REMO Archivio frassinettiano, vol. I, Centro Vocazionale<br />
G. Frassinetti, Roma. ―Pro manuscripto‖<br />
Il nostro fine speciale primario, Centro Coor<strong>di</strong>natore ―Opera Amici Aspiranti‖,<br />
Cagliari, 1964 ―Pro manuscripto‖<br />
PARENTE PIETRO, Commemorazione del Frassinetti tenuta a Siena nel 1968, non<br />
pubblicata.<br />
G. FRASSINETTI, Opera Omnia, Tip. Poliglotta Vaticana, Roma, 1912<br />
Volumi I-XIII.<br />
Le singole opere consultate sono citate nelle note.<br />
Sergio De Angelis fsmi<br />
235 MAGNO VITO, Il terzo congresso nazionale vocazioni, in Rogate Ergo,<br />
Anno XXXVIII, Febbraio 1975, pag. 22— 27.<br />
105
VOI PREGHERETE COSÍ<br />
EXCURSUS SUL<br />
«PATER NOSTER DI SANTA TERESA DI GESÚ»<br />
del Venerabile Giuseppe Frassinetti<br />
Poiano - Verona<br />
Noviziato 1988/9<br />
SOMMARIO<br />
Introduzione<br />
Capitolo primo<br />
Necessità della preghiera<br />
Capitolo secondo<br />
È importante incominciare in qualunque modo l‘esercizio della preghiera<br />
Capitolo terzo<br />
La preghiera nella quale dobbiamo esercitarci<br />
Capitolo quarto<br />
Cosa s‘intende per me<strong>di</strong>tazione necessaria a molte persone<br />
Capitolo quinto<br />
La preghiera che deve accompagnare la vocale<br />
Capitolo sesto<br />
Altri insegnamenti sulla preghiera<br />
Capitolo settimo<br />
Modo <strong>di</strong> procurarsi la compagnia del Signore mentre preghiamo<br />
Capitolo ottavo<br />
Quanto sia intima la nostra unione con Dio<br />
Capitolo nono<br />
Come possiamo esercitarci in questa <strong>di</strong>vina presenza con pie contemplazioni<br />
Capitolo decimo<br />
Strategia per acquistare il sentimento della interiore <strong>di</strong>vina presenza<br />
Capitolo un<strong>di</strong>cesimo<br />
I beni che derivano da questo genere <strong>di</strong> preghiera<br />
INTRODUZIONE<br />
Durante il noviziato ci siamo accostati, come era <strong>di</strong> necessità, allo<br />
stu<strong>di</strong>o della vita e soprattutto delle opere del fondatore della nostra<br />
Congregazione.<br />
106
Nella ricerca sulla preghiera è scaturita una scoperta molto interessante<br />
ovvero che il servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti si <strong>di</strong>stingueva<br />
anche come eccellente maestro <strong>di</strong> preghiera.<br />
Quello che noi vogliamo porre in evidenza del Frassinetti<br />
«maestro <strong>di</strong> preghiera» lo abbiamo compen<strong>di</strong>ato in queste note.<br />
Egli rivela una spiccata capacità <strong>di</strong> proporre la preghiera a tutti,<br />
cercando <strong>di</strong> abbattere tutte le barriere che si frappongono sia da parte <strong>di</strong><br />
chi dovrebbe proporla, sia da parte <strong>di</strong> chi (il popolo cristiano) la deve<br />
perseguire per camminare verso il Padre.<br />
Il priore Frassinetti nei suoi scritti porge la preghiera a tutti con<br />
grande semplicità senza assolutizzare meto<strong>di</strong> ma invitando il cristiano ad<br />
avvicinarvisi gradualmente ma con perseveranza.<br />
La sua «scuola <strong>di</strong> iniziazione alla preghiera», come la si potrebbe<br />
definire, ha il carattere esperienziale, ovvero manifesta chiaramente la<br />
esperienza della sua preghiera personale, egli corrobora la sua esperienza<br />
con l‘autorità <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa d‘Avila. Le due esperienze si accostano e pur<br />
nella soggettività del sentire dei due maestri, il Frassinetti trova le costanti<br />
per educare il popolo <strong>di</strong> Dio al <strong>di</strong>alogo con il Signore.<br />
Il servo <strong>di</strong> Dio demitizza e infrange il preconcetto che riserva ai<br />
gran<strong>di</strong> mistici l‘esperienza interiore e la vita con Dio e me<strong>di</strong>a <strong>Santa</strong> Teresa<br />
in modo che la comparazione della grandezza della <strong>Santa</strong> non schiacci o<br />
non scoraggi nessuna persona che vuole mettersi nella via della preghiera.<br />
Il fatto prezioso è che egli riesce a cogliere la forza degli insegnamenti<br />
<strong>di</strong> Teresa d‘Avila e a porgerli in una semplicità e<strong>di</strong>ficante che elimina<br />
ogni timore reverenziale e apre a tutti il cammino della preghiera.<br />
In questo nostro «tomo» abbiamo riportato gli insegnamenti del<br />
servo <strong>di</strong> Dio, insegnamenti tratti dal libro «Il pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong><br />
Gesú».<br />
Il nostro intento è quello <strong>di</strong> portare a conoscenza, <strong>di</strong> chi gra<strong>di</strong>sce,<br />
che egli, seppure <strong>di</strong>stante da noi nel tempo, manifesta la sua attualità<br />
proprio perché il <strong>di</strong>alogo con Dio non conosce limiti <strong>di</strong> tempo e <strong>di</strong> cultura<br />
ma soprattutto lo proponiamo perché il messaggio si trasformi in invito<br />
alla preghiera-<strong>di</strong>alogo per tutti senza esclusione.<br />
Poiano, 8 settembre 1989<br />
107
CAPITOLO I<br />
NECESSITÀ DELLA PREGHIERA<br />
La preghiera è la strada migliore per arrivare alla perfezione. Praticandola<br />
si acquista un gran tesoro per cui non si deve badare allo sforzo<br />
richiesto. Verrà il tempo in cui si capirà che è un nulla l‘impegno richiesto<br />
in confronto all‘acquisto della capacità <strong>di</strong> pregare. Un uomo senza<br />
preghiera è come un paralitico, che, anche se ha le mani, non le può usare.<br />
Tuttavia vi sono molte persone che conoscono l'importanza della preghiera<br />
e i suoi benefici, ma non si decidono mai ad incominciare e invecchiano<br />
pregando poco e male. Se fossimo in questo stato bisogna persuaderci e<br />
cominciare con una grande e risoluta determinazione <strong>di</strong> non fermarsi sino<br />
all‘acquisto <strong>di</strong> essa. ―Se il demonio conosce qualcuno leggero e incostante<br />
nel bene e con poca determinazione <strong>di</strong> perseverare, non lo lascerà, come si<br />
suol <strong>di</strong>re, né per sole né per ombra; gli metterà paura e gli rappresenterà<br />
inconvenienti senza fine‖.<br />
Si deve partire con coraggio senza badare alle mormorazioni <strong>di</strong><br />
persone vuote <strong>di</strong> spiritualità e <strong>di</strong> chiunque ci voglia <strong>di</strong>stogliere dall‘esercizio<br />
della preghiera. Il tempo che usiamo per la preghiera bisogna donarlo a<br />
Dio e non prestarglielo, pensando a quanti beni che siamo incapaci <strong>di</strong><br />
apprezzare nel loro pieno valore, abbiamo già ricevuto da Lui; per cui non<br />
dobbiamo pensare che il tempo sia nostro, è imprestato, spenderlo per la<br />
preghiera è un atto <strong>di</strong> restituzione.<br />
Incominciare con grande determinazione aiuta molto ad affrontare<br />
e superare tutti gli ostacoli che possono insorgere. La nostra<br />
determinazione dovrebbe essere simile a quella del soldato, il quale,<br />
sapendo che non può salvare la propria vita se non con la vittoria sul<br />
nemico, avanza risoluto per combattere fino all'ultimo sangue. Costui non<br />
teme tanto i colpi perché ha davanti quello che gli importa: la vittoria, e sa<br />
che vincendo avrà salva la vita.<br />
Ora, l‘esperienza insegna, che il troppo pensare produce problemi<br />
i quali impe<strong>di</strong>scono l‘inizio del cammino, fossilizzandoci nel nostro continuo<br />
indugiare. Dunque chi, per grazia <strong>di</strong> Dio, ha stimato il suo Dio sopra<br />
ogni cosa e ha inteso quanto sia dolce e buona cosa il conversare interiormente<br />
con Lui me<strong>di</strong>ante la preghiera, e sentito l‘amorosa sua voce che lo<br />
invita e lo stimola, si decida ad arrivare alla perfezione me<strong>di</strong>ante questo<br />
grande dono che Dio ci fa.<br />
―Il Padre è amico <strong>di</strong> persone generose, purché camminino con<br />
umiltà, abbandonate completamente a Dio. Io non ho mai visto alcuna <strong>di</strong><br />
queste persone che sia rimasta in<strong>di</strong>etro in questo cammino, neanche una<br />
108
persona codarda, anche se umile, che in molti anni cammini tanto quante<br />
queste altre fervorose in pochi giorni. Resto sbalor<strong>di</strong>ta dal molto che giova<br />
in questo cammino il farsi animo a cose gran<strong>di</strong>; poiché quantunque la<br />
persona non abbia subito forza, dà non <strong>di</strong> meno un generoso volo e arriva<br />
molto avanti come un piccolo uccellino il quale ha ancora la prima<br />
lanugine, che si ferma e si stanca. Ma il volo lo ha fatto e, dopo il primo, dà<br />
il secondo, il terzo e così via, finché cresciute le piume, non si stanca e non<br />
si ferma piú‖.<br />
CAPITOLO II<br />
È IMPORTANTE INCOMINCIARE IN QUALUNQUE MODO<br />
L'ESERCIZIO DELLA PREGHIERA<br />
Ora, però, ci sono persone, ancora all‘inizio che osservando quale<br />
determinazione viene richiesta, corrono il rischio <strong>di</strong> abbattersi poiché non<br />
hanno tale forza e coraggio. Questo non deve essere un problema, perché<br />
Dio dà a tutti e, in modo <strong>di</strong>verso, il dono della preghiera.<br />
―Dio è cosí buono che in molte maniere dà da bere a coloro che<br />
lo vogliono seguire, questo perché nessuno vada sconsolato, né muoia <strong>di</strong><br />
sete; atteso che da questa abbondantissima fonte (della orazione)<br />
scaturiscano rivi, altri gran<strong>di</strong> e altri piccoli, e qualche volta piccoli laghetti<br />
per i bambini, ai quali questo basta, e il mostrar loro piú acqua<br />
significherebbe spaventarli, (questi sono quelli che stanno ai principi)‖.<br />
Perciò tutti devono sperare <strong>di</strong> arrivare al proprio stato <strong>di</strong><br />
preghiera, a cui Dio, il donatore, chiama. Dunque se anche manca una<br />
decisa determinazione per cominciare, non bisogna credersi indegni o<br />
incapaci, ma si incominci a dare già un primo passo, e in seguito Dio darà<br />
la forza <strong>di</strong> andare avanti. Dio, infatti, accetta tutto, anche un solo sguardo o<br />
preghiera tiepida, purché ci sia in noi un principio <strong>di</strong> buona volontà. È<br />
vero, vi sarà qualche <strong>di</strong>fferenza tra chi incomincia con ferma<br />
determinazione e procede coraggioso nell‘esercizio della preghiera senza<br />
fermarsi piú e, chi comincia con freddezza e titubanza, e poi si sente<br />
mancare le forze e si ferma ai primi passi. Quel primo correrà e quasi<br />
volerà alla perfezione cristiana, come cervo alla fonte, come aquila al sole; il<br />
secondo si muoverà, si alzerà appena come lento bue, come gallina <strong>di</strong><br />
debole piuma; tuttavia questo muoversi, questo poco alzarsi, è qualcosa <strong>di</strong><br />
piú che il non far nulla.<br />
La preghiera sia fatta quanto tiepidamente si vuole, è molto<br />
stimata da Dio. Quin<strong>di</strong> non tenete in poco conto questa prima grazia (<strong>di</strong><br />
109
pregare anche tiepidamente), né vi rattristate quando vedete che non<br />
rispondete subito al Signore, che ben sa Dio aspettare molti giorni ed anni,<br />
particolarmente quando vede perseveranza e buoni desideri. Infatti la storia<br />
ci presenta molti esempi <strong>di</strong> persone che incominciarono ad avvicinarsi al<br />
Signore con freddezza e titubanza, e davano un po‘ alla volta alcuni passi,<br />
quasi impauriti <strong>di</strong> avvicinarsi al <strong>di</strong>vino, e poi si fermavano facilmente e<br />
affermavano che era impossibile arrivare alla perfezione, alla santità, ma,<br />
siccome conservarono quel principio <strong>di</strong> buona volontà, sebbene debole,<br />
aiutate dalla grazia <strong>di</strong> Dio, che non badava ai loro meriti ma al suo amore,<br />
fecero finalmente passi piú franchi e risoluti e arrivarono a quell‘altezza che<br />
tanto li spaventava. Chiunque, dunque, non ha ancora provato quanto è<br />
buono il Signore, non tema, ma si accosti a Lui con fiducia. E poi provare<br />
non fa male.<br />
CAPITOLO III<br />
LA PREGHIERA NELLA QUALE DOBBIAMO ESERCITARCI<br />
È cosa impossibile stabilire un tempo <strong>di</strong> preghiera opportuno per<br />
tutte le persone. Gesú ha detto a tutti <strong>di</strong> pregare continuamente, senza<br />
cessare. Questa regola che sembra spaventarci è data dallo Spirito Santo, e<br />
non può essere che ragionevole e <strong>di</strong>screta; piuttosto è da capire come si<br />
deve intendere. Essa non può essere presa alla lettera; che cioè il cristiano<br />
sia in continua preghiera; invece s‘intende che il cristiano deve dare alla<br />
preghiera un tempo conveniente secondo le proprie esigenze e con<strong>di</strong>zioni.<br />
Per non sbagliare è meglio farsi in<strong>di</strong>rizzare dal proprio <strong>di</strong>rettore spirituale.<br />
Poi tutte le azioni quoti<strong>di</strong>ane le donerà al Signore e cosí facendo sarà in<br />
continua preghiera.<br />
La preghiera si <strong>di</strong>stingue in vocale e mentale e sono entrambe<br />
necessarie. Quin<strong>di</strong> si possono <strong>di</strong>stinguere due tipi <strong>di</strong> persone; uno che è<br />
capace <strong>di</strong> raccogliersi in se stesso e me<strong>di</strong>tare la parola <strong>di</strong> Dio in cuor suo e,<br />
un altro, che non riesce in questo, essendo per natura troppo <strong>di</strong>stratto.<br />
Ora, però, questa persona non si deve credere inferiore, poiché<br />
questo effetto può derivare o dalla propria natura irrequieta o da Dio che<br />
lo permette per arrivare ai suoi scopi. Costui, dunque, può de<strong>di</strong>carsi alla<br />
preghiera vocale, non solo <strong>di</strong> bocca, ma esprimendo nelle parole tutto il<br />
suo amore a Dio.<br />
―Conosco io una persona, che non poté mai fare se non orazione<br />
vocale; ed attaccata a questa, aveva tutto; e se non orava vocalmente, le andava<br />
l‘intelletto cosí <strong>di</strong>stratto e <strong>di</strong>vagato che non lo poteva soffrire: tuttavia<br />
110
piacesse a Dio che tale avessimo noi tutte la orazione mentale. In certi<br />
Pater noster che <strong>di</strong>ceva ad onore dei vari spargimenti del Sangue <strong>di</strong> nostro<br />
Signore, si tratteneva due o tre ore circa. Se ne venne una volta da me<br />
molto affannata per non saper fare orazione mentale, né poter contemplare,<br />
ma solo pregare vocalmente. Le domandai che orazione <strong>di</strong>ceva e<br />
conobbi che, attaccata al Pater noster aveva pura contemplazione, ed era<br />
innalzata dal Signore a congiungersi seco in orazione <strong>di</strong> unione. E ben ciò<br />
io conosceva nelle sue opere, perché menava una vita molto buona; onde<br />
ne lodai il Signore, ed ebbi invi<strong>di</strong>a della sua orazione vocale‖.<br />
Quin<strong>di</strong> non c‘è da affaticarsi e sforzarsi per ottenere il dono della<br />
me<strong>di</strong>tazione, poiché tali sforzi potrebbero essere non solo inutili, ma anche<br />
dannosi, portando cosí, scrupoli e confusione. Ma perché non si pensi che<br />
si ottenga poco guadagno dal pregare oralmente con perfezione, è da<br />
notare che è molto possibile che, mentre <strong>di</strong>ciamo il Padre nostro o altra<br />
preghiera vocale il Signore ci innalzi a perfetta contemplazione. Che qualcuno<br />
<strong>di</strong>ca che la me<strong>di</strong>tazione è un mezzo molto efficace per arrivare alla<br />
perfezione, non lo si nega; si insegna solo che la preghiera vocale è un<br />
mezzo ugualmente efficace. Per cui essendo importante il conseguimento<br />
della perfezione e non l‘uso piú <strong>di</strong> un mezzo che <strong>di</strong> un altro, verrà sempre<br />
<strong>di</strong> conseguenza che le persone incapaci <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tare non si debbano, perciò,<br />
angustiare, ne sforzarsi a tale esercizio.<br />
CAPITOLO IV<br />
CHE COSA SI INTENDE PER MEDITAZIONE <strong>NECESSARIA</strong> A<br />
MOLTE PERSONE<br />
La me<strong>di</strong>tazione è <strong>di</strong> due specie:<br />
- la prima è quella «meto<strong>di</strong>ca», cioè quando uno riesce a<br />
tenere il pensiero su un tema e arrivare al suo significato con l‘aiuto <strong>di</strong> un<br />
libro o <strong>di</strong> un metodo <strong>di</strong> preghiera;<br />
- la seconda è quella «semplice» e consiste nell‘avere<br />
l‘attenzione della nostra mente alle verità della fede.<br />
Se infatti un cristiano sente la parola <strong>di</strong> Dio senza badare a quello<br />
che gli viene detto, e se prega senza concentrarsi su Dio, non può essere<br />
che un cristiano sbadato. Quin<strong>di</strong> le persone che non hanno la capacità <strong>di</strong><br />
fare la preghiera <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tazione meto<strong>di</strong>ca devono continuare a pregare<br />
ugualmente, credendo che Dio vuole cosí.<br />
Chi non ha questa capacità, non s‘inquieti, e segua la preghiera vocale,<br />
perché è una strada <strong>di</strong>versa ma conduce alla stessa meta, sapendo che<br />
111
Dio dà ad ognuno secondo le proprie possibilità. Qualora una persona si eserciti<br />
bene nella me<strong>di</strong>tazione semplice, non ha bisogno della meto<strong>di</strong>ca, né<br />
per assicurarsi la salvezza, né per arrivare alla santità. Infatti ci sono molte<br />
persone che facendo me<strong>di</strong>tazione semplice arrivano per grazia <strong>di</strong> Dio alla<br />
contemplazione. Ci sono molte persone che tuttavia sono da Dio innalzate<br />
alla contemplazione e che arrivano al terzo grado dell‘esercizio spirituale <strong>di</strong><br />
cui parla S. Bernardo nella «Scala de‘ claustrali».<br />
La «Scala de‘ claustrali» si può così riassumere:<br />
- la lettura, cui corrisponde l‘ascoltare la <strong>di</strong>vina parola;<br />
- la me<strong>di</strong>tazione semplice o meto<strong>di</strong>ca, egli non <strong>di</strong>stingue;<br />
- l‘orazione;<br />
- la contemplazione.<br />
Nel terzo grado S. Bernardo <strong>di</strong>ce: ―una devota attenzione del<br />
cuore rivolta a Dio con la quale la persona, arrivata a questo grado, sfoga le<br />
sue brame per essere liberata dai veri mali ed essere arricchita dei veri<br />
beni‖.<br />
CAPITOLO V<br />
LA PREGHIERA CHE DEVE ACCOMPAGNARE LA VOCALE<br />
La preghiera vocale non è staccata dalla mentale. La <strong>di</strong>fferenza tra<br />
preghiera vocale e mentale non consiste nel tenere la bocca chiusa o aperta,<br />
ma piuttosto nella consapevolezza <strong>di</strong> parlare con Dio e rivolgere l‘attenzione<br />
della mente, della bocca e del cuore a Dio.<br />
―Sappiate, figliole, che la <strong>di</strong>fferenza dall‘essere o non essere orazione<br />
mentale non consiste in tener serrata o aperta la bocca. Che se io,<br />
parlando, sto internamente attendendo e vedendo che parlo con Dio, con<br />
maggiore avvertenza che nelle parole che <strong>di</strong>co; questo è fare insieme orazione<br />
mentale e vocale. Salvo, se non vi <strong>di</strong>cono alcuni, che basta stiate con<br />
la bocca parlando con Dio recitando il Pater noster, e col cuore pensando<br />
al mondo. Io qui taccio. Ma se avete da stare, come <strong>di</strong> ragione star dovete,<br />
parlando con sí gran Signore, è bene stiate considerando con chi parlate, e<br />
chi siete voi, almeno per parlare con creanza. Perciocché, come potrete<br />
parlare, dare al re il titolo <strong>di</strong> Maestà, o <strong>di</strong> Sire, o sapere quali cerimonie si<br />
usano per parlare ad un principe grande, se non sapete bene quale sia il suo<br />
stato, e quale il vostro? Conforme a questo e all‘uso, si devono fare le<br />
riverenze e i complimenti; altrimenti, non sapendo neppure questo, vi<br />
rimanderanno per rozzi e balor<strong>di</strong>, e non potrete trattare <strong>di</strong> alcuna cosa‖.<br />
112
Quin<strong>di</strong> prima <strong>di</strong> iniziare la preghiera, riflettiamo con chi an<strong>di</strong>amo<br />
a parlare e chi siamo noi davanti a quell‘infinita Bontà, cui <strong>di</strong>rigiamo le<br />
nostre parole. Con questo ci troveremo facilmente, riconcentrati<br />
trasformando questa preghiera sia in vocale che in mentale.<br />
―Se accostandovi a Lui, arriverete a pensare ed intendere con chi<br />
andate a parlare, o con chi state parlando, sappiate certo, che in mille vite<br />
della nostra non finiremo d‘intendere, come merita <strong>di</strong> essere trattato questo<br />
Signore, alla cui presenza gli Angeli tremano, che il tutto comanda, il tutto<br />
può, il cui volere è operare.<br />
Sarà, dunque ragionare, figliole mie, che procuriamo <strong>di</strong>lettarci in<br />
queste grandezze del nostro Sposo.... Chi è suo Padre, che paese è quello<br />
che ci ha da condurre, che bene promette darci, che con<strong>di</strong>zione è la sua; e<br />
come meglio potremo contentarlo, in che gli daremo gusto; e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are<br />
come accomodare la nostra con<strong>di</strong>zione, per conformarla con la sua....<br />
L‘intendere, figliole mie, questa verità, è orazione mentale. Se volete andare<br />
intendendo ed investigando questo è pregare vocalmente, alla buon‘ora; ma<br />
non mi state a parlare con Dio, pensando ad altra cosa‖.<br />
Dunque in ogni preghiera vocale fatta con attenzione c‘è anche la<br />
mentale. Per cui ognuno cammini per la sua via, cioè col suo metodo <strong>di</strong><br />
preghiera, purché essa sia fatta con attenzione, senza inquietu<strong>di</strong>ne o paura.<br />
C‘è il pericolo che sforzandovi con altri meto<strong>di</strong>, che magari non fanno per<br />
voi, vi affatichereste inutilmente. È chiaro, poi, che la preghiera fatta <strong>di</strong><br />
cuore, cioè con attenzione interna, non esclude le <strong>di</strong>strazioni involontarie le<br />
quali sono inevitabili data l‘incostanza della fantasia umana. Si sa che<br />
queste <strong>di</strong>strazioni non guastano in alcun modo la nostra preghiera.<br />
CAPITOLO VI<br />
ALTRI INSEGNAMENTI SULLA PREGHIERA.<br />
Quando facciamo la preghiera vocale bisogna che ognuno <strong>di</strong>a un<br />
senso alle parole che <strong>di</strong>ce, altrimenti si rischia <strong>di</strong> <strong>di</strong>re una poesia invece <strong>di</strong><br />
una preghiera. Quando recitiamo una preghiera non bisogna sentirsi soli,<br />
perché il Signore è molto vicino, come quando un figlio parla con suo<br />
padre. Con questo sentimento dobbiamo esporre a Dio le nostre domande,<br />
nella consapevolezza che Egli non ci lascia soli. Per pregare meglio,<br />
sentiamo cosa <strong>di</strong>ce Gesú: ―Quando vorrai pregare, entra nella tua stanza e,<br />
chiusa la porta, prega in segreto il Padre tuo‖. Infatti l‘esperienza insegna<br />
che nel silenzio e nella solitu<strong>di</strong>ne, si fa una preghiera piú attenta, e piú<br />
fervida, dove tutto l‘uomo si abbandona all'impulso dello Spirito, senza<br />
113
doversi contenere, senza nessun riguardo umano. Qui è libero <strong>di</strong> prostrarsi,<br />
<strong>di</strong> sospirare, e <strong>di</strong> piangere come piace allo Spirito; qui non ha da<br />
sopprimere il fervore della preghiera, anzi si aiuta. Ora però non si pensi<br />
che si voglia <strong>di</strong>sapprovare l‘uso della preghiera comune, che è tanto<br />
necessaria alla comune e<strong>di</strong>ficazione. La preghiera comune è molto<br />
importante, anzi in<strong>di</strong>spensabile al cristiano per celebrare nella Chiesa la<br />
liturgia e poco meno si deve <strong>di</strong>re della preghiera fatta in comune nella<br />
famiglia. Tuttavia una persona dovrebbe trovar tempo per l‘una e per l‘altra<br />
secondo quanto gli permette la sua con<strong>di</strong>zione e stato <strong>di</strong> vita.<br />
Mettendo dunque in pratica quello che è stato detto avremo<br />
sicuramente il vantaggio <strong>di</strong> trovare unita la nostra preghiera vocale con la<br />
mentale senza quasi pena e fatica, poiché applicandosi al senso delle parole<br />
e alla <strong>di</strong>vina presenza, la nostra preghiera sarà piú <strong>di</strong> mente che <strong>di</strong> bocca e<br />
perciò piú mentale che vocale.<br />
Ora, però, ci sono persone che nonostante questo non vi riescono<br />
e sono <strong>di</strong>stratte e inquiete, o per mal umore o per debolezza <strong>di</strong> testa. A<br />
queste <strong>di</strong>ciamo <strong>di</strong> non preoccuparsi per queste inquietu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> mente che<br />
sono contro la nostra volontà, perché quando preghiamo attentamente,<br />
facciamo quanto Dio esige da noi e, se non vi riusciamo, Dio è contento<br />
del nostro buon desiderio.<br />
Preghiamo perciò come possiamo e non ci inquietiamo se ci<br />
sembra <strong>di</strong> pregar male. Anzi, se la debolezza della persona, la malinconia<br />
fosse troppo forte, non dobbiamo sforzarci, ma <strong>di</strong>strarci un po‘ per<br />
sollevare il nostro spirito, senza però esagerare, perché ci può essere chi<br />
per eccesso <strong>di</strong> preoccupazione riman<strong>di</strong> sempre e quin<strong>di</strong> non andrà mai<br />
avanti.<br />
―Accarezzamento del corpo e orazione, non si uniscono insieme‖.<br />
―È cosa strana, quanto ama essere accarezzato (questo corpo), e come<br />
qui ha qualche buon colore (cioè pretesto); per poca che sia la<br />
necessità, inganna la povera anima, a ciò non guadagni e non profitti.<br />
Se cominciassimo a vincere e a strapazzare questi capricciuoli, non ci<br />
stancherebbe tanto... Quante volte questo corpo ci ha burlati!‖<br />
―Appena ci immaginiamo che dolga la testa, che subito lasciamo <strong>di</strong><br />
andare al Coro, che pure non ci ammazza. Un giorno lasciamo<br />
d‘andarvi, perché ci duole; l‘altro perché ci è doluta e altri tre perché<br />
non ci dolga‖.<br />
Conclu<strong>di</strong>amo dunque, la preghiera vocale con l‘aiuto <strong>di</strong> Dio, può<br />
portarci alla perfezione; deve essere una preghiera raccolta nella quale<br />
dobbiamo sentire presenza <strong>di</strong> Dio, badare a ciò che gli <strong>di</strong>ciamo, e vedere<br />
cosa ci <strong>di</strong>ce con le sue ispirazioni. Questa sarà preghiera vocale<br />
accompagnata dalla mentale.<br />
114
CAPITOLO VII<br />
MODO DI PROCURARCI LA COMPAGNIA<br />
DEL SIGNORE MENTRE PREGHIAMO<br />
Per procurarci la compagnia del Signore mentre preghiamo, è<br />
bene personificarlo accanto a noi. Se noi domanderemo questa grazia, cioè,<br />
che ci accompagni nella nostra preghiera, Lui sicuramente ce la concederà e<br />
sentiremo la sua presenza in modo che non lo potremo scacciar da noi e in<br />
tutti i luoghi ce lo troveremo. Tuttavia non preten<strong>di</strong>amo <strong>di</strong> acquistare<br />
questo senso <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong>vina in pochi giorni: se ci volesse anche piú <strong>di</strong><br />
un anno <strong>di</strong> esercizio, sarebbe troppo ben impiegato dato il cosí grande<br />
acquisto. L‘esercizio <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>vina presenza non deve sembrarci troppo<br />
<strong>di</strong>fficile. Infatti con la nostra immaginazione ci facciamo presenti le cose<br />
piú lontane, come quando ci immaginiamo <strong>di</strong> aver avanti un caro amico, ci<br />
parliamo e talvolta ci immedesimiamo in quel pensiero <strong>di</strong> modo che non<br />
ba<strong>di</strong>amo piú alle cose che abbiamo davanti agli occhi e ci pare <strong>di</strong> essere con<br />
lui.<br />
Ora perché non ci potremo immaginare <strong>di</strong> avere con noi il nostro<br />
Signore? Nel mirare il Divino Maestro, lo troveremo come lo vorremmo<br />
noi, lieto se lieto, addolorato se addolorato ecc.. Cosí quando saremo presi<br />
da sentimenti <strong>di</strong> allegria interiore, per meglio in<strong>di</strong>rizzarli a Lui e gioire con<br />
Lui, lo troveremo ricolmo <strong>di</strong> letizia nella sua gloriosa risurrezione o nella<br />
trasfigurazione sul Tabor, e mirandolo in tanta gioia esulteremo con Lui. O<br />
quando saremo presi da sentimenti <strong>di</strong> tristezza, quando ci troveremo presi<br />
da affanni, trafitti dai dolori, per mantenere la perseveranza e incoraggiarci<br />
a soffrire in buon cuore con Lui, ecco lo troveremo in somma mestizia<br />
quando suda sangue nell‘orto, affannato sotto il peso della croce sulla via<br />
del calvario, ecc.<br />
Ugualmente se ci troveremo atterriti dal peso dei nostri peccati lo<br />
troveremo in atto <strong>di</strong> gran conforto, mirando come permette alla Maddalena<br />
che abbracci i suoi pie<strong>di</strong> ecc. E simili esempi per altri sentimenti.<br />
Per aiutarci in questo sarà molto vantaggioso procurarci una<br />
immagine o un ritratto del Signore che sia <strong>di</strong> nostro gusto per parlargli<br />
spesso, perché specialmente all‘inizio, quando non ci riuscirà tanto facile<br />
guardarlo con gli occhi dell‘anima, lo guarderemo spesso nella sua<br />
immagine con gli occhi del corpo e ciò servirà per imprimerci la sua<br />
amorosa figura nella nostra mente, in modo che dopo lo possiamo<br />
contemplare dentro <strong>di</strong> noi.<br />
115
L‘immagine deve essere piú che possibile <strong>di</strong> nostro gusto, senza,<br />
però dare risalto alla preziosità della materia, dell‘arte, della ricchezza cose<br />
che molte volte servono piuttosto a <strong>di</strong>strarre. Anche un buon libro sarà un<br />
buon rime<strong>di</strong>o per raccogliere il pensiero e fare una buona preghiera vocale.<br />
Infine, bisogna aiutarsi con tutti i mezzi che si possono avere. Pren<strong>di</strong>amo<br />
dunque l‘abitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> parlare con il Signore, perché il non trattare con una<br />
persona con cui abbiamo familiarità provoca una certa <strong>di</strong>sarmonia e un<br />
<strong>di</strong>stacco da lei.<br />
―Quello che potrete fare per aiuto <strong>di</strong> questo, è il procurare <strong>di</strong> avere<br />
un'immagine o ritratto <strong>di</strong> questo Signore, che sia a vostro gusto, non per<br />
portarlo solamente in seno e non mirare poi mai; ma per parlare spesso<br />
seco, che Egli vi suggerirà quello che avete da <strong>di</strong>rgli: se avete parole per<br />
parlare con altre persone, perché qui vi hanno da mancare per parlare con<br />
Dio? Non lo cre<strong>di</strong>ate: almeno io non ve le crederà, se lo prenderete in uso;<br />
che altrimenti purtroppo vi mancheranno; atteso che il non trattare con<br />
una persona cagiona una certa stranezza un non saper come parlar con lei,<br />
che pare non la conosciamo, benché sia parente; imperocché la parentela<br />
ed amicizia si perdono col mancamento della comunicazione.<br />
È bene, però, essere clementi con se stessi e attendere con<br />
pazienza ed umiltà che il Signore ci faccia questa grazia. Quin<strong>di</strong> è meglio<br />
che non si facciano sforzi nell‘immaginazione per procurare e mantenere la<br />
<strong>di</strong>vina presenza, sforzi i quali riuscirebbero dannosi e, invece <strong>di</strong> procurarla,<br />
impe<strong>di</strong>rebbero la devozione.<br />
Ci vuole un po‘ <strong>di</strong> avvertenza, naturale, tranquilla con la quale<br />
anche per brevissimo tempo volgiamo gli occhi dell‘anima nostra al nostro<br />
Divino Maestro‖.<br />
CAPITOLO VIII<br />
QUANTO SIA INTIMA LA NOSTRA UNIONE CON DIO<br />
È bello immaginarsi il Signore accanto a noi, ma beato colui se oltre<br />
la <strong>di</strong>vina presenza me<strong>di</strong>ante l‘immaginazione e il pensiero si trovasse<br />
veramente con Lui. Questa sarebbe veramente grande fortuna e vera<br />
compagnia del Signore. Ora, però, è bene sapere che se vogliamo possiamo<br />
trattenerci nella preghiera con Dio realmente presente. Questo non solo<br />
perché è accanto a noi o nel luogo dove preghiamo, ma perché è anche<br />
dentro <strong>di</strong> noi nel nostro cuore e nella nostra anima.<br />
―V‘importa molto l‘intendere questa verità, che Dio sta dentro <strong>di</strong><br />
voi e che quivi ce ne stiamo seco.... non ci immaginiamo vuote<br />
116
nell‘interiore.... che tegno per impossibile, se avessimo pensiero <strong>di</strong><br />
ricordarci che abbiamo un tale ospite dentro <strong>di</strong> noi, che ci dessimo tanto<br />
alle cose del mondo‖.<br />
Ci sono tre tipi <strong>di</strong> presenze: la prima è essenziale poiché non è<br />
solo presente in persone buone e sante, ma anche nelle tristi e peccatrici e<br />
in tutte le altre. La seconda è <strong>di</strong> grazia, per mezzo della quale Dio abita in<br />
noi, per cui chi ammette in sé la colpa grave la perde. La terza è per via <strong>di</strong><br />
spirituale pre<strong>di</strong>lezione, cioè Id<strong>di</strong>o fa provare un assaggio delle dolcezze del<br />
para<strong>di</strong>so. In questo caso lo Spirito Santo ammaestra l‘anima e la preghiera<br />
si sprigiona dal suo cuore <strong>di</strong> per se stessa fervida e fragrante a Dio Padre.<br />
Questa, però è dono <strong>di</strong> Dio e giunge a chi Dio vuole.<br />
Ci sono persone che non hanno questa unione con Dio, poiché<br />
troppo mondane e quin<strong>di</strong> non fanno abbastanza spazio a questo Dio<br />
desideroso <strong>di</strong> <strong>di</strong>morare in esse. Egli, però quantunque <strong>di</strong> mala voglia vi<br />
soggiorna segreto e non lo sentono se non quando gli dà dei momenti <strong>di</strong><br />
luce. Ma a quelle che sono arrivate a tale unione, e sentono la Divina sua<br />
presenza cosí dolce e necessaria all‘anima, Egli da altre gioie e saggi che<br />
sono solo del para<strong>di</strong>so. Se qualcuno è in stato <strong>di</strong> peccato, è inutile andare a<br />
cercare altrove il me<strong>di</strong>co, lo cerchi invece dentro <strong>di</strong> sé e quin<strong>di</strong> lo troverà<br />
<strong>di</strong>spostissimo al perdono. Anzi gli darà la forza <strong>di</strong> vincere le cattive<br />
abitu<strong>di</strong>ni e <strong>di</strong> presentarsi al confessionale per riconciliarsi con Dio e con gli<br />
uomini.<br />
―Ben conosceva io, che aveva anima; ma quello che meritasse<br />
quest‘anima e chi stesse dentro <strong>di</strong> lei non intendeva, perché mi bendava gli<br />
occhi con le vanità <strong>di</strong> questa vita, per non vederlo. A mio parere, se allora<br />
avessi inteso, come oggidí intendo, che questo piccolo palazzo dell‘anima<br />
mia capisse cosí gran Re, non l‘avrei tante volte lasciato solo; talora l‘avrei<br />
tenuto compagnia, me ne sarei io stata seco, e avrei procurato <strong>di</strong> non<br />
ritrovarmi tanto lorda‖.<br />
Teniamo frequente compagnia a quest‘ospite cosí generoso, che<br />
ha deciso <strong>di</strong> abitare in noi, non perché egli ha bisogno <strong>di</strong> noi, ma per<br />
sod<strong>di</strong>sfare il grande bisogno che abbiamo noi <strong>di</strong> Lui e per arricchirci <strong>di</strong><br />
ogni bene, e poi cerchiamo <strong>di</strong> tenere la casa, cioè l‘anima, pulita da ogni<br />
immondezza, cioè libera da ogni malizia e peccato.<br />
CAPITOLO IX<br />
117
COME POSSIAMO ESERCITARCI IN QUESTA DIVINA<br />
PRESENZA CON PIE CONTEMPLAZIONI<br />
L‘anima è la casa <strong>di</strong> Dio, poiché il Signore la riconosce come tale.<br />
Cosí nel Cantico dei Cantici Id<strong>di</strong>o si rallegra perché sta alla porta<br />
<strong>di</strong> questa casa e picchia: ―Io dormo, ma il mio cuore veglia. Questa è la<br />
voce del mio <strong>di</strong>letto che picchiando alla mia porta, <strong>di</strong>ce: Aprimi o mia<br />
sorella, mia amica, mia bella. E l‘anima, u<strong>di</strong>to il tocco della mano <strong>di</strong>vina,<br />
nonché, l‘affettuoso invito della sua voce, <strong>di</strong>ce: «mi son levata per aprire al<br />
mio <strong>di</strong>letto». E nuovamente nell'Apocalisse: «Ecco io sto alla porta e busso;<br />
chi ascolterà la mia voce e mi aprirà la sua porta, entrerò da lui, e cenerò<br />
con lui ed egli con me». Quin<strong>di</strong> l‘anima si deve considerare come casa del<br />
suo <strong>di</strong>letto Signore.<br />
Questa casa è anche da raffigurare tutta d‘oro con ornamenti <strong>di</strong><br />
preziosissime gemme; perché l‘anima deve essere vestita dell‘oro della<br />
carità e ricca <strong>di</strong> tutte le gemme delle altre virtú. Ora quali sentimenti e quale<br />
confusione può sorgere al vedere che la casa della nostra anima non è per<br />
nulla tutto oro <strong>di</strong> carità, né ricca delle perle preziose delle altre virtú, ma<br />
anzi piena <strong>di</strong> sozzure per tanti <strong>di</strong>fetti e peccati! Quali vivi desideri nasceranno<br />
in noi, <strong>di</strong> fare tutto il possibile per purificare, arricchire questa<br />
nostra casa, con cui accogliervi meno indegnamente un cosí grande<br />
Signore.<br />
Essa è anche giar<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Dio, che è custo<strong>di</strong>to da una salda cinta <strong>di</strong><br />
mura da ogni lato, per i molti mezzi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa che Cristo gli ha donato,<br />
affinché fosse protetta dai suoi nemici spirituali, che sempre cercano <strong>di</strong><br />
asse<strong>di</strong>arlo.<br />
In questo giar<strong>di</strong>no potremo osservare il Signore che si compiace<br />
dei suoi frutti e fiori. Ora, però, se avessimo questo giar<strong>di</strong>no incusto<strong>di</strong>to,<br />
arido e sterile, a causa della nostra ingratitu<strong>di</strong>ne e freddezza, quanta ragione<br />
avremo <strong>di</strong> confonderci e <strong>di</strong> pregare con cuore ardente questo giar<strong>di</strong>niere<br />
perché con la sua infinita misericor<strong>di</strong>a voglia rime<strong>di</strong>are ai tanti danni del<br />
suo orto.<br />
Essa viene definita da S. Gregorio Magno, cielo <strong>di</strong> Dio, infatti<br />
afferma cosí: «<strong>di</strong>ce il Signore: il cielo è la mia sede; e Salomone <strong>di</strong>ce:<br />
l‘anima del giusto è la sede della sapienza. Paolo poi chiama Cristo la virtú<br />
<strong>di</strong> Dio, la sapienza <strong>di</strong> Dio; perciò è da concludere, che se Dio è la stessa<br />
sapienza e l‘anima del giusto è la sede della sapienza, mentre il cielo è da<br />
chiamare sede <strong>di</strong> Dio, l‘anima del giusto deve essere considerata come un<br />
cielo». L‘anima è anche tempio <strong>di</strong> Dio, come <strong>di</strong>ce S. Paolo. Quin<strong>di</strong> deve<br />
essere un tempio ricco, grazioso e bene adorno, dove non cessano le<br />
preghiere, i ringraziamenti e le lo<strong>di</strong> a Dio. Quin<strong>di</strong> piangiamo ed umiliamoci<br />
118
per le nostre colpe, se troveremo che la nostra anima è un tempio misero e<br />
angusto. Essa si può paragonare anche al cuore, perché come dal cuore<br />
procede la vita del corpo e mancando il cuore, subito manca la vita; cosí<br />
mancando a lei la presenza amorosa del suo Signore, subito resterebbe<br />
morta alla grazia <strong>di</strong> Dio.<br />
Queste contemplazioni si potranno fare <strong>di</strong> tempo in tempo,<br />
quando siamo <strong>di</strong>sposti. Sarà anche bene animare questa fede della presenza<br />
<strong>di</strong> Dio in noi quando dobbiamo occuparci del nostro corpo, secondo la<br />
<strong>di</strong>vina volontà; come sarebbe il mangiare, il bere, il riposare ecc., ma non<br />
per dare gusto a noi, ma a Dio che è in noi.<br />
È però da osservare che non si devono fare sforzi per trattenersi<br />
in queste contemplazioni, quando non ci si presentano con pace e<br />
spontaneità; quando non si è <strong>di</strong>sposti si continui la preghiera, ricordando <strong>di</strong><br />
quando in quando che questa si sta facendo con Dio‖.<br />
CAPITOLO X<br />
STRATEGIE PER ACQUISTARE IL SENTIMENTO DELLA<br />
INTERIORE DIVINA PRESENZA<br />
La prima attenzione sta nell‘esercizio, della memoria, ricordandoci<br />
spesso che Dio è con noi, anzi dentro <strong>di</strong> noi. Noi non proviamo nessuna<br />
<strong>di</strong>fficoltà nel pensare che nel nostro petto ci sia il cuore, che ci dà vita,<br />
battendo in<strong>di</strong>pendentemente dalla nostra volontà. Egli, però, non vuole<br />
vivificare la nostra anima in<strong>di</strong>pendentemente dalla nostra volontà, come il<br />
cuore vivifica il corpo; e perciò la memoria <strong>di</strong> Lui è sommamente<br />
necessaria alla salute dell‘anima, questo ci permetterà <strong>di</strong> stare piú in<br />
armonia e attenti a Lui, senza voltarg1i le spalle. Ciò è quanto possiamo<br />
fare, naturalmente con l‘aiuto della <strong>di</strong>vina grazia, perché l‘avere particolari<br />
sentimenti della presenza interiore <strong>di</strong> Dio, è cosa che <strong>di</strong>pende totalmente<br />
da Lui; e tali sentimenti ce li darà, quando crederà opportuno.<br />
―Conchiudo, che chi vorrà conseguire questo buon modo <strong>di</strong><br />
raccoglimento (poiché <strong>di</strong>co sta con l‘aiuto <strong>di</strong> Dio in poter nostro) non si<br />
stanchi da avvezzarsi a quello che si è detto, perché è un impadronirsi a<br />
poco a poco <strong>di</strong> se stesso; non perdendosi in libertà indarno, anzi<br />
guadagnando sé a sé medesimo, cioè a valersi dei suoi sentimenti per le<br />
cose interiori. Se parlerà, procurerà ricordarsi che ha con chi parlare dentro<br />
<strong>di</strong> se stesso; se ascolterà, ha da pensare che deve u<strong>di</strong>re chi piú da presso gli<br />
parla. Insomma, far conto che può, se vuole, non allontanarsi da sí buona<br />
compagnia e dolersi quando per molto tempo ha lasciato solo suo padre, <strong>di</strong><br />
119
cui ha tanta necessità. Se potrà farlo molte volte al giorno, lo faccia; se non,<br />
almeno poche, che quando prenderà in costume, ne riuscirà con guadagno,<br />
o presto o un poco piú tar<strong>di</strong>.<br />
Tutto questo può sembrare oscuro, ma non c‘è da preoccuparsi,<br />
basterà ricordarsi <strong>di</strong> essere con Dio e non <strong>di</strong>strarsi volontariamente. Il<br />
Signore vedendo che uno cerca tale attenzione (sempre senza sforzo e con<br />
pace), gli darà i1 desiderato raccoglimento, sebbene non capisce e le paia<br />
molto oscuro quanto si <strong>di</strong>ce.<br />
Non è perciò da sospettare che questo non intendere provenga da<br />
rozzezza da una mancanza <strong>di</strong> intelletto; qui il non intendere proviene da<br />
mancanza <strong>di</strong> esperienza. È da notare, infatti che per capire certe cose <strong>di</strong><br />
preghiera non c‘è bisogno <strong>di</strong> un grande intelletto. Il buono e fine intelletto<br />
è dono <strong>di</strong> Dio, non è per niente necessario per pregare bene. Esso è<br />
necessario per parlare con gli uomini, ma non è necessario per parlare bene<br />
con Dio. Per parlare bene con Dio è necessario il buon desiderio e non si<br />
pretende <strong>di</strong> piú. Quin<strong>di</strong> è bene ricordarci sempre o qualche volta, che Dio<br />
è in noi. Il che vuol <strong>di</strong>re che quando si è presi dalle cose quoti<strong>di</strong>ane e ci<br />
<strong>di</strong>mentichiamo <strong>di</strong> Dio, dovremmo umilmente domandargli scusa per la<br />
nostra scortesia.<br />
Un‘altra accortezza è quella <strong>di</strong> impegnarci con molto zelo a tenere<br />
la nostra anima ben pulita e sgombra da tutte le giustificazioni dagli<br />
attaccamenti materiali e dagli attaccamenti alle cose terrene che sono<br />
d‘impe<strong>di</strong>mento e d‘ingombro alla pienezza della presenza <strong>di</strong>vina.<br />
Quando preghiamo sarà buona cosa il chiudere gli occhi per<br />
meglio raccogliersi in se stessi. Questo può sembrare una cosa minuziosa e<br />
<strong>di</strong> poca importanza dato che si può pregare anche con gli occhi aperti<br />
specialmente quando non si sanno le preghiere a memoria, ma dato che si<br />
ha bisogno <strong>di</strong> concentrarsi sarà bene che la vista interiore non sia<br />
<strong>di</strong>sturbata da quella esteriore‖.<br />
CAPITOLO XI<br />
I BENI CHE DERIVANO DA QUESTO GENERE<br />
DI PREGHIERA<br />
È molto importante questo esercizio <strong>di</strong> preghiera per una persona<br />
«naturalmente» <strong>di</strong>stratta; infatti quel guardare in fede dentro <strong>di</strong> noi il<br />
Signore, sarà molto efficace per non lasciarsi <strong>di</strong>strarre dalle cose mondane.<br />
Comportiamoci con Dio come con un Padre, un fratello, uno sposo.<br />
120
Ditegli che è per voi molto importante il fatto che Egli è dentro <strong>di</strong> voi, ed<br />
egli vi insegnerà cosa dovete fare per essere piú in armonia con Lui.<br />
In questo modo avrete una piú facile familiarità con Dio, tanto<br />
che Egli non si <strong>di</strong>staccherà mai da noi se noi non vorremmo <strong>di</strong>staccarci da<br />
Lui. Perciò in questa preghiera <strong>di</strong> interno raccoglimento faremo maggior<br />
cammino in minor tempo facilmente impareremo a riempire <strong>di</strong> Dio le<br />
potenze dell‘anima, cioè l‘intelletto, la memoria e la volontà e, quasi<br />
liberandoci dai sentimenti esteriori, che si pascono nelle vanità del mondo,<br />
eserciteremo gli interiori, che si pascono nei vari beni <strong>di</strong> Dio.<br />
È da considerare che le potenze dell‘anima sono cosí profonde<br />
che come <strong>di</strong>ce San Giovanni della Croce non si riempiono neanche con<br />
l‘infinito. Il nostro intelletto non può essere contento se non ripieno della<br />
luce <strong>di</strong> Dio; la nostra memoria non può essere compensata, se non ripiena<br />
della presenza <strong>di</strong> Dio; la nostra volontà non può essere sod<strong>di</strong>sfatta se non<br />
ripiena del suo amore.<br />
È anche utile considerare che l‘uomo ha due specie <strong>di</strong> sensi: quelli<br />
esteriori e quelli interiori. I sensi esteriori hanno per oggetto le cose<br />
materiali da cui vengono appagati. I sensi interiori hanno per oggetto la<br />
<strong>di</strong>vinità dalla cui contemplazione sono nobilitati. E come nel corpo, anche<br />
nell‘anima le percezioni avvengono per mezzo dei sensi interiori.<br />
È nella bibbia che abbiamo un opportuno riscontro: ―vedete che<br />
io sono Dio‖, ―chi ha orecchie ascolti cosa <strong>di</strong>ce lo Spirito‖, ―gustate e<br />
vedete come è soave il Signore‖, ―voi siete il buon odore <strong>di</strong> Cristo‖, e<br />
Cristo <strong>di</strong>sse <strong>di</strong> essere toccato piú con la fede che con le mani della donna<br />
che ricorreva a Lui per essere sanata dal flusso <strong>di</strong> sangue. Quin<strong>di</strong> per<br />
mezzo dei sensi dello spirito si ha esperienza delle cose spirituali.<br />
Esercitandoci nella preghiera avremo facilmente l‘interiore raccoglimento<br />
con Dio, anche se all‘inizio si prova <strong>di</strong>fficoltà nel raccogliere e concentrare<br />
in Dio i propri sentimenti.<br />
―È necessario fare molta attenzione su queste parole perché le<br />
persone quando cominciano ad avere preghiera <strong>di</strong> raccoglimento le sembra<br />
cosí poca cosa che non si avverte <strong>di</strong> averla e non la conosce; quando poi il<br />
raccoglimento cresce, allora <strong>di</strong>viene sensibile e tanto piú sensibile quanto è<br />
maggiore‖.<br />
Le persone che si danno alla preghiera sono favorite dalla grazia<br />
del raccoglimento prima che se ne accorgano. La comprensione <strong>di</strong> queste<br />
cose avviene solo attraverso l‘esperienza vitale ed essa esige da noi una<br />
buona dose <strong>di</strong> preparazione ed attenzione. La possibilità <strong>di</strong> riuscire, come<br />
si è visto, è nelle nostre mani, l‘effetto invece è nelle mani del Signore, che<br />
lo darà come e quando vorrà e in quella misura che a lui parrà meglio.<br />
Tutto questo ci farà guardare in fede dentro <strong>di</strong> noi il nostro Signore e ci<br />
121
tratterà alla sua presenza e troveremo la nostra mente occupata da santi<br />
pensieri.<br />
Qualcuno potrebbe pensare che la preghiera <strong>di</strong> raccoglimento sia<br />
solo per quelle persone che non riescono a fare me<strong>di</strong>tazione regolarmente,<br />
ma essa è utile anche per chi ha capacità <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tare. Queste persone<br />
faranno bene ogni tanto a fermare quel loro tipo <strong>di</strong> preghiera e mettersi<br />
davanti al Signore per ammirarlo nella fede e trattenersi con Lui<br />
amorosamente e familiarmente e per confidargli i propri bisogni.<br />
Novizi: Giovanni Passaro fsmi<br />
Enrico Spano fsmi<br />
TRACCE DI SPIRITUALITÀ<br />
122
nella vita e nelle opere del<br />
Venerabile Giuseppe Frassinetti<br />
Poiano – Verona<br />
Noviziato 1992/3<br />
PRESENTAZIONE<br />
Con decreto del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II datato 14<br />
maggio 1991, la Congregazione per le Cause dei Santi ha riconosciuto al<br />
Servo <strong>di</strong> Dio Don Giuseppe Frassinetti l‘eroicità delle virtú.<br />
Per i «<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>», che ne hanno ere<strong>di</strong>tato e ne continuano il<br />
carisma, e per quanti sono uniti al Frassinetti dai vincoli della storia e da<br />
quelli dello Spirito, continuare a promuovere la conoscenza dell‘opera e<br />
della personalità del Fondatore, è un imperativo dell‘amore e della<br />
riconoscenza che a lui li lega.<br />
Parlare <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti oggi vuol <strong>di</strong>re riscoprire la sua<br />
straor<strong>di</strong>naria figura <strong>di</strong> sacerdote, l‘uomo <strong>di</strong> Dio e il pastore d‘anime;<br />
significa ricollocarne le opere e gli scritti in una prospettiva storica che i<br />
moderni criteri d‘indagine possono aiutarci a ricostruire con atten<strong>di</strong>bilità;<br />
vuol <strong>di</strong>re scandagliare le ragioni del suo pensiero e del suo apostolato e<br />
ritradurne per i nostri tempi la sorprendente attualità; significa riconoscere<br />
in lui l‘impronta dello Spirito Santo e farci interpreti e <strong>di</strong>vulgatori <strong>di</strong> una<br />
forza carismatica che attraverso il suo operato brilla nella Chiesa.<br />
I brevi saggi che seguono si propongono <strong>di</strong> mettere in luce<br />
qualche spunto che sia stimolo per una riflessione ulteriore.<br />
Emergono da questi lavori solo alcuni tratti salienti della vita, della<br />
spiritualità e della pastorale frassinettiana: dall‘indagine sui suoi rapporti<br />
con la sorella <strong>Santa</strong> Paola scaturisce la ricchezza <strong>di</strong> una fraternità vissuta<br />
interamente al servizio del Signore, e si leggono in essa le colonne portanti<br />
<strong>di</strong> un amore alla vita consacrata, <strong>di</strong> uno zelo ardentissimo per la cura dei<br />
giovani e delle ragazze e <strong>di</strong> una particolare sensibilità per il problema<br />
vocazionale, che hanno lasciato i loro segni vivi nel tempo; analogamente,<br />
stu<strong>di</strong>are la profetica concezione dell‘apostolato laicale, cosí come fu<br />
pensata e attuata dal Frassinetti, implica una riflessione sulla opportunità<br />
della consacrazione dei laici e sulle eventuali modalità <strong>di</strong> una loro piú<br />
stretta comunione spirituale e collaborazione pastorale con i F.S.M.I.;<br />
l‘illustrazione e il commento del «Convito del Divino Amore» illumina un<br />
123
aspetto essenziale della spiritualità frassinettiana: l‘amore e la devozione<br />
all‘Eucaristia, e sottolinea quel senso profondo del Mistero e dell‘Incontro<br />
che fecero del Venerabile un vero apostolo della Comunione frequente;<br />
infine, prestare attenzione al Frassinetti pre<strong>di</strong>catore e al suo magistero della<br />
Parola, ci aiuta a focalizzare la sua identità <strong>di</strong> pastore impegnato<br />
nell‘istruzione nelle cose <strong>di</strong> Dio, nell‘educazione all‘ascolto e nella<br />
santificazione del popolo a lui affidato, <strong>di</strong> tutto il popolo, attraverso<br />
l‘incontro con Cristo Parola <strong>di</strong> Vita; frutto, questo, <strong>di</strong> una consuetu<strong>di</strong>ne<br />
personale vissuta nella fede e trasmessa con l‘ardore dell‘esperienza.<br />
Consapevoli della loro limitatezza e non esaustività, offriamo i<br />
nostri piccoli contributi ai cari confratelli, ai parenti, agli amici, ai<br />
collaboratori e ai simpatizzanti: il Buon Dio ci conceda <strong>di</strong> esserne arricchiti<br />
interiormente secondo la Sua Volontà.<br />
I Novizi<br />
LA CONSACRAZIONE DEI LAICI<br />
124
SOMMARIO<br />
Premessa<br />
Capitolo primo<br />
La laica consacrata<br />
Capitolo secondo<br />
Il laico consacrato<br />
Capitolo terzo<br />
Le Missionarie <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong><br />
Capitolo quarto<br />
La seconda Congregazione<br />
Capitolo quinto<br />
Conclusione generale<br />
Bibliografia<br />
PREMESSA<br />
La Consacrazione dei laici è qualcosa a cui siamo abituati, infatti<br />
molti Istituti Religiosi Secolari sono sorti riempiendo un grande vuoto nella<br />
presenza tra<strong>di</strong>zionale dei consacrati; non è un modo ma un dono del<br />
Signore alla sua Chiesa pellegrina nel tempo.<br />
Ciò che oggi constatiamo è il frutto dello zelo pastorale e<br />
dell‘intuizione profetica <strong>di</strong> pastori, che attenti alle necessità, seppero<br />
presentare ai fedeli i beni spirituali necessari per vivere ra<strong>di</strong>calmente la<br />
chiamata del Signore alla perfezione evangelica.<br />
Analizzando il suo tempo Frassinetti scriveva: ―I costumi, le<br />
opinioni, le leggi mai sono state cosí concor<strong>di</strong> in tante parti del mondo<br />
come lo sono ora, nel porre ostacoli perché gli uomini non possano<br />
condurre una vita religiosa nelle comunità approvate dalla Chiesa‖.<br />
Sia l‘operetta «La monaca in casa» (1859), come «Il religioso al<br />
secolo» (1864) avevano come scopo dare un sicuro fondamento e <strong>di</strong>rezione<br />
agli uomini e alle donne che volevano consacrare la loro vita senza lasciare<br />
«il mondo».<br />
Esamineremo brevemente queste due opere del Servo <strong>di</strong> Dio<br />
Giuseppe Frassinetti, con le Costituzioni dell‘Istituto Secolare delle<br />
Missionarie <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> e il progetto <strong>di</strong> Statuto della<br />
Seconda Congregazione.<br />
CAPITOLO I<br />
125
LA LAICA CONSACRATA<br />
1 A chi si rivolge.<br />
―<strong>Figli</strong>a cristiana, che ascolti una voce interiore che ti invita a<br />
separarti dalle cose create per unirti piú intimamente al tuo Creatore, figlia<br />
cristiana che senti una santa invi<strong>di</strong>a per quelle giovani che vivono nel<br />
convento o in una casa religiosa, che desideri essere religiosa ma per<br />
<strong>di</strong>verse ragioni non puoi e sei costretta a rimanere nel mondo, io mi<br />
in<strong>di</strong>rizzo a te per istruirti e consolarti nel tuo desiderio ed afflizione, per<br />
<strong>di</strong>rti che puoi consacrarti al Signore anche vivendo a casa tua.<br />
Potrà sembrarti una cosa strana vivere nel mondo come se ne<br />
fossi separata, però con l‘aiuto della grazia <strong>di</strong>vina mi propongo <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>mostrarti che questo è possibile e facile‖.<br />
2. Che significa essere laica consacrata.<br />
Essere laica consacrata significa vivere nella propria casa, nella<br />
propria famiglia, senza nessun affetto <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato fuori misura: praticare i<br />
consigli evangelici ed avere come scopo la perfezione cristiana, la santità<br />
perfetta.<br />
Significa consacrare a Dio tutta la propria persona, anima e corpo,<br />
in modo tale che si viva solo per Lui, e non vivere se non per dargli gloria,<br />
gusto e onore.<br />
3. Desiderio <strong>di</strong> perfezione<br />
Per poter raggiungere la perfezione sono necessari: la volontà, lo<br />
sforzo, l‘impegno personale: è necessario desiderarla.<br />
Questo desiderio implica <strong>di</strong> vivere solo per Dio, non desiderare le<br />
cose del mondo ed usare <strong>di</strong> esse solo per quanto è necessario. Sforzarsi <strong>di</strong><br />
purificarsi <strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>fetti spirituali per attirare l‘amore del Signore Gesú<br />
Cristo, per essere degne <strong>di</strong> presentarsi davanti a Lui in qualsiasi momento<br />
Egli <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> chiamarvi.<br />
In questo consistono tutti i desideri e le aspirazioni della vera<br />
consacrata, ed in questo, se volete essere tali, dovete accentrare tutti i<br />
desideri del vostro cuore.<br />
4. I consigli evangelici<br />
a) Povertà<br />
La pratica <strong>di</strong> questo consiglio evangelico è <strong>di</strong> massima importanza,<br />
perché solo un cuore realmente <strong>di</strong>staccato dalle cose del mondo è <strong>di</strong>sposto<br />
all‘unione con Dio.<br />
126
È libera dalle cose del mondo una persona, che anche se ne ritiene<br />
il dominio le usa per la gloria <strong>di</strong> Dio ed è <strong>di</strong>sposta a rinunciarvi e a<br />
privarsene ogni volta che l‘amore a Dio lo richieda. Però è piú libera, quella<br />
persona che rinuncia assolutamente a quanto possiede, non mantenendo<br />
per sé nessun possesso.<br />
Per quanto ti è permesso dai tuoi genitori incomincia a vestire<br />
modestamente, scegliendo abiti poco costosi; lo stesso comportamento<br />
devi avere per i mobili e le suppellettili della casa, eliminando, per quanto è<br />
possibile, ogni cosa superflua o <strong>di</strong> valore.<br />
b) Obbe<strong>di</strong>enza<br />
Per le cose che si riferiscono allo spirito devi obbe<strong>di</strong>re al tuo<br />
<strong>di</strong>rettore spirituale, nelle cose temporali devi obbe<strong>di</strong>re ai tuoi genitori e alle<br />
persone che ti sono preposte.<br />
Il primo grado <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza esige che ti sottometta agli or<strong>di</strong>ni<br />
legittimi dei tuoi superiori. Il secondo grado, è molto piú alto ed esige che<br />
tu obbe<strong>di</strong>sca non solo ai loro or<strong>di</strong>ni ma anche ai loro desideri e consigli e<br />
non solo ai desideri e consigli dei tuoi superiori ma anche degli eguali.<br />
Ti devi esercitare sempre nella mortificazione interiore e vedrai<br />
che non ti mancherà la pazienza necessaria e accetterai questo con molto<br />
merito. Ti raccomando che non ti inquieti mai per gli or<strong>di</strong>ni che ti danno<br />
per quanto ti sembrino capricciosi e in<strong>di</strong>screti, essi non superano il <strong>di</strong>sagio<br />
che ti produce la sottomissione alle persone <strong>di</strong> casa nonostante che le senti<br />
pesanti e irrazionali.<br />
Ogni volta che puoi fare un atto <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza a qualcuno, fallo<br />
sempre <strong>di</strong> buon cuore, per far piacere a Dio.<br />
c) Castità<br />
Devi proporti <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>re e conservare la santa verginità in modo<br />
angelico. Tu, figlia, non sei un angelo, però senza dubbio ti devi proporre<br />
<strong>di</strong> vivere come un angelo. Se la tua verginità e la tua castità devono essere<br />
angeliche e niente <strong>di</strong> meno <strong>di</strong> questo, ciò è possibile con la grazia <strong>di</strong> Dio<br />
Onnipotente.<br />
Se ti proponi <strong>di</strong> osservare la castità ed anche fai voto <strong>di</strong><br />
conservarla perfetta, fai un grande piacere al Signore e si compiace del tuo<br />
dono preziosissimo. D‘altra parte questo voto è necessario per te, cosí sarai<br />
irrevocabilmente sposa del Signore e per ciò stesso, sposa vera nel<br />
significato del termine.<br />
Per fare questo voto è necessaria l‘approvazione del tuo <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale, e per questo, anche se ti senti ispirata <strong>di</strong> farlo, devi ottenere il<br />
suo permesso.<br />
5. Altre virtú<br />
127
a) Umiltà<br />
Come è certo che nei tre consigli evangelici c‘è la sostanza della<br />
vita religiosa, cosí è certo che nessuno arriverà mai a praticarli come<br />
conviene, senza l‘aiuto <strong>di</strong> altre virtú <strong>di</strong> cui la fondamentale è l‘umiltà.<br />
Di questa grande virtú, l‘umiltà, se ne parla tanto ma senza dubbio<br />
la maggioranza ne capisce molto poco. Non c‘è in terra né libro né maestro<br />
che possa insegnare la vera umiltà, lo può insegnare lo Spirito Santo, ed<br />
anche Lui stesso deve infonderla nei cuori.<br />
Allora devi incominciare a pregare fervorosamente il Signore<br />
perché te la conceda, costi quel che costi, a <strong>di</strong>spetto del nostro amor<br />
proprio, e <strong>di</strong>co costi quel che costi, perché se cerchi la vera umiltà devi<br />
deciderti <strong>di</strong> sacrificare senza pietà il tuo orgoglio.<br />
b) Abbandono in Dio<br />
Se desideri aspirare alla perfezione autentica che si ad<strong>di</strong>ce ad<br />
un‘anima <strong>di</strong>staccata dal mondo, devi ricordare le parole che il Signore <strong>di</strong>sse<br />
a <strong>Santa</strong> Caterina da Siena. ―Caterina, pensa a me che io penserò a te‖.<br />
Perciò cercherai <strong>di</strong> vivere senza preoccupazioni e ansietà per le<br />
cose del mondo, convinta che se servi bene il Signore, Egli non permetterà<br />
che ti manchi alcunché <strong>di</strong> necessario.<br />
Non puoi immaginare come si compiace il Signore <strong>di</strong> una creatura<br />
che si abbandona totalmente nelle sue mani e non ha altro pensiero se non<br />
<strong>di</strong> farlo contento. Puoi pensare: per far questo devo vivere in un monastero<br />
dove la comunità si occupa <strong>di</strong> tutto, invece una laica che vive nel mondo<br />
deve pensare in tutto o in parte al suo mantenimento materiale.<br />
Hai ragione, ma io ti <strong>di</strong>co <strong>di</strong> vivere senza preoccupazioni ed<br />
ansietà non <strong>di</strong> mancare ai tuoi doveri; procurarti il necessario per vivere è<br />
un tuo dovere: non saresti nel giusto se la pensassi in altro modo. Se <strong>di</strong>co<br />
che pensi a Dio perché Dio penserà a te, non ti voglio <strong>di</strong>re <strong>di</strong> stare a<br />
visitare le chiese dal mattino alla sera, <strong>di</strong> stare sempre con i libri <strong>di</strong><br />
preghiere aperti, sperando che Dio miracolosamente ti manda il necessario,<br />
o che preten<strong>di</strong> <strong>di</strong> vivere <strong>di</strong> elemosina mentre ti puoi mantenere con il tuo<br />
lavoro. Se ti comportassi cosí la tua pietà sarebbe falsa, per niente gra<strong>di</strong>ta<br />
agli occhi <strong>di</strong> Dio e poco e<strong>di</strong>ficante agli occhi degli uomini.<br />
La pietà è sempre falsa se non è unita al compimento dei propri<br />
doveri; te lo ripeto: è tuo dovere guadagnarti il necessario se Dio ti ha<br />
posto in situazione <strong>di</strong> farlo.<br />
Dire che tu ti abbandoni nelle mani <strong>di</strong> Dio senza preoccupazioni o<br />
ansietà significa che non consideri calcoli inutili e inopportuni come<br />
sarebbe pensare al tuo futuro, nella tua vecchiaia e lasciarti impaurire. Il<br />
Signore sa provvedere e si occuperà delle tue necessità in una forma che<br />
ora non puoi prevedere.<br />
128
6. Un metodo <strong>di</strong> vita<br />
Le religiose nelle loro comunità hanno un metodo <strong>di</strong> vita che è<br />
importante per la loro santificazione: è un metodo, cioè, una regolarità <strong>di</strong><br />
vita per la quale tutto il giorno ha un suo orario. La preghiera, il lavoro, i<br />
pasti, il sonno, la ricreazione, ogni cosa a suo posto, niente <strong>di</strong>pende dal<br />
capriccio, tutto con sapienza e buon or<strong>di</strong>ne: questo serve moltissimo<br />
perché la vita scorra serena, in pace e piena <strong>di</strong> buone opere.<br />
Tu che desideri consacrarti in casa ugualmente devi avere questo<br />
atteggiamento delle religiose che vivono in comunità. In ogni comunità<br />
religiosa c‘è un metodo <strong>di</strong>verso, perciò ogni consacrata avrà un metodo<br />
adatto alla sua con<strong>di</strong>zione. Importante è avere un metodo adatto e<br />
conveniente al tuo stato. Perché sia stabilito con prudenza e non ti venga<br />
meno il merito dell‘obbe<strong>di</strong>enza, è importante stabilirlo con il <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale, che saprà considerare le tue necessità e capacità.<br />
Tuttavia ti espongo uno schema che potrai utilizzare come<br />
modello:<br />
1. Dormire sei o sette ore, questo è sufficiente a meno che non hai<br />
altre necessità per la tua salute.<br />
2. Avere ogni mattino un tempo per la preghiera in casa o in<br />
chiesa, piú o meno lunga, mentale o vocale, in accordo con il tuo <strong>di</strong>rettore.<br />
3. Se possibile partecipare quoti<strong>di</strong>anamente alla <strong>Santa</strong> Messa.<br />
4. Fare un po‘ <strong>di</strong> lettura spirituale.<br />
5. De<strong>di</strong>care al lavoro tutto il tempo necessario: occuparlo con<br />
allegria, come se fosse la preghiera piú devota, pensando che con il lavoro<br />
fai la volontà <strong>di</strong> Dio, amato sia quando lavori come quando preghi.<br />
6. Durante il giorno mantenersi alla presenza del Signore con<br />
giaculatorie <strong>di</strong> amore o <strong>di</strong> offerta.<br />
7. Pregare una terza parte del rosario, se puoi in un tempo adatto<br />
altrimenti durante il lavoro.<br />
8. Fare la sera l‘esame <strong>di</strong> coscienza.<br />
9. Confessarsi ogni quin<strong>di</strong>ci giorni o ogni mese.<br />
10. Ogni sabato fare una mortificazione in onore della Santissima<br />
Vergine, d‘accordo con il tuo <strong>di</strong>rettore spirituale.<br />
7. Avere il confessore o il <strong>di</strong>rettore spirituale.<br />
Il <strong>di</strong>rettore spirituale può essere <strong>di</strong>stinto dal confessore: una<br />
persona si può far guidare da un maestro <strong>di</strong> spirito mentre si confessa da<br />
un altro. Però normalmente è la stessa persona cosí in queste riflessioni<br />
parlando <strong>di</strong> uno intendo parlare anche dell‘altro.<br />
129
Normalmente è il vescovo che nomina il confessore <strong>di</strong> una casa<br />
religiosa, tiene conto della pietà e della capacità <strong>di</strong> lui: nella stesso modo e<br />
con gli stessi criteri, è cosa buona che tu scelga un confessore per te.<br />
Ti devi convincere che per te un buon confessore è un grande<br />
dono <strong>di</strong> Dio. Se dunque non ce l‘hai ancora, devi incominciare a chiederlo<br />
nella preghiera, chiedendo a Dio con fede, perseveranza e confidenza,<br />
come si deve fare quando si chiedono grazie importanti. Desidero che ti<br />
convinca della necessità <strong>di</strong> un buon <strong>di</strong>rettore, perché questa convinzione ti<br />
renderà piú insistente nell‘orazione e ti impegnerà a fare una buona scelta.<br />
Credo che un buon <strong>di</strong>rettore spirituale non è sostituibile da niente,<br />
sebbene uno abbia buoni desideri e legga molti libri.<br />
È compito del <strong>di</strong>rettore spirituale dare le in<strong>di</strong>cazioni e le regole<br />
particolari, applicando le norme generali per ogni persona. Dico che<br />
«normalmente» perché in caso <strong>di</strong> impossibilità, Dio sa trovare il modo per<br />
donare la sua sapienza, attraverso persone anche me<strong>di</strong>ocri.<br />
Devi manifestargli le tue buone intenzioni e la tua volontà <strong>di</strong><br />
consacrarti al Signore: solo partendo da questo potrà suggerirti ciò che ti è<br />
necessario per la tua santificazione.<br />
8. Conclusione<br />
Mi sembra <strong>di</strong> averti <strong>di</strong>mostrato come si può vivere con semplicità<br />
e facilità come consacrata in casa e come si può raggiungere la perfezione<br />
desiderata.<br />
Animo, dunque per vincere tutti gli ostacoli e le <strong>di</strong>fficoltà che ti<br />
procurerà il tuo amor proprio, il mondo e il demonio: sii costante e <strong>di</strong><br />
giorno in giorno crescerà il buon proposito, va avanti senza arrenderti.<br />
Vedrai alla fine come si coronerà degnamente questo inizio.<br />
Cre<strong>di</strong> alle mie parole, ho visto molte ragazze impegnarsi per il<br />
Signore con cuore <strong>di</strong>sposto con l‘intenzione <strong>di</strong> giungere all‘amore perfetto<br />
<strong>di</strong> Lui e non ho visto mai nessuna che, desiderandolo, non abbia potuto<br />
superare le tentazioni e le <strong>di</strong>fficoltà dei suoi nemici; ho visto sempre che,<br />
ognuna, quanto piú andava avanti, tanto piú cresceva nel suo santo<br />
desiderio; e non ne ho incontrato nessuna che abbia desiderato tornare<br />
in<strong>di</strong>etro, nemmeno per un attimo. Le stesse spine che Dio permetteva che<br />
nel cammino della perfezione crescessero sotto i suoi pie<strong>di</strong>, le servivano<br />
come stimolo per farle correre piú rapidamente verso al meta desiderata.<br />
Prova e vedrai.<br />
CAPITOLO II<br />
IL LAICO CONSACRATO<br />
130
1. Chi è un laico consacrato?<br />
Dal titolo si capisce che non parliamo del religioso che professa la<br />
vita spirituale in or<strong>di</strong>ni o istituti religiosi approvati dalla Chiesa. Qui si parla<br />
in generale dell‘uomo religioso laico, che vive nel mondo, rimanendo nello<br />
stato in cui la Divina Provvidenza lo ha posto.<br />
2. Mezzi per raggiungere una vita spirituale<br />
Per facilitare la via alla quale aspira, il laico consacrato si adopererà<br />
a spogliarsi dell‘ambizione <strong>di</strong> possedere, <strong>di</strong> essere onorato, <strong>di</strong> essere stimato<br />
dagli uomini, della ricerca dei piaceri mondani e da tutto quello che lo può<br />
allontanare dal suo unico desiderio.<br />
Nella vita spirituale ci sono situazioni che possono <strong>di</strong>strarci e<br />
rallentarci.<br />
«Fiat voluntas tua», non cerchiamo niente delle cose temporali o<br />
spirituali, solamente la Grazia <strong>di</strong> Dio e fare la sua santa volontà, alzando in<br />
alto la sua santa Croce che è il miglior simbolo del suo immenso amore.<br />
3. Offerta quoti<strong>di</strong>ana<br />
Significa offrire tutto se stesso e tutto quello che l‘uomo fa<br />
quoti<strong>di</strong>anamente, affinché il Signore <strong>di</strong>sponga assolutamente <strong>di</strong> tutto<br />
secondo la sua volontà.<br />
Per fare questa offerta come si deve, sarà necessario considerare<br />
con fede viva che tutto quello che siamo e tutto quello che abbiamo, tutto<br />
è <strong>di</strong> Dio, in modo che non abbiamo attaccamento né a noi stessi né alle<br />
nostre cose, solo Lui è padrone e Signore.<br />
Dobbiamo considerare che in questo servizio a Dio, risiede tutto il<br />
nostro bene, cosí è anche questa la finalità per la quale siamo stati creati.<br />
4. Procurare la gloria <strong>di</strong> Dio<br />
Chi ama procura <strong>di</strong> fare piacere all‘amato, perciò il laico<br />
consacrato deve essere amante e grande amante <strong>di</strong> Dio, e cercherà <strong>di</strong> fare<br />
piacere al Signore e procurargli la sua gloria.<br />
Il laico consacrato deve essere <strong>di</strong>staccato dalle cose del mondo ed<br />
avere una perfetta adesione alla volontà <strong>di</strong>vina per vivere solo per Lui.<br />
Come dunque non dovrà sforzarsi <strong>di</strong> procuragli gloria?<br />
Come potrà vivere solo per Lui, senza desiderare e lavorare perché<br />
anche gli altri lo conoscano e lo amino?<br />
Vivendo in mezzo ai suoi fratelli, ha mille possibilità <strong>di</strong> cooperare<br />
attivamente e <strong>di</strong>rettamente al loro bene spirituale.<br />
C‘è da notare che il clero oggi va <strong>di</strong>minuendo sensibilmente, ed è<br />
perciò necessario che i Laici Consacrati impegnati si de<strong>di</strong>chino a questo<br />
131
compito <strong>di</strong> aiuto al clero dando una mano in tutto ciò che da un punto <strong>di</strong><br />
vista laicale si può fare.<br />
Questo si fa già in tanti posti e nel futuro anche in altri. I nemici<br />
della religione non trionferanno sulla Chiesa del Signore. Un gran numero<br />
<strong>di</strong> laici pii, animato dallo zelo apostolico, <strong>di</strong>fende la Sposa <strong>di</strong> Cristo.<br />
5. Promozione delle buone iniziative<br />
Il laico consacrato dovrà impegnarsi per la gloria <strong>di</strong> Dio non solo<br />
procurando il bene delle anime, ma anche promuovendo tante buone<br />
opere per mezzo delle quali farà fruttificare il suo impegno pastorale.<br />
Queste buone opere ed iniziative sono molte, ne propongo alcune:<br />
a) Nella liturgia. Il laico promuoverà lo splendore delle funzioni<br />
liturgiche, ravvivando la fede dei cristiani, nel suo luogo <strong>di</strong> origine e<br />
secondo le sue possibilità; promuoverà soprattutto quelle che hanno un<br />
significato liturgico piú alto e sono piú efficaci spiritualmente. Si deve<br />
tenere in conto il parere del Parroco e senza <strong>di</strong> lui non si deve promuovere<br />
niente. Essendo opportuno proporre iniziative che siano <strong>di</strong> vantaggio per i<br />
fedeli.<br />
b) Le Pie Unioni. Il laico consacrato promuoverà le associazioni<br />
cristiane in modo che possano contrastare le influenze negative <strong>di</strong> quelle<br />
atee. Promuoverà specialmente quelle unioni che causano maggior<br />
frequenza al sacramento dell‘Eucaristia e al suo culto.<br />
c) I buoni collegi<br />
Promuoverà i buoni collegi dove maestri cristiani e <strong>di</strong>ligenti<br />
formino la gioventú allontanandola dall‘ignoranza dei suoi doveri religiosi e<br />
morali. Importa doppiamente questo impegno: per un lato per il bene <strong>di</strong><br />
formare cristianamente la gioventú e poi per evitare che sorgano collegi <strong>di</strong><br />
corrente contraria che crescono ogni giorno come una vera e propria peste.<br />
6. La Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong><br />
Infine promuoverà la Pia Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, che dovrà essere propriamente la Pia Unione dei Laici<br />
Consacrati; Pia Unione <strong>di</strong> fedeli che vivono nel celibato per rimanere piú<br />
liberi nel coltivare il bene morale e religioso, non aspirando ad altro che alla<br />
propria santificazione e a quella dei vicini. Suscitati dalla misericor<strong>di</strong>a del<br />
Signore, i Laici Consacrati, possono supplire in qualche modo quei religiosi<br />
che nei tempi attuali sono cosí avversati e per dare una buona mano ai<br />
Sacerdoti, che scarseggiano in questi tempi <strong>di</strong>fficili.<br />
Sempre sono vive le istanze della perfezione cristiana e quelli che<br />
sono obbligati a rimanere in mezzo a questo campo ostile, hanno bisogno<br />
<strong>di</strong> una salvaguar<strong>di</strong>a per rimanere su una base solida. Questa salvaguar<strong>di</strong>a<br />
132
potrà essere la Pia Unione che provveda loro i mezzi necessari per la<br />
perfezione.<br />
CAPITOLO III<br />
LE MISSIONARIE FIGLIE DI SANTA MARIA IMMACOLATA<br />
1. Uno sguardo alle loro costituzioni<br />
Le Missionarie <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> (MFSMI), sono<br />
persone che formano un Istituto Laicale ―coscienti della chiamata<br />
universale alla santità, accolgono questo dono vivendo e perpetuando lo<br />
spirito e il carisma del Venerabile Giuseppe Frassinetti. Tendono perciò<br />
alla perfezione della Carità e si de<strong>di</strong>cano a promuovere la santificazione del<br />
mondo rimanendo nello stato laicale e cooperando fraternamente con i<br />
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> ( Art. 2), conservando però la propria<br />
autonomia nelle proprie realizzazioni nella organizzazione e nelle iniziative<br />
da prendere‖.<br />
2. Carisma<br />
―La missione specifica dell‘Istituto è quella <strong>di</strong> continuare nella<br />
Chiesa il cammino e la vocazione del Venerabile Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe<br />
Frassinetti de<strong>di</strong>candosi:<br />
a) All‘attività per le vocazioni sacerdotali e religiose,<br />
particolarmente a quelle dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>.<br />
b) Alla collaborazione con i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong><br />
nell‘apostolato <strong>di</strong> orientamento della gioventú.<br />
c) Alla collaborazione parrocchiale con i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, soprattutto nel campo della catechesi.<br />
d) Alla cooperazione con l‘opera educativa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong><br />
e) A promuovere incontri <strong>di</strong> preghiera e momenti <strong>di</strong> spiritualità<br />
per chiedere al Signore vocazioni sacerdotali e religiose (Art. 4).<br />
3. Forma <strong>di</strong> vita delle Missionarie <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong><br />
―Vivranno o con i propri famigliari o in gruppi <strong>di</strong> vita fraterna‖<br />
(Art. 11).<br />
La vita comunitaria non è obbligatoria nell‘Istituto, perciò i<br />
membri che scelgono questo tipo <strong>di</strong> vita in comune, lo faranno liberamente<br />
e si organizzeranno in forma autonoma, rimanendo ogni gruppo<br />
pienamente responsabile dell‘organizzazione della propria vita comunitaria.<br />
133
Avrà una responsabile locale nominata dal consiglio generale.<br />
L‘assemblea locale organizza la vita comunitaria e stabilisce il tipo <strong>di</strong><br />
collaborazione con i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>.<br />
4. L‘ammissione all‘Istituto<br />
―Possono essere ammesse all‘Istituto le fedeli cristiane cattoliche,<br />
nubili o vedove che, godono <strong>di</strong> un buono stato <strong>di</strong> salute e <strong>di</strong> buona<br />
moralità, desiderano consacrarsi a Dio, rimanendo laiche‖ (Art. 19).<br />
Il periodo del postulandato durerà almeno due anni, mentre il<br />
noviziato durerà un anno, prorogabile a due; la professione dei voti sarà<br />
sempre pubblica. La professione temporanea durerà sei anni ed i voti si<br />
rinnovano ogni anno; al termine dei sei anni si potrà fare domanda alla<br />
Sorella Maggiore e suo Consiglio della ammissione alla professione<br />
perpetua.<br />
5. Struttura dell‘Istituto<br />
L‘Istituto gode <strong>di</strong> una autonomia propria nella sua <strong>di</strong>sciplina, nel<br />
suo governo interno però nel suo apostolato si unisce alla Congregazione<br />
dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>.<br />
Questa caratteristica ci permette <strong>di</strong> stabilire come punto operativo<br />
<strong>di</strong> base, la formazione <strong>di</strong> comunità locali o <strong>di</strong> gruppi fraterni <strong>di</strong> Apostolato<br />
in ognuna delle opere dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> (Art. 53).<br />
L‘Istituto è governato dall‘Assemblea Generale composta dalle<br />
professe <strong>di</strong> voti che partecipano o per ufficio per elezione.<br />
Presiede la Sorella Maggiore che sarà la prima moderatrice<br />
dell‘Istituto aiutata dal Consiglio Generale composto <strong>di</strong> quattro membri dei<br />
quali la prima eletta sarà Vicaria Generale; la seconda promotrice<br />
vocazionale; la terza Animatrice pastorale e la quarta Economa Generale.<br />
Con l‘amministrazione dei beni le Missionarie <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong><br />
<strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong><br />
Sovvenzionano le proprie comunità<br />
Aiutano i membri in necessità<br />
Assistono i poveri<br />
Contribuiscono alle opere dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong><br />
Aiutano la Chiesa nelle sue necessità ( Cap. V).<br />
Avranno una <strong>di</strong>pendenza morale e spirituale dal Superiore<br />
Generale della Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, a cui<br />
sarà presentata una relazione annuale sullo stato morale e amministrativo<br />
dell‘attività dell‘opera.<br />
134
6. Riassumendo<br />
Certamente le MFSMI sono il consolidamento del desiderio <strong>di</strong><br />
Giuseppe Frassinetti <strong>di</strong> permettere a quelle persone che per motivi<br />
economici o famigliari non potevano abbandonare «il modo», <strong>di</strong> tendere<br />
alla perfezione fuori del convento. Non c‘è dubbio che questo era un<br />
grande ostacolo in quei tempi.<br />
L‘Istituto delle MFSMI non solo permette oggi alle donne il<br />
cammino verso la perfezione nella ricerca della propria vocazione<br />
in<strong>di</strong>viduale ma anche dà la possibilità <strong>di</strong> consacrarsi a Dio nell‘attività<br />
apostolica e <strong>di</strong> essere fermento nel mondo dal <strong>di</strong> dentro dello spirito del<br />
Vangelo.<br />
Nate per l‘iniziativa <strong>di</strong> Padre Giuseppe Battistella, che seguendo lo<br />
stile del Frassinetti, che visse totalmente consacrato in particolare<br />
all‘Eucaristia, felice <strong>di</strong> essere un uomo <strong>di</strong> Dio, vide per le donne del suo<br />
tempo la possibilità <strong>di</strong> vivere consacrate a Dio.<br />
Le MFSMI vivono come laiche consacrate in un Istituto secolare,<br />
la spiritualità, lo stile e le attività dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>.<br />
CAPITOLO IV<br />
LA SECONDA CONGREGAZIONE<br />
1. Che cosa è<br />
Intorno alle nostre comunità, sia nei collegi come nelle parrocchie<br />
dove esercitiamo l‘apostolato, ci sono tante persone che apprezzano le<br />
opere, lo stile <strong>di</strong> vita dei FSMI; con simpatia ci seguono, perché per nostro<br />
mezzo si sono avvicinate <strong>di</strong> piú al Signore, Grazie a questo incontro fatto<br />
<strong>di</strong> sensibilità e anche molto fecondo, sorge una testimonianza <strong>di</strong><br />
partecipazione laicale nelle nostre attività. Di fatto queste persone formano<br />
la seconda Congregazione.<br />
2. Livelli <strong>di</strong> partecipazione<br />
Per rispondere ad una chiamata personale in conformità <strong>di</strong> ciò che<br />
il Signore chiede ad ognuno, si stabiliscono tre livelli <strong>di</strong> partecipazione:<br />
a) Persone consacrate, legate da voti o vincoli equivalenti, che<br />
vivono la loro vita nel mondo come consacrati, trasformandolo come sale<br />
della terra o come lievito nella farina.<br />
b) Persone che lavorano con stretta collaborazione con i religiosi<br />
nello spirito del volontariato e nel carisma della gratuità e della generosità.<br />
135
c) Persone che simpatizzano e appoggiano secondo la loro<br />
possibilità le iniziative, gli impegni <strong>di</strong> una comunità in particolare o <strong>di</strong> tutta<br />
la Congregazione.<br />
3. I consacrati<br />
Possono essere celibi o sposati/e, se sono sposati è preferibile che<br />
partecipano come coppia. La consacrazione consiste in un vincolo <strong>di</strong><br />
consacrazione che ognuno sceglierà in accordo con il proprio <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale. Potrebbe essere il corrispondente ai tre voti religiosi, se si vede<br />
che è opportuno. La durata non deve superare i tre anni, dopo <strong>di</strong> che si<br />
può rinnovare.<br />
4. I collaboratori<br />
Possono essere:<br />
a) Professori che nei nostri collegi, mossi da spirito apostolico<br />
danno il loro apporto all‘opera educativa alla luce del Vangelo.<br />
b) Persone che in forma attiva aiutano le nostre opere <strong>di</strong><br />
apostolato, con particolare attenzione alle vocazioni alla vita consacrata.<br />
c) Persone che non hanno contatto con le nostre comunità, però<br />
sono <strong>di</strong>sponibili per compiti <strong>di</strong> appoggio e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nazione proprie dei<br />
FSMI.<br />
5. I simpatizzanti<br />
Ci si riferisce a persone che sono in contatto con i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> in<br />
particolar modo agli ex-alunni. Essi possono essere animatori nel luogo in<br />
cui risiedono, dei nostri collegi e scuole. Possono in<strong>di</strong>rizzare giovani in<br />
ricerca vocazionale e <strong>di</strong>vulgatori della presenza dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>.<br />
6. La spiritualità<br />
La spiritualità <strong>di</strong> ispirazione è naturalmente la stessa dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Maria</strong>, sottolineando le caratteristiche: giovanile, mariana e vocazionale.<br />
L‘attenzione ai giovani soprattutto nella loro crescita spirituale, la<br />
figura della Vergine <strong>Maria</strong> come modello ed ispiratrice, il desiderio che la<br />
Chiesa abbia operai per la messe del Regno, queste dovrebbero essere le<br />
caratteristiche conduttrici <strong>di</strong> questa partecipazione spirituale.<br />
7. Organizzazione<br />
Il Superiore Generale è il supremo moderatore della<br />
Congregazione, per conseguenza è il principale responsabile degli aggregati<br />
con la collaborazione <strong>di</strong> un incaricato che curerà l‘unità interna.<br />
136
Ogni comunità locale e, secondo il caso, ogni gruppo <strong>di</strong> esse, avrà<br />
un promotore e responsabile <strong>di</strong> riferimento. Sarà opportuno, tenendo in<br />
conto la libertà personale, che sia parimenti <strong>di</strong>rettore spirituale dei membri<br />
della zona.<br />
Ogni gruppo, oltre il <strong>di</strong>rettore spirituale, avrà un laico incaricato,<br />
eletto dal gruppo stesso che promuoverà le iniziative ed animerà le<br />
riunioni.<br />
8. Appartenenza alla famiglia dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong><br />
Il desiderio <strong>di</strong> appartenere alla seconda Congregazione esige una<br />
scelta libera e motivata, perciò stesso chi decide <strong>di</strong> entrare deve accettare<br />
un programma adeguato <strong>di</strong> preparazione che durerà il tempo necessario<br />
per <strong>di</strong>scernere la propria chiamata.<br />
Questo comprende: preghiera, riflessione e approccio agli scritti <strong>di</strong><br />
Giuseppe Frassinetti sotto la <strong>di</strong>rezione del religioso responsabile.<br />
L‘entrata ufficiale avviene con una promessa personale in cui si<br />
esprime la volontà personale <strong>di</strong> vivere il Battesimo nello spirito dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Maria</strong>.<br />
CAPITOLO V<br />
CONCLUSIONE GENERALE<br />
Questo sguardo d‘insieme dato al Frassinetti circa la<br />
Consacrazione dei Laici, ci ha permesso <strong>di</strong> entrare nel ricco mondo in cui<br />
egli con maestria ed efficacia seppe cogliere le necessità del tempo.<br />
Due problemi concreti furono <strong>di</strong> spinta e cui Frassinetti dovette<br />
dare risposta:<br />
1. Come favorire la consacrazione dei quelle persone che per<br />
mancanza <strong>di</strong> mezzi economici e per i vincoli famigliari, non potevano<br />
rivolgersi alle congregazioni tra<strong>di</strong>zionali.<br />
2. Come far fronte ad un anticlericalismo galoppante,<br />
salvaguardando i valori <strong>di</strong> una società cristiana cattolica in crisi.<br />
Da qui nascono le pie Unioni dei <strong>Figli</strong> e delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>.<br />
Ed infine c‘è il problema urgente degli operai per la messe del<br />
Signore. Con le Pie Unioni laicali non solo permette che si possa<br />
consacrarsi ma anche imprime un marcato orientamento ed un appoggio<br />
alle vocazioni sacerdotali.<br />
137
La Congregazione laicale è precisamente vivere il dono del Signore<br />
«al secolo». Dall‘altare della famiglia consacrare a Dio giorno dopo giorno il<br />
mondo al Creatore.<br />
Nella visione che ―tutto coopera al bene <strong>di</strong> coloro che Dio ama‖<br />
(Rm 8,28), si eleva l‘inno della creatura al suo Signore. Il laico consacra la<br />
propria attività «laicale», nella sua vita quoti<strong>di</strong>ana:<br />
a) l‘obbe<strong>di</strong>enza costante a coloro a cui è dovuta, sotto la guida del<br />
magistero della Chiesa.<br />
b) la retribuzione del lavoro giusta ed onesta gli permetta <strong>di</strong> vivere<br />
con decoro nella prospettiva del sermone della montagna: ―Beati i poveri in<br />
spirito perché <strong>di</strong> essi è il regno dei Cieli‖ (Mt 5,3).<br />
c) una testimonianza per il mondo a vivere la vita con amore:<br />
―Beati i puri <strong>di</strong> cuore perché vedranno Dio‖ (Mt 5,8).<br />
La partecipazione del laico nella attività della Chiesa nasce dal<br />
Battesimo, dal suo carattere <strong>di</strong> figlio <strong>di</strong> Dio è mandato nel mondo tra i<br />
fratelli ad essere presenza viva dell‘amore del Padre.<br />
Nessun consacrato deve assumere un carattere «clericale»<br />
confondendo il suo ruolo e per questo perdendo il suo carisma <strong>di</strong> essere<br />
dono per la Chiesa.<br />
Nella misura che nella prospettiva laicale dà il suo apporto alla<br />
venuta del Regno nella famiglia dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> il suo<br />
apporto non solo è desiderato ma è anche un segno <strong>di</strong> maturità pastorale<br />
alla luce del servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti.<br />
Come sintesi finale, scelgo questa bella preghiera del nostro<br />
fondatore:<br />
Signore, io sono tuo,<br />
come tue sono tutte le cose.<br />
Ti offro il mio essere con tutte le sue capacità,<br />
l‘intelligenza, la memoria e la volontà.<br />
Ti offro la mia salute e la mia vita<br />
e quanto possiedo in questo mondo,<br />
purché si faccia <strong>di</strong> me quello che tu vuoi.<br />
Conce<strong>di</strong>mi la grazia che la mia esistenza<br />
non serva ad altro che a fare la tua volontà<br />
e a darti gloria ed onore.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
1. Opere ascetiche II, vol I, Postulazione Generale FSMI, Roma, 1978<br />
2. P. RENZI GIORDANO, Giuseppe Frassinetti, Roma, 1992<br />
138
3. NOVIZIATO FSMI, Laica consagrada, Argentina, 1989, Pro manuscripto<br />
4. P. CACCIOTTI VENTURINO, La seconda congregazione. Bozza <strong>di</strong> statuto, Pro<br />
manuscripto.<br />
5. ISTITUTO SECOLARE MFSMI, Regola. Bozza, Pro manuscripto<br />
6. ISTITUTO SECOLARE MFSMI, Direttorio. Bozza, Pro manuscripto<br />
Novizio Hernan Villalobos fsmi<br />
GIUSEPPE FRASSINETTI ANIMA EUCARISTICA<br />
Saggio sull‘opera<br />
«Il convito del Divino Amore»<br />
139
SOMMARIO<br />
Introduzione<br />
L‘Eucaristia<br />
Capitolo primo<br />
L‘Eucaristia mistero sorprendente<br />
Capitolo secondo<br />
I beni derivanti dalla Comunione<br />
Capitolo terzo<br />
Disposizioni per avvicinarsi al Convito del Divino Amore<br />
Capitolo quarto<br />
Frequenza al Convito del Divino Amore<br />
Capitolo quinto<br />
Lo zelo necessario per promuovere la partecipazione al Convito del Divino<br />
Amore<br />
Conclusione<br />
Bibliografia<br />
INTRODUZIONE<br />
L’EUCARISTIA<br />
―Il Signore Gesú nella notte in cui fu tra<strong>di</strong>to, prese il pane, rese<br />
grazie, lo <strong>di</strong>ede ai <strong>di</strong>scepoli e <strong>di</strong>sse: QUESTO È IL MIO CORPO, che sarà<br />
offerto per voi. Fate questo in mia memoria.<br />
Allo stesso modo dopo la cena prese il calice e <strong>di</strong>sse: QUESTO È<br />
IL MIO SANGUE, che sarà sparso per voi, fate questo in mia memoria.<br />
Ogni volta che mangiate <strong>di</strong> questo pane e berrete questo calice, annunziate<br />
la morte del Signore, fino al giorno della sua venuta.<br />
Chi mangia questo pane e beve questo calice indegnamente è reo<br />
del corpo e del sangue del Signore‖ (1 Cor 11, 23-27).<br />
Cristo ha voluto rimanere in mezzo a noi con il suo Corpo,<br />
Sangue, Anima e Divinità, nell‘umile forma <strong>di</strong> pane e vino. Affidò alla<br />
Chiesa questo sacramento, perché fosse cibo <strong>di</strong> vita eterna per i suoi figli.<br />
Per questo la Chiesa è la custode del Corpo Eucaristico <strong>di</strong> Gesú. Come una<br />
tesoriera <strong>di</strong> questo dono, ha <strong>di</strong>sposto leggi e norme per accedere a questo<br />
Sacramento e celebrare il suo culto. La Chiesa ha stabilito che i fedeli si<br />
devono comunicare almeno una volta l‘anno; ed ha posto le con<strong>di</strong>zioni per<br />
ricevere il Corpo <strong>di</strong> Cristo: essere in grazia <strong>di</strong> Dio, sapere chi si va a<br />
ricevere e almeno un‘ora <strong>di</strong> <strong>di</strong>giuno. In fondo significa che bisogna<br />
140
accostarsi alla comunione: ―Cum magna devotione et reverentia‖ come<br />
afferma San Tommaso d‘Aquino.<br />
Durante i secoli la Chiesa ha sofferto per la presenza <strong>di</strong> eresie che<br />
hanno lasciato un loro strascico. Tra queste ci fu il Giansenismo, che<br />
presentava una religione dura e puritana.<br />
Pre<strong>di</strong>cavano i giansenisti che l‘anima doveva essere purissima per<br />
ricevere la <strong>Santa</strong> Eucaristia e che era quasi impossibile all‘uomo accostarsi<br />
alla comunione, per le sue molte imperfezioni e <strong>di</strong>fetti. La comunione era<br />
per i puri e i santi come gli angeli. Questa corrente, condannata dalla<br />
Chiesa, ha lasciato le sue tracce soprattutto nel secolo XVIII e al principio<br />
del XIX. Il comando <strong>di</strong> Gesú: ―Prendete e mangiatene tutti…‖, era stato<br />
<strong>di</strong>menticato. Per timore <strong>di</strong> abusi e sacrilegi ci si comunicava raramente e<br />
con una minuziosa preparazione.<br />
Si temeva che l‘avvicinarsi frequentemente alla comunione fosse<br />
una mancanza <strong>di</strong> rispetto se l‘anima non fosse purificata a fondo <strong>di</strong> tutti i<br />
peccati, compresi i veniali. Nel secolo XIX, sorse una grande controversia<br />
sulla comunione frequente, alcuni teologi e maestri <strong>di</strong> spirito erano a<br />
favore, altri contro. Era ora che nella Chiesa si presentasse il Pane<br />
Eucaristico come sostegno dei deboli. ―La comunione è per quelli che<br />
vogliono <strong>di</strong>ventare santi, non per i santi‖, <strong>di</strong>ceva don Bosco.<br />
Tutti i santi dell‘epoca <strong>di</strong>fesero la comunione frequente, fra essi il<br />
Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe Frassinetti, che con forza ed ardore la <strong>di</strong>fese e la<br />
<strong>di</strong>ffuse dovunque. Il suo impegno è condensato nell‘opera «Il Convito del<br />
Divino Amore».<br />
CAPITOLO I<br />
L’EUCARISTIA: MISTERO SORPRENDENTE<br />
Giuseppe Frassinetti avverte un grande pericolo per le anime: che<br />
l‘Eucaristia si cambi in qualcosa <strong>di</strong> usuale e si perda <strong>di</strong> vista quello che<br />
veramente è. Sicuramente nella sua esperienza <strong>di</strong> pastore <strong>di</strong> anime, notò<br />
questo pericolo, per questo con grande delicatezza, spiega come nell‘Ostia<br />
c‘è il Corpo <strong>di</strong> Cristo. È lo stesso corpo che nacque da <strong>Maria</strong> Vergine e che<br />
morí sulla croce. Non solo il corpo ma anche l‘anima e la <strong>di</strong>vinità <strong>di</strong> Gesú.<br />
Un corpo che per l‘unione ipostatica è il corpo <strong>di</strong> Dio stesso. Perciò<br />
l‘Eucaristia contiene tutto il Corpo, il Sangue, l‘Anima e la Divinità <strong>di</strong><br />
nostro Signore Gesú Cristo. Cosí si incontra il Dio vivo, realmente<br />
presente. È Il miracolo piú grande della bontà, della potenza e della<br />
sapienza <strong>di</strong> Dio.<br />
141
Frassinetti, da vero adoratore ed estasiato, si sforza <strong>di</strong> trovare un<br />
nome che possa designare l‘Eucaristia. Afferma che tutte le definizioni<br />
sono inadeguate e che non si può definire questo gran<strong>di</strong>ssimo sacramento.<br />
Vede solo come definizione piú vicina quella <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa <strong>di</strong> Gesú:<br />
―Midollo delle Viscere <strong>di</strong> Dio‖. Questo è il nome piú appropriato che<br />
descrive la profon<strong>di</strong>tà e la tenerezza dell‘amore <strong>di</strong> Dio; dall‘altra parte è<br />
anche il piú adatto per considerare l‘Eucaristia il Convito del Divino<br />
Amore.<br />
Ammira il mistero eucaristico ed ammira la grandezza e la<br />
generosità <strong>di</strong> Dio, che volle abitare in mezzo a noi. Per questo ha scelto<br />
forme tanto semplici come il pane e il vino. Per amore Dio sceglie le cose<br />
piú comuni che ci possono tornare imme<strong>di</strong>atamente <strong>di</strong> giovamento, per<br />
restare il piú vicino possibile a noi e tutto questo per amore.<br />
L‘amante sempre opera in favore dell‘amato, e sebbene faccia cose<br />
gran<strong>di</strong>, sempre gli sembra che fa poco. Rimane presente nel pane e nel vino<br />
e non in solo posto ma in tutte le chiese del mondo. Si mette nelle mani<br />
degli uomini e si espone al <strong>di</strong>sprezzo e all‘in<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> coloro a cui non<br />
interessa la sua adorabile presenza.<br />
CAPITOLO II<br />
I BENI DERIVANTI DALLA COMUNIONE<br />
Perché Gesú resta presente nell‘Eucaristia? Senza dubbio per<br />
arricchirci e trasmetterci gli effetti <strong>di</strong> santificazione. Quali sono questi<br />
effetti che l‘Eucaristia produce in noi?<br />
In questo capitolo il Frassinetti ci offre la risposta.<br />
Il primo effetto della comunione è la grazia santificante. Con la<br />
comunione aumenta in noi la grazia santificante, per la quale siamo figli <strong>di</strong><br />
Dio ed ere<strong>di</strong> del Para<strong>di</strong>so. Attraverso la grazia il Padre Eterno vede in noi il<br />
volto <strong>di</strong> Gesú e ci <strong>di</strong>vinizza. Per partecipazione si arriva a possedere la<br />
stessa vita <strong>di</strong> Dio. La grazia santificante o vita <strong>di</strong> Dio in noi è soggetta ad<br />
aumento. La comunione è il mezzo piú efficace per tale aumento e per<br />
accrescere ogni volta l‘amore <strong>di</strong> Dio in noi.<br />
Il secondo effetto della comunione è: da essa riceviamo la forza<br />
per resistere alle tentazioni e superare le nostre <strong>di</strong>fficoltà. Il Frassinetti lo<br />
spiega in una forma molto colorita: una persona che deve fare una lunga<br />
corsa, se non è bene alimentata non potrà mai arrivare alla meta. Nello<br />
stesso modo se noi non ci alimentiamo con il Corpo <strong>di</strong> Cristo, mai<br />
giungeremo alla meta. Le <strong>di</strong>fficoltà, le tentazioni sono tante, e per questo ci<br />
142
è necessario un alimento forte e sicuro. L‘unico e il migliore alimento per il<br />
nostro spirito è il Corpo <strong>di</strong> Cristo.<br />
Sappiamo che mai Dio permetterà che siamo tentati al <strong>di</strong> sopra<br />
delle nostre forze e che sempre ci darà le grazie necessarie per superare le<br />
tentazioni. Queste grazie ci vengono comunicate in modo speciale nel<br />
Santissimo Sacramento. Solo in Gesú Eucaristia troviamo la forza per<br />
andare avanti.<br />
Il terzo effetto della Comunione è: cancella e purifica dal peccato<br />
veniale. Le nostre piccole imperfezioni o peccati veniali ci sono perdonati<br />
con il ricevere la <strong>Santa</strong> Comunione. Il Signore, nella sua bontà, quando<br />
entriamo a contatto con il suo Corpo, ci perdona questi <strong>di</strong>fetti causati non<br />
da malizia o da cattiva volontà, ma dalla nostra natura ferita e incline al<br />
male.<br />
Il quarto effetto della comunione è: la consolazione spirituale che<br />
essa produce in noi. Questa consolazione è un dono <strong>di</strong> Dio. Ci fa gustare<br />
un po‘ già sulla terra le delizie del Para<strong>di</strong>so. Questa consolazione o delizia<br />
consiste nel rimanere in comunione con il Signore.<br />
Frassinetti ci spiega che quest‘effetto è riservato per coloro che si<br />
preparano con molta attenzione all‘incontro con Gesú, coloro che hanno<br />
una particolare fame e sete <strong>di</strong> Lui. È chiaro che questo quarto effetto non è<br />
sempre sensibile. Il Signore ci lesina queste dolcezze per non farci cadere<br />
nella sod<strong>di</strong>sfazione personale, che ha come effetto la superbia, che è un<br />
grande male.<br />
CAPITOLO III<br />
DISPOSIZIONI PER AVVICINARSI AL CONVITO DEL<br />
DIVINO AMORE<br />
La grazia santificante è la <strong>di</strong>sposizione necessaria.<br />
Nel capitolo II, il Frassinetti parla della grazia santificante come<br />
una conseguenza della Comunione. In questo capitolo ne parla come <strong>di</strong><br />
una con<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>spensabile per accostarsi alla mensa del Signore. È una<br />
conseguenza perché la Comunione la aumenta.<br />
È una con<strong>di</strong>zione perché senza la grazia santificante nessuno può<br />
osare <strong>di</strong> ricevere il Corpo <strong>di</strong> Cristo. Chi si accosta senza lo stato <strong>di</strong> grazia<br />
alla santa Eucaristia ―mangia e beve la propria condanna‖.<br />
La grazia santificante rende l‘anima limpida e trasparente, senza<br />
nessuna traccia <strong>di</strong> peccato mortale. Frassinetti, facendo una acuta<br />
interpretazione della parabola del banchetto nuziale del Vangelo <strong>di</strong> San<br />
143
Matteo (Cap. 22,1-13) spiega l‘importanza della grazia per ricevere<br />
l‘Eucaristia. Tutti sono invitati alla feste delle nozze, però quelli che sono<br />
senza l‘abito nuziale, cioè senza l‘ornamento richiesto dalla circostanza,<br />
sono legati e cacciati fuori dove c‘è solo «pianto e stridor <strong>di</strong> denti».<br />
Per comunicarsi è necessario il vestito adeguato, cioè avere l‘anima<br />
vestita <strong>di</strong> grazia. Un‘anima in stato <strong>di</strong> grazia è vestita con l‘abito nuziale: ha<br />
perciò <strong>di</strong>ritto al banchetto che il Signore le offre.<br />
L‘unica e in<strong>di</strong>spensabile con<strong>di</strong>zione per ricevere la Comunione è<br />
questa: la purezza da ogni peccato mortale. Su questo punto insiste molto,<br />
perché solo possedendo lo stato <strong>di</strong> grazia saremo riconoscenti verso Dio.<br />
Una persona in stato <strong>di</strong> grazia è figlia e amica <strong>di</strong> Dio ed è oggetto della sua<br />
compiacenza. La comunione in lei produce molto frutto, accresce questa<br />
vita <strong>di</strong>vina e le dà forza per procedere a gran<strong>di</strong> passi verso la virtú.<br />
È vero che esistono altre <strong>di</strong>sposizioni, che il Frassinetti chiama<br />
«<strong>di</strong>sposizioni desiderabili», ma appunto esse non sono in<strong>di</strong>spensabili, né<br />
necessarie. Chiarisce che se alcuni maestri <strong>di</strong> spirito le esigono, farebbero<br />
un grave errore.<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni utili e desiderabili sono: la purezza da ogni<br />
peccato, compreso quello veniale, una vita <strong>di</strong> raccoglimento e <strong>di</strong> orazione,<br />
la mortificazione dai piaceri ecc.<br />
Queste <strong>di</strong>sposizioni sono necessarie nelle persone che desiderano<br />
servire meglio il Signore, in special modo per i religiosi e le religiose, che se<br />
non cercano <strong>di</strong> possedere queste con<strong>di</strong>zioni danno chiaro segno <strong>di</strong> vita<br />
me<strong>di</strong>ocre e leggera, rispetto all‘ideale che si sono proposti <strong>di</strong> raggiungere,<br />
cioè la perfezione.<br />
CAPITOLO IV<br />
FREQUENZA AL CONVITO DEL DIVINO AMORE<br />
In questo capitolo giungiamo al nocciolo, alla parte piú importante<br />
dell‘opera <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti. La frequenza della santa Comunione era<br />
una delle preoccupazioni piú gran<strong>di</strong> del suo operare come pastore <strong>di</strong><br />
anime. Con quale frequenza uno si può accostare a ricevere il Sacramento<br />
dell‘Eucaristia?<br />
Risponde il Frassinetti: ―Ogni volta che il confessore lo<br />
permette…e i confessori non devono essere stretti nel permetterlo…‖ Egli<br />
sostiene con forza la pratica della Comunione frequente.<br />
Come primo argomento si basa sul Padre nostro. Dice, che la<br />
quarta petizione: ―Dacci oggi il nostro pane quoti<strong>di</strong>ano‖ non si riferisce<br />
144
solo al pane materiale, ma anche all‘alimento dello spirito, all‘Eucaristia.<br />
Per il parroco <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina è evidente che i primi cristiani avevano<br />
nell‘Eucaristia il cibo quoti<strong>di</strong>ano e da esso trovavano la forza per<br />
sopportare il martirio.<br />
Il tema della comunione frequente è affermato nei documenti del<br />
Concilio <strong>di</strong> Trento, nel Catechismo romano e molto piú chiaramente nel<br />
decreto <strong>di</strong> papa Innocenzo XI.<br />
Basandosi sulla dottrina dei Santi Padri e riferendosi ad essi come<br />
primi maestri <strong>di</strong> spiritualità, <strong>di</strong>mostra che essi hanno sempre <strong>di</strong>feso e<br />
promosso la comunione frequente.<br />
Alcuni teologi del suo tempo ponevano questa <strong>di</strong>fficoltà: la<br />
frequenza della Comunione fa perdere il rispetto dovuto all‘Eucaristia.<br />
Egli sottolinea che lo stesso si dovrebbe <strong>di</strong>re dei sacerdoti che<br />
celebrano la Messa tutti giorni. Dice: ―Gesú è presente nell‘Eucaristia non<br />
tanto per farsi rispettare ma per farsi amare‖. Continua: ―L‘amico mai <strong>di</strong>ce<br />
all‘amico, rimani piú lontano, amiamoci a <strong>di</strong>stanza, ma al contrario, lo<br />
invita ad essere vicino e gode nel passare insieme a lui le intere giornate‖.<br />
―Comunicarsi quoti<strong>di</strong>anamente non è mancanza <strong>di</strong> rispetto, ma è onorare e<br />
amare Cristo‖. Cita a proposito San Tommaso: ―Appartiene al rispetto <strong>di</strong><br />
questo sacramento il riceverlo ogni giorno‖ (III P. Q. LXXX.).<br />
È importante inculcare ai fedeli la Comunione quoti<strong>di</strong>ana. ―Si<br />
dovrebbe pre<strong>di</strong>care ai fedeli che gli antichi cristiani si comunicavano tutti i<br />
giorni e che il Concilio <strong>di</strong> Trento desidera questa buona usanza si<br />
mantenga e il Catechismo romano la inculca.<br />
Per tutti questi motivi si dovrebbe pre<strong>di</strong>care che i fedeli farebbero<br />
cosa santissima e molto efficace e <strong>di</strong> grande gloria a Dio e <strong>di</strong> molta<br />
e<strong>di</strong>ficazione del prossimo se si comunicassero tutti i giorni con<br />
devozione…‖ ―Un‘anima in grazia <strong>di</strong> Dio, senza nessun peccato mortale, è<br />
libera, ed ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ricevere quoti<strong>di</strong>anamente il Corpo <strong>di</strong> Cristo<br />
Eucaristia‖.<br />
Una frase <strong>di</strong> Genna<strong>di</strong>o che era attribuita impropriamente a<br />
Sant‘Agostino, si usava per <strong>di</strong>ssuadere dal ricevere la comunione: ―Ricevere<br />
la comunione tutti i giorni non è cosa né da lodarsi, né da condannarsi‖.<br />
Frassinetti con energia la contesta, <strong>di</strong>cendo che Sant‘Agostino<br />
apertamente loda ed approva la comunione frequente, che Genna<strong>di</strong>o non<br />
ha mai avuto l‘autorità <strong>di</strong> un santo padre.<br />
La comunione frequente è desiderata e lodata dalla Chiesa per cui<br />
―perché non lodare ciò che la Chiesa loda? Non è nemmeno lecito <strong>di</strong>re<br />
«non la condanno», come se si stesse a fare un favore alla Chiesa non<br />
condannando ciò che essa approva‖.<br />
145
La voce del Frassinetti è chiara e suona in perfetta sintonia con<br />
tutta la Chiesa.<br />
―Se avete il permesso <strong>di</strong> comunicarvi tutti i giorni, non tralasciate<br />
mai <strong>di</strong> comunicarvi‖:<br />
CAPITOLO V<br />
LO ZELO NECESSARIO PER PROMUOVERE LA<br />
PARTECIPAZIONE AL CONVITO DIVINO<br />
Nella comunione sta tutto il bene che l‘uomo può compiere a<br />
gloria <strong>di</strong> Dio. La Chiesa promuove molte opere che servono ad onorare il<br />
Signore: la mortificazione, la preghiera, le sacre funzioni, le opere <strong>di</strong><br />
misericor<strong>di</strong>a, la vita religiosa ecc. Questi beni devono essere promossi<br />
perché sono a gloria <strong>di</strong> Dio e utili per la santificazione dell‘uomo, ma il<br />
Frassinetti mette in luce il bene piú grande: l‘Eucaristia.<br />
― Mi sembra senza dubbio che nel Santissimo Sacramento risiede<br />
tutto il bene con cui Dio può mostrare all‘uomo il suo amore, come anche<br />
nella Comunione c‘è tutto il bene che l‘uomo può fare per onorare Dio‖.<br />
Chi riceve frequentemente la Comunione deve essere puro nella<br />
coscienza, perché qui sta il fondamento della vita spirituale. Perciò<br />
promuovere la comunione frequente è promuovere tutta la vita spirituale<br />
in modo molto forte. Senza dubbio gli effetti per raggiungere la perfezione<br />
sono molto evidenti e Frassinetti lo sottolinea, infatti la comunione supera<br />
in qualità tutte le opere <strong>di</strong> pietà e <strong>di</strong> carità.<br />
Uno degli effetti piú importanti della comunione frequente è la<br />
castità perfetta; entrando in contatto con il Corpo verginale <strong>di</strong> Cristo è<br />
impossibile non contagiarsi. L‘Eucaristia è il sostentamento e la forza <strong>di</strong><br />
coloro che abbracciano la castità perfetta.<br />
Frassinetti ci presenta una bella trilogia: Comunione – Castità –<br />
Sacerdozio. Promuovere la comunione quoti<strong>di</strong>ana corrisponde a<br />
promuovere la castità perfetta e ciò è causa <strong>di</strong> un aumento delle vocazioni<br />
al sacerdozio. Veramente ammirevole la sensibilità vocazionale del<br />
Frassinetti! Ci dà la chiave e accentua il punto centrale della pastorale<br />
vocazionale: portare i giovani a Gesú e a Gesú presente nell‘Eucaristia.<br />
Se un giovane riceve quoti<strong>di</strong>anamente la Comunione è impossibile<br />
che non senta la voce del Signore che lo invita a seguirlo. Una volta sentita<br />
la chiamata troverà la forza per <strong>di</strong>re il suo «si». Nell‘Eucaristia sta la<br />
chiamata e la fonte del sacerdozio.<br />
146
Rivolgendosi ai sacerdoti il Frassinetti scrive: ―Prepariamo il<br />
Convito del <strong>di</strong>vino amore, è il pane <strong>di</strong>sceso dal cielo che si è messo nelle<br />
nostre mani.. È nostro impegno chiamare gli invitati, che sono tutti i fedeli.<br />
Ogni giorno saliamo all‘altare e in forza delle parole onnipotenti<br />
che pronunciamo, scende il vero Pane del cielo. Questo convito non deve<br />
essere quoti<strong>di</strong>ano solo per noi, ma per tutto il popolo cristiano. Per questo<br />
non siamo piú prudenti con gli altri <strong>di</strong> quello che siamo con noi stessi. Non<br />
esigiamo da loro maggior santità <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> quella che esigiamo da noi stessi<br />
quando celebriamo la <strong>Santa</strong> Messa‖.<br />
CONCLUSIONE<br />
È qui che Frassinetti si mostra apostolo e <strong>di</strong>fensore della<br />
comunione quoti<strong>di</strong>ana.<br />
Sforzandosi <strong>di</strong> correggere l‘idea <strong>di</strong> un Dio terribile e ven<strong>di</strong>cativo<br />
da cui era sempre prudente stare lontano e presentando il Dio «nell‘Ostia<br />
santa» presenta un Dio-Amore.<br />
Come un buon padre, nel mostrare Gesú presente nell‘Eucaristia<br />
nostro alimento ed oggetto del nostro amore, sente la necessità <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fendere la comunione frequente, contro la mentalità del tempo ancora<br />
inficiata <strong>di</strong> resti giansenistici.<br />
Non molto tempo dopo, eletto alla cattedra <strong>di</strong> Pietro, il grande<br />
pontefice San Pio X, non solo risolverà la questione della comunione<br />
frequente ma andrà piú oltre: faciliterà la comunione ai fanciulli, già alla<br />
prima età.<br />
Questa opera del Frassinetti è tutta impregnata <strong>di</strong> ardente amore<br />
per l‘Eucaristia e <strong>di</strong> un trasparente zelo per farla amare. Il suo amore e il<br />
suo zelo eucaristico si può paragonare a quello <strong>di</strong> San Pietro Giuliano<br />
Eymard.<br />
Visse eucaristicamente e annunziò l‘Eucaristia come ―centro<br />
culmine <strong>di</strong> tutta la vita cristiana‖, come piú tar<strong>di</strong> la definirà il Concilio<br />
Vaticano II.<br />
Che cosa ci <strong>di</strong>rebbe oggi il Frassinetti? Sicuramente non<br />
insisterebbe sulla bellezza della comunione quoti<strong>di</strong>ana, giacché la possibilità<br />
c‘è per tutti, ma insisterebbe sulla purezza <strong>di</strong> coscienza e sul fervore<br />
eucaristico. Rilancerebbe il sacramento della Confessione, poiché oggi è<br />
poco frequentato: si vedono lunghe file alla comunione e poca gente al<br />
confessionale. Forse si pecca <strong>di</strong> meno? Si sta perdendo la coscienza del<br />
peccato? È un problema serio per tutti i pastori <strong>di</strong> anime.<br />
147
Partendo dal Frassinetti facciamo un esame <strong>di</strong> coscienza sulla<br />
nostra pietà eucaristica. Noi, uomini del XX secolo che consapevolezza<br />
abbiamo che nei tabernacoli delle nostre chiese è presente il Dio vivo<br />
<strong>di</strong>sposto ad ascoltarci e ad essere nostro alimento?<br />
Noi che tanto pre<strong>di</strong>chiamo sulla liturgia rinnovata abbiamo<br />
rinnovato il nostro fervore verso Gesú Eucaristico?<br />
Gesú dal tabernacolo ci interpella: Giuseppe Frassinetti ci mostra<br />
il cammino e il re dei cuori ci invita: ―Venite a me tutti…‖.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
- GIUSEPPE FRASSINETTI, Il convito del <strong>di</strong>vino amore, Opere Ascetiche,<br />
Vol. I, pag. 329-403, Postulazione Generale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, Roma, 1978.<br />
- TULLIO GOFFI, La spiritualità dell’ottocento, EDB, Bologna, 1989.<br />
- VENTURINO CACCIOTTI, Due brevi saggi frassinettiani, (Pro<br />
manuscrito), Centro Vocazionale G. Frassinetti, Roma, 1969.<br />
Novizio Marcelo De Haan fsmi<br />
LA POTENZA DELLA PAROLA NELL'AZIONE<br />
PASTORALE DEL VEN. GIUSEPPE. FRASSINETTI<br />
( Alcune attenzioni nell‘arte della pre<strong>di</strong>cazione )<br />
148
―Parla da padre, parla da fratello, parla da amico,<br />
riusciranno piene <strong>di</strong> grazia le tue parole<br />
e volentieri saranno u<strong>di</strong>te‖.<br />
( da «Gesú Cristo regola del Sacerdote», G. Frassinetti)<br />
SOMMARIO<br />
Introduzione<br />
Capitolo primo<br />
Frassinetti pre<strong>di</strong>catore consacrato al popolo genovese<br />
Capitolo secondo<br />
Il presbitero cultore della Parola<br />
Bibliografia generale<br />
INTRODUZIONE<br />
La pre<strong>di</strong>cazione si suole definire la presentazione orale delle verità<br />
cristiane, emessa dall‘autorità competente, per richiamare, esortare, educare<br />
gli u<strong>di</strong>tori alla fede, alla pratica della legge morale, alla conversione del<br />
cuore. L‘oggetto della pre<strong>di</strong>cazione è il Vangelo (cfr. Mc. 16,15). ―I<br />
pre<strong>di</strong>catori debbono illuminare a riguardo <strong>di</strong> ciò che si deve credere,<br />
<strong>di</strong>rigere nell‘operare, in<strong>di</strong>care quanto è da evitarsi, e, ora minacciando, ora<br />
esortando, pre<strong>di</strong>care agli uomini‖ 236. La propagazione e conservazione del<br />
Vangelo è affidata essenzialmente alla parola viva, parlata, piú che allo<br />
scritto od altro.<br />
Cristo si propose al mondo come Maestro <strong>di</strong> verità ed affidò agli<br />
apostoli il compito <strong>di</strong> continuare la sua opera: ―Chi ascolta voi ascolta me,<br />
chi <strong>di</strong>sprezza voi, <strong>di</strong>sprezza me, chi <strong>di</strong>sprezza me <strong>di</strong>sprezza il Padre che mi<br />
ha mandato‖ (Lc. 10,16). Gli apostoli ebbero da Cristo stesso il potere <strong>di</strong><br />
pre<strong>di</strong>care che trasmisero a loro volta ai loro successori. Il pre<strong>di</strong>catore ha<br />
l‘impegno <strong>di</strong> presentare il contenuto essenziale della fede in conformità<br />
con l‘esigenza dei suoi tempi, confrontato con la storia, le scienze, rivestito<br />
del registro linguistico corrente; pertanto la pre<strong>di</strong>cazione avrà come fonti<br />
secondarie la scienza, la letteratura, la storia.<br />
Come incarnò tutto questo il venerabile Giuseppe Frassinetti?<br />
È ciò che inten<strong>di</strong>amo stu<strong>di</strong>are, approfon<strong>di</strong>re, analizzare e proporre<br />
in questo breve lavoro, augurandoci possa riuscire a penetrare piú<br />
autenticamente possibile la personalità del Frassinetti che a riguardo si<br />
presenta incre<strong>di</strong>bilmente affascinante e sempre ricco <strong>di</strong> inviti alla santità.<br />
236 S. TOMMASO, Commento in Mt., 5°.<br />
149
CAPITOLO I<br />
FRASSINETTI, PREDICATORE CONSACRATO AL POPOLO<br />
GENOVESE<br />
L‘oratoria sacra del secolo <strong>di</strong>ciannovesimo è <strong>di</strong>visa fra classicismo<br />
e romanticismo. Sulla scia dell‘oratoria francese (Ravignan, Fryssenon,<br />
Lacordaire), gli oratori italiani si <strong>di</strong>edero alla polemica contro il<br />
razionalismo, risultando spesso accademici, e quando si tennero ad una<br />
pre<strong>di</strong>cazione popolare, questa mancò <strong>di</strong> sostanza. La crisi <strong>di</strong> idee della<br />
seconda metà dell‘ottocento, poi, si rifletté anche nell‘oratoria sacra,<br />
sviluppando una serie <strong>di</strong> oratori apologetici, polemisti, manieristi,<br />
impegnati nel sociale e nel politico (cfr. ad es. G. Ventura, G.B. Giordano,<br />
T. Gaudensi, C.M. Curci ).<br />
La grandezza del Frassinetti risiede nell‘essere andato in un certo<br />
senso contro corrente: il suo stile semplice, schietto ed imme<strong>di</strong>ato costruito<br />
per il popolo, per tutto ì1 popolo, colorito <strong>di</strong> espressioni <strong>di</strong>alettali, motti<br />
arguti, esempi tratti dalla vita quoti<strong>di</strong>ana, cozzavano senza dubbio con il<br />
registro linguistico fiorito, leccato e rigorosamente farcito <strong>di</strong> eru<strong>di</strong>zione -<br />
poco accessibile <strong>di</strong> conseguenza per la maggior parte del pubblico - che si<br />
andava <strong>di</strong>ffondendo fra gli oratori della seconda metà dell‘ottocento.<br />
Nelle sue «Riflessioni» scriveva: ―Si cerca il bello, il leggiadro, la<br />
moda per piacere... si spargono al vento vane parole, ed i popoli restano<br />
<strong>di</strong>giuni mentre vengono per satollarsi del pane <strong>di</strong> vita‖ 237.<br />
Dietro un linguaggio semplice, si nascondeva tuttavia grande preparazione<br />
teologica e somma eru<strong>di</strong>zione, facilmente intuibile, fra l‘altro,<br />
dalle sempre puntuali citazioni dei Padri della Chiesa e della Sacra Scrittura,<br />
dagli stu<strong>di</strong> attenti del S. Alfonso <strong>Maria</strong> de‘ Liguori proposti ai lettori<br />
nonché agli ascoltatori delle sue orazioni, dalla conoscenza profonda e<br />
brillante della lingua latina.<br />
Del suo stile nel pre<strong>di</strong>care, scrive il Sac. Domenico Fassiolo, avendo<br />
avuto l‘opportunità <strong>di</strong> ascoltarlo: ―Egli amava esser breve: <strong>di</strong>ceva che<br />
questo è uno dei mezzi piú sicuri per trar ad u<strong>di</strong>rlo coloro che <strong>di</strong> leggeri se<br />
ne annoiano. Quin<strong>di</strong> nella spiegazione del Vangelo non oltrepassava mai la<br />
mezza ora o i venticinque minuti, eppure vi faceva molte riflessioni; amava<br />
parlare alla gente devota, e solo in<strong>di</strong>rettamente combatteva gli errori contro<br />
237 Cfr. C. OLIVARI, Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio Sac. G.<br />
Frassinetti, Roma 1928, Poliglotta Vaticana, p. 295.<br />
150
la fede. Per questo rispetto che egli aveva per l'u<strong>di</strong>enza, era sentito<br />
volentieri e si guadagnò molto concorso. Il suo stile era semplice, non del<br />
tutto <strong>di</strong>sadorno e sempre <strong>di</strong>dascalico: quello che però attirava l‘attenzione<br />
era il fervore del suo <strong>di</strong>re, l‘energia del favellare, la profon<strong>di</strong>tà della dottrina<br />
e soprattutto quella celeste unzione che trae l‘anima e ne spiega al bene la<br />
volontà‖ 238.<br />
Frassinetti parla e scrive da pastore premuroso, sempre attento<br />
alle esigenze concrete del suo pubblico; carica dì vigore ogni singola<br />
espressione, spesso utilizzando la frase interrogativa o esclamativa,<br />
provocando l‘ascoltatore ad una piú profonda riflessione. Mette a fuoco<br />
con chiarezza i problemi, avendo sempre <strong>di</strong> mira il popolo che ha davanti<br />
agli occhi, con cui vive, si confronta, <strong>di</strong> cui si nutre; un popolo che ama<br />
profondamente e sente <strong>di</strong> adoperarsi pienamente e totalmente nel condurlo<br />
a Cristo. È per questo che sceglie spesso la chiarezza e la facile<br />
imme<strong>di</strong>atezza del <strong>di</strong>aletto; in ambiente genovese, per un pubblico<br />
genovese.<br />
Scrive a riguardo:<br />
―V‘ha una pre<strong>di</strong>cazione che può chiamarsi <strong>di</strong> lusso e serve al lustro<br />
delle funzioni... sono le orazioni panegiriche, le quali non si fanno<br />
perché siano intese dagli ignoranti, ma perché siano amate ed applau<strong>di</strong>te<br />
dagli eru<strong>di</strong>ti; a me questa pre<strong>di</strong>cazione sembra parola <strong>di</strong> Dio abusata,<br />
perché la parola <strong>di</strong> Dio, tutta e sempre deve essere <strong>di</strong>retta alla<br />
santificazione del popolo cristiano, il quale per la maggior parte è<br />
composto <strong>di</strong> ignoranti... Non vi sarebbe arte <strong>di</strong> scrivere le piú belle e<br />
graziose cose, tutt‘insieme piane ed intelligibili ad ogni persona?... Gesú<br />
Cristo, scrive S. Alfonso de‘ Liguori, sapeva <strong>di</strong> retorica piú <strong>di</strong> noi; ma per<br />
farsi capire dalle turbe, non seppe scegliere altro stile che parabole e<br />
similitu<strong>di</strong>ni dozzinali...In grazie della maggiore intelligibilità, il parroco farà<br />
bene a pre<strong>di</strong>care in <strong>di</strong>aletto...‖ 239 .<br />
Come non essere convinti che il Frassinetti, scrivendo in tal forma,<br />
non parlasse <strong>di</strong> se stesso e della sua vita pastorale? Ne dà conferma il<br />
suo biografo nonché amico e fedele frequentatore <strong>di</strong> S. Sabina, Sac.<br />
Domenico Fassiolo, il quale afferma che il suo scrivere è frutto<br />
principalmente della sua santità 240.<br />
238 Cfr. C. OLIVARI, op. cit., p.302.<br />
239 G. FRASSINETTI, Manuale del Parroco Novello, Ed. Paoline, Alba 1964,<br />
pp. 144,145.<br />
240 Cfr. D. FASSIOLO, Memorie storiche intorno alla vita del Sac. G.<br />
Frassinetti, Genova 1879, Tip. Della Gioventú, pp.91,92.<br />
151
Non è <strong>di</strong>fficile cogliere come sentisse il bisogno <strong>di</strong> vivere a contatto<br />
con la sua gente; <strong>di</strong> qui instancabile confessore assiduo <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale, sempre <strong>di</strong>sponibile all‘annuncio <strong>di</strong> Cristo Risorto, pala<strong>di</strong>no della<br />
verità. Il Frassinetti seppe trasmettere energicamente quello spirito <strong>di</strong> sano<br />
ottimismo, grazie al quale fu infaticabile operaio nella vigna del Signore.<br />
Il santo Gianelli, suo professore, amico e confidente, desiderava<br />
fosse piú impegnato nel curare lo stile con cui presentava le orazioni ed i<br />
numerosi scritti 241, ma il Frassinetti era animato solo dal desiderio d‘esser<br />
capito; <strong>di</strong> qui semplicità e chiarezza, come abbiamo detto, da considerarsi<br />
conseguenza <strong>di</strong> chiarezza d‘idee.<br />
Il suo pensiero fu sempre limpido e risultato <strong>di</strong> una corposa me<strong>di</strong>tazione.<br />
È impressionante la sua abilità nel liberare l‘essenziale da ogni<br />
involucro <strong>di</strong> sovrastrutture e costruzioni artificiose, e muoversi con agilità<br />
nel <strong>di</strong>fficile campo delle argomentazioni teologiche; fu per questo che<br />
usava ripetere concetti e riproporre riflessioni già espresse; a lui premeva<br />
d‘esser capito e la ripetizione è senza dubbio uno strumento idoneo a tale<br />
scopo.<br />
Impossibile non cogliere un Frassinetti <strong>di</strong> simil stampo nella trasparenza<br />
dei suoi scritti.<br />
CAPITOLO II<br />
IL PRESBITERO, CULTORE DELLA PAROLA<br />
Il Frassinetti unitamente alla cura del popolo, si preoccupò in<br />
numerosi suoi scritti, che il clero genovese comprendesse e sfruttasse<br />
l‘incre<strong>di</strong>bile potenza della parola e ritenesse la pre<strong>di</strong>cazione come il primo<br />
mezzo dell‘apostolato e salvezza delle anime, una pre<strong>di</strong>cazione assistita<br />
dalla preghiera e animata dalla Grazia. Fu sempre zelante nel mettere a<br />
<strong>di</strong>sposizione umilmente la sua esperienza <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>catore e pastore a quanti<br />
sono chiamati alla cura delle anime, ritenendo necessaria la collaborazione<br />
e comunione fra confratelli e questo sempre e solo per il sommo bene del<br />
suo popolo.<br />
È per questo che scrive «Il Manuale del Parroco Novello», tra i<br />
primi manuali <strong>di</strong> teologia pastorale in lingua italiana (<strong>di</strong> trattati sulla vita<br />
pastorale ve ne erano molti, ma per maggioranza composti in lingua latina),<br />
celebrato in Italia e all‘estero (tradotto in lingua francese, spagnola, inglese)<br />
con enorme successo, collocando il Frassinetti fra i piú insigni autori <strong>di</strong><br />
241 Lettere del 22/12/1842 e del 10/2/1845, A.F., vol.II, pp.97-101.<br />
152
teologia pastorale. ―Libro eccellente, possa il nostro giovane clero ispirarsi<br />
in tutta la sua condotta ai suoi saggi e fruttuosi consigli‖ (Il Vescovo <strong>di</strong><br />
Verdun).<br />
Preoccupato dei doveri pastorali, <strong>di</strong> un parroco in rapporto alle<br />
esigenze ed alle necessità del suo tempo e dell‘ascetica che deve informare<br />
la vita sacerdotale, si rivolge con attenzione, sapienza e prudenza,<br />
sostenuto da mite carità e solida dottrina, nonché grande esperienza e<br />
<strong>di</strong>screzione, al giovane clero, al quale de<strong>di</strong>ca ampio spazio nella esposizione<br />
dei suoi consigli sull‘arte della pre<strong>di</strong>cazione.<br />
Pre<strong>di</strong>care senza avere nulla <strong>di</strong> scritto è una forte tentazione <strong>di</strong><br />
vanità: il ministro da un lato crede <strong>di</strong> farsi onore, dando ad intendere <strong>di</strong><br />
possedere prontezza <strong>di</strong> ingegno e facilità <strong>di</strong> parola da non aver bisogno <strong>di</strong><br />
alcuna preparazione, qualora la prova risultasse positiva; se per contrario<br />
risultasse negativa, si illude <strong>di</strong> convincere gli ascoltatori scusandosi riguardo<br />
al mancato ingegno e alla stentata parola con la mancanza <strong>di</strong> una<br />
preparazione adeguata. ―Tutti hanno bisogno <strong>di</strong> prepararsi alla<br />
pre<strong>di</strong>cazione!‖ 242. In questo Frassinetti è chiarissimo, mostra ancora una<br />
volta <strong>di</strong> tenere in sommo conto la potenza della parola come mezzo idoneo<br />
per curare ed amare il popolo. La pre<strong>di</strong>cazione è «spezzare» la parola <strong>di</strong><br />
Dio per offrirla al popolo, rendendola masticabile, <strong>di</strong>geribile, è il pane <strong>di</strong><br />
vita con cui il pastore nutre il suo popolo; per questo è in<strong>di</strong>spensabile<br />
un‘adeguata preparazione, che significa rispetto, donazione, generosità,<br />
desiderio <strong>di</strong> condurre a Cristo.<br />
La pre<strong>di</strong>cazione per Frassinetti deve arrivare a ―cattivarsi i cuori<br />
per poi ammollirli e piegarli e fare che vengano ad amare ciò che<br />
aborrivano, e ad aborrire ciò che amavano.(...). Bisogna non <strong>di</strong>menticare<br />
che tutti i cuori essendo fatti per amare, nessun linguaggio intendono cosí<br />
bene, come quello dell‘amore‖ 243.<br />
Il Frassinetti suggerisce al giovane clero <strong>di</strong> scegliere nel pre<strong>di</strong>care<br />
tutta la buona grazia <strong>di</strong> cui si è capaci, per attirare a sé l‘amore e la<br />
confidenza degli ascoltatori: un padre amorevole che parla ai suoi figli<br />
sempre per il loro bene. E qui è facilissimo scontrarsi e cozzare commossi<br />
con l‘immagine viva che il Frassinetti delinea <strong>di</strong> sé: non v'è dubbio che<br />
nello scrivere riguardo la «buona grazia» che deve accompagnare la<br />
pre<strong>di</strong>cazione, egli non suggerisse ciò che in prima persona e con pieno<br />
convincimento mettesse in pratica; non v‘è dubbio che non avesse provato,<br />
me<strong>di</strong>tato, vissuto ciò che espone come umile esortazione. È da notare<br />
ancora come il tono con cui si rivolge al giovane clero sia sempre zelante,<br />
242 Manuale del Parroco Novello, op. cit., p.141.<br />
243 Manuale del Parroco Novello, op. cit., p.141.<br />
153
accorato, coinvolgente: al Frassinetti sta a cuore la salvezza delle anime piú<br />
<strong>di</strong> ogni altra cosa ed impiega tutte le sue forze, tutte le sue possibilità, tutto<br />
il suo fervore per convincere il clero a lavorare in pienezza e totalità per il<br />
popolo: ―Dote in<strong>di</strong>spensabile al sacro oratore è l‘essere fervoroso.(...). È<br />
necessario che il parroco abbia viva fede, carità ardente, zelo svegliato,<br />
affinché la sua parola, essendo quasi <strong>di</strong> fuoco, commuova i cuori.(...).<br />
Ravviviamo la fede sull‘importanza della nostra pre<strong>di</strong>cazione, <strong>di</strong>retta a<br />
compiere gli eterni <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Dio quanto alla manifestazione della sua<br />
gloria, ed alla salvezza delle anime redente da Cristo; ravviviamo la fede del<br />
bene immenso che possiamo operare nella Chiesa, annunziando ai popoli<br />
la <strong>di</strong>vina parola‖ 244.<br />
In questo passaggio il nostro oratore si presenta incre<strong>di</strong>bilmente<br />
convincente; chiunque leggesse anche superficialmente queste pagine si<br />
renderebbe conto facilmente <strong>di</strong> quanta importanza Frassinetti caricasse la<br />
pre<strong>di</strong>cazione e con quanta profon<strong>di</strong>tà e fervore colorasse ogni singola<br />
espressione <strong>di</strong>retta al clero, con lo scopo <strong>di</strong> convincere <strong>di</strong> quale<br />
preziosissimo strumento si possiede per «fare miracoli»: la viva parola.<br />
Frassinetti si presenta rigorosamente delicato e prudente nel<br />
passaggio in cui espone le sue convinzioni riguardo la moderazione che<br />
deve usare il parroco nel proclamare le dottrine della morale cristiana 245. Il<br />
movimento con cui <strong>di</strong>pinge le pagine, ricche <strong>di</strong> argomenti semplici, <strong>di</strong> buon<br />
senso, facilmente assimilabili, dà vita ad un <strong>di</strong>scorso che spesso si tramuta<br />
in colloquio quasi confidenziale con il lettore, in specie con il giovane<br />
parroco, il quale necessariamente si sente catturato da simpatia verso chi<br />
parla <strong>di</strong> questioni cosí delicate con tanta affabilità.<br />
Il Frassinetti sembra far penetrare in modo misterioso le verità <strong>di</strong><br />
cui è convinto nel cuore stesso dello ascoltatore e riesce a formare<br />
convinzioni con enorme naturalezza. La Chiesa, sostiene il Frassinetti, ha<br />
sofferto il doppio flagello della rilassatezza da parte degli atei, e <strong>di</strong> rigore<br />
estremo da parte dei farisei: il primo spronava all‘empietà i già corrotti, il<br />
secondo spaventava anche i piú timorati; <strong>di</strong> conseguenza, mentre da una<br />
parte <strong>di</strong>lagava l‘irreligione, dall‘altra la religione stava <strong>di</strong>ventando quasi<br />
impraticabile. È cosa troppo grave per un accorato pre<strong>di</strong>catore come il<br />
Frassinetti che i «cultori della pietà» si affatichino a soffocare la pietà stessa.<br />
―Dio si è servito della penna <strong>di</strong> S. Alfonso per sconfiggere questo secondo<br />
flagello‖ 246. Ed è proprio lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> S. Alfonso che Frassinetti suggerisce<br />
al parroco novello.<br />
244 Manuale del Parroco Novello, op. cit., pp.149 e 150.<br />
245 Cfr. Manuale del Parroco Novello, op. cit., p. 163.<br />
246 Id., op. cit.,p. 164.<br />
154
Riguardo alla dottrina della morale cristiana, Frassinetti offre una<br />
serie <strong>di</strong> consigli che ancora una volta sottolineano la sua saggia esperienza<br />
<strong>di</strong> pre<strong>di</strong>catore consacrato al suo popolo. Ricorda al parroco che la cosa piú<br />
sacra al mondo, davanti alla ragione e alla fede è la verità: ―la sola verità<br />
deve enunciarsi e segnatamente quando si parli dalla cattedra della<br />
verità‖ 247. Il parroco, aggiunge, non è arbitro ma semplice espositore delle<br />
varie sentenze teologiche e <strong>di</strong> conseguenza non può comandare ai<br />
parrocchiani <strong>di</strong> credere al modo suo o <strong>di</strong> qualche suo moralista.<br />
I pre<strong>di</strong>catori rigorosi non fanno che allontanare dalla parola <strong>di</strong> Dio<br />
i traviati, e scoraggiare le anime pie. È necessario: moderazione, equilibrio e<br />
mitezza nell‘esposizione della dottrina cristiana; si devono insegnare le<br />
dottrine elementari e le conseguenze piú ovvie che ne derivano: ―I<br />
sottilizzatori non illuminano il popolo ma lo confondono, non tolgono i<br />
dubbi ma li moltiplicano. Voler insegnare al popolo teologia, sia dogmatica,<br />
sia morale, è vana impresa‖ 248.<br />
Forse ai nostri tempi tali consigli possono in parte risultare non<br />
attualizzabili; ma considerati in relazione alle necessità della fine<br />
dell‘ottocento, rappresentano senza dubbio uno stimolo valido per il clero;<br />
ancora una volta il Frassinetti immerso nel suo tempo, impegnato per il<br />
suo popolo, consacrato per la salvezza <strong>di</strong> tutti, si <strong>di</strong>mostra un valido<br />
ministro <strong>di</strong> Dio. La sua grandezza, sottolineo ancora, risiede proprio in<br />
questo: un sacerdote nel suo tempo, per il suo tempo, con il suo popolo.<br />
―La parola deve essere come spada, deve saper gridare e<br />
tuonare‖ 249. Il Frassinetti pre<strong>di</strong>catore seppe incarnare con animo generoso<br />
la sua chiamata ad essere «pastore», egli tuonò e gridò e ci auguriamo possa<br />
gridare ancora a lungo.<br />
BIBBLIOGRAFIA GENERALE<br />
FRASSINETTI G., Gesú Cristo regola del sacerdote, Opere Ascetiche, vol. II,<br />
Roma, 1975.<br />
FRASSINETTI G., Brevi parole ai sacerdoti fratelli, Opere Ascetiche, vol. II,<br />
Roma, 1975.<br />
FRASSINETTI G., Propositi fatti per sé e per alcuni amici, Opere Ascetiche, vol.<br />
II, Roma, 1975.<br />
247 Id., op. cit., p. 166.<br />
248 Manuale del Parroco Novello, op. cit., p.166.<br />
249 Gesú Cristo Regola del Sacerdote, O.A., vol II, p. 556.<br />
155
FRASSINETTI G., Riflessioni proposte agli ecclesiastici, Opere Ascetiche, vol. II,<br />
Roma, 1975.<br />
FRASSINETTI G., Manuale pratico del parroco novello, Ed. Paoline, Alba 1964.<br />
FRASSINETTI G., Compen<strong>di</strong>o della teologia morale <strong>di</strong> S. Alfonso <strong>Maria</strong> de’ Liguori,<br />
Società Ed. Internazionale, Torino 1947.<br />
GOFFI T., La spiritualità dell'ottocento, Ed. Dehoniane, Bologna 1989.<br />
OLIVARI C., Della vita e delle opere del Servo <strong>di</strong> Dio G. Frassinetti, Ed. Poliglotta<br />
Vaticana, Roma, 1928.<br />
VAILATI V., Un maestro <strong>di</strong> vita sacerdotale il Servo <strong>di</strong> Dio G. Frassinetti, Post.<br />
F.S.M.I., Roma 1977.<br />
Novizio Roberto Amici fsmi<br />
GIUSEPPE E PAOLA: FRATERNITÀ E SANTITÀ<br />
―L’amor <strong>di</strong> Dio non può star solo: deve <strong>di</strong> necessità<br />
aggiungersi con l’amore del prossimo. Questi due amori<br />
156
sono come due rivoli che muovono dalla stessa fonte, né<br />
l’uno può scompagnarsi dall’altro‖.<br />
(G. Frassinetti).<br />
SOMMARIO<br />
Introduzione<br />
In famiglia<br />
Il rapporto fraterno e l‘influsso reciproco<br />
Il rapporto apostolico: Don Giuseppe e le Dorotee<br />
Osservazioni sulla spiritualità<br />
Giuseppe e Paola: un carisma per i giovani<br />
Concludendo<br />
Riferimenti bibliografici<br />
INTRODUZIONE<br />
Genova, 1804/1868: la vita del Venerabile Servo <strong>di</strong> Dio Giuseppe<br />
Frassinetti si inscrive nel quadro <strong>di</strong> un‘età <strong>di</strong> transizione che ha fatto epoca,<br />
in una fase <strong>di</strong> grande travaglio politico e culturale e in un clima <strong>di</strong><br />
confusione e <strong>di</strong>sorientamento morale e spirituale. La tensione ideale dei<br />
giovani protagonisti della storia <strong>di</strong> quegli anni va alla ricerca <strong>di</strong> un nuovo<br />
modo <strong>di</strong> essere in una società che sta cambiando. Cosí, la chiesa genovese<br />
del secolo scorso consegna alla memoria dei posteri le figure, bellissime,<br />
dei suoi figli, pala<strong>di</strong>ni della fede ed eloquenti profeti dei tempi nuovi: S.<br />
Antonio <strong>Maria</strong> Gianelli, Gaetano Alimonda, Don Eugenio Fassicomo,<br />
Don Francesco Montebruno, P. Assarotti, Benedetta Cambiaggio, Eugenia<br />
Ravasco, Don Agostino Roscelli, Rosa Gattorno, Don Luigi Sturla, il<br />
«Padre santo» S. Francesco <strong>Maria</strong> da Camporosso, e molti altri. Fra loro, i<br />
fratelli Frassinetti: Don Giuseppe e <strong>Santa</strong> Paola, ―due cuori che si<br />
emulavano nell‘amore <strong>di</strong> Dio e dei prossimi –secondo una bella<br />
espressione <strong>di</strong> P. Persoglio- come già Benedetto e Scolastica, Francesco<br />
d‘Assisi e Chiara, Francesco <strong>di</strong> Sales e Giovanna <strong>di</strong> Chantal…‖<br />
La Provvidenza certamente tracciò per l‘uno e per l‘altra vie<br />
<strong>di</strong>verse, ma essi sempre furono intimamente uniti in un solo, luminoso<br />
ideale <strong>di</strong> santità: la gloria <strong>di</strong> Dio e la salvezza degli uomini.<br />
Del resto, <strong>Santa</strong> Paola fu «alunna e maestra» – secondo un<br />
sodalizio spirituale non estraneo a Sant‘Agostino, come nota il caro Padre<br />
Falasca, <strong>di</strong> Don Giuseppe. Lo stesso Card. Martini, presentando una<br />
recente biografia della <strong>Santa</strong>, scrive che ―se <strong>di</strong> una ricchezza si può parlare<br />
nella vita <strong>di</strong> Paola, fu quella <strong>di</strong> aver avuto vicino un fratello sacerdote come<br />
157
Giuseppe (il «Curato d‘Ars» <strong>di</strong> Genova), apostolo in cura d‘anime, teologo<br />
e moralista, formatore del giovane clero. Da lui Paola fu avviata alla vita<br />
spirituale e all‘apostolato …Una felice integrazione col sacerdozio<br />
ministeriale che arricchí entrambi…‖<br />
Anche nel corso del Processo Or<strong>di</strong>nario per la Canonizzazione del<br />
Servo <strong>di</strong> Dio, fra le testimonianze ha spiccato autorevolissima quella della<br />
sorella, quasi a riconfermare una profonda unione <strong>di</strong> cuore e <strong>di</strong> spirito che<br />
mai venne meno, e che oggi gode, ne siamo certi, della gloria <strong>di</strong> Dio nella<br />
comunione perfetta del Cielo.<br />
IN FAMIGLIA<br />
Vicolo <strong>di</strong>etro S. Paolo Vecchio, nei pressi <strong>di</strong> Campetto, si trova<br />
nel territorio della Parrocchia <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> delle Vigne in Genova: qui<br />
nacque Giuseppe Frassinetti. Paola nasce invece cinque anni dopo nel<br />
rione <strong>di</strong> Portoria, in Vico Chiuso <strong>di</strong> Perera, proprio <strong>di</strong>etro l‘antico<br />
Seminario Arcivescovile, a due passi dalla Via Giulia (l‘attuale Via XX<br />
Settembre). I Frassinetti, originari <strong>di</strong> Rivarolo, si trasferiranno <strong>di</strong> lí a non<br />
molto al n. 80 <strong>di</strong> Rivotorbido (Ponticello), sempre nella Parrocchia<br />
dell‘antichissima e gloriosa chiesa <strong>di</strong> S. Stefano.<br />
Giovanni Battista Frassinetti e Angela Viale ebbero altri nove figli,<br />
dei quali soltanto tre sopravvissero: Francesco, Giovanni e Raffaele.<br />
Papà «Giobatta», titolare <strong>di</strong> un negozietto in Borgo Lanaioli,<br />
temprato da una fede forte e saldamente ra<strong>di</strong>cata nella tra<strong>di</strong>zione, si occupò<br />
personalmente dell‘educazione dei figliuoli, comunicando loro tutta la sua<br />
austerità <strong>di</strong> vita, la sua <strong>di</strong>ffidenza dagli intrighi mondani e dai <strong>di</strong>vertimenti,<br />
il suo amore per il lavoro serio ed onesto.<br />
Mamma Angela, pia e dolcissima, pervase il clima <strong>di</strong> casa con la<br />
sua mitezza, la sua devozione alla Vergine e la sua de<strong>di</strong>zione alla famiglia e<br />
alla causa del Signore, tanto che trasmise a tutti i suoi cinque figli – e ad un<br />
sesto cui fece da balia - la volontà <strong>di</strong> consacrarsi. Accanto a lei Paola<br />
crebbe in pietà, purezza e semplicità, e apprese quell‘amore al sacrificio e<br />
quello spirito <strong>di</strong> servizio che ne faranno una donna tenera e forte.<br />
All‘età <strong>di</strong> sei anni, la vigilia dell‘Assunta, Paola viene consacrata al<br />
cuore <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, nel Santuario della Madonnetta sull‘altura della Carbonara,<br />
secondo una tra<strong>di</strong>zione dei genovesi; cinque anni prima, Giuseppe aveva<br />
fatto altrettanto: è il primo segno che accomuna i due fratelli in una<br />
singolare appartenenza alla Madre Celeste. Giuseppe sempre ricorderà con<br />
affetto quel gesto e lo ripeterà con i fanciulli che il Signore gli affiderà nel<br />
tempo. Anche i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> mantennero fede all‘usanza per anni,<br />
158
iconoscendo in quel momento significativo una grazia tutta particolare che<br />
li univa al Fondatore.<br />
L‘Epifania del 1819 segna una svolta in casa Frassinetti: la<br />
scomparsa prematura della madre costringe i due fratelli ad una precoce<br />
responsabilizzazíone. Giuseppe, figlio maggiore, deve affiancare il padre<br />
nella conduzione della famiglia; Paola, unica donna in casa (a parte la<br />
presenza temporanea e comunque poco determinante della zia Anna), si<br />
trova a dover accu<strong>di</strong>re cinque uomini e a «far da mamma» ai fratellini piú<br />
piccoli.<br />
Risale forse a quest‘epoca il sodalizio tra Giuseppe e Paola, la loro<br />
amicizia reciproca e duratura: la necessità <strong>di</strong> far fronte alla morte della<br />
mamma stabilí fin da allora un legame piú intimo e stretto fra loro e quella<br />
profonda intesa nel segno della quale vivranno la loro eccezionale<br />
fraternità.<br />
Non a caso è la sorella a lasciarci del giovane Giuseppe il ritratto<br />
piú caro e piú nitido: ―focosissimo ma sempre incline alla pietà… vivace sí,<br />
ma risoluto a non commettere mai peccato alcuno…‖<br />
In famiglia Paola e Giuseppe fanno prima, vera esperienza <strong>di</strong><br />
obbe<strong>di</strong>enza alla vita e <strong>di</strong> carità, e si aprono allo zelo apostolico. Casa<br />
Frassinetti è anche fonte dell‘ideale, instancabilmente coltivato dal Servo <strong>di</strong><br />
Dio, della vita religiosa «al secolo», che sperimenterà anzitutto sulla sorella<br />
e le sue compagne.<br />
Paola, del resto, ancora bambina, viene istruita dal fratello nelle<br />
verità celesti: spesso egli la prende in <strong>di</strong>sparte per parlarle delle cose <strong>di</strong> Dio,<br />
con semplicità e pazienza. Da quei <strong>di</strong>scorsi ascoltati mentre lavava i piatti o<br />
riassettava la cucina, Paola apprese la grandezza e le meraviglie del Signore.<br />
Giuseppe stava «cesellando» l‘anima della sorella e imparava a<br />
conoscerne l‘ardore, e quando, parroco a Quinto al Mare, con il pretesto<br />
dell‘aria buona per il suo esaurimento, la chiama a vivere con sé, intuendo il<br />
suo carisma per la cura delle giovani, non sbaglia: Paola si rivela presto<br />
un‘educatrice nata, ne sono primi frutti le fedeli compagne, tra cui le<br />
primissime che con lei si consacreranno: Teresa Albino e <strong>Maria</strong>nna<br />
Danero.<br />
IL RAPPORTO FRATERNO E L’INFLUSSO RECIPROCO<br />
―Le fanciulle cristiane –scriveva il Frassinetti- sono certamente<br />
considerate le piú inette alle opere dello zelo apostolico; ciò nonostante …<br />
159
le ve<strong>di</strong>amo in tanta parte emulare coloro che sono <strong>di</strong>rettamente assunti<br />
all‘apostolico ministero‖.<br />
Era, in certe sue implicazioni, un‘affermazione dai risvolti «rivoluzionari».<br />
Ma Giuseppe Frassinetti, fin da quand‘era parroco a Quinto, e poi<br />
quando <strong>di</strong>venne Priore in S. Sabina, concepí, avviò e sviluppò molte forme<br />
nuove <strong>di</strong> pastorale femminile, e da questa <strong>di</strong>mensione della sua vasta<br />
attività sacerdotale molti scritti scaturirono nel corso degli anni.<br />
Sicuramente per lui, la vicinanza della «dolce e forte Paola» fu motivo <strong>di</strong><br />
riflessione circa un nuovo ruolo della donna nella Chiesa – cosí <strong>di</strong>verso da<br />
quello pensato e attuato, per esempio, da Don Bosco negli stessi anni.<br />
Ma S. Paola non è soltanto l‘ispiratrice e il prototipo<br />
dell‘apostolato al femminile del Frassinetti: ella gli è ―maestra –scrive Padre<br />
Falasca circa- il modo <strong>di</strong> esporre il messaggio <strong>di</strong> salvezza e renderlo<br />
comprensibile ed efficace per persone semplici e <strong>di</strong> poco o nessuno<br />
stu<strong>di</strong>o‖.<br />
Il debito <strong>di</strong> Paola nei confronti del fratello, specialmente per<br />
quanto concerne la sua formazione, è anche piú sostanzioso. Suor Matilde<br />
Neirotti, in un suo articolo per il centenario della morte del Servo <strong>di</strong> Dio,<br />
lo definisce felicemente ―il Cherubino che ha formato una Serafina della<br />
Croce‖.<br />
È noto come Paola abbia ricevuto gran parte della sua educazione<br />
in casa, ascoltando in un silenzio attivo e intelligente gli argomenti <strong>di</strong><br />
Teologia e <strong>di</strong> Morale dì cui gli uomini <strong>di</strong> casa, in particolare Giuseppe e il<br />
padre suo, andavano <strong>di</strong>scorrendo ad ogni ora. Ella stessa ammette <strong>di</strong> aver<br />
imparato in quel modo ―piú che da ogni altro libro‖, e proprio le sue<br />
«Memorie» attestano come ―sui quaderni vecchi scartati dai fratelli ella<br />
impara a scrivere e a formar lettere…‖<br />
Anche il celebre motto della sua vita per il Signore, «Volontà <strong>di</strong><br />
Dio, Para<strong>di</strong>so mio»!, sembra ricalcarsi su un‘altra frase cara a Giuseppe:<br />
«Nel fare la volontà <strong>di</strong> Dio è la nostra pace».<br />
E poi Don Giuseppe è il grande apostolo della vita consacrata e la<br />
vocazione della sorella matura e si realizza grazie a lui: la santità <strong>di</strong> Paola si<br />
è accesa dal cuore <strong>di</strong> lui e la sua missione le è stata rivelata dal fratello,<br />
nell‘iniziativa, nata nella canonica <strong>di</strong> Quinto, <strong>di</strong> una scuola alla buona per le<br />
fanciulle povere.<br />
Il filo che lega Paola e Giuseppe resiste, anzi si rinsalda, quando<br />
lei, Fondatrice <strong>di</strong> un Istituto fecondo in opere e vocazioni, si trasferisce a<br />
Roma (1841): ella si trova nella capitale della Cristianità, ma il suo cuore è<br />
ancora a Genova…<br />
Risale a quegli anni la fitta corrispondenza con Giuseppe:<br />
l‘epistolario che ci è pervenuto consta <strong>di</strong> una quarantina <strong>di</strong> lettere<br />
160
in<strong>di</strong>rizzate dalla <strong>Santa</strong> al fratello (non ci sono state conservate quelle <strong>di</strong><br />
Don Giuseppe alla sorella, purtroppo: probabilmente lei, assai piú sbrigativa<br />
del fratello e dotata <strong>di</strong> un notevole senso pratico, le ha tolte <strong>di</strong> mezzo<br />
dopo averle lette e prima che potessero esserle d‘impiccio!).<br />
Il rapporto epistolare è la prova <strong>di</strong> quanto i due fratelli sapessero<br />
vivere la «vicinanza» reciproca nonostante le <strong>di</strong>stanze; quel linguaggio,<br />
forse proprio per la sua imme<strong>di</strong>atezza e la sua spontaneità, penetra subito<br />
nell‘anima: quelle frasi concise, ―nella semplicità <strong>di</strong> uno stile robusto e<br />
insieme soffuso <strong>di</strong> tenerezza‖, sono testimoni <strong>di</strong> una mistica intimità<br />
(Renzi).<br />
Da Roma Paola scrive spesso al fratello. Anche quando i suoi<br />
impegni <strong>di</strong> Generale non le consentono <strong>di</strong> comunicare con gli altri cari<br />
lontani, sembra non voler rinunciare all‘incontro con Giuseppe: magari<br />
poche righe, o due notiziole da nulla! Gli confida le sue speranze e le sue<br />
preoccupazioni e si affida con trepidazione alle sue preghiere: lui, <strong>di</strong>ce, è il<br />
suo «avvocato presso Dio».<br />
Continuamente gli raccomanda la cura delle sue figlie nelle case <strong>di</strong><br />
Genova e Rivarolo e lo prega <strong>di</strong> ―animarle…e coltivarle, facendo loro<br />
qualche esortazione‖.<br />
Giuseppe è anche per Paola il me<strong>di</strong>atore per tutti i suoi affari in<br />
Genova e, attraverso <strong>di</strong> lui, raggiunge gli altri parenti e i familiari lontani.<br />
Non <strong>di</strong> rado lo delega per le questioni materiali ed economiche delle sue<br />
Opere liguri e gli chiede <strong>di</strong> ―prendersi un poco <strong>di</strong> pensiero delle cose loro e<br />
<strong>di</strong> scriverle che cosa gli pare che si possa fare‖.<br />
Paola riconosce quanto giusti siano i consigli del fratello e quanto<br />
preziosi siano i suoi suggerimenti, ma il loro rapporto è anche molto<br />
franco: quando ritiene che lui sia in errore (come a proposito del<br />
rimprovero ricevuto in seguito all‘allontanamento del Passi, a <strong>di</strong>re il vero<br />
«un po‘ impiccione»), non esita a manifestargli il suo <strong>di</strong>saccordo, con molta<br />
libertà come tra fratelli, come tra amici! Ma ogniqualvolta le vengano a<br />
mancare gli appoggi piú importanti e gli affetti piú cari, ricorre subito a<br />
Giuseppe, suo costante punto <strong>di</strong> riferimento. Alla morte del padre (1853), è<br />
proprio Giuseppe a comunicarle la triste notizia: in questi frangenti<br />
dolorosi, sempre Paola sa superare ogni lontananza tramite una fervida<br />
preghiera, segno <strong>di</strong> intima comunione con i suoi cari e <strong>di</strong> irriducibile<br />
affetto.<br />
La morte del fratello, fulminato da una polmonite nel 1868, fu per<br />
Paola la prima croce <strong>di</strong> quell‘anno terribile. Giuseppe entrava ricco nel<br />
«Convito del Divino Amore»… E Paola tacque, ma lo compianse nel<br />
segreto del suo cuore: si erano amati da santi, in modo tenerissimo e<br />
sublime. Paola sempre riconobbe nel fratello lo strumento attraverso il<br />
161
quale Dio le aveva permesso <strong>di</strong> realizzare la sua vocazione, e <strong>di</strong> ciò gli era<br />
infinitamente grata.<br />
Poche volte da allora parlò <strong>di</strong> lui, e solo con chi la conosceva bene<br />
e la capiva fino in fondo. In una lettera <strong>di</strong>ce: ―Nel cuore sento una certa<br />
fiducia che sia già in cielo a bene<strong>di</strong>re Id<strong>di</strong>o‖ e scrivendo, proprio nel<br />
Febbraio 1868, a Madre Giuseppina Bozzano: ―…a volte sono quasi<br />
costretta a raccomandargli le cose mie‖. Un‘estrema conferma che il loro<br />
vincolo spirituale e apostolico non conobbe arresti neppure <strong>di</strong> fronte alla<br />
morte.<br />
IL RAPPORTO APOSTOLICO:<br />
DON GIUSEPPE E LE DOROTEE<br />
La straor<strong>di</strong>naria comunione fraterna e il mirabile sodalizio apostolico<br />
tra Paola e Giuseppe si realizza eminentemente nei primor<strong>di</strong> della<br />
Congregazione delle Suore dì S. Dorotea e nel suo rapido sviluppo.<br />
Quando Paola, in quel <strong>di</strong> Quinto, matura l‘aspirazione alla vita<br />
consacrata, si muove secondo le <strong>di</strong>rettive sapienti del fratello parroco, il<br />
quale sulle prime applica alla sorella e alle sue do<strong>di</strong>ci compagne, da lui<br />
stesso selezionate fra le numerose vocazioni che il buon Dio suscitava<br />
attorno a quella giovinetta, i criteri pensati per le religiose «nel mondo». Le<br />
ragazze vivevano come «monache in casa» e si radunavano nei giorni festivi<br />
nell‘Oratorio <strong>di</strong> S. Pantaleo: qui Don Giuseppe teneva loro ―ragionamenti<br />
alla buona sulla vita religiosa‖.<br />
E quando, dopo numerosi travagli e dure prove, la sorella mostra<br />
il fermo desiderio <strong>di</strong> realizzare un Istituto proprio, è ancora Don Giuseppe<br />
a stu<strong>di</strong>are l‘iniziativa con lo Sturla e il Padre Bresciani; lui <strong>di</strong>venne primo<br />
<strong>di</strong>rettore, consigliere e guida dell‘Istituto nascente, lui scrisse, in preghiera<br />
con Paola e le altre <strong>di</strong>nanzi al Santissimo, il primo regolamento (1834) delle<br />
«<strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> S. Fede» (il prezioso documento è andato perduto, ma<br />
presumibilmente si può trovar traccia dello spirito che lo animava nella<br />
Regola delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> <strong>di</strong> Mornese. Piú tar<strong>di</strong> Paola<br />
riscriverà le Costituzioni del suo Istituto (Roma, 1851), traducendo e<br />
riadattando a fatica il modello gesuitico delle «Dame del Sacro Cuore»;<br />
tuttavia non ne vide mai la approvazione completa); e fu sempre lui a<br />
celebrare l‘Eucarestia, il 12 Agosto del 1834, nella chiesa <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Chiara in<br />
S. Martino d‘Albano, per le quattro «bianche colombe» che per prime<br />
emisero i voti; e lui stesso procurò alle suorine la loro primissima residenza,<br />
una modesta casetta nei pressi <strong>di</strong> Quinto.<br />
162
La collaborazione ha subito inizio: nell‘estate del 1835 scoppia a<br />
Genova un‘epidemia <strong>di</strong> colera, e le <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> S. Fede, in prima fila con Don<br />
Giuseppe, incuranti del pericolo e mosse da eroica carità, accorsero ai letti<br />
dei malati.<br />
Paola nel 1838 accoglie le proposte <strong>di</strong> Don Luca Passi,<br />
instancabile promotore dell‘Opera <strong>di</strong> S. Dorotea in tutt‘Italia, e muta il<br />
nome della Congregazione in quello <strong>di</strong> «Suore Maestre <strong>di</strong> S. Dorotea»: il<br />
fratello inizialmente non ne è entusiasta, ma ella ebbe sempre un carattere<br />
spigliato, tanto da tener fuori dall‘organizzazione del suo Istituto, quando<br />
lo avesse ritenuto opportuno, tanto il Passi quanto il Frassinetti. Lo stesso<br />
Giuseppe lo riconosceva: ―mia sorella mi viene sempre a chiedere<br />
consiglio, ma poi fa <strong>di</strong> testa sua … però devo ammettere che ci azzecca!‖.<br />
Paola nutre le sue suore e le sue allieve con i libretti che Don<br />
Giuseppe andava scrivendo e pubblicando con successo ed in grande<br />
numero: spessissimo gli scrive da Roma per farsene spe<strong>di</strong>re quante piú<br />
copie gli è possibile, per il fabbisogno spirituale delle sue ragazze.<br />
Per loro il Frassinetti compone anche un «Libretto <strong>di</strong> pie<br />
considerazioni e canzoncine spirituali»: le suore ne leggevano una massima<br />
ad ogni ora del giorno, da ruminare tra sé e sé durante il lavoro (e quest‘uso<br />
è ancora attestato nella pratica del Noviziato nell‘anno 1934/35!).<br />
Del resto, le fonti per l‘alimentazione della vita interiore e il<br />
nutrimento dell‘anima sono proprio quelle pre<strong>di</strong>lette dal Priore <strong>di</strong> S.<br />
Sabina: le «Me<strong>di</strong>tazioni» del Venerabile Ludovico da Ponte, le opere <strong>di</strong> S.<br />
Teresa <strong>di</strong> Gesú, quelle <strong>di</strong> S. Giovanni della Croce e la «Imitazione <strong>di</strong><br />
Cristo» <strong>di</strong> Tomaso da Kempis. Anche molte giaculatorie preferite dal<br />
Frassinetti passano nell‘uso delle Suore <strong>di</strong> S. Dorotea e vi permangono a<br />
lungo.<br />
Sorprendente è l‘affinità riscontrabile da una comparazione delle<br />
Regole dell‘Istituto delle Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea con quelle compilate dal<br />
Frassinetti per il Giovane Clero, in or<strong>di</strong>ne alla cura quoti<strong>di</strong>ana dello spirito:<br />
o un‘ora <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tazione<br />
o mezz‘ora <strong>di</strong> lettura spirituale<br />
o un quarto d‘ora <strong>di</strong> adorazione eucaristica<br />
o comunione frequente<br />
o esame <strong>di</strong> coscienza serale<br />
o mortificazione del sabato in onore della Vergine<br />
Ma il Servo <strong>di</strong> Dio non solo dà l‘avvio e l‘impronta della sua<br />
spiritualità alla nuova Istituzione: egli partecipa <strong>di</strong>rettamente anche allo<br />
sviluppo dell‘Istituto, nelle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> governo e nella gestione degli affari<br />
economici. Paola gli affida, per esempio, la ven<strong>di</strong>ta della casa delle Grazie<br />
in Genova, gli spe<strong>di</strong>sce perio<strong>di</strong>camente minuto resoconto della sua<br />
163
situazione in Roma, si consiglia con lui, specialmente per l‘andamento<br />
dell‘Opera in Genova (ve<strong>di</strong> la riapertura della Casa <strong>di</strong> via S. Nazaro dopo i<br />
moti del 48/49); ella sempre chiede il parere del fratello riguardo le novità,<br />
le iniziative e le proposte che riceve (per esempio, circa l‘apertura <strong>di</strong> una<br />
Comunità a Firenze, voluta dal Passi), lo sollecita affinché le <strong>di</strong>ca ―quello<br />
che crede meglio per la maggior gloria <strong>di</strong> Dio e a vantaggio dell‘Istituto‖, e<br />
non raramente gli lascia carta bianca, perché faccia ―ciò che è utile e<br />
necessario‖.<br />
L‘ultimo commiato del Venerabile dalla Congregazione delle<br />
Dorotee fu quella visita all‘Opera delle «Artigianelle» che le suore avevano<br />
aperto in Carignano; ormai avanti negli anni e tanto benemerito davanti<br />
agli uomini e al cospetto <strong>di</strong> Dio, Giuseppe gioí nel vedere realizzata, per<br />
mano <strong>di</strong> Paolina, un‘istituzione che lui stesso aveva a lungo sognato: fu<br />
l‘estremo segno <strong>di</strong> una consonanza <strong>di</strong> sentire e <strong>di</strong> volere che<br />
contrad<strong>di</strong>stinse tutto il suo rapporto con la sorella santa.<br />
E Paola, ormai Fondatrice e anima <strong>di</strong> un grande istituto e Madre<br />
<strong>di</strong> innumerevoli figlie, guarda al piccolo seme <strong>di</strong>venuto «albero immenso»,<br />
ed elevando la sua lode a Dio certamente serba in cuore una profonda<br />
gratitu<strong>di</strong>ne per l‘amato fratello.<br />
OSSERVAZIONI SULLA SPIRITUALITÀ<br />
La spiritualità <strong>di</strong> S. Paola, donna energica e perseverante nella<br />
sequela del Cristo, coerente e fedele al mandato ricevuto, eppur dolcissima<br />
e soave nella sua de<strong>di</strong>zione all‘opera <strong>di</strong> Dio e nella materna cura delle figlie<br />
sue, è in parte non trascurabile un prodotto dell‘attentissimo zelo pastorale<br />
del fratello sacerdote, che tanto influí sulla sua formazione giovanile e sulla<br />
fondazione del suo istituto.<br />
Paola incarna, fin dai primi tempi <strong>di</strong> Quinto, la dottrina<br />
frassinettìana della «verginità consacrata e dell‘arte <strong>di</strong> farsi santi» vivendo<br />
nel mondo la propria castità per il Regno (cfr. «La gemma delle fanciulle<br />
cristiane», «Il Para<strong>di</strong>so in terra nel celibato cristiano», «La monaca in casa»,<br />
«Il religioso al secolo» e le Pie Opere ed Unioni fondate dal Frassinetti:<br />
<strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> S. Fede, <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>,<br />
ecc.).<br />
Anche la splen<strong>di</strong>da virtú della povertà le fu certamente ispirata<br />
dallo spirito <strong>di</strong> umiltà e mortificazione <strong>di</strong> Don Giuseppe, che ella stessa<br />
tratteggiò in una sua «Memoria intorno alla vita del fratello».<br />
Negli Atti del Processo Or<strong>di</strong>nario del Servo <strong>di</strong> Dio si legge che<br />
―imitando il poverello <strong>di</strong> Assisi, alla cui milizia era ascritto come terziario,<br />
164
Giuseppe Frassinetti mostrò grande amore per l‘eccelsa virtú della Povertà:<br />
era la stessa virtú che le Costituzioni delle «Suore <strong>di</strong> S. Dorotea» del 1889<br />
chiamavano: il muro piú saldo del nostro Istituto‖.<br />
Lo stesso si <strong>di</strong>ca dello spirito <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza alla vita e alla volontà<br />
del Signore, che segnò l‘infanzia dei due fratelli e li mantenne simili ed uniti<br />
in ogni vicenda della loro avventura apostolica; si manifesta in uno<br />
spiccatissimo amore per la Passione e la Croce <strong>di</strong> Cristo e in una devozione<br />
tenerissima al Gesú sofferente ed offerente (lo testimonia anche<br />
l‘assunzione, da parte delle suore, della «Divozione alle cinque piaghe <strong>di</strong><br />
Nostro Signore» e della «Pia offerta del Sangue <strong>di</strong> Gesú all‘Eterno Padre»,<br />
entrambe usate dal Frassinetti); parimenti si esprime in quell‘ardentissimo<br />
zelo per la <strong>di</strong>fesa e la <strong>di</strong>ffusione della fede che Don Giuseppe trasmise alla<br />
sorella (non a caso, le prime suore ebbero il nome <strong>di</strong> «<strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> S. Fede»!) e<br />
in quella fiducia fermissima e chiarissima fedeltà al Papa e alla Chiesa <strong>di</strong><br />
Roma, che fu tipica del robusto insegnamento <strong>di</strong> Giuseppe (che tanto si<br />
accalorava e si esponeva per <strong>di</strong>fendere il Sommo Pontefice dalle insi<strong>di</strong>ose<br />
polemiche del tempo): l‘amicizia <strong>di</strong> S. Paola con Pio IX ne fu testimonianza<br />
bellissima.<br />
Don Giuseppe trovò nella sorella anche la prima trasparente interprete<br />
<strong>di</strong> quel culto perpetuo del SS.mo Sacramento e <strong>di</strong> quella amorosa<br />
frequenza alla Comunione Eucaristica <strong>di</strong> cui, in tempi <strong>di</strong> Giansenismo, egli<br />
si era fatto apostolo instancabile (cfr. «Dissertazione sulla Comunione<br />
quoti<strong>di</strong>ana», «Il Convito del Divino Amore» ecc.).<br />
Non si può tacere dell‘amore profondo e filiale alla Madonna, che<br />
si espresse nell‘uno e nell‘altra come sigillo della loro consacrazione. <strong>Maria</strong><br />
è per Giuseppe e Paola la Madre (che loro mancò tanto presto) e il modello<br />
<strong>di</strong> una adesione generosa ed incon<strong>di</strong>zionata, silenziosa eppur salvifica, della<br />
creatura al <strong>di</strong>segno del Padre. Amavano molto la Vergine Addolorata (la<br />
recita quoti<strong>di</strong>ana della «Coroncina dei Sette Dolori <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>» appartiene alle<br />
prime regole dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> e delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, come pure a quelle<br />
delle Suore <strong>di</strong> S. Dorotea) ed entrambi esultarono per la proclamazione dei<br />
Dogma dell‘<strong>Immacolata</strong> Concezione, <strong>di</strong> cui serbarono sempre tenero e<br />
geloso ricordo.<br />
Cosí, quando Paola, dopo trentacinque anni <strong>di</strong> assenza, fa ritorno<br />
alla città natale (1876), lascia un segno tangibile della sua visita facendo<br />
apporre nel giar<strong>di</strong>no della Casa <strong>di</strong> Albaro una statua della <strong>Immacolata</strong>. E le<br />
«Memorie» riportano che a Lourdes, in viaggio verso il Portogallo, dove<br />
alcune suore erano missionarie da anni, la Fondatrice si fermò due giorni,<br />
―standosene quanto piú possibile nella santa grotta‖; non solo, ma le ultime<br />
parole <strong>di</strong> S. Paola sembrano essere state proprio un affettuoso appello alla<br />
Madre Celeste: ―Madonnina mia, ricordatevi che sono vostra figlia‖.<br />
165
GIUSEPPE E PAOLA: UN CARISMA PER I GIOVANI<br />
È bello constatare come il Buon Dio abbia anche unito i due<br />
fratelli nella missione, facendoli depositari <strong>di</strong> un carisma dello Spirito che i<br />
rispettivi Istituti sono chiamati a continuare.<br />
Come il programma pastorale <strong>di</strong> Don Giuseppe ebbe sempre un<br />
occhio <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>lezione per le necessità dei giovani, attraverso un‘opera <strong>di</strong><br />
istruzione, evangelizzazione ed orientamento vocazionale, cosí Paola si<br />
de<strong>di</strong>cò alla cura delle ragazze (uno dei settori scoperti <strong>di</strong> servizio e <strong>di</strong><br />
azione, pur in un secolo eccellente nel <strong>di</strong>ffondere i «lumi» della scienza).<br />
I Frassinetti furono ben consapevoli che ―i poveri non hanno solo<br />
bisogno <strong>di</strong> pane, ma <strong>di</strong> istruzione, <strong>di</strong> educazione‖, e si fecero promotori <strong>di</strong><br />
scuole popolari per la gioventú (questo è il motivo per cui Giuseppe<br />
chiama Paola a Quinto, lui che sempre desiderò realizzare ―…un‘Unione <strong>di</strong><br />
giovani ecclesiastici, che… si de<strong>di</strong>cassero in modo speciale a coltivare i<br />
giovani‖) e quando Paola scrive: ―giacché i cattivi si affaticano tanto per<br />
corrompere la gioventú, noi cerchiamo <strong>di</strong> salvarne piú che possiamo‖,<br />
espone un programma che non è soltanto suo.<br />
Cosí, nella Quaresima del 1829, il celebre Don Luca Passi,<br />
giungendo a Genova non poteva non trovare presso i Frassinetti un<br />
terreno fertile per la sua «Opera <strong>di</strong> S. Raffaele e <strong>di</strong> S. Dorotea»: Don<br />
Giuseppe, accogliendo l‘iniziativa, fece salire i giovinetti del catechismo da<br />
50 a 700 (!) e le «Dorotee» <strong>di</strong> Paola <strong>di</strong>vennero presto «albero gigantesco»,<br />
che estendeva i suoi rami anche oltre Oceano!<br />
CONCLUDENDO<br />
Conoscere S. Paola Frassinetti, per noi <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, vuol <strong>di</strong>re<br />
scoprire in tutta la sua freschezza e la sua bellezza quell‘intimo connubio<br />
che costantemente la legò al fratello Giuseppe, nostro Venerabile<br />
Fondatore, e lasciarci illuminare dal loro rapporto fraterno vissuto nella<br />
reciprocità e nella santità.<br />
Ma parlare <strong>di</strong> Giuseppe e Paola significa anche parlare <strong>di</strong> «<strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Maria</strong>» e «Suore <strong>di</strong> S. Dorotea», focalizzare le origini comuni dei nostri<br />
Istituti, constatarne l‘affinità <strong>di</strong> carismi e, alla luce del meraviglioso<br />
cammino dei due fratelli, congiunti nel <strong>di</strong>segno unitario del Padre,<br />
rivalutarne la vicinanza e la speciale comunione «fraterna»!<br />
166
Il Buon Dio bene<strong>di</strong>ca le nostre Famiglie Religiose e ci conceda <strong>di</strong><br />
poter testimoniare quei due fratelli, che –come scrisse il nostro P. Renzi-<br />
―ora camminano insieme per i sentieri fioriti del Cielo, lei già avvolta nello<br />
splendore del nimbo dei santi, e lui che forse sorriderà del nostro lavoro<br />
qui in terra affinché quel medesimo nimbo coroni il suo volto‖.<br />
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI<br />
OLIVARI CARLO, Il Servo <strong>di</strong> Dio Sacerdote Giuseppe Frassinetti, Roma,<br />
Tip. Poliglotta Vaticana, 1928.<br />
FALDI EMILIO FELICE, Il Priore <strong>di</strong> S.Sabina…., Sc. Grafica Dori,<br />
Genova Sampierdarena, 1967.<br />
ROSSETTO ROSA, Paola Frassinetti in punta <strong>di</strong> pie<strong>di</strong>, Ed. Messaggero<br />
Padova, 1984.<br />
G. LUBICH, P. LAZZARIN, Paola Frassinetti una donna, Città Nuova<br />
ed., 1980.<br />
a cura TERESA SOMMARIVA e MARGHERITA MASYN, Memorie<br />
intorno alla Venerabile Serva <strong>di</strong> Dio Paola Frassinetti e all’Istituto da lei<br />
fondato, Roma, 1908.<br />
a cura JOLE TESEI, Documenti relativi alla presenza del Frassinetti nei<br />
primor<strong>di</strong> della Congregazione <strong>di</strong> S. Dorotea (spirito e storia), Genova 1968,<br />
ms. ine<strong>di</strong>to.<br />
GIUSEPPE FRASSINETTI, Opere Ascetiche (2 voll..), Postulaz.<br />
Generale F.S.M.I., Roma 1978.<br />
PAOLA FRASSINETTI, Lettere, Congreg. Suore <strong>di</strong> S. Dorotea della<br />
Frassinetti, Roma 1985.<br />
Costituzioni e regole dell’Istituto Religioso delle Suore Maestre <strong>di</strong> S. Dorotea,<br />
Roma, 1851.<br />
Archivio Frassinettiano Vol. 1, pro-manuscripto, Roma 1967.<br />
GIORDANO RENZI, Paola e Giuseppe Frassinetti: annotazioni da un<br />
epistolario ine<strong>di</strong>to, in «Il Citta<strong>di</strong>no» 23-X-1973.<br />
MANFREDO FALASCA, S. Paola Frassinetti alunna e maestra del fratello<br />
Giuseppe, in «Risonanze» 1991/1.<br />
MATILDE NEIROTTI, L’aquila <strong>di</strong> Genova, in «S. Dorotea» 1968/1.<br />
MATILDE NEIROTTI, Paola Frassinetti a Genova,…<br />
Congregatio de Causis Sanctorum: Canonizationis Servi Dei Pauli<br />
Josephi <strong>Maria</strong>e Frassinetti…, Relatio et Vota Congressus peculiaris<br />
167
super virtutibus, Romae 1990.<br />
Articoli sulla vita e virtú del Servo <strong>di</strong> Dio G. Frassinetti presentati<br />
al Processo Or<strong>di</strong>nario, 1916.<br />
Novizio Daniele Bruzzone fsmi<br />
IL PRIMATO DELL’INTERIORITÀ<br />
NELLA PEDAGOGIA PASTORALE DI GIUSEPPE<br />
FRASSINETTI<br />
168
SOMMARIO<br />
Introduzione<br />
1. Il primato dell‘interiorità<br />
2. Mezzi per costruire l‘interiorità<br />
3. Il desiderio della santità: una dottrina completa<br />
4. Spunti pedagogici e vocazionali<br />
INTRODUZIONE<br />
Il primato dell‘interiorità nella pedagogia pastorale del Frassinetti.<br />
Perché la scelta <strong>di</strong> questo tema?<br />
Giuseppe Frassinetti nella sua azione sacerdotale e pastorale può<br />
essere definito un «suscitatore <strong>di</strong> carismi» 250, considerati come<br />
prolungamento ed espressione della fondamentale vocazione cristiana alla<br />
santità, intesa come pienezza dell‘amore.<br />
Il Pastore e il Teologo spirituale e morale si incontrano in questa<br />
preoccupazione fondamentale: costruire una coscienza cristiana fondata<br />
sull‘interiorità, che – come vedremo – si alimenta della presenza dell‘amore<br />
<strong>di</strong> Dio, un fuoco che genera e suscita la <strong>di</strong>namica del desiderio. Il desiderio,<br />
poi, costituisce una dottrina completa e complessa, ricca <strong>di</strong> fermenti<br />
pedagogici e vocazionali. Dal desiderio infatti scaturisce la scintilla della<br />
decisione vocazionale, luogo <strong>di</strong> incontro fra il desiderare dell‘uomo e il<br />
desiderare <strong>di</strong>vino.<br />
1. IL PRIMATO DELL’INTERIORITÀ<br />
Negli scritti destinati ai laici, soprattutto ai giovani, e in quelli<br />
de<strong>di</strong>cati al clero emerge un dato costante: il primato accordato<br />
all‘interiorità.<br />
In «Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú» 251, una<br />
nota pastorale del 1851 destinata alle adolescenti che si incamminano nella<br />
250 L’espressione non è mia, ma <strong>di</strong> Suor Roberta Frati, stu<strong>di</strong>osa <strong>di</strong> Rosa<br />
Gattorno.<br />
251 G. FRASSINETTI, Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> una figlia che vuole essere tutta <strong>di</strong> Gesú e<br />
compen<strong>di</strong>o della dottrina spirituale del B. Giovanni Colombini, Genova,<br />
Tip. Ligustico 1851.<br />
169
via della perfezione cristiana, e in «Gesú Cristo, regola del Sacerdote» 252,<br />
dell‘anno successivo, il Priore esor<strong>di</strong>sce ponendo come fondamento del<br />
cammino ascetico e apostolico i «ricor<strong>di</strong> per l‘interiore».<br />
Scrive alle giovani:<br />
―Il vostro cuore consideratelo come un tabernacolo […] dove egli<br />
starà notte e giorno colla sua <strong>di</strong>vina presenza, me<strong>di</strong>ante la sua<br />
grazia‖ 253.<br />
E ai sacerdoti circa la vita interiore:<br />
―Tu devi essere uno specchio immacolato ed un‘immagine della mia<br />
bontà‖ 254.<br />
Il centro e il cuore della vita interiore è dunque l‘amore <strong>di</strong> Dio<br />
in noi che ci rende ―specchio e immagine della sua bontà‖ 255.<br />
Il tema dell‘interiorità - è bene notarlo subito - è affrontato<br />
dall‘Autore attingendo alla piú genuina tra<strong>di</strong>zione cristiana, senza alcuna<br />
contaminazione con il soggettivismo filosofico <strong>di</strong> matrice umanistica o con<br />
la <strong>di</strong>mensione dell‘autocoscienza del pensiero romantico 256.<br />
252 IDEM, Gesú Cristo, regola del Sacerdote, coll’aggiunta <strong>di</strong> alcune regole <strong>di</strong><br />
vita e quoti<strong>di</strong>ani esercizi del Beato Gregorio Barbarico Vescovo <strong>di</strong> Padova e<br />
Car<strong>di</strong>nale, Firenze, Tip. Cecchi 1852.<br />
253 Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> una figlia…, in IDEM, Opere ascetiche. Introduzione e note <strong>di</strong><br />
GIORDANO RENZI, Roma, Postulazione Generale dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>, 1978, OA, I, 638.<br />
254 Gesú Cristo, regola del Sacerdote…, in OA, II, 551.<br />
255 Scrive nella Monaca in casa: ―L’amore <strong>di</strong> Dio! Il primo tesoro, non<br />
solo sulla terra, ma dello stesso para<strong>di</strong>so [… ] al solo nominarlo il vostro<br />
cuore si commuove <strong>di</strong> allegrezza e <strong>di</strong> pianto‖ (IDEM, La monaca in casa,<br />
con due appen<strong>di</strong>ci:1°Pia Unione della <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>;<br />
2° Le amicizie spirituali, imitazione <strong>di</strong> S. Teresa, Oneglia, Tip. Tasso<br />
1859, in OA, II, 38.<br />
256 Non vi è traccia del percorso filosofico–pedagogico che da Cartesio va<br />
fino a Rousseau, si tratta invece <strong>di</strong> una tematica <strong>di</strong> squisita tra<strong>di</strong>zione<br />
cristiana, che lega con un filo d’oro Agostino con il filosofo Rosmini,<br />
passando per Teresa d’Avila e S. Giovanni della Croce.<br />
170
L‘amore <strong>di</strong> Dio è per Frassinetti ―la regina <strong>di</strong> tutte le virtú‖ 257 e<br />
costituisce la sostanza della santità:<br />
―La santità è tutta riposta nell‘amor <strong>di</strong> Dio e perciò dove è piú<br />
grande l‘amor <strong>di</strong> Dio, ivi necessariamente è maggiore santità, come<br />
dove è piú fuoco ivi necessariamente è piú ardore‖ 258.<br />
Nel libretto devozionale «Le do<strong>di</strong>ci stelle» scrive:<br />
―L‘amor <strong>di</strong> Dio è quella virtú che ci unisce a Dio e ci fa voler bene<br />
a Lui piú che ad ogni altra cosa […], è l‘aspetto piú dolce del cuore,<br />
è il gau<strong>di</strong>o dello spirito, è la fonte <strong>di</strong> ogni vera consolazione, è la<br />
vita dell‘anima, è quello che rende il cuor nostro […] degno<br />
abitacolo della santissima Trinità […]. Amiamo Dio e<br />
contentiamoci del suo solo amore‖ 259.<br />
L‘interiorità è in sostanza vivere la compagnia <strong>di</strong> Dio e questa<br />
presenza amorosa <strong>di</strong> Dio in noi si traduce subito in adempimento della sua<br />
volontà. Scrive nel «Convito del Divino Amore»:<br />
―L‘amor <strong>di</strong> Dio, in sostanza non è altro che l‘uniformità alla<br />
volontà <strong>di</strong> Dio <strong>di</strong>modochè se vogliamo ciò che vuole Dio, noi<br />
abbiamo l‘amor <strong>di</strong> Dio‖ 260.<br />
E piú oltre:<br />
―L‘amante non vive per sé, ma vive per l‘amato, e non ha piú volontà se<br />
non per Lui‖ 261.<br />
257 G. FRASSINETTI, Le do<strong>di</strong>ci stelle, ossia le virtù della B.V. <strong>Maria</strong>,<br />
coll’aggiunta della coroncina dell’<strong>Immacolata</strong> e <strong>di</strong> una <strong>di</strong>vota corona a<br />
<strong>Maria</strong> SS, Genova Tip. Fassi-Como 1857, in OA, II, 427.<br />
258 IDEM, La rosa senza spine, memorie sulla vita della pia zitella Rosa<br />
Cordone, morta in Genova ai 26 Novembre 1858, Torino, Tip. Paravia<br />
1859, in IDEM, Opere e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te, Roma, Tip. Poliglotta Vaticana<br />
1906-1913, 13 voll. OEI, XII, 415. E altrove: «Sarete come dei: perché in<br />
verità il perfetto amor <strong>di</strong> Dio vi conferisce la nobiltà e la santità che è<br />
propria <strong>di</strong> Dio» IDEM, Il Convito del <strong>di</strong>vino Amore, Genova, Tip.<br />
Gioventù 1867, in OA, I, 344.<br />
259 Le do<strong>di</strong>ci stelle..., in OA, II, 427.<br />
260 Il Convito..., in OA, I, 343.<br />
171
Questo amore conduce alla reciprocità e alla fusione misteriosa<br />
delle due volontà:<br />
―Allora delle due volontà, umana e <strong>di</strong>vina, si fa una volontà sola, in<br />
quanto che l‘umana non vuole piú, se non ciò che vuole la <strong>di</strong>vina, e<br />
resta così nobilitata e santificata‖ 262.<br />
Agli effetti <strong>di</strong> questo amore Frassinetti de<strong>di</strong>ca un opuscolo,<br />
«Alcuni effetti che fa nell‘anima l‘amore <strong>di</strong>vino», ispirato alla «Fiamma <strong>di</strong><br />
amor vivo» <strong>di</strong> S. Giovanni della Croce 263.<br />
La pienezza della vita cristiana consiste nell‘or<strong>di</strong>nare tutta<br />
l‘esistenza secondo l‘amore e l‘amore si traduce nella resa della volontà a<br />
Dio. Da qui parte tutto il <strong>di</strong>namismo della vita spirituale, l‘allontanamento<br />
e il <strong>di</strong>stacco da tutto ciò che compromette la libertà interiore e<br />
l‘avvicinamento o unione con Dio, fonte e meta della libertà cristiana.<br />
Come nella spiritualità alfonsiana, da cui Frassinetti <strong>di</strong>pende, i<br />
<strong>di</strong>namismi <strong>di</strong> «negazione» e «affermazione» (<strong>di</strong>stacco dalle creature e<br />
unione con Dio) sono movimenti complementari in vista <strong>di</strong> un‘armonia<br />
della carità.<br />
―Quando si giunge a voler incontrare qualunque sacrificio piuttosto<br />
che commettere avvertitamente un peccato anche solo veniale, si ha<br />
l‘amore perfetto <strong>di</strong> Dio‖ 264.<br />
―Bisogna che ci persua<strong>di</strong>amo bene che noi siamo <strong>di</strong> Dio e nulla<br />
possiamo avere <strong>di</strong> maggior bene che l‘essere tutti suoi e che si adempia<br />
perfettamente la sua santa volontà‖ 265.<br />
―Se l‘amore non cerca questa unione non è vero amore. Amiamo<br />
veramente Gesú? Uniamoci con Gesú‖ 266.<br />
261 Ibidem.<br />
262 Ivi, 344.<br />
263 IDEM, Alcuni effetti che fa nell’anima l’anima l’amor <strong>di</strong>vino. Ricavati<br />
dall’opuscolo <strong>di</strong> S. Giovanni della Croce «Fiamma <strong>di</strong> amor vivo», ed.<br />
postuma, in OEI, XII, 231-235.<br />
264 Il Convito..., in OA, I, 343.<br />
265 IDEM, Offerta <strong>di</strong> noi a Dio, ed. postuma, OEI, XII, in OA, I, 321.<br />
266 IDEM, Amiamo Gesú!, Genova, Tip. Gioventù 1864, in OA, I, 439.<br />
172
Il nucleo centrale e perciò il movente <strong>di</strong> tutto questo <strong>di</strong>namismo<br />
spirituale è Gesú Cristo, rivelatore dell‘amore <strong>di</strong>vino:<br />
―Gesú è venuto apposta in terra per accendere nei nostri cuori<br />
l‘amore <strong>di</strong> Dio. A Lui piú <strong>di</strong> ogni altra cosa importa – anzi questa<br />
sola importa – che noi abbiamo, nutriamo, accresciamo nei nostri<br />
cuori l‘amor <strong>di</strong> Dio‖ 267.<br />
È nota l‘importanza del cristocentrismo nella teologia spirituale e<br />
pastorale <strong>di</strong> Frassinetti che, come molti pensatori cristiani del suo tempo,<br />
pur fondando le proprie argomentazioni su verità teologiche, ama<br />
esprimersi in modo devozionale.<br />
Del mistero pasquale è fortemente esaltata l‘opera redentiva del<br />
Cristo attraverso la sua passione e morte, in secondo piano è posta la<br />
resurrezione. L‘Eucaristia costituisce il centro intorno a cui ruota la<br />
riflessione teologica e l‘esperienza devozionale.<br />
Sintetizzando, possiamo affermare che l‘umanità santissima <strong>di</strong><br />
Gesú, adorata nell‘Eucaristia e contemplata sulla croce, costituisce il tema,<br />
anzi la realtà centrale che appare negli scritti e nell‘esperienza religiosa <strong>di</strong><br />
Frassinetti.<br />
L‘intero <strong>di</strong>namismo spirituale è dunque posto in movimento da<br />
questo slancio ascetico-mistico che trova in Gesú e nella sua sequela il<br />
centro propulsore.<br />
―Sposo <strong>di</strong> sangue è Gesú all‘anima, [...] me<strong>di</strong>ante l‘effusione del suo<br />
sangue infatti se l‘ha ricomprata, l‘ha redenta e fatta sua Sposa e<br />
l‘arricchisce poi <strong>di</strong> tutti i beni, la ricolma <strong>di</strong> tutte le consolazioni, e<br />
l‘ammette alla sua piú intrinseca famigliarità, finché se la unisca in<br />
gloria. [...] La Sposa deve considerare quale debba essere il suo<br />
amore verso questo suo Sposo celeste: amore forte, amore <strong>di</strong><br />
sacrificio, che arrivi per fino al sangue‖ 268.<br />
Tutto deve essere fatto «per» amore a Gesú, «per» piacere a Lui.<br />
La sofferenza e la croce, in modo particolare, costituiscono una via<br />
privilegiata per gustare l‘intimità amorosa col Cristo.<br />
267 IDEM, La <strong>di</strong>vozione illuminata. Manuale <strong>di</strong> preghiere, Genova, Tip.<br />
Gioventù 1867, in OA, II, 254.<br />
268 IDEM, Il Pater Noster <strong>di</strong> S. Teresa <strong>di</strong> Gesú, trattato della preghiera,<br />
Parma, Tip. Fiaccadori 1860, in OA, I, 238.<br />
173
―Se volete essere davvero <strong>di</strong> Gesú, dovete abbandonarvi sulla croce<br />
con Lui. Preparatevi perciò alle tribolazioni‖ 269.<br />
―Gesú vi ama, non vi lascerà privi <strong>di</strong> cosa a sé tanto cara come è la<br />
croce‖ 270.<br />
Questo slancio amoroso costituisce il vero asse che dà equilibrio<br />
ad ogni esercizio ascetico. La virtú deve essere praticata a partire dal cuore,<br />
sede <strong>di</strong> questo amore esclusivo e <strong>di</strong>ffusivo.<br />
L‘amore a Gesú conduce all‘identificazione con Lui:<br />
―Amiamo veramente Gesú? Uniamoci con Gesú‖ 271.<br />
Fino a riprodurre in noi il modello <strong>di</strong>vino:<br />
―Gesú Cristo è il modello che il cristiano deve in sé ricopiare, <strong>di</strong><br />
maniera che nelle azioni e nella vita <strong>di</strong> lui abbiano a risplendere la<br />
vita e le azioni <strong>di</strong> Gesú, giacché un vero cristiano [...] è un altro<br />
Gesú Cristo‖ 272.<br />
Questo amore <strong>di</strong>vino, fatto carne in noi produce altra carità, che si<br />
<strong>di</strong>ffonde come luce:<br />
―I cuori <strong>di</strong> quelli che hanno la perfetta carità sono come lampade,<br />
anzi come faci che gettano fiamme [...] (e accendono) gli altri cuori<br />
che a loro si avvicinano‖ 273.<br />
―L‘amor <strong>di</strong> Dio non può star solo: deve <strong>di</strong> necessità aggiungersi<br />
con l‘amore del prossimo. Questi due amori sono come due rivoli<br />
che muovono dalla stessa fonte‖ 274.<br />
269 Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> una figlia ..., in OA, I, 644.<br />
270 La monaca in casa..., in OA, II, 51.<br />
271 Amiamo Gesú..., in OA, I, 439.<br />
272 La <strong>di</strong>vozione..., in OA, II, 242.<br />
273 IDEM, Novene e <strong>di</strong>scorsi per le principali solennità dell’anno, ed.<br />
postuma, in OEI, VI, 177.<br />
274 Ivi, 217-218.<br />
174
I gran<strong>di</strong> mezzi per tener vivo in noi questo amore <strong>di</strong>vino sono per<br />
Frassinetti la preghiera e l‘Eucaristia. In «Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> una figlia che vuole<br />
essere tutta <strong>di</strong> Gesú» raccomanda:<br />
―Ricordatevi che in questo vostro cuore abita il vostro Signore<br />
Id<strong>di</strong>o, dategli spesso un abbraccio coll‘affetto dell‘anima e pregatelo<br />
a non permettere che non lo <strong>di</strong>scacciate mai piú […]. Beata l‘anima<br />
che spesso pensa che ha Dio nel cuore‖ 275.<br />
A questo esercizio per ravvivare la fede nella presenza <strong>di</strong> Dio in<br />
noi e ai suoi frutti sono de<strong>di</strong>cati i capp. dal VII all‘ XI della prima parte del<br />
trattato <strong>di</strong> preghiera «Il Pater Noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa».<br />
Questo è un tema centrale e importantissimo che in questa sede<br />
non intendo approfon<strong>di</strong>re.<br />
Riprendo la dottrina teresiana, Frassinetti insegna che l‘anima non<br />
deve cercare il «<strong>di</strong>vino Diletto» fuori <strong>di</strong> se stessa, ma nel proprio cuore e<br />
rivolgersi frequentemente con slancio amoroso, ripetendogli, mentre si<br />
abbandona totalmente alle sue braccia, «Osculare me osculo oris tui» 276.<br />
Questo bacio corrisponde al «Fiat voluntas tua», alla piena<br />
uniformità al suo santo volere 277.<br />
―Datemi dunque, o Signore, questo bacio della vostra bocca per<br />
cui io piú non senta né desiderio né voglia che non sia<br />
l‘adempimento perfetto della vostra santa volontà‖ 278.<br />
L‘Eucaristia è l‘altro mezzo per ravvivare questo amore <strong>di</strong> Dio in<br />
noi. Nel «Convito del <strong>di</strong>vino Amore» scrive:<br />
―O anime, che già amate Dio e vi lamentate <strong>di</strong> essere tiepide nel<br />
<strong>di</strong>vino Amore, accostatevi […] alla Mensa del Signore e<br />
acquisterete il fervore da voi bramato, ed arriverete anche al<br />
perfettissimo amor <strong>di</strong> Dio. […] quando vi comunicate mettete il<br />
Cuor <strong>di</strong> Gesú appresso al vostro cuore […]. Se frequentemente<br />
275 Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> una figlia ..., in OA, I, 638.<br />
276 IDEM, Osculetur me oculo oris sui, ed. postuma, in OEI, anche in OA, I,<br />
316<br />
277 Ivi, 315.<br />
278 Ivi, 318.<br />
175
[…] metterete quella fornace d‘immenso <strong>di</strong>vino amore presso il<br />
cuor vostro, questo si accenderà‖ 279.<br />
2. I MEZZI PER COSTRUIRE L’INTERIORITÀ<br />
Quali sono, secondo Frassinetti, i principali mezzi per costruire<br />
l‘interiorità, che – come abbiamo visto – è costituita dalla presenza<br />
dell‘amore <strong>di</strong> Dio in noi?<br />
Lo ricaviamo da due testi fondamentali: «Il conforto dell‘anima<br />
<strong>di</strong>vota» (1844) e «L‘arte <strong>di</strong> farsi santi» (1861).<br />
Nel «Conforto» i mezzi in<strong>di</strong>cati sono due: il desiderio <strong>di</strong><br />
conseguire la perfezione cristiana e un buon Direttore spirituale.<br />
Si tratta in sostanza <strong>di</strong> un foro interno e un foro esterno che<br />
vengono posti in giusto equilibrio e armonia.<br />
Il buon Direttore, cui si deve perfetta sottomissione e obbe<strong>di</strong>enza,<br />
è in funzione del rafforzamento e della purificazione del desiderio, che<br />
costituisce in realtà la vera forza motrice della santità. Il buon Direttore,<br />
secondo Frassinetti<br />
―sarà quegli che assegnerà a ciascun‘anima ciò che avrà da praticare<br />
per giungere alla perfezione, vedendo egli ciò che convenga alla sua<br />
con<strong>di</strong>zione, capacità e stato particolare‖ 280.<br />
Secondo una visione <strong>di</strong> equilibrio tra natura e grazia, Frassinetti è<br />
convinto che l‘amore <strong>di</strong> Dio agisce con forza e insieme soavità:<br />
―Suole adattarsi [la grazia] ai vari naturali delle persone, e senza<br />
<strong>di</strong>struggere le loro varie inclinazioni, le piega e le <strong>di</strong>rige al<br />
conseguimento della perfezione desiderata‖ 281.<br />
<strong>Maria</strong> Esther Posada osserva:<br />
―I mezzi che il Frassinetti presenta per raggiungere la santità sono<br />
semplici, accessibili a tutti e, a mio parere, in qualche modo<br />
originali, nel modo cioè in cui li sceglie, li gerarchizza, li valuta. Ci si<br />
aspetterebbe infatti […] <strong>di</strong> trovare la proposta o almeno l‘accenno<br />
279 Il Convito..., in OA, I, 346.<br />
280 Il conforto..., in OA, I, 44.<br />
281 Ivi, 45.<br />
176
ai tra<strong>di</strong>zionali mezzi riportati dai manuali e consacrati dalla prassi<br />
della vita cristiana: preghiera, ascesi, nonché una trattazione sui<br />
sacramenti. Ci si trova invece con una impostazione <strong>di</strong>versa‖ 282.<br />
Nell‘«Arte <strong>di</strong> farsi santi» prospetta tre mezzi: l‘offerta <strong>di</strong> sé a Dio,<br />
la docilità alle buone ispirazioni e la Direzione spirituale.<br />
Abbiamo già considerato il tema della <strong>di</strong>rezione spirituale,<br />
esaminiamo ora gli altri due mezzi, l‘offerta <strong>di</strong> sé a Dio e la docilità alle<br />
buone ispirazioni. Essi sostituiscono in sostanza il primo termine in<strong>di</strong>cato<br />
nel «Conforto», cioè il desiderio, e in realtà lo definiscono nelle due<br />
componenti <strong>di</strong>namiche.<br />
La dottrina sull‘offerta <strong>di</strong> se stessi a Dio viene sviluppata anche in<br />
altre opere («Il conforto dell‘anima <strong>di</strong>vota», «La monaca in casa», «Il<br />
religioso al secolo», «Il Pater Noster <strong>di</strong> S. Teresa», «Industrie spirituali», «La<br />
<strong>di</strong>vozione illuminata», la pagellina intitolata «Offerta <strong>di</strong> noi a Dio», etc.).<br />
―Ad essa l‘Autore conferisce molta importanza, tanto da soffermarsi<br />
facendone una vera questione teologica‖ 283.<br />
Sentiamo come la formula nell‘«Arte <strong>di</strong> farsi santi»:<br />
―Signore, io rassegno nelle vostre mani tutto me stesso: l‘anima, il<br />
corpo, la salute e la vita, e tutto quanto mi avete dato in questo<br />
mondo, senza riservarmi nessuna cosa; <strong>di</strong> me e delle cose mie fate<br />
voi ciò che volete; io non voglio altro che il vostro amore, la vostra<br />
grazia, il vostro gusto‖ 284.<br />
Commenta nel «Conforto»:<br />
―Oh, che dolce violenza fa al cuore <strong>di</strong> Dio la piena e totale offerta<br />
che gli fa l‘anima <strong>di</strong> tutta se stessa!‖ 285.<br />
Osserva Marìa Esther Posada:<br />
282 M. E. POSADA, Storia e Santità. Influsso del teologo Giuseppe<br />
Frassinetti nella spiritualità <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> Domenica Mazzarello, Roma<br />
1992, 111.<br />
283 Ibidem.<br />
284 G. FRASSINETTI, L’Arte <strong>di</strong> farsi santi, Genova 1861[non si conoscono<br />
altri dati], in AO, I, 87.<br />
285 Il conforto..., in OA, I, 42.<br />
177
―L‘offerta <strong>di</strong> sé è da collocarsi […] non come un termine <strong>di</strong> un<br />
processo <strong>di</strong> crescita spirituale ma come punto <strong>di</strong> partenza del<br />
medesimo, quasi primo atto intenzionale, volontario, totale‖ 286.<br />
Nell‘atto dell‘iniziale e totale donazione <strong>di</strong> sé a Dio Frassinetti<br />
vede, non solo la decisa volontà dell‘uomo, ma anche l‘azione <strong>di</strong>retta <strong>di</strong><br />
Dio, perché il cristiano incomincia a fare questa offerta appunto con l‘aiuto<br />
della grazia.<br />
―Tuttavia bisogna notare che il cristiano comincia a fare questa<br />
offerta coll‘aiuto della grazia <strong>di</strong> Dio, senza la quale è impossibile<br />
concepire il minimo buon pensiero‖ 287.<br />
Accanto all‘offerta <strong>di</strong> sé il Frassinetti pone la ―docilità e la<br />
corrispondenza alle buone ispirazioni‖, cioè allo Spirito Santo.<br />
―Dio manda a ciascuno quelle ispirazioni che sono congrue […] ai<br />
<strong>di</strong>segni della sua <strong>di</strong>vina Provvidenza‖ 288.<br />
―La santità cristiana è infatti essenzialmente opera e dono dello<br />
Spirito Santo – osserva Ancilli – è il sentimento della completa <strong>di</strong>pendenza<br />
da Dio. Lo sforzo legittimo e necessario della conquista della perfezione<br />
morale non deve mai indurre a credere che questo sforzo abbia valore in se<br />
stesso‖ 289.<br />
Consideriamo piú da vicino questi due elementi: essi costituiscono<br />
la componente ascetica (= offerta <strong>di</strong> sé a Dio) e la componente mistica (=<br />
docilità allo Spirito Santo) del desiderio, inteso come <strong>di</strong>namica<br />
fondamentale nella crescita della vita cristiana e come effetto dell‘amore<br />
<strong>di</strong>vino in noi.<br />
―Un altro effetto del <strong>di</strong>vino amore […] è il desiderio <strong>di</strong> congiungersi<br />
con Lui in vita e gloria eterna‖ 290.<br />
Questo pensiero è il risultato dell‘equilibrio stesso della sua<br />
dottrina circa il rapporto natura – grazia. Questo equilibrio lo allontana dai<br />
286 POSADA, Storia e Santità…,44.<br />
287 L’Arte..., in OA, I, 87.<br />
288 Ivi, 89.<br />
289 POSADA, Storia e santità..., 112.<br />
290 Alcuni effetti dell’amore <strong>di</strong>vino in noi..., in OA, I, 325.<br />
178
pericoli dell‘in<strong>di</strong>vidualismo spirituale, del perfezionismo e del<br />
volontarismo.<br />
―Egli mitiga ed integra l‘ascetica del combattimento nel farsi santi<br />
con uno slancio <strong>di</strong> apertura e <strong>di</strong> abbandono a Dio, fonte e autore della<br />
santità‖ 291.<br />
Sarebbe a mio avviso interessante sviluppare questa tematica sul<br />
versante antropologico e psicologico, si scoprirebbe in questa sintesi<br />
frassinettiana un‘eguale <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> equilibrio e <strong>di</strong> armonia.<br />
―Il desiderio, o il desiderare – afferma Cencini – significa<br />
concentrare, canalizzare tutte le energie in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> qualcosa<br />
d‘importante per sé e centrale per la propria vita‖ 292.<br />
Il desiderio quin<strong>di</strong> non può essere confuso con un cieco impulso,<br />
coll‘essere eccitati da ciò che è piacevole qui e ora, ma costituisce una<br />
tendenza significativa verso qualcosa che vale in se stesso e che l‘in<strong>di</strong>viduo<br />
scopre e vuole al centro della propria vita e del proprio futuro 293.<br />
Le componenti costitutive del desiderio sono pertanto due: la<br />
Verità e la Libertà. La Verità è la capacità <strong>di</strong> percepire qualcosa come vero<br />
– bello – buono in sé; la Libertà è la capacità <strong>di</strong> sentirlo come tale per la<br />
propria vita, sperimentandone l‘attrazione.<br />
Il desiderio non è dunque una sensazione o una seduzione<br />
incontrollata ma scoperta <strong>di</strong> sé e della propria identità in quell‘insieme<br />
significativo. L‘attrazione – afferma Cencini – nasce dalla sintesi tra Verità<br />
oggettiva e Libertà soggettiva; ed è tanto piú forte, quanto piú intensa è la<br />
loro connessione.<br />
Trascurando per ora ulteriori considerazioni <strong>di</strong> tipo<br />
fenomenologico 294, proviamo a trascrivere i dati frassinettiani, formulati in<br />
termini teologici e spirituali, nella <strong>di</strong>mensione antropologica.<br />
La Verità corrisponde alla ―docilità alle buone ispirazioni‖, cioè<br />
allo Spirito Santo.<br />
La Verità oggettiva non è quella <strong>di</strong> natura filosofica o il prodotto<br />
della mente umana, è invece quella rivelata che ha come trasmettitore e<br />
291 POSADA, Storia e santità..., 113.<br />
292 A.CENCINI, Il mondo dei desideri. Orientamenti per la guida spirituale,<br />
Milano 1988, 11-12.<br />
293 Cfr. ibidem.<br />
294 Ad esempio la situazione <strong>di</strong> appagamento e non appagamento, i due<br />
versanti del desiderio.<br />
179
interprete la Spirito Santo. Lo Spirito parla <strong>di</strong>rettamente alla coscienza, al<br />
cuore, persuade interiormente, accarezzando la nostra mente.<br />
La Libertà corrisponde all‘offerta <strong>di</strong> sé a Dio, poiché il pieno<br />
possesso <strong>di</strong> se stessi costituisce il presupposto per il dono <strong>di</strong> sé.<br />
Qui risiede l‘autentica libertà interiore, libertà in senso cristiano,<br />
cioè secondo il modello <strong>di</strong>vino rivelato in Gesú Cristo. Cristo è colui che<br />
liberamente si dona, decide <strong>di</strong> non appartenersi, consegnandosi a noi<br />
attraverso il dono dello Spirito Santo.<br />
Anche su un piano puramente antropologico, il desiderio<br />
autentico ha come con<strong>di</strong>zione fondamentale la capacità <strong>di</strong> rinuncia, il<br />
rinunciare a ciò che in qualche modo finirebbe per arrestare il cammino<br />
stesso, bloccandolo ad un livello inferiore, rispetto all‘obiettivo iniziale.<br />
La capacità <strong>di</strong> rinunciare a sé stessi, <strong>di</strong> non possedersi, costituisce<br />
un atto libero della volontà. Poiché esiste un rapporto strettissimo tra<br />
desiderio e decisione. Il desiderio autentico porta infatti alla decisione.<br />
Scrive Amedeo Cencini: ―Il desiderio che non porta alla decisione<br />
è velleità sterile e finzione ingannevole. Soltanto il desiderio, in ogni caso<br />
può mettere in moto l‘intero <strong>di</strong>namismo psichico […]. La decisione senza<br />
desiderio è volontarismo che non convince e non può durare a lungo‖ 295.<br />
3. IL DESIDERIO DELLA SANTITÀ:<br />
<strong>UNA</strong> DOTTRINA COMPLETA<br />
Frassinetti non ha scritto uno specifico trattato sul tema del<br />
desiderio, tuttavia dai suoi numerosi scritti <strong>di</strong> pastorale e <strong>di</strong> ascetica è<br />
possibile ricavare una dottrina completa, che ne definisce la natura, le<br />
qualità, le manifestazioni, lo sviluppo e naturalmente ne <strong>di</strong>mostra l‘utilità e<br />
la necessità.<br />
Fonti per la sua dottrina sono anzitutto Agostino e Tommaso.<br />
Per Agostino l‘uomo non è esclusivamente animale razionale,<br />
bensì animale desiderante 296. I desideri piú profon<strong>di</strong> del cuore rimangono<br />
inappagati fino a quando l‘uomo non incontra il volto <strong>di</strong> Dio 297. Inoltre è il<br />
295 CENCINI, Il mondo dei desideri..., 14.<br />
296 Cfr. A. BOCHET, Saint Augustin et le dèsir de Dieu, Paris 1982.<br />
297 Cfr. AGOSTINO, Confessioni, 1,1.<br />
180
desiderio a dare forza alla preghiera, così come è la preghiera ad assicurare<br />
l‘efficacia del buon desiderio:<br />
―Il tuo desiderio è la tua preghiera. Se continuo è il tuo desiderio,<br />
continua è la tua preghiera [...]. Il desiderio è la preghiera interiore<br />
che non conosce interruzioni‖ 298.<br />
Per S. Tommaso il desiderio rende atti e prepara a ricevere il bene<br />
desiderato. ―Dio ritiene il desiderio come un atto compiuto‖ 299.<br />
Altra fonte importante è Teresa d‘Avila. Per Teresa i desideri<br />
svolgono un ruolo decisivo per giungere alle vette piú alte dell‘unione<br />
mistica. Scrive nella «Vita» che è assai piú conveniente confidare in Dio che<br />
non soffocare i desideri che sorgono nel nostro animo, i santi, ponendo in<br />
opera il loro desiderio <strong>di</strong> perfezione, hanno raggiunto a poco a poco la<br />
pienezza della santità.<br />
Come risulta chiaramente dalla «Relazione I» della stessa <strong>Santa</strong>,<br />
l‘esperienza mistica è accompagnata da un crescendo <strong>di</strong> desideri: l‘anima<br />
non vuole che il suo Creatore; comprende <strong>di</strong> non poterlo vedere se non<br />
con la morte e, poiché non può darsi la morte da sé, muore dal desiderio <strong>di</strong><br />
morire.<br />
Insieme a S. Teresa ricor<strong>di</strong>amo un‘altra fonte importante della<br />
spiritualità carmelitana: S. Giovanni della Croce. Di questo mistico<br />
Frassinetti commentò un‘opera, «La fiamma <strong>di</strong> amor vivo», imperniata sul<br />
tema del desiderio dell‘unione mistica della creatura col suo creatore 300.<br />
Altri autori citati dal Frassinetti su questo tema sono S. Francesco<br />
<strong>di</strong> Sales e S. Alfonso <strong>Maria</strong> de‘ Liguori.<br />
Nel «Conforto dell‘anima <strong>di</strong>vota» li cita volentieri, soprattutto<br />
quando parla della necessità che questo desiderio sia risoluto e posto in<br />
atto prontamente. Riporta ad esempio un‘ammonizione <strong>di</strong> S. Alfonso:<br />
―(Vivono) anime (che) si pascono <strong>di</strong> desideri ma non danno mai un<br />
passo nella via <strong>di</strong> Dio‖ 301.<br />
298 IDEM, Enarrationes in Psalmos, PL XXXLVI, Ps 37, 14.<br />
299 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, III, 68, 2.<br />
300 Ut supra, nota 17.<br />
301 Il Conforto..., in OA, I, 41.<br />
181
E fa sue le parole <strong>di</strong> S. Francesco <strong>di</strong> Sales:<br />
―Bisogna cominciare con una forte e costante risoluzione <strong>di</strong> darsi<br />
tutti a Dio, protestandogli che per l‘avvenire vogliamo essere suoi<br />
servi senza alcuna riserva, e poi andare spesso rinnovando questa<br />
medesima risoluzione‖ 302.<br />
―Noi non possiamo sapere – scrive il Santo nel «Teotimo» – se amiamo<br />
Dio sopra tutte le cose, se Egli stesso non ce lo rivela, ma possiamo<br />
sapere però se desideriamo <strong>di</strong> amarlo; e quando sentiamo nascere in noi<br />
il desiderio dell‘amore <strong>di</strong>vino, allora incominciamo ad amare […]. Chi<br />
desidera ardentemente l‘amore, amerà presto ardentemente‖ 303.<br />
Esaminiamo ora brevemente questa dottrina 304 sul desiderio.<br />
Circa la natura del desiderio or<strong>di</strong>nato alla perfezione 305, Frassinetti<br />
sottolinea la continuità esistente tra l‘or<strong>di</strong>ne naturale (la tendenza<br />
spontanea e automatica, o decisa e libera, verso un oggetto conosciuto ma<br />
non ancora posseduto) e l‘or<strong>di</strong>ne della grazia (la tensione della volontà,<br />
sostenuta dallo Spirito Santo, verso l‘unione con Dio, l‘imitazione <strong>di</strong> Gesú<br />
nella pratica della virtú).<br />
Questo desiderio, che pervade tutte le manifestazioni della vita<br />
personale, è in qualche modo ciò che l‘apostolo Paolo esprime con una<br />
frase cristallina: «Non sono piú io che vivo, ma è Cristo che vive in me».<br />
Il desiderio della perfezione <strong>di</strong>venta allora desiderio <strong>di</strong> adempiere<br />
totalmente la volontà <strong>di</strong> Dio, amato con tutte le forze. Frassinetti esprime<br />
questa risoluzione della volontà nella preghiera <strong>di</strong> offerta, <strong>di</strong> cui il Pactum<br />
pacis costituisce un‘espressione <strong>di</strong> alto lirismo.<br />
Il desiderio della santità può essere definito, secondo la dottrina<br />
frassinettiana, come tensione della volontà, sostenuta dallo Spirito, verso<br />
l‘unione con Dio e l‘imitazione <strong>di</strong> Cristo.<br />
Circa le qualità, Frassinetti ne in<strong>di</strong>ca alcune in<strong>di</strong>spensabili.<br />
Anzitutto deve essere soprannaturale, teso alla sola gloria <strong>di</strong> Dio,<br />
all‘imitazione e alla comunione con Cristo. Il desiderio non deve essere<br />
302 Ibidem.<br />
303 FRANCESCO DI SALES, Teotimo, XII, 2.<br />
304 Il corsivo utilizzato è nostro.<br />
305 Ricor<strong>di</strong>amo che nel quadro ascetico tra<strong>di</strong>zionale esso è collocato tra i<br />
mezzi soggettivi generali, cioè tra le <strong>di</strong>sposizioni intime che aiutano<br />
l’anima ad unirsi a Dio.<br />
182
orientato verso un ideale <strong>di</strong> perfezione che si identifica con azioni<br />
straor<strong>di</strong>narie, con il fervore e le consolazioni, ma deve mirare al<br />
compimento degli atti umili e or<strong>di</strong>nari del proprio dovere, compiuto con la<br />
sola forza dell‘amore.<br />
Il desiderio deve essere umile e fiducioso, non appoggiato alle proprie<br />
forze o con<strong>di</strong>zionato da certi meccanismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa della personalità, inoltre<br />
deve essere alieno dagli scrupoli e non deve gettare l‘anima nell‘inquietu<strong>di</strong>ne.<br />
L‘eccesso <strong>di</strong> introspezione infatti lascia chiaramente intravedere le venature<br />
dell‘orgoglio e della vanità 306.<br />
Il desiderio deve essere sostenuto dalla retta intenzione. Anche se è<br />
<strong>di</strong>fficile che il desiderio della santità sia perfetto sin dall‘inizio, tuttavia nel<br />
suo cammino <strong>di</strong> purificazione esso deve essere guidato da un cuore retto,<br />
che non nutre sentimenti <strong>di</strong> compiacenza per i progressi o <strong>di</strong>spetto per le<br />
cadute, ma accetta serenamente la verità <strong>di</strong> se stesso.<br />
Il desiderio deve essere costante e fermo, tale da resistere alle<br />
<strong>di</strong>fficoltà e non esaurirsi in uno slancio fervoroso provocato da eventi<br />
straor<strong>di</strong>nari.<br />
Infine deve essere attuale, cioè posto in atto prontamente, senza<br />
proroghe, senza attendere con<strong>di</strong>zioni migliori, utilizzando i mezzi or<strong>di</strong>nari<br />
a sua <strong>di</strong>sposizione.<br />
Circa le sue manifestazioni Frassinetti sottolinea alcune<br />
caratteristiche.<br />
La capacità <strong>di</strong> resistere agli assalti del demonio e alle tentazioni, nello<br />
sforzo <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>re lo stato <strong>di</strong> grazia.<br />
La ferma decisione <strong>di</strong> crescere nell’amore <strong>di</strong> Dio, cercando ciò che è<br />
piú aspro, fino ad abbracciare totalmente e con amore la croce.<br />
La pena e il timore <strong>di</strong> non servire bene Dio, in una tensione ascetica che<br />
conduce al <strong>di</strong>sprezzo <strong>di</strong> sé e dei propri piaceri, nella continua ricerca <strong>di</strong> ciò<br />
che dà maggior gloria a Dio.<br />
L‘osservanza puntuale <strong>di</strong> ciò che si conoscere essere come volontà<br />
<strong>di</strong> Dio, nel perfetto compimento dei doveri del proprio stato.<br />
Circa lo sviluppo del desiderio Frassinetti in<strong>di</strong>ca:<br />
La stima e la conoscenza della perfezione, unita alla coscienza <strong>di</strong> non<br />
possederla 307. Alla fase intellettuale (conoscenza) deve necessariamente far<br />
306 Cfr. Il conforto..., Appen<strong>di</strong>ce sul santo timor <strong>di</strong> Dio, in OA, I, 55-75.<br />
307 Siamo sulla linea <strong>di</strong> Agostino che parla <strong>di</strong> illuminazione o <strong>di</strong> Rosmini<br />
che parla dell’idea dell’essere.<br />
183
seguito la fase operativa (azione), <strong>di</strong> modo che il valore oggettivo si<br />
trasformi in valore soggettivo.<br />
La <strong>di</strong>rezione spirituale, come aiuto per purificare e rafforzare il<br />
desiderio della santità.<br />
Il <strong>di</strong>stacco dalle creature e dall’avi<strong>di</strong>tà materiale, nell‘esercizio della<br />
mortificazione e delle altre virtú passive.<br />
La preghiera, frequente e fervorosa, che ha come anima l’Atto <strong>di</strong><br />
Offerta, unita all‘esercizio della me<strong>di</strong>tazione che apre l‘intelligenza, la volontà e<br />
l‘affettività all‘intimità con Dio e all‘amicizia con Cristo.<br />
La confessione e la comunione frequente, le due sorgenti <strong>di</strong> Grazia che<br />
accrescono l‘amore e il desiderio <strong>di</strong> Dio.<br />
Infine le amicizie sante o amicizie spirituali, viste in una prospettiva<br />
ecclesiale e comunitaria, che possono correggere la <strong>di</strong>mensione<br />
in<strong>di</strong>vidualistica e privatistica della perfezione.<br />
4. SPUNTI PEDAGOGICI E VOCAZIONALI<br />
Quali insegnamenti possiamo trarre oggi da questa dottrina sul<br />
desiderio?<br />
Vi propongo alcuni spunti pedagogici che potrebbero applicarsi<br />
all‘accompagnamento vocazionale.<br />
Partiamo da una breve analisi della situazione <strong>di</strong> oggi, mirata<br />
soprattutto al mondo giovanile.<br />
È constatazione <strong>di</strong> molti osservatori che oggi stiamo assistendo ad<br />
un fenomeno inquietante, il recesso della qualità dei desideri e del<br />
desiderare stesso come facoltà.<br />
I giovani <strong>di</strong> oggi desiderano poco, a senso unico e in modo<br />
ripetitivo. Osserva Amedeo Cencini:<br />
―Sembrano accontentarsi <strong>di</strong> quei tre, quattro desideri, sempre gli<br />
stessi, senza tanta fantasia né originalità e all‘interno <strong>di</strong> prospettive<br />
a corto raggio, <strong>di</strong> bisogni imme<strong>di</strong>ati, <strong>di</strong> gusti elementari, <strong>di</strong><br />
ambizioni primitive‖ 308.<br />
Sono sempre piú rare le esigenze spirituali e <strong>di</strong> autotrascendenza,<br />
con un‘evidente ricaduta a livello vocazionale.<br />
308 Riportato in CENCINI, Il mondo dei desideri..., 21.<br />
184
Quali sono le cause? L‘Autore sopra citato ne riporta quattro, che<br />
ora brevemente riassumerò 309. Esse costituiscono, a mio avviso, un<br />
panorama sociopsicologico molto significativo del <strong>di</strong>sagio giovanile e ci<br />
aiuteranno ad attualizzare meglio il pensiero del nostro Fondatore.<br />
1. Vuoto educativo e vuoto esistenziale.<br />
I nostri giovani sono immersi in una cultura consumista e<br />
sostanzialmente permissiva che concede un sod<strong>di</strong>sfacimento pressoché imme<strong>di</strong>ato<br />
dei loro desideri. Non esiste piú l‘attesa, l‘intervallo tra la richiesta e la<br />
gratificazione <strong>di</strong> essa.<br />
Afferma Castellazzi:<br />
―Oggi al bambino e all‘adolescente non è riconosciuto il <strong>di</strong>ritto alla<br />
sofferenza, quella sana sofferenza che deriva dalla capacità<br />
progressiva <strong>di</strong> opporsi alla logica o al ricatto del piacere<br />
obbligato‖ 310.<br />
In questo modo abbiamo tolto ai giovani la grande esperienza<br />
della mancanza e poi della conquista. Il principio della gratificazione<br />
imme<strong>di</strong>ata e totale significa in concreto mortificare la libertà e <strong>di</strong> conseguenza<br />
l‘età del desiderio, l‘adolescenza e la fanciullezza, rischia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare l‘età<br />
del vuoto esistenziale.<br />
2. Cultura della prevenzione e società della paura.<br />
Oggi si è persa, nella cultura come anche nelle aspirazioni interiori,<br />
la connessione tra verità – bellezza – bontà. Il desiderio, come il pensiero, è<br />
<strong>di</strong>ventato debole!<br />
Esiste uno sca<strong>di</strong>mento del gusto estetico poiché la società sollecita<br />
i giovani a scegliere solo in base al criterio della funzionalità e dell‘utilità<br />
personale, mai in vista della bontà e della verità come valori in sé. Questa<br />
libertà <strong>di</strong> scegliere il bello e il buono è sostituita dalla paura.<br />
Tutto fa paura (il futuro, la società violenta, l‘ingiustizia, le<br />
malattie, etc.), perciò ci si deve <strong>di</strong>fendere attraverso la prevenzione, che<br />
<strong>di</strong>venta il modello <strong>di</strong> tutte le relazioni sociali, il nuovo mito, la nuova parola<br />
d‘or<strong>di</strong>ne 311.<br />
309 Ivi, 22-34.<br />
310 Cfr. ivi, 23.<br />
311 Cfr. ivi, 26.<br />
185
Questa paura genera <strong>di</strong> conseguenza un ripiegamento sul<br />
conosciuto, anche se privo <strong>di</strong> vitalità, su se stessi, sul solito, sul familiare,<br />
poiché queste realtà danno sicurezza ed evitano l‘impatto con la sofferenza<br />
del «<strong>di</strong>verso».<br />
È un circolo vizioso: laddove non esiste il fascino della bellezza e<br />
il rischio della conquista della verità si perdono gli ideali e la speranza <strong>di</strong><br />
costruire una nuova storia. È un cancro sottile!<br />
3. Dall’ingratitu<strong>di</strong>ne alla noia.<br />
Nella nostra società dove tutto deve essere perfetto, dove tutto<br />
sembra dovuto, dove vige il principio del sod<strong>di</strong>sfacimento imme<strong>di</strong>ato,<br />
viene a mancare una componente essenziale dell‘equilibrio umano: la<br />
gratitu<strong>di</strong>ne! E‘ la libertà <strong>di</strong> commuoversi <strong>di</strong>nanzi alla bontà della vita e <strong>di</strong><br />
tante persone che sono state buone con noi! 312<br />
Senza la gratitu<strong>di</strong>ne, specie per i giovani, c‘è la pretesa <strong>di</strong><br />
continuare ad avere tutto dai genitori, come un <strong>di</strong>ritto insindacabile. Ciò<br />
che dovrebbe essere motivo <strong>di</strong> riconoscenza (il dono della vita) <strong>di</strong>venta ora<br />
una «colpa».<br />
Se non c‘è gratitu<strong>di</strong>ne, la speranza si allontana dall‘orizzonte della<br />
vita e subentra la noia esistenziale.<br />
La febbre del sabato sera, la ricerca <strong>di</strong> emozioni forti, come la<br />
droga o il sesso, sono il segno <strong>di</strong> questo vuoto interiore. Riflettiamo su<br />
questo dato dell‘Istat: in Italia, sotto i ventun anni, il suici<strong>di</strong>o costituisce la<br />
seconda causa <strong>di</strong> morte, dopo gli incidenti automobilistici.<br />
4. Il grande pantheon e l’appiattimento generale.<br />
Viviamo in una società complessa, multirazziale, multiculturale. E‘<br />
l‘epoca della comunicazione <strong>di</strong> massa, <strong>di</strong> Internet, dei percorsi a «rete»<br />
multi<strong>di</strong>rezionali, i giovani vivono in un mondo costituito da molteplici<br />
sollecitazioni, dove vi è un‘eccedenza <strong>di</strong> possibilità e <strong>di</strong> opportunità.<br />
Diventa per essi sempre piú <strong>di</strong>fficile recuperare una visione unitaria del<br />
mondo, una focalizzazione dei valori e delle priorità, elaborare una propria<br />
progettualità.<br />
Il mondo è un pantheon dove sono presenti tutte le <strong>di</strong>vinità, in cui<br />
ogni valore ha la sua nicchia, valori <strong>di</strong>versi e contrastanti, che coesistono<br />
senza una gerarchizzazione precisa 313. Risulta perciò sempre piú debole nei<br />
giovani la capacità progettuale della vita.<br />
Nel documento Nuove vocazioni per una nuova Europa si <strong>di</strong>ce:<br />
312 Cfr. ivi, 28.<br />
313 Cfr. ivi, 30.<br />
186
―Nell‘Europa culturalmente complessa e priva <strong>di</strong> precisi punti <strong>di</strong><br />
riferimento, simile ad un grande pantheon, il modello antropologico<br />
prevalente sembra essere quello dell‘uomo senza vocazione.<br />
Ovvero dove non nascono desideri e capacità <strong>di</strong> desiderare, lì è<br />
molto <strong>di</strong>fficile che nascano opzioni e <strong>di</strong>sponibilità vocazionali‖ 314.<br />
I nostri giovani spesso non sanno cosa vogliono né ciò che non<br />
vogliono. Vivono nell‘ignoranza <strong>di</strong> se stessi!<br />
Questa è la situazione in cui si trovano le nuove generazioni. Cosa<br />
può insegnarci Frassinetti?<br />
Credo molto. La sua dottrina sul desiderio ci suggerisce<br />
sostanzialmente tre priorità educative:<br />
bisogna anzitutto ―educare‖ ai gran<strong>di</strong> desideri, ―formarli‖ attraverso<br />
una pratica ascetico-mistica ed infine far scoccare la scintilla vocazionale a<br />
partire dai desideri piú profon<strong>di</strong>.<br />
Cosa significa educare ai gran<strong>di</strong> desideri?<br />
Anzitutto far emergere, a livello <strong>di</strong> coscienza, i veri desideri della<br />
persona 315. ―E–ducere‖, cioè tirar fuori, non semplicemente quel che si sente<br />
dentro (questa è solo sincerità soggettiva, necessaria ma non sufficiente),<br />
ma la verità del desiderio, ciò che realmente attira cuore, mente, volontà. È un<br />
viaggio per portare alla luce la verità profonda della persona.<br />
Ma questo viaggio si può affrontare da soli? L‘esperienza<br />
pedagogica della Chiesa, se<strong>di</strong>mentata nel tempo, ci <strong>di</strong>ce che non è possibile<br />
intraprendere da soli questo itinerario nelle profon<strong>di</strong>tà dell‘essere. E‘<br />
necessario fare un ―viaggio guidato‖, ci vuole qualcuno che sappia <strong>di</strong>scernere i<br />
desideri apparenti da quelli reali. Questo viaggio ha necessità <strong>di</strong> un uomo<br />
esperto <strong>di</strong> Dio (Frassinetti parla <strong>di</strong> Direttore spirituale) 316, anche se questa<br />
funzione oggi può essere assunta da una comunità cristiana che realmente<br />
progre<strong>di</strong>sca nel cammino <strong>di</strong> fede.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una Kenosis, <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scesa agli inferi, poiché è<br />
necessario prendere coscienza dei «mostri» che abitano la propria anima.<br />
Senza questa esperienza, spesso dolorosa, non ci può essere un ritorno a<br />
314 Cfr. Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, Nuove vocazioni<br />
per una nuova Europa, Documento finale del Congresso sulle Vocazioni al<br />
Sacerdozio e alla Vita Consacrata (Roma, 5-10 maggio 1997), 11.<br />
315 Cfr. CENCINI, Il mondo dei desideri..., 35.<br />
316 Cfr. Il Conforto..., in OA, I, 44-45; L’Arte..., in OA, I, 89-90.<br />
187
casa, alle proprie ra<strong>di</strong>ci, a quel santuario che è il nostro cuore, dove Dio e<br />
lo Spirito sono presenti 317.<br />
Non si può costruire questa interiorità da soli, perciò Frassinetti<br />
consiglia l‘esperienza delle «sante amicizie», quale mezzo privilegiato per<br />
perfezionare e purificare il desiderio della santità.<br />
Educare significa - come afferma Cencini - scavare il desiderio 318, per<br />
giungere alla scoperta della sua verità, che si identifica con la storia stessa <strong>di</strong><br />
quel desiderio. Cosa c‘è <strong>di</strong>etro ogni desiderio?<br />
Andare in profon<strong>di</strong>tà significa andare a ritroso, scrutare i propri<br />
comportamenti e da lì passare ad esaminare gli atteggiamenti <strong>di</strong> vita, per<br />
poi scoprire i sentimenti, espressi o repressi, che guidano la nostra<br />
esistenza e infine in<strong>di</strong>viduare le motivazioni, i veri perché che spiegano i<br />
comportamenti e le aspirazioni <strong>di</strong> una persona, la sua opzione<br />
fondamentale. Si potrebbe così scoprire la realtà profonda, la genesi del<br />
vuoto esistenziale, della propria noia o paura.<br />
Se non ci si ascolta in questa realtà profonda <strong>di</strong> vuoto, <strong>di</strong> morte, <strong>di</strong><br />
non senso, Dio non potrà mai arrivare come risposta ai nostri bisogni. La<br />
stima della perfezione – afferma Frassinetti – va <strong>di</strong> pari passo con la<br />
coscienza <strong>di</strong> non possederla 319.<br />
Ma qual è il luogo dove avviene questo «scavo»? Frassinetti in<strong>di</strong>ca<br />
due luoghi privilegiati: la preghiera e l‘Eucaristia. Pregare è mettersi <strong>di</strong> fronte<br />
alla verità <strong>di</strong> Dio nella verità <strong>di</strong> se stessi. ―Nulla come la luce proveniente<br />
dalla Parola [...] o dalla verità della croce e del mistero pasquale, celebrato<br />
nell‘Eucaristia, ha il potere <strong>di</strong> scavare dentro la coscienza umana, [...] (fino<br />
a farle percepire) la voce del Signore che chiama‖ 320.<br />
Bisogna scoprire il desiderio <strong>di</strong> vocazione, e che in ogni desiderio vi è<br />
una tensione vocazionale.<br />
Lo scavo è una sorta <strong>di</strong> viaggio all‘in<strong>di</strong>etro, procedendo <strong>di</strong><br />
desiderio in desiderio si risale alla sorgente: il desiderio <strong>di</strong> Dio.<br />
Cosa significa ―formare‖ i desideri?<br />
Non basta far emergere la verità, bisogna «scalare» i desideri,<br />
scrutarne la <strong>di</strong>rezione possibile, il suo futuro, alla luce dei desideri <strong>di</strong>vini 321.<br />
Frassinetti può ancora darci delle in<strong>di</strong>cazioni, ve<strong>di</strong>amole.<br />
317 Cfr. CENCINI, Il mondo dei desideri..., 37.<br />
318 Ibidem.<br />
319 L’Arte..., in OA, I, 85.<br />
320 CENCINI, Il mondo dei desideri..., 40.<br />
321 Ivi, 46.<br />
188
Bisogna ricondurre i desideri all‘unità: l‘unico desiderio dell‘uomo<br />
è in fondo vedere Dio, il suo volto. Bisogna far emergere questa aspirazione<br />
<strong>di</strong>vina. Ogni desiderio, anche il piú terreno, può <strong>di</strong>ventare un mezzo che<br />
porta a Dio.<br />
Si rilegga in questo senso «La forza <strong>di</strong> un libretto»: è il cammino<br />
dell‘amicizia che sfocia nella scoperta <strong>di</strong> Dio e della propria vocazione 322.<br />
Formare i desideri secondo una pratica ascetico-mistica significa<br />
soprattutto tenere alto lo sguardo, verso il definitivo e l’eterno. Questo non<br />
comporta il <strong>di</strong>sprezzo del go<strong>di</strong>mento o della <strong>di</strong>stensione umana, ma<br />
intravedere dentro il nostro bisogno <strong>di</strong> felicità una ulteriorità. Ogni dono<br />
terreno è introduttore al dono per eccellenza, il possesso <strong>di</strong> Dio. La festa<br />
che celebriamo è soltanto la pregustazione <strong>di</strong> una festa <strong>di</strong>versa, che Dio ha<br />
preparato per noi.<br />
Formare significa infine pregare. Frassinetti parla <strong>di</strong> docilità alle<br />
buone ispirazioni, cioè allo Spirito Santo. Pregare è supplicare Dio perché<br />
ci trasmetta i suoi stessi desideri 323.<br />
Ogni vocazione nasce ―dalla in–vocazione orante, da una<br />
preghiera che è piú preghiera <strong>di</strong> fiducia che <strong>di</strong> domanda, preghiera come<br />
sorpresa e gratitu<strong>di</strong>ne‖ 324. Frassinetti scrive delle preghiere che esprimono<br />
anzitutto la consapevolezza del dono e il fiducioso abbandono in Dio.<br />
La preghiera è il luogo <strong>di</strong> «torsione» dei desideri dell‘uomo 325 che<br />
―si arrotolano su desideri altri‖ 326, è il luogo in cui si pensa e si attua il<br />
proprio futuro nella linea del desiderare <strong>di</strong>vino.<br />
―E volgeranno la sguardo a colui che hanno trafitto‖ (Gv. 19,37):<br />
ecco il movimento <strong>di</strong> questa torsione dei desideri!<br />
Siamo arrivati alla fine, a questo punto il desiderio dovrebbe<br />
sfociare nella decisione!<br />
C‘è un strettissimo rapporto tra desiderio e decisione vocazionale: l‘uno<br />
apre all‘altra.<br />
Nel nostro lavoro <strong>di</strong> accompagnamento vocazionale Frassinetti ci<br />
in<strong>di</strong>ca una strada: bisogna porre piú attenzione alla <strong>di</strong>namica del desiderare,<br />
ai due movimenti <strong>di</strong> «scavare» e «scalare» (per usare la terminologia <strong>di</strong><br />
322 Cfr. M. F. PORCELLA, La consacrazione secolare femminile. Pensiero e<br />
prassi in Giuseppe Frassinetti, Roma 1999, 109.<br />
323 CENCINI, Il mondo dei desideri..., 52.<br />
324 Nuove vocazioni..., 35d.<br />
325 CENCINI, Il mondo dei desideri..., 52.<br />
326 A.GODEN, Psicologia delle esperienze religiose. Il desiderio e la realtà,<br />
Brescia 1983, 194.<br />
189
Cencini), che in buona sostanza significano ―far emergere il desiderio<br />
dell‘uomo e il desiderio <strong>di</strong> Dio, il primo purificato da tante incrostazioni e<br />
interferenze 327, il secondo come ra<strong>di</strong>ce e destino del desiderare umano [...].<br />
L‘incontro fra i due desideri dovrebbe far scoccare quella scintilla da cui<br />
nasce la decisione vocazionale‖ 328.<br />
Desidero concludere queste riflessioni con un‘espressione <strong>di</strong><br />
Frassinetti tratta dal Pactum pacis, che condensa in modo sublime e lirico<br />
questo pensiero: ―Hoc modo inter tuam et meam voluntatem fiat pax‖ 329.<br />
Porto 28 Dicembre 1999<br />
<strong>Maria</strong> Francesca Porcella<br />
DESIDERIO DI PERFEZIONE E METODO DI VITA<br />
INTERIORE:<br />
PER <strong>UNA</strong> PEDAGOGIA DELLA SANTITÀ<br />
SECONDO GIUSEPPE FRASSINETTI<br />
Per cogliere qualche elemento utile ad una sistematizzazione della<br />
pedagogia spirituale frassinettiana, ho scelto <strong>di</strong> tracciare un‘ipotesi <strong>di</strong><br />
comprensione che consenta <strong>di</strong> sottolineare due nozioni-chiave dell‘ascetica<br />
e della pastorale del Frassinetti: il desiderio e il Metodo <strong>di</strong> Vita. Sebbene la<br />
sequenza logicamente preveda il desiderio, che nell‘e<strong>di</strong>ficio spirituale e nella<br />
pedagogia frassinettiana ha una priorità assoluta, dal punto <strong>di</strong> vista<br />
esplorativo seguiremo la via inversa a partire, cioè, dal Metodo <strong>di</strong> Vita.<br />
Il Metodo è un vero e proprio pilastro della prassi pastorale<br />
frassinettiana, ovvero uno strumento educativo (meglio: auto-educativo)<br />
327 È il cammino <strong>di</strong> ascesi.<br />
328 CENCINI, Il mondo dei desideri..., 54.<br />
329 [G. FRASSINETTI], Pactum pacis, ed. postuma, in OEI, anche in OA,<br />
II, 592.<br />
190
strutturato con una certa invariabilità, raccomandato puntualmente -<br />
talvolta con le opportune mo<strong>di</strong>fiche - a coloro che si decidono per un<br />
itinerario <strong>di</strong> crescita cristiana, come regolamento in base al quale organizzare<br />
il proprio cammino e verificarne l‘andamento.<br />
La funzione del Metodo <strong>di</strong> Vita è quella <strong>di</strong> far passare dal desiderio<br />
alla volontà, o meglio, <strong>di</strong> conformare progressivamente la volontà al<br />
desiderio <strong>di</strong> farsi santi.<br />
Il desiderio, infatti, per non restare al livello <strong>di</strong> mera «buona intenzione» (<strong>di</strong><br />
quelle che, si <strong>di</strong>ce, tappezzano il suolo dell‘inferno!), ha bisogno <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ventare il criterio educatore della volontà, cioè deve farsi azione, e<br />
tradursi progressivamente in atteggiamento, ossia in struttura interiore atta<br />
a cercare e fare il bene pressoché spontaneamente (e tuttavia non<br />
meccanicamente, ma responsabilmente: una sorta <strong>di</strong> «istinto spirituale»,<br />
un‘abitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> vita che viene dalla libera scelta. Cfr. Frankl: ―la decisione<br />
<strong>di</strong> oggi è l‘istinto <strong>di</strong> domani‖!)<br />
Il Metodo, quin<strong>di</strong>, non è contro la libertà, anzi, è lo strumento con<br />
il quale la libertà <strong>di</strong>sciplina se stessa, si pone dei criteri e degli obiettivi<br />
concreti per definirsi. Il presupposto è quello del tirocinio della libertà, che<br />
abbisogna <strong>di</strong> una struttura <strong>di</strong> regolarità per passare dai singoli actus isolati<br />
all‘acquisizione <strong>di</strong> habitus permanenti. La formazione spirituale, del resto,<br />
consiste proprio non tanto nel conformarsi a dei meccanismi<br />
comportamentali, quanto ad interiorizzare responsabilmente degli<br />
atteggiamenti, me<strong>di</strong>ante la ripetizione <strong>di</strong> decisioni orientate al medesimo<br />
significato-valore. È attraverso la decisione e l’azione che l‘uomo si forma e si<br />
trans-forma.<br />
Vale la pena riconfrontarsi con il Metodo <strong>di</strong> Vita, in quanto tale,<br />
perché conserva a mio parere una sua attualità pastorale e una sua<br />
sperimentabilità per l‘accompagnamento giovanile e vocazionale, oltre che<br />
naturalmente per il proprio cammino spirituale.<br />
Naturalmente, <strong>di</strong>etro il Metodo, come in ogni autentico progetto<br />
educativo, si può rinvenire una «teorizzazione nascosta» o magari implicita,<br />
ovvero l‘anima propriamente pedagogica che sostiene l‘opzione<br />
metodologica – la prassi educativa. Ora, se è vero che l‘opera frassinettiana<br />
non possiede i caratteri dell‘organicità e della sistematicità, perché<br />
corrisponde ad altre esigenze e ad altri criteri (si tratta per la maggior parte<br />
<strong>di</strong> opuscoli occasionali o poco piú, scritti per le piú <strong>di</strong>verse circostanze<br />
pastorali e per classi <strong>di</strong> destinatari talvolta assai <strong>di</strong>fferenziate, per cui hanno<br />
normalmente un‘impostazione decisamente pratica o ascetica, e talvolta<br />
un‘intonazione almeno apparentemente moralistica o devozionale), tuttavia<br />
191
non si deve credere che manchi nel Frassinetti una teologia spirituale<br />
integrale ed una coerente antropologia pedagogica, senza la quale quasi<br />
certamente non avrebbe potuto essere il grande, efficace educatore <strong>di</strong><br />
coscienze e <strong>di</strong> vocazioni che in effetti, innegabilmente, è stato. Del resto, il<br />
Frassinetti si serve non solo <strong>di</strong> sani principi antropologici e teologici, ma<br />
anche – ed è non meno importante – della sua ricchissima esperienza<br />
personale.<br />
Il Metodo è dunque per il Frassinetti un fondamentale strumento <strong>di</strong><br />
santificazione, che racchiude molti degli elementi caratterizzanti della sua<br />
ascetica. Il Metodo (gr. metà + odos) è la «via attraverso la quale» raggiungere<br />
una meta prefissata, e senza la quale non c‘è meta raggiungibile e concreta,<br />
anzi non si cammina affatto! L‘educazione, del resto, è sempre una<br />
questione <strong>di</strong> metodo.<br />
E la via (il metodo) non è meno rilevante della meta (il risultato). Nel caso<br />
del cammino per la santità, non <strong>di</strong>mentichiamo che, in ogni caso, la meta è<br />
sempre dono gratuito <strong>di</strong> Dio. La santità, cioè, è frutto <strong>di</strong> un itinerario ascetico e,<br />
non <strong>di</strong> meno, teologale – umano e soprannaturale. In questo senso la<br />
devozione e la vita sacramentale (specie eucaristica) si integrano<br />
mirabilmente: cfr. «Conforto dell‘anima <strong>di</strong>vota» e «Convito del <strong>di</strong>vino<br />
amore»…<br />
Nel contesto della spiritualità dell‘Ottocento non è raro<br />
riscontrare un certo <strong>di</strong>vorzio tra ascetica e mistica, tra natura e Grazia (lo<br />
stesso giansenismo tanto inviso al Frassinetti eppure tanto <strong>di</strong>lagante ne era<br />
un sintomo). La reazione gesuitica aveva promosso la cosiddetta «devotio»<br />
come atteggiamento <strong>di</strong> confidente abbandono e <strong>di</strong> perfetto adempimento<br />
dei propri doveri. La coscienza virtuosa veniva progressivamente a<br />
coincidere con uno sforzo abituale della volontà, in una prospettiva<br />
eminentemente in<strong>di</strong>vidualistica.<br />
Ancora una volta risulta chiaro come il realismo frassinettiano<br />
ispirato all‘equilibrio <strong>di</strong> S. Alfonso, si mantenga equi<strong>di</strong>stante dai pericoli<br />
dell‘ascetismo e dalle secche del quietismo. La spiritualità frassinettiana<br />
apre (o promuove) nuovi orizzonti, superando l‘in<strong>di</strong>vidualismo, il<br />
volontarismo, il perfezionismo, il devozionismo. Un itinerario <strong>di</strong><br />
santificazione sorretto da una vocazione universale ed accessibile a tutti,<br />
―sereno, facile, attivo, fondato sull‘interiorità, cristocentrico e mariano‖ (P.<br />
Renzi). Per la verità, non solo <strong>di</strong> S. Alfonso si tratta, perché probabilmente<br />
(ma andrebbe ulteriormente verificato, e io non ne ho avuto modo) si<br />
potrebbero identificare le fonti possibili del Metodo o <strong>di</strong> alcuni elementi<br />
che lo compongono in altri Santi. Tra essi, almeno Ignazio (Esercizi<br />
192
Spirituali: tra gli atti che meglio <strong>di</strong>spongono ad accogliere i doni <strong>di</strong> Dio),<br />
Francesco <strong>di</strong> Sales (per l‘atteggiamento amoroso <strong>di</strong> abbandono tipico<br />
dell‘Atto <strong>di</strong> Offerta), Teresa d‘Avila e Giovanni della Croce (per la forza<br />
della preghiera e la spiritualità della croce…) (cfr. Eduardo Monje, L’amore<br />
alla Croce in Giuseppe Frassinetti,Roma, 2002).<br />
Il Frassinetti pensò il Metodo dapprima per la spiritualità<br />
sacerdotale (fu questo, del resto, l‘ambito del suo impegno prioritario e<br />
iniziale), proponendolo nell‘ambito della Congregazione del Beato<br />
Leonardo iniziata (nel 1829 e poi chiusa nel ‘47) sul «triplice fondamento»<br />
della buona intenzione, della preghiera e del consiglio (si vedano, a questo<br />
proposito, le opere de<strong>di</strong>cate ai sacerdoti, specialmente le «Riflessioni<br />
proposte agli ecclesiastici» del ‘37, le «Osservazioni sopra gli stu<strong>di</strong><br />
ecclesiastici» del ‘39, «Gesú Cristo Regola del Sacerdote», il «Manuale del<br />
parroco novello», il «Compen<strong>di</strong>o della Teologia Morale», fino alle «Brevi<br />
parole ai sacerdoti fratelli» e soprattutto ai cosiddetti «Propositi fatti per sé<br />
e per alcuni amici»), poi lo estese alla spiritualità laicale (dalla sorella Paola e<br />
le sue compagne, alla Regola delle Pie Unioni delle <strong>Figli</strong>e e dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. M.<br />
I.), cambiandone naturalmente alcuni connotati, ma conservandone la<br />
struttura <strong>di</strong> base, che si articola essenzialmente in: preghiera, vita<br />
sacramentale, ascesi. In questo senso, compose in modo piuttosto <strong>di</strong>dattico<br />
e a scopo e<strong>di</strong>ficante le due Biografie <strong>di</strong> Rosa Cordone e <strong>di</strong> Rosina<br />
Pedemonte (primi fiori del giar<strong>di</strong>no delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> M. I. <strong>di</strong> Genova), due<br />
veri e propri exempla <strong>di</strong> Metodo in atto, pieni (soprattutto il secondo) <strong>di</strong><br />
chiarimenti dottrinali, <strong>di</strong>gressioni parenetiche e suggerimenti spirituali<br />
(Rosa Cordone, «oscura domestica» originaria della Valpolcevera morta nel<br />
‗59, organizzò la sua vita spirituale secondo un metodo esemplare; Rosina<br />
Pedemonte, morta appena ventenne nel ‘60, è in<strong>di</strong>cata come modello <strong>di</strong><br />
verginità consacrata). Il Frassinetti infine fece uso del Metodo <strong>di</strong> Vita per la<br />
cura pastorale dei giovani e delle fanciulle e come strumento <strong>di</strong> pedagogia<br />
vocazionale (ricor<strong>di</strong>amo l‘Opera <strong>di</strong> S. Raffaele e S. Dorotea: cfr. «Ricor<strong>di</strong><br />
per una figlia che vuol essere tutta <strong>di</strong> Gesú», «Ricor<strong>di</strong> ad un giovanetto<br />
cristiano»), e lo riprese come anima dell‘associazionismo laico, <strong>di</strong> cui fu<br />
instancabile promotore in vista <strong>di</strong> una santificazione parrocchiale (cfr. le<br />
«Amicizie Spirituali», «la Pia Unione delle Anime che desiderano farsi<br />
sante», etc...).<br />
Le «Amicizie spirituali – Imitazione <strong>di</strong> S. Teresa <strong>di</strong> Gesú» (1853) si<br />
fondano sul cap. XVI della «Vita» della carmelitana. Il Frassinetti ne ebbe<br />
notizia fin dal ‘48, quando ne fa cenno in una lettera da S. Cipriano a Sr.<br />
Carlotta Gibelli, e il principio coeducativo <strong>di</strong> una «verace amicizia» (cfr.<br />
Bonhoeffer: amicizia psichica e amicizia pneumatica…) <strong>di</strong>venta presto un<br />
193
«mezzo necessario» e fondamento <strong>di</strong> tutte le iniziative associative e<br />
congregazionali da lui istituite.<br />
Naturalmente, il Metodo non è uno regolamento isolato, ma si<br />
inserisce nel complesso del progetto pastorale frassinettiano come la<br />
«magna charta» dell‘autoeducazione spirituale. Saltano in ogni caso<br />
all‘occhio la centralità dell‘Atto <strong>di</strong> Offerta, il nesso strettissimo con la<br />
pratica delle virtú (attive e passive: quelle passive sintetizzate nell‘umiltà –<br />
fondamenta dell‘e<strong>di</strong>ficio virtuoso - e quelle attive nella carità – essenza<br />
della santità cristiana…), il rapporto essenziale con la Direzione Spirituale e<br />
con la mortificazione (interna ed esterna; e qui merita un cenno il nesso<br />
strettissimo con il celibato e la verginità, promosso in una quantità <strong>di</strong><br />
operette ben conosciute, da «La gemma delle fanciulle cristiane» del ‘41 a<br />
«La forza <strong>di</strong> un libretto» alla «Lettera sul celibato» al «Para<strong>di</strong>so in terra»…<br />
Un mezzo ritenuto dal Frassinetti non necessario alla santità, e tuttavia<br />
un‘aspirazione insopprimibile <strong>di</strong> chi desidera davvero appartenere a Dio.<br />
Gli stessi atti del Processo in<strong>di</strong>viduano, a livello biografico, un vero e<br />
proprio «stu<strong>di</strong>um castitatis» nel Frassinetti che quasi rasenta lo scrupolo!<br />
Tra l‘altro, un tema pedagogicamente molto interessante e delicatissimo è<br />
anche quello del passaggio, promosso dal Frassinetti in tutte quelle persone<br />
per caso o per costrizione impe<strong>di</strong>te al matrimonio o al claustro, dalla<br />
verginità come con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> fatto alla verginità come con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
elezione, senza che ciò implichi – lo ripete spesso – una vocazione<br />
particolare…) e infine, la <strong>di</strong>mensione comunitaria ed ecclesiale <strong>di</strong> quello<br />
che è essenzialmente uno strumento <strong>di</strong> formazione in<strong>di</strong>viduale (il Metodo,<br />
infatti, <strong>di</strong>venta un elemento car<strong>di</strong>ne del cosiddetto «tripode» delle sopra<br />
citate «Amicizie Spirituali»: metodo, appunto, autoaccusa – rispetto<br />
all‘adempimento del Metodo - e correzione fraterna. Una proposta<br />
educativa <strong>di</strong> <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> gruppo che non può non interpellare anche le<br />
nostre Comunità religiose e i nostri progetti <strong>di</strong> formazione…)<br />
Esempi in<strong>di</strong>cativi <strong>di</strong> Metodo <strong>di</strong> Vita si trovano nella «Monaca in<br />
casa», nel «Religioso al secolo» e, ovviamente, nelle regole dei <strong>Figli</strong> e delle<br />
<strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>:<br />
―Potendo ascolteranno tutte le mattine la santa Messa<br />
Faranno mezz‘ora, o almeno un quarto d‘ora <strong>di</strong> orazione mentale e vocale<br />
ogni giorno<br />
Un po‘ <strong>di</strong> adorazione al SS. Sacramento, se potranno, alla sera<br />
Similmente un po‘ <strong>di</strong> lettura spirituale<br />
Mattina e sera... (devozione mariana)<br />
194
Faranno una piena offerta <strong>di</strong> se stessi al Signore, offerendogli anima, corpo<br />
e quanto possiedono, perché <strong>di</strong> tutto faccia ciò che Egli vuole... (a volte F.<br />
raccomanda il gesto <strong>di</strong> Gesú in Croce: a braccia aperte)<br />
Si confesseranno ogni otto giorni e faranno tutte le comunioni che loro<br />
saranno permesse<br />
Reciteranno ogni giorno un Pater, Ave e Credo...<br />
Al sabato faranno una mortificazione in onore <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> SS.‖ (OA II 178)<br />
(cfr. anche: OA II 59-62)<br />
Ne «La monaca in casa», e meglio nell‘Appen<strong>di</strong>ce (Regola delle<br />
<strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> M. I. del 1856) si parla del primo e dell‘ultimo pensiero della<br />
giornata rivolto a Dio in rigraziamento, delle ―Orazioni mattutine e serali<br />
del buon cristiano‖ (che sono sostanzialmente quelle in<strong>di</strong>cate ne «La<br />
devozione illuminata»), dell‘esame <strong>di</strong> coscienza serale, della terza parte del<br />
Rosario da recitarsi ogni giorno, e altrove vengono in<strong>di</strong>cati anche gli<br />
Esercizi Spirituali da svolgersi ogni anno. Anche il sonno viene<br />
<strong>di</strong>sciplinato: non meno <strong>di</strong> 7 ore – <strong>di</strong>ce il Frassinetti - …ma non piú <strong>di</strong> 7 e<br />
mezzo!<br />
La preghiera <strong>di</strong> cui parla il Frassinetti (ma ci sarebbe un intero<br />
trattato a scrivere!) deve poter passare dagli «esercizi <strong>di</strong> pietà» alla<br />
«preghiera fatta col cuore» (da cui l‘uso <strong>di</strong> poche e semplici parole da<br />
«ruminare», come le giaculatorie, secondo il precetto raccomandato da Don<br />
Bosco alla Mazzarello <strong>di</strong> «pregare sempre»), fino alla me<strong>di</strong>tazione (che non<br />
si deve confondere con una sorta <strong>di</strong> allenamento intellettuale, ma consiste<br />
ultimamente nella ―attenzione della nostra mente alle verità della fede e ai<br />
nostri doveri, la quale deve accompagnarci nelle pie letture, nell‘ascoltare la<br />
Parola <strong>di</strong> Dio e nella preghiera). Qui si fa imperioso l‘influsso <strong>di</strong> S. Teresa<br />
d‘Avila (cfr. il «Pater Noster»…), l‘incontro con la quale (soprattutto con il<br />
«Cammino <strong>di</strong> perfezione» e la «Vita») fu per il Frassinetti (a detta <strong>di</strong> P.<br />
Renzi) «folgorante»! (Teniamo presente che l‘effettiva <strong>di</strong>vulgazione del<br />
pensiero teresiano in Italia, non solo a livello d‘élite, ma anche popolare, si<br />
deve perlopiú al Frassinetti, e l‘influsso della spiritualità e della mistica<br />
carmelitana sulla sua opera sarebbe questione da stu<strong>di</strong>are attentamente).<br />
Al centro del Metodo - e <strong>di</strong> tutta l‘ascetica frassinettiana - c‘è<br />
l’interiorità: il cuore è come un ―tabernacolo della Trinità‖, in cui è custo<strong>di</strong>ta<br />
la Presenza <strong>di</strong> Dio, e il cammino del <strong>di</strong>scepolo è, in ultima analisi, un<br />
percorso <strong>di</strong> conformazione interiore a Cristo: ―devi essere specchio immacolato<br />
e immagine della mia bontà‖ (Gesú Cristo Regola del Sacerdote). Come<br />
scrive S. Paolo: ―abbiate gli stessi sentimenti che furono <strong>di</strong> Cristo Gesú‖...<br />
―non sono piú io che vivo, ma Cristo vive in me‖.<br />
195
L‘interiorità è il luogo dell‘amore <strong>di</strong> Dio: ―regina <strong>di</strong> tutte le virtú‖;<br />
la santità è come l‘ardore e la luminescenza dell‘anima che tanto piú arde e<br />
fa luce quanto piú grande è il fuoco della carità che racchiude. La santità per<br />
il Frassinetti consiste infatti nella carità, cioè nell’amore assoluto <strong>di</strong> Dio, che poi<br />
consiste nell‘adempimento della sua volontà (Il Conforto dell‘anima<br />
<strong>di</strong>vota), la quale poi consiste in nuce nell‘amore del prossimo (cfr.<br />
comandamento nuovo: ―amatevi come io vi amo‖). L’amore <strong>di</strong> Dio, infatti, è<br />
in<strong>di</strong>ssolubilmente collegato all’amore del prossimo, per cui interiorità non<br />
significa allontanamento dal mondo e dagli altri, ma ritorno ad essi per<br />
servirli senza esserne alienati.<br />
L‘interiorità per il Frassinetti non è dunque il soggettivismo<br />
romantico, non è puro in<strong>di</strong>vidualismo, solipsismo o ripiegamento egoistico<br />
o introversione «psicotica» (autismo): l‘interiorità è anzi (agostinianamente)<br />
trascendenza <strong>di</strong> sé nell‘intimo, accoglienza dell’Altro nel cuore del Sé; unione con<br />
Dio, <strong>di</strong>alogo con un Tu, fusione <strong>di</strong> due volontà. Nel «Convito del Divino<br />
Amore» il Frassinetti <strong>di</strong>ce molto bene che l‘amore <strong>di</strong> Dio (sinonimo <strong>di</strong><br />
santità ed essenza dell‘interiorità) consiste ultimamente nell‘uniformità<br />
perfetta alla Sua volontà, fino a fare delle due volontà una volontà sola.<br />
La libertà interiore è dunque il luogo da <strong>di</strong>fendere da tutto ciò che<br />
tende ad espellere la presenza <strong>di</strong> Dio, e il luogo da colmare dell‘amore <strong>di</strong><br />
Lui. Come in S. Alfonso, c‘è qui una complementarità tra negazione e<br />
affermazione, tra l‘ascetica del <strong>di</strong>stacco dai beni terreni, tra il vuoto <strong>di</strong><br />
passioni, e la mistica dell‘unione con Dio e del riempimento della Sua<br />
Passione (non a caso il Frassinetti pre<strong>di</strong>ligeva l‘icona della croce,<br />
apprezzava la devozione al S. Cuore, ed attribuiva un ruolo centrale e<br />
decisamente preponderante, nel <strong>di</strong>namismo della santificazione, alla<br />
contemplazione eucaristica e alla Comunione al sacrificio dell‘altare).<br />
I mezzi in<strong>di</strong>cati dal Frassinetti per costruire l’interiorità nel «Conforto<br />
dell‘Anima <strong>di</strong>vota» sono i seguenti: il Desiderio <strong>di</strong> farsi santi e il Direttore<br />
spirituale (ove questo è, ovviamente, al servizio <strong>di</strong> quello e senza quello<br />
sarebbe del tutto inutile):<br />
―S‘io dovessi parlarvi <strong>di</strong> tutti i mezzi che possono conferire al<br />
conseguimento della perfezione cristiana, bisognerebbe ch‘io vi facessi un<br />
lunghissimo trattato... due soli mezzi vi assegnerò dai quali sogliono<br />
<strong>di</strong>pendere tutti gli altri. Il primo, è quello che vi metterà sulla strada della<br />
perfezione cristiana; il secondo, è quello che vi servirà da guida sicura,<br />
affinché camminiate bene e facciate gran<strong>di</strong> passi sulla strada medesima. Il<br />
primo è il desiderio <strong>di</strong> conseguire la perfezione cristiana, e senza <strong>di</strong> questo<br />
non si fa nulla [Il secondo è il <strong>di</strong>rettore spirituale]...Questo desiderio però<br />
196
non sia un desiderio irresoluto, come quello <strong>di</strong> tante anime che vorrebbero<br />
farsi sante, ma però non si sanno giammai determinare... Bisogna<br />
cominciare con una forte e costante risoluzione <strong>di</strong> darsi tutti a Dio - <strong>di</strong>ceva<br />
S. Francesco <strong>di</strong> Sales - ... e poi andare spesso rinnovando questa medesima<br />
risoluzione‖.<br />
(OA I 40-41)<br />
Altrove («L‘Arte <strong>di</strong> Farsi Santi»), il Frassinetti enumera come<br />
mezzi: l’offerta <strong>di</strong> sé, la docilità alle buone ispirazioni e la <strong>di</strong>rezione spirituale:<br />
―Affinché ci facciamo santi, due cose sono necessarie: la grazia <strong>di</strong> Dio e la<br />
nostra volontà. Se Dio non ci desse la grazia, sarebbe impossibile che ci<br />
facessimo santi; e sarebbe parimente impossibile se a questa grazia non<br />
volessimo corrispondere, perché Dio non fa santi per forza. Or bene: la<br />
prima <strong>di</strong> queste due cose, cioè la grazia <strong>di</strong> Dio, non manca mai, perché Egli<br />
a tutti la dà: manca spesse volte la seconda, cioè la nostra volontà, perché<br />
noi, pel nostro attaccamento, ossia pel nostro amore <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato a noi<br />
stessi ed alle cose <strong>di</strong> questo mondo, abbiamo una volontà, o in tutto o in<br />
parte, contraria e nemica alla santità... È dunque necessario <strong>di</strong>struggere<br />
questa contrarietà e questa inimicizia della nostra volontà, levando<br />
quell‘attaccamento <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato... colla totale offerta che noi facciamo a Dio<br />
<strong>di</strong> tutti noi stessi, e <strong>di</strong> tutte le cose nostre ... Ed ecco come si fa questa<br />
offerta... Il cristiano si mette davanti a Dio, e gli offre umilmente tutto<br />
quanto è, e quanto ha in questo mondo, perché Dio ne faccia tutto ciò che<br />
vuole... Presenta in offerta a Dio l‘anima, le sue facoltà, memoria, intelletto,<br />
volontà; il corpo, le forze, la sanità, la vita; tutta la sua roba, denaro,<br />
sostanze, o poche o molte che ne abbia; il suo onore, la sua riputazione, le<br />
sue cariche, occupazioni, professione o mestiere, e qualunque altra cosa<br />
possa avere, rassegnando tutto nelle sue santissime paterne mani, e<br />
pregandolo a fare <strong>di</strong> lui stesso e delle cose sue come e quanto meglio stima;<br />
<strong>di</strong>mandandogli solo la grazia <strong>di</strong> amarlo con tutto il cuore, <strong>di</strong> adempiere<br />
perfettamente e per ogni modo la sua santissima volontà... Vedete che in<br />
questa offerta il cristiano si <strong>di</strong>scioglie, si svincola da ogni affetto<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato che possa avere a se stesso e alle cose... Il cristiano incomincia<br />
a fare questa offerta coll‘aiuto della grazia <strong>di</strong> Dio, senza la quale è<br />
impossibile concepire un minimo buon pensiero; e questa grazia <strong>di</strong> Dio che<br />
fa cominciare, è quella pure che fa compiere e perfezionare la stessa<br />
offerta, e la rende efficace e fruttuosa nella pratica...‖ [poi parla della<br />
corrispondenza alle buone ispirazioni e del <strong>di</strong>rettore spirituale]<br />
(OA I 86-90)<br />
197
Volendo fare l‘equazione, dovremmo <strong>di</strong>re che: desiderio = offerta <strong>di</strong><br />
sé + docilità alle buone ispirazioni.<br />
Il desiderio della santità comporta ―che voi vogliate vivere<br />
solamente per Id<strong>di</strong>o, e non vogliate piú esistere, se non per dargli gloria,<br />
gusto ed onore... Quando <strong>di</strong>co che quivi si devono riconcentrare tutte le<br />
vostre brame, voi capite che voglio <strong>di</strong>rvi, doversi <strong>di</strong>rigere al conseguimento<br />
della perfezione tutti i desideri che potete avere in questo mondo: e vorrei<br />
che si <strong>di</strong>rigessero tutti al conseguimento della perfezione con tanta<br />
pienezza, da potersi <strong>di</strong>re che voi non avete piú che un solo desiderio,<br />
quello cioè <strong>di</strong> conseguirla. Felice il cuore che non ha piú, se non un amore<br />
e un desiderio!... Rinunziate, dunque, a tutti gli altri desideri, che mai<br />
potessero nascervi in cuore, e ritenete questo, unico e solo... Tutti gli altri<br />
desideri che in questo non fossero riconcentrati, servirebbero a <strong>di</strong>videre il<br />
vostro cuore tra Dio e le creature, e vi sarebbero d‘impe<strong>di</strong>mento‖.<br />
(OA II 10)<br />
Ma, lungi da ogni spiritualismo inconsistente e aleatorio o astratto,<br />
il Frassinetti ricorda il nesso tra obbe<strong>di</strong>enza a Dio e obbe<strong>di</strong>enza alla vita<br />
(che è vero in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> vocazione!):<br />
―La via piú spe<strong>di</strong>ta per giungere a conseguire la perfezione... ci viene<br />
tracciata da S. Giovanni della Croce nella Salita al Carmelo (Lib. I cap. 5),<br />
dove <strong>di</strong>ce che «quell‘anima la quale altro non pretenderà, se non osservare<br />
perfettamente la legge <strong>di</strong> Dio e portar bene la croce, sarà vera arca che<br />
conterrà in sé la vera manna, cioè Dio»... Ora qui è chiaro, che il santo<br />
vorrebbe per tal modo escluso dal cuore dell‘uomo qualunque appetito o<br />
desiderio, eccettuato quello <strong>di</strong> osservare in tutta esattezza e puntualità la<br />
legge <strong>di</strong> Dio... e quello <strong>di</strong> portare con piena uniformità ai <strong>di</strong>vini voleri la<br />
croce propria, cioè le tribolazioni e le angustie della vita‖.<br />
(OA II 93)<br />
L’Offerta <strong>di</strong> Sé è punto <strong>di</strong> partenza e punto <strong>di</strong> arrivo del cammino<br />
<strong>di</strong> crescita spirituale. La sua funzione è quella <strong>di</strong> stabilire e <strong>di</strong> consolidare<br />
progressivamente un autentico e totale atteggiamento <strong>di</strong> libera autotrascendenza (che<br />
è l‘essenza stessa del desiderio: il Frassinetti parla in proposito <strong>di</strong> «stato <strong>di</strong><br />
oblazione abituale»). La docilità alle Buone Ispirazioni consiste invece<br />
nell‘accoglienza della Grazia e dei moti dello Spirito.<br />
Abbiamo dunque in perfetto equilibrio la componente ascetica e<br />
quella mistica del desiderio: l‘una ha per soggetto l’uomo, l‘altra ha per<br />
soggetto Dio; l‘una si pone nella prospettiva della natura e della volontà,<br />
l‘altra dal punto <strong>di</strong> vista della Grazia e dell‘iniziativa gratuita <strong>di</strong> Dio.<br />
198
Notiamo che la garanzia <strong>di</strong> riuscita del Metodo è, comunque, non tanto la<br />
capacità umana, quanto la fedeltà incon<strong>di</strong>zionata <strong>di</strong> Dio: solo così si capisce<br />
come il Frassinetti possa <strong>di</strong>re che la santità ―è cosa semplice e anche facile‖<br />
(L‘Arte <strong>di</strong> Farsi Santi). Nessun volontarismo, nessun perfezionismo,<br />
dunque: il piú lo fa Dio - occorre solo pre<strong>di</strong>sporre un Metodo che ci educhi a<br />
lasciarLo operare. La Grazia ci precede sempre e ci accompagna (cfr. OA I<br />
43).<br />
Il segreto della santità, sembra <strong>di</strong>rci il Frassinetti continuamente, è<br />
confidare piú nella Sua potenza <strong>di</strong> quanto non ci preoccupiamo delle<br />
nostre fragilità, contare piú su <strong>di</strong> Lui che su noi stessi: per questo il cuore<br />
della santificazione è la costante, ripetuta, perseverante offerta <strong>di</strong> sé, che<br />
significa un sempre rinnovato abbandono nelle Sue mani: ―Tu sei mio, non<br />
sei cosa tua; abbandonati nelle mie mani; io farò <strong>di</strong> te sempre il meglio,<br />
come il saggio padrone fa delle sue cose‖ («Gesú Cristo Regola del<br />
Sacerdote»).<br />
Ed infatti la Grazia santificante proveniente dalla vita sacramentale<br />
(confessione e in particolare Comunione frequente) è il mezzo piú efficace,<br />
secondo il Frassinetti, per conservare intatto e vivo il desiderio della santità<br />
e per mantenersi non solo nella castità (cioè nella totale appartenenza a<br />
Dio), che è un pilastro dell‘ascetica frassinettiana, ma anche<br />
nell‘obbe<strong>di</strong>enza e nella povertà, quando sono richieste dallo stato <strong>di</strong> vita<br />
(perché tutte scaturiscono dalla maturità <strong>di</strong> quell‘amore oblativo e<br />
sommamente libero che si esprime pienamente nella partecipazione al<br />
sacrificio della croce).<br />
Il desiderio, vero motore della santità, a detta del Frassinetti, deve<br />
essere: soprannaturale, umile e fiducioso (tiene conto piú della misericor<strong>di</strong>a<br />
<strong>di</strong> Dio che delle debolezze umane), alieno da scrupoli (che rischiano <strong>di</strong> far<br />
precipitare nell‘immobilismo della paura o nell‘orgoglio dell‘introspezione<br />
esasperata), costante e fermo (non legato all‘entusiasmo o a circostanze<br />
contingenti o straor<strong>di</strong>narie).<br />
Senza desiderio non c‘è santità, non c‘è vocazione, non c‘è crescita<br />
spirituale, non c‘è felicità. La vocazione stessa, del resto, nasce dal mistero<br />
dell‘incontro tra la ricerca dell‘uomo e la risposta <strong>di</strong> Dio (notate: Dio<br />
risponde a noi molto prima e molto piú <strong>di</strong> quanto noi possiamo presumere <strong>di</strong><br />
rispondere a Lui!); nasce, cioè, da un grande desiderio - o meglio,<br />
dall‘incontro <strong>di</strong> due desideri, due progetti, due sogni (come tutte le autentiche<br />
storie d‘amore...)<br />
Il desiderio sta dunque a fondamento e al centro anche del<br />
Metodo, che sembrerebbe costruito interamente attorno ad esso, come un<br />
e<strong>di</strong>ficio fortificato atto a custo<strong>di</strong>re qualcosa <strong>di</strong> prezioso, <strong>di</strong> vitale: lo<br />
199
itroviamo in quell‘espressione-chiave dell‘ascetica frassinettiana che è,<br />
appunto, l’Atto d’Offerta.<br />
Tutti gli altri elementi del Metodo <strong>di</strong> Vita sono anzi, se non<br />
m‘inganno, mezzi e strumenti per la conservazione e l‘espansione <strong>di</strong> quel<br />
desiderio che viene espresso nell‘offerta <strong>di</strong> sé: stima e conoscenza della<br />
perfezione (quin<strong>di</strong> istruzione e catechesi), <strong>di</strong>rezione spirituale,<br />
mortificazione (<strong>di</strong>stacco dal materiale e rinuncia al mondo per aderire piú<br />
pienamente a Dio: <strong>di</strong>namica battesimale), preghiera e me<strong>di</strong>tazione come<br />
educazione dell‘intelligenza e dell‘affettività, vita sacramentale (confessione<br />
perio<strong>di</strong>ca e comunione frequente), devozione alla Madonna (modello <strong>di</strong><br />
santità e <strong>di</strong> perfetta castità), amicizie spirituali (santità come avventura<br />
ecclesiale e comunitaria, non intimistica o privatistica)...<br />
È molto importante – ed estremamente attuale, a mio giu<strong>di</strong>zio –<br />
questo primato del desiderio nell‘educazione alla vita spirituale. Di fatto,<br />
non c‘è educazione se non attenendosi al principio <strong>di</strong>namico del desiderare:<br />
chi non desidera non apprende, non ama, non cresce, perché<br />
semplicemente non si trascende!<br />
Ecco perché una società, poi, che si fonda prevalentemente sulla<br />
sod<strong>di</strong>sfazione (e sull‘induzione) dei bisogni vecchi e nuovi (com‘è la società<br />
materialistica dei consumi, appiattita sul presente, sull‘imme<strong>di</strong>ato, sulla<br />
retorica del potere e del successo, su un certo narcisismo) è profondamente<br />
<strong>di</strong>s-educativa, de-formativa: perché non accede all‘interiorità, e riduce<br />
anche le esigenze spirituali allo stato <strong>di</strong> bisogni bio-psicologici (che<br />
facilmente conducono alla religione fai-da-te <strong>di</strong> cui ormai sono pieni anche i<br />
reparti dei nostri supermarket!). Nel 1922 O. Spengler nel suo controverso<br />
«Tramonto dell‘Occidente» aveva profetizzato che la nostra civiltà si<br />
sarebbe estinta per il trionfo del denaro sullo spirito…<br />
Il desiderio è la capacità <strong>di</strong> canalizzare tutte le nostre energie verso<br />
un oggetto, un fine, un valore, un‘aspirazione trascendente, che <strong>di</strong>viene<br />
centrale per noi e per l‘organizzazione della nostra identità. Non è un<br />
impulso cieco e irrazionale, una causa che «spinge» da tergo, ma è una<br />
motivazione proattiva, una ragione che attrae: è un «per» finale, non<br />
causale! La sua essenza sta nel futuro, non nel passato. Il bisogno limita,<br />
costringe la libertà. Il desiderio, invece, la estende. I bisogni stabiliscono<br />
una tirannia del «dover-essere» (muessen); i desideri esigono un <strong>di</strong>verso<br />
dover-essere (sollen). La libertà, del resto, non è mai vuota, ma piena <strong>di</strong><br />
doveri (scelti, non imposti!). Ma certo c‘è una <strong>di</strong>fferenza fondamentale tra<br />
l‘essere «costretto perché determinato» e l‘essere «obbligato perché libero»<br />
(cfr. Manenti, Vivere gli ideali. Tra paura e desiderio, EDB, Bologna).<br />
200
Il desiderio è sempre orientato all‘altro (allocentrico) – il bisogno è<br />
centrato su <strong>di</strong> sé (ego-centrico). Chi ha bisogno riduce l‘altro (un significato<br />
o un valore o una persona, anche Dio!) ad oggetto, a mezzo per un fine:<br />
può anche ucciderlo; per chi desidera, invece, l‘altro è il fine: e allora può<br />
uccidere se stesso (dono <strong>di</strong> sé e sacrificio: la Croce!).<br />
Go<strong>di</strong>n («Psicologia delle esperienze religiose») <strong>di</strong>stingue la<br />
religione Funzionale (alla base della quale c‘è una risposta a bisogni naturali)<br />
dalla religione Personale (guidata invece dall‘appello dei desideri <strong>di</strong>vini). Se il<br />
desiderio <strong>di</strong> Dio (innato nella coscienza…) degenera o si assopisce, si<br />
frantuma questa esigenza <strong>di</strong> ulteriorità inesauribile in una molteplicità <strong>di</strong><br />
miopi bisogni (<strong>di</strong> intimità, <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong> sacralità, <strong>di</strong> benessere…).<br />
Ebbene, per il Frassinetti l‘autentico rapporto con Dio deve condurre ad<br />
un incontro <strong>di</strong> desideri, anzi ad un sovvertimento dell‘or<strong>di</strong>ne dei desideri,<br />
fino alla fusione delle due volontà, fino a lasciare che a poco a poco Dio<br />
desideri in noi (e questa è vocazione!): come <strong>di</strong>ce, la liturgia: ―…conce<strong>di</strong>ci<br />
<strong>di</strong> amare ciò che coman<strong>di</strong> e <strong>di</strong> desiderare ciò che prometti‖.<br />
I prodromi <strong>di</strong> questa priorità del desiderio si possono far risalire<br />
ad Agostino (ricordate: ―Inquietum cor nostrum…‖), ma forse ad<strong>di</strong>rittura<br />
a Platone (la via erotica che tende all‘assoluto: l‘amore ha una rilevanza<br />
metafisica, anche se può degenerare in concupiscenza…), fino a S.<br />
Bonaventura, che nell‘«Itinerarium» assegna il primato nell‘ascensus in<br />
Deum alla Voluntas (che è una facoltà essenzialmente affettiva), e a S.<br />
Tommaso, che nella S. Th. (II-II, q.180, a.1, se non ricordo male), afferma<br />
che la vita contemplativa è guidata dall‘intentio, che afferisce alla sfera<br />
affettiva della voluntas, la quale ha il potere <strong>di</strong> muovere tutte le altre<br />
facoltà, intelletto incluso…<br />
Su questo ricordo che un confronto con la spiritualità <strong>di</strong> S. Ignazio<br />
<strong>di</strong> Lojola può essere fecondo. Ultimamente è uscito su «La civiltà cattolica»<br />
un contributo <strong>di</strong> Spadaro molto utile in proposito, circa la funzione del<br />
desiderio negli Esercizi ignaziani. Effettivamente, Ignazio raccomanda il<br />
suo metodo solo a persone ―molto desiderose <strong>di</strong> perfezione‖. E i suoi<br />
commentatori <strong>di</strong>cono che lo scopo degli Esercizi consiste nel ―lasciare<br />
parlare il desiderio fondamentale‖ (De Certeau) ovvero nel trovare il punto<br />
unico in cui si unifichino i molteplici desideri umani. E anche negli Esercizi<br />
si trova ―l‘offerta <strong>di</strong> sé come rispondenza ad un desiderio ed una ferma<br />
volontà‖ (ES 98). Del resto, lo stesso fondatore della Compagnia <strong>di</strong> Gesú<br />
descriveva nell‘Autobiografia la propria conversione come una<br />
―metamorfosi‖ <strong>di</strong> desiderio: da quello <strong>di</strong> ―acquistare onore‖ a quello <strong>di</strong><br />
―servire Dio‖.<br />
E mi preme rilevare ancora che altri mistici e maestri <strong>di</strong> spiritualità<br />
stanno verosimilmente alla base <strong>di</strong> questa intuizione frassinettiana: mi<br />
201
iferisco alla «Fiamma d‘amore» <strong>di</strong> S. Giovanni della Croce, alle Sante<br />
Brigida, Geltrude e Maddalena de‘ Pazzi, piú volte citate dal Frassinetti, e<br />
soprattutto a S. Caterina da Genova (Caterinetta Fieschi Adorno), mistica e<br />
santa della carità straor<strong>di</strong>naria vissuta nella seconda metà del XV secolo,<br />
che il Frassinetti denomina la «serafina del puro amor <strong>di</strong> Dio», per la quale<br />
la carità fu tutta un ardente desiderio capace <strong>di</strong> bruciare – letteralmente –<br />
come un fuoco tutto il resto (si vedano le pagine bellissime sulla pena <strong>di</strong><br />
desiderio nel «Trattato del Purgatorio» e quelle veramente stupefacenti<br />
della «Vita» circa le sofferenze della strana infermità degli ultimi tempi…)<br />
Se il Metodo è il contesto educativo del desiderio, il desiderio è il<br />
cuore del Metodo: cosí al centro del Metodo ritroviamo sempre l‘Atto <strong>di</strong><br />
Offerta. Perché, se il desiderio è – potremmo <strong>di</strong>re – il principio<br />
motivazionale dell‘itinerario <strong>di</strong> crescita spirituale, l‘atto <strong>di</strong> offerta ne è il<br />
principio <strong>di</strong>namico, perché appunto <strong>di</strong>namizza continuamente il desiderio<br />
ispiratore, lo sostiene, lo riconferma e non ne lascia cadere la tensione. La<br />
preghiera, <strong>di</strong> cui l‘atto <strong>di</strong> offerta è la quintessenza, ―alimenta il desiderio e<br />
questo muove la volontà‖ (cfr. «Monaca in casa»).<br />
La preghiera per il Frassinetti - ed in particolare questa, che deve<br />
essere la piú personale, la piú frequente e la piú intima - deve essere forte,<br />
partecipata, breve <strong>di</strong> parole e intensa, semplice e confidente. L‘Atto <strong>di</strong><br />
offerta è il punto <strong>di</strong> partenza (e <strong>di</strong> arrivo!) e l‘essenza stessa della preghiera,<br />
e il Frassinetti – come osserva Sr. E. Posada - ne fa una vera propria<br />
questione teologica:<br />
―L‘offerta della propria volontà è un abbandono che l‘anima sposa deve<br />
fare <strong>di</strong> tutta se stessa e <strong>di</strong> tutte le cose sue nelle mani dello Sposo; il quale<br />
abbandono è il principio e il fine <strong>di</strong> tutta la perfezione... perché<br />
generalmente, quella prima offerta e moltissime che si fanno dopo, non<br />
sono così perfette nella loro sostanza, come lo sono nelle parole. Dice<br />
l‘anima: Signore, io mi do tutta a Voi, e tutte le cose mie; ma pure, senza<br />
avvedersene, conserva ancora moltissimi attacchi... e quin<strong>di</strong> è necessario<br />
che sempre attenda alla purificazione del proprio cuore, e che frattanto<br />
rinnovi sempre la sua offerta; affinché a volta a volta <strong>di</strong>venga essa sempre<br />
piú sincera davanti a Dio, e finalmente con piena verità si abbandoni nelle<br />
sue mani... Per la qual cosa, ogni anima veramente desiderosa <strong>di</strong> piacere al<br />
Signore, con grande umiltà ed amore insieme, rinnovi frequentemente la<br />
sua offerta, e non si stanchi fino alla morte; perché, beata lei! se allora,<br />
allora almeno, arriverà a farla così perfetta, com‘è a desiderare!‖<br />
(OA I 242)<br />
202
―La Gerusalemme Celeste non ha una, ma do<strong>di</strong>ci porte!‖ - sta<br />
scritto nel Conforto dell‘Anima Divota. Se il Frassinetti sostenne sempre la<br />
vocazione universale alla santità, non per questo impose a tutti la stessa<br />
«via», ma modulò il percorso a seconda del sesso, della con<strong>di</strong>zione sociale,<br />
dello stato <strong>di</strong> vita, dell‘indole psicologica e spirituale dei singoli, della<br />
concreta fase esistenziale che stanno attraversando.<br />
L‘importante è capire che la vocazione è progettualità, e un progetto è<br />
sempre fatto <strong>di</strong> obiettivi e strumenti per conseguirli. Vocazione significa viversi<br />
come un progetto, e vivere la vita come un compito. Nessun istrionismo,<br />
nessuna improvvisazione, nessuna pseudo-creatività (che poi si riduce<br />
spesso nel non creare un bel niente!) Il Metodo deve aiutarci ad allenare la<br />
capacità <strong>di</strong> cercare la volontà <strong>di</strong> Dio, che molto spesso passa attraverso la<br />
«vocazione» insita in ogni singola situazione esistenziale e in ogni incontro<br />
interpersonale.<br />
Sarebbe quin<strong>di</strong> opportuno – entro già nel merito delle proposte –<br />
che ognuno elaborasse un proprio Atto <strong>di</strong> Offerta, personalissimo (ma già<br />
il «Pactum pacis» ne è un esempio eccellente) da ripetere al mattino e piú<br />
volte durante il giorno, per rinvigorire il desiderio <strong>di</strong> abbandonarsi<br />
totalmente in Dio. E dal momento che ―ad ottenere le cose giovano i<br />
mezzi, non i desideri‖ («Il religioso al secolo»), sarebbe bello anche che<br />
ognuno avesse un suo Metodo <strong>di</strong> Vita interiore (oltre le Costituzioni, che<br />
già rappresentano uno strumento <strong>di</strong> crescita spirituale). Il Metodo è<br />
personalizzato e sarà poi da verificare però con la <strong>di</strong>screzione e il<br />
<strong>di</strong>scernimento del sacerdote-guida o del Direttore Spirituale. Occorre aver<br />
cura però che corrisponda ad alcuni criteri: sia essenziale (pochi elementi<br />
qualificanti), realistico (a partire dalla situazione personale concreta e<br />
d‘accordo con le reali possibilità <strong>di</strong> impegno <strong>di</strong> ciascuno), effettuabile e<br />
verificabile (cioè fatto <strong>di</strong> propositi pratici), semplice e serio<br />
contemporaneamente (cioè non troppo né troppo poco impegnativo).<br />
Deve comunque riguardare i seguenti punti caratterizzanti: preghiera<br />
giornaliera; vita sacramentale (Confessione perio<strong>di</strong>ca e frequenza<br />
all‘Eucarestia); me<strong>di</strong>tazione della Parola e formazione cristiana (catechesi,<br />
lettura spirituale, etc.); impegno e servizio; affettività e relazioni;<br />
lavoro/stu<strong>di</strong>o/tempo libero.<br />
Occorre preliminarmente fare un‘analisi il piú possibile obiettiva<br />
della propria situazione, delle maggiori <strong>di</strong>fficoltà, degli ambiti e bisogni <strong>di</strong><br />
crescita piú urgenti, dei «talloni d‘Achille» eventualmente (anzi: quasi<br />
certamente) presenti, dei desideri piú attuali e degli obiettivi piú sentiti, per<br />
poi tradurli in propositi concreti e dettagliati, in modo che possano poi essere<br />
verificati <strong>di</strong> volta in volta.<br />
203
Porto 28 Dicembre 1999<br />
Daniele Bruzzone<br />
LA SCELTA DELLO STATO DI VITA E L’APPELLO<br />
ALLA VERGINITÀ.<br />
Alcune considerazioni sul pensiero <strong>di</strong> G. Frassinetti<br />
SOMMARIO<br />
1. La vocazione e gli stati <strong>di</strong> vita<br />
2. Il primo passo per la scelta dello stato <strong>di</strong> vita: il desiderio <strong>di</strong> santità e<br />
l‘abbandono alla volontà <strong>di</strong> <strong>di</strong>o per mezzo dell‘atto <strong>di</strong> offerta<br />
3. Le due forme dell‘amore sponsale: matrimonio e verginità<br />
4. La castità perfetta come mezzo privilegiato <strong>di</strong> santificazione<br />
5. Il <strong>di</strong>scernimento sulla propria vita e il ruolo della preghiera<br />
6. La necessità dell‘accompagnamento <strong>di</strong> un padre spirituale<br />
204
1. LA VOCAZIONE E GLI STATI DI VITA<br />
Dio chiama ogni uomo a realizzare un progetto <strong>di</strong> santità che deve<br />
condurlo al possesso della vita eterna. Nella misura in cui l‘uomo prende<br />
coscienza <strong>di</strong> questo progetto e cerca <strong>di</strong> adeguare ad esso la propria vita, egli<br />
realizza la sua vocazione.<br />
C‘è una vocazione che interessa tutti, che è quella alla fede e alla<br />
santità: ―In Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto<br />
nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi‖ (Ef 1,4-5);<br />
Si <strong>di</strong>stinguono poi vocazioni particolari, che sono evidentemente<br />
<strong>di</strong>verse per ognuno e sono dunque personali.<br />
In sintesi questi sono gli elementi fondamentali <strong>di</strong> ogni vocazione<br />
particolare:<br />
1) Un modo <strong>di</strong> vivere, cioè lo stare con Gesú per imitare la sua vita;<br />
2) La missione, il compito specifico o il carisma. Questa vocazione<br />
apostolica dei primi <strong>di</strong>scepoli è il tipo <strong>di</strong> ogni vocazione personale.<br />
Un aspetto della vocazione personale è la forma <strong>di</strong> vita che si è<br />
chiamati ad abbracciare. È chiaro dunque che ogni cristiano che vuole<br />
vivere la sua vocazione, deve sempre volgere lo sguardo alla vita <strong>di</strong> Cristo<br />
per imitarla nella propria forma <strong>di</strong> vita cioè ad essere santo come Lui è<br />
santo.<br />
Tutti sono infatti chiamati alla santità ciascuno secondo il proprio<br />
stato <strong>di</strong> vita: inutile dunque cercare la santità al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> esso. Ci<br />
santificheremo nella misura in cui compiremo fedelmente ogni giorno la<br />
volontà <strong>di</strong> Dio in quella forma <strong>di</strong> vita che egli ha scelto per noi. E ognuno<br />
<strong>di</strong> noi riceve da Dio una missione (cf Mc 3,13-14) che è chiamato a vivere<br />
secondo la forma <strong>di</strong> vita che gli è propria, secondo il proprio posto che<br />
occupa nella Chiesa.<br />
Qual è il contributo <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti circa la scelta dello<br />
stato <strong>di</strong> vita?<br />
2. IL PRIMO PASSO PER LA SCELTA DELLO STATO DI VITA:<br />
IL DESIDERIO DI SANTITÀ E L’ABBANDONO ALLA<br />
VOLONTÀ DI DIO PER MEZZO DELL’ATTO DI OFFERTA<br />
Una delle piú assillanti preoccupazioni del Frassinetti fu quella <strong>di</strong><br />
presentare la santità come possibile a tutti, tentando a piú riprese <strong>di</strong><br />
demolire il pregiu<strong>di</strong>zio che la santità sia privilegio <strong>di</strong> poche anime prescelte.<br />
Frassinetti dunque ripete in molte sue opere, quasi a mo‘ <strong>di</strong> slogan,<br />
che il farsi santi è una vocazione per tutti, dal momento che Dio vuole che<br />
205
le anime si facciano sante in qualunque stato e con<strong>di</strong>zione esse si trovino.<br />
La santità consiste innanzitutto nell‘adempimento della volontà <strong>di</strong> Dio. Il<br />
farsi santi vuol <strong>di</strong>re darsi pienamente a Dio. La santità si esprime dunque<br />
nella conformità alla volontà <strong>di</strong> Dio, nel farsi dono al Signore senza riserve,<br />
nell‘amore che opera appunto la ―fusione‖ tra le due volontà, quella umana<br />
e quella <strong>di</strong>vina, nel compiere ciò che piace al Signore. Di qui nasce<br />
l‘impegno <strong>di</strong> ricerca del proprio stato <strong>di</strong> vita. ―La santità cristiana consiste<br />
nell‘adempimento della volontà <strong>di</strong>vina‖ («Il conforto dell‘anima <strong>di</strong>vota»,<br />
OA I, 7).<br />
Il primo passo da compiersi in questo itinerario <strong>di</strong> ricerca è<br />
appunto l‘attivazione del desiderio <strong>di</strong> santità (cf «Il conforto dell‘anima<br />
<strong>di</strong>vota», OA I, 40-42); se non si ha il desiderio <strong>di</strong> una cosa, neppure la si<br />
cerca, la si vuole per sé.<br />
Per giungere a questa meta uno degli «strumenti» che il Priore<br />
consiglia è l‘offerta totale <strong>di</strong> sé che l‘anima farà a Dio, perché Egli faccia <strong>di</strong><br />
lei ciò che vuole. È un atto reale <strong>di</strong> abbandono, un arrendersi alla volontà<br />
<strong>di</strong> Dio. Ascoltiamo cosa <strong>di</strong>ce il Frassinetti nell‘operetta «Offerta <strong>di</strong> noi a<br />
Dio» (OA I, 321-322): ―Dio ci ha fatti liberi, e Dio non lavora nel nostro cuore se<br />
noi non lo vogliamo. Egli è pronto a farci tutti suoi, cioè santi, ma vuole che noi siamo<br />
pronti a tutto, e che ci offriamo a Lui con un’offerta intera e irrevocabile. Come si fa?<br />
Bisogna che ci persua<strong>di</strong>amo che noi siamo <strong>di</strong> Dio, e che nulla possiamo avere <strong>di</strong> maggiore<br />
bene che l’essere tutti suoi, e che si adempia la sua santa volontà sopra <strong>di</strong> noi. Allora<br />
l’uomo sta veramente bene quando la <strong>di</strong>vina volontà si adempie perfettamente da lui e<br />
sopra <strong>di</strong> lui: ancorchè fosse nel fuoco, ne sarebbe lieto…Fatta questa offerta così piena,<br />
ecco che Dio comincia a lavorare nel nostro cuore per farci santi‖.<br />
È dunque necessario <strong>di</strong>struggere le resistenze, le contrarietà<br />
proprie della nostra volontà, quell‘«attaccamento <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato» a noi stessi e<br />
alle cose del mondo, che può essere annientato solo con l‘offerta totale a<br />
Dio <strong>di</strong> noi stessi e delle nostre cose (cf «L‘arte <strong>di</strong> farsi santi», OA I, 86).<br />
L‘uomo presenta in offerta a Dio la sua anima, le sue facoltà, la memoria,<br />
l‘intelletto, la volontà, il corpo, le forze, la sanità, la vita; e poi il suo onore,<br />
la sua reputazione, le sue occupazioni, la sua professione o mestiere,<br />
domandandogli soltanto la grazia <strong>di</strong> amarlo con tutto il cuore (cf «L‘arte <strong>di</strong><br />
farsi santi», OA I, 87). In questo modo il cristiano si svincola da ogni<br />
affetto <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato e da ogni legame ai desideri umani e si apre così alla<br />
efficacia della grazia <strong>di</strong>vina, trovando appunto il nostro cuore nella<br />
<strong>di</strong>sposizione migliore. E questa offerta non bisogna farla una volta sola o<br />
una volta per tutte, è necessario ripeterla molte volte perché ―quanto piú<br />
frequente si ripete, tanto meglio se ne prende l’abito…e il cristiano resta come in uno<br />
stato <strong>di</strong> abituale offerta a Dio <strong>di</strong> tutto se stesso e <strong>di</strong> tutte le cose che è lo stato piú<br />
206
tranquillo, piú pacifico e della maggiore unione con Dio che possa avere l’anima in<br />
questo mondo‖ («L‘arte <strong>di</strong> farsi santi», OA I, 88).<br />
Bisogna dunque cercare <strong>di</strong> costruire la propria vita su motivazioni<br />
cristiane, a servizio della volontà <strong>di</strong> Dio. E questo è valido per ogni<br />
cammino <strong>di</strong> santificazione, per ogni esperienza <strong>di</strong> fede che si intende<br />
intraprendere in seno alla Chiesa, e per ogni stato <strong>di</strong> vita: ―Il matrimonio<br />
cristiano è sacro e santo e vuole pie e sante <strong>di</strong>sposizioni‖ («Vita S. Giuseppe», OA<br />
II, 485).<br />
Il Cristiano, in qualsiasi stato viva, deve sempre stare in un<br />
rapporto concentrico nei confronti <strong>di</strong> Cristo, così come per Cristo non<br />
c‘era alcuna possibilità <strong>di</strong> collocarsi al <strong>di</strong> fuori del Padre.<br />
3. LE DUE FORME DELL’AMORE SPONSALE: MATRIMONIO<br />
E VERGINITÀ<br />
Normalmente la vocazione personale si identifica con uno dei stati<br />
<strong>di</strong> vita esistenti oggi nella Chiesa: la vita consacrata, sacerdotale e religiosa,<br />
e la vita laicale, nel matrimonio e nel celibato. Perché queste forme <strong>di</strong> vita<br />
possano definirsi vocazioni cristiane, esse devono imitare il modello unico<br />
<strong>di</strong> vita cristiana che è appunto il Cristo. Questo principio del tutto chiaro<br />
per la vita sacerdotale, che mira a conformarsi a Cristo sacerdote, e per la<br />
vita consacrata che tende alla sequela <strong>di</strong> Cristo povero, casto ed obbe<strong>di</strong>ente<br />
è altrettanto valido per la vita nel matrimonio; il fondamento della vita<br />
coniugale è infatti l‘essere immagine dell‘amore <strong>di</strong> Cristo per la sua Chiesa.<br />
C‘è chi pensa che la verginità o la castità perfetta sia in netta<br />
antitesi alla vita matrimoniale. In realtà il contrasto è solo apparente in<br />
quanto verginità e matrimonio, colte nel loro nucleo fondamentale, sono<br />
due forme <strong>di</strong> un unico amore sponsale, quello espresso appunto tra Cristo<br />
sposo e Chiesa sposa. In questo senso si può affermare che la verginità<br />
cristiana mostra il senso ultimo della sponsalità e il matrimonio ne mostra<br />
tutta la concretezza storica.<br />
Verginità e matrimonio dunque si relazionano tra loro e<br />
potremmo <strong>di</strong>re sono inter<strong>di</strong>pendenti a partire dall‘evento-Cristo che li<br />
fonda. C‘è <strong>di</strong> piú. La sponsalità umana, che si caratterizza inevitabilmente<br />
dall‘intreccio <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenza sessuale, de<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> sé e fecon<strong>di</strong>tà, trova anche<br />
il suo fondamento nel mistero della Trinità, cioè nella <strong>di</strong>fferenza delle tre<br />
persone <strong>di</strong>vine e nella loro vicendevole e perfetta reciprocità.<br />
La vita cristiana dunque non consiste <strong>di</strong> due strade, <strong>di</strong> cui una<br />
sponsale e l‘altra no. Ogni forma <strong>di</strong> vita cristiana è intrinsecamente<br />
sponsale. Per questo è necessario che l‘uomo assuma all‘interno dello<br />
207
statuto <strong>di</strong> cristiano una scelta definitiva, una decisione fondamentale per la<br />
propria esistenza che esprima concretamente ciò che è stato posto con il<br />
battesimo.<br />
Non è raro il caso <strong>di</strong> una vita coniugale che non è stata oggetto <strong>di</strong><br />
scelta vocazionale. I coniugi dovranno prendere coscienza del fatto che il<br />
matrimonio è una vera vocazione cristiana. Anche se la decisione non fosse<br />
stata determinata originariamente dalla coscienza <strong>di</strong> una vocazione<br />
soprannaturale, i coniugi cercheranno <strong>di</strong> vivere l‘amore umano come<br />
vocazione <strong>di</strong>vina, cioè nella carità, facendo prevalere l‘amore oblativo cioè<br />
<strong>di</strong> donazione, sull‘istinto del possesso e dell‘egoismo. La vocazione alla vita<br />
familiare implica il convincimento che tutte le vicende tristi e gioiose<br />
dell‘esistenza vanno considerate come lo strumento voluto da Dio per<br />
portare ciascuno alla santità.<br />
Come è noto, il Frassinetti si fa portavoce delle prospettive<br />
cristiane che venivano preferite nel suo tempo e quin<strong>di</strong> esalta lo stato <strong>di</strong><br />
verginità come piú degno <strong>di</strong> merito e <strong>di</strong> ammirazione rispetto allo stato<br />
coniugale (cf «La gemma delle fanciulle cristiane», OA I, 515). Tuttavia<br />
istruisce i coniugi cristiani a vivere l‘indole ed i doveri relativi al proprio<br />
stato. Ogni stato <strong>di</strong> vita – <strong>di</strong>ce il Frassinetti – ha dei doveri particolari, oltre<br />
a quelli generali che sono comuni a tutti i fedeli. È in<strong>di</strong>spensabile dunque<br />
esercitarsi in quei doveri che sono propri dello stato in cui si vive. Per gli<br />
sposati dunque è necessario esercitarsi nella cura della famiglia,<br />
nell‘educazione dei figli, nell‘amore e nel rispetto vicendevole, nella fedeltà<br />
coniugale, nel conservare la purità propria del loro stato ecc. (cf «Vita <strong>di</strong> S.<br />
Giuseppe», OA II 485-486).<br />
4. LA CASTITÀ PERFETTA COME MEZZO PRIVILEGIATO DI<br />
SANTIFICAZIONE<br />
La castità perfetta è ritenuta dal Frassinetti, specialmente nella sua<br />
espressione <strong>di</strong> verginità e celibato, come un importante mezzo <strong>di</strong><br />
santificazione. Verginità e celibato sono particolarmente celebrati nei suoi<br />
scritti con espressioni cariche <strong>di</strong> una positività quasi stucchevole. Eccone<br />
alcune: ―La castità è la piú brillante fra le do<strong>di</strong>ci stelle che incoronano il capo <strong>di</strong> <strong>Maria</strong><br />
in para<strong>di</strong>so‖ («Amiamo <strong>Maria</strong>», OA II, 345); ―Sulle corone dei santi nel cielo è la<br />
perla piú luminosa‖ («Avviamento dei giovinetti…», OA II, 379); ―È la piú<br />
eccelsa e la piú splen<strong>di</strong>da‖ («La monaca in casa», OA II, 23) ecc.<br />
Anche se la verginità ed il celibato non sono in<strong>di</strong>spensabili per<br />
raggiungere la santità, tuttavia costituiscono in modo del tutto speciale una<br />
aspirazione del cuore <strong>di</strong> appartenere totalmente a Dio. Uno dei piú<br />
consistenti ostacoli al conseguimento della santità è la imèu<strong>di</strong>cizia, perché<br />
s‘insinua nel cuore e lo domina. Lo stato <strong>di</strong> castità perfetta allora opera una<br />
208
purificazione ed una liberazione dei desideri che possono nascere nel cuore<br />
e che sono d‘impe<strong>di</strong>mento alla completa rinuncia <strong>di</strong> se stessi (cf «Religioso<br />
al secolo», OA II, 110-111). La castità deve essere conservata da tutti,<br />
ciascuno secondo il proprio stato («Amiamo S. Giuseppe», OA II 476; «La<br />
<strong>di</strong>vozione illuminata», OA II, 254).<br />
I mezzi per acquistare questa virtú tanto preziosa sono numerosi:<br />
la frequenza ai sacramenti ed in particolare all‘Eucarestia («Due gioie<br />
nascoste», OA I, 630 [che fu l‘opera che tanto piacque a Don Bosco, i cui<br />
contenuti trovarono ampio spazio nella sua pedagogia giovanile]; «Il<br />
convito del <strong>di</strong>vino amore», OA 350-351), la preghiera, in special modo la<br />
devozione a <strong>Maria</strong> e a Giuseppe, la mortificazione dei sensi, l‘autodominio<br />
delle passioni, che conduce ad una affettività matura.<br />
Il Frassinetti inoltre richiamò ripetutamente l‘attenzione sul fatto<br />
che occorre <strong>di</strong>ventare apostoli della verginità e del celibato, promuoverli<br />
con ogni mezzo per il bene della chiesa e della società (cf «Amiamo S.<br />
Giuseppe», OA II, 477; «Due gioie nascoste», OA I, 633). La castità<br />
<strong>di</strong>venta infatti una forza capace <strong>di</strong> trascinare i buoni valori, come il buon<br />
lievito che fa fermentare le masse popolari e in particolare quelle giovanili<br />
(cf «Il Para<strong>di</strong>so in terra nel celibato cristiano», OA I, 487), perché libera il<br />
cuore per una piú generosa e totale donazione per il bene del prossimo (cf<br />
«Il Para<strong>di</strong>so in terra nel celibato cristiano», OA I, 488).<br />
5. IL DISCERNIMENTO SULLA PROPRIA VITA E IL RUOLO<br />
DELLA PREGHIERA<br />
Il Frassinetti richiama spesso l‘idea <strong>di</strong> servire fedelmente Dio in<br />
quello stato o con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vita in cui Egli ci ha collocato o vuole che ci<br />
collochiamo, ognuno contento del posto che occupa nel Regno <strong>di</strong> Dio,<br />
senza ambire altro, e camminando serenamente per quell‘itinerario dove lo<br />
ha chiamato lo Spirito del Signore. Sia negli avvenimenti favorevoli, sia<br />
nelle situazioni avverse che incontrerà sulla sua strada, l‘uomo è chiamato a<br />
<strong>di</strong>stinguere la presenza della Provvidenza <strong>di</strong>vina che vuole e permette<br />
soltanto il nostro maggior bene (cf «Il Pater Noster…», OA I, 223-224).<br />
È dunque in<strong>di</strong>spensabile per conoscere la volontà <strong>di</strong> Dio sulla<br />
propria vita e per potersi ad essa allineare, una attenta lettura della propria<br />
storia, saper <strong>di</strong>scernere i «segni» che comunicano la volontà <strong>di</strong> Dio, saper<br />
osservare i fatti concreti della propria vita con gli occhi dello Spirito <strong>di</strong> Dio.<br />
A questo proposito nel Frassinetti si possono incontrare alcuni<br />
accenni per un itinerario <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento della vocazione verginale. È<br />
innanzitutto importante far conoscere pregi e valori dello stato <strong>di</strong> vita<br />
209
verginale. Ci sono infatti giovani che a causa <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse circostanze si<br />
trovano obbligati a vivere il celibato e la verginità e spesso ritengono che lo<br />
stato in cui sono costretti a vivere sia una vera e propria <strong>di</strong>sgrazia che li<br />
costringe a vivere irrealizzati, nella tristezza e senza meriti. Scoprire invece<br />
che la verginità è un tesoro prezioso, è una vera e propria realizzazione <strong>di</strong><br />
vita, è una reale unione sponsale, aiuterà non poco queste persone a<br />
rivalutare lo stato in cui si trovano a vivere e a considerarsi non piú<br />
<strong>di</strong>sgraziati ma favoriti e benedetti da Dio (cf «La gemma delle fanciulle<br />
cristiane», OA I, 515ss).<br />
I giovani che non hanno occasione <strong>di</strong> contrarre matrimonio non<br />
vivono in uno stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>sgrazia, ma anzi sono chiamati a <strong>di</strong>scernere<br />
attentamente se quello stato non sia voluto, permesso e favorito da Dio<br />
stesso, perché Egli ha un progetto <strong>di</strong> amore su ciascun uomo. Si possono<br />
dunque trasformare le situazioni <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento al matrimonio (<strong>di</strong> natura<br />
sociale, fisica, morale ecc.) in una libera scelta dello stato celibatario e<br />
verginale purché le persone siano messe nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> conoscere ed<br />
apprezzare le gioie della castità e della vita verginale, nel pieno dono <strong>di</strong> se<br />
stessi a Dio e agli altri. Non è infatti compatibile con il processo <strong>di</strong><br />
santificazione la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> chi patisce, subisce passivamente lo stato<br />
verginale e celibatario, quelle che Frassinetti chiama «vergini sforzate» (per<br />
tutto questo paragrafo cf PORCELLA 94-95, 97-98, 257-258 e le relative<br />
citazioni).<br />
La scelta dello stato è poi impensabile se non è abbondantemente<br />
lubrificata da una vita <strong>di</strong> preghiera: ―Se noi non abbiamo ancora abbracciato uno<br />
stato determinato, pensiamo che nella scelta del medesimo non dobbiamo andare a<br />
capriccio, ma colla preghiera e col consiglio <strong>di</strong> qualche persona prudente, dobbiamo<br />
cercare quale sia quello stato al quale ci chiama la Divina provvidenza‖ («Vita <strong>di</strong> s.<br />
Giuseppe», OA II 484-485). Per la scelta e la conservazione dello stato <strong>di</strong><br />
vita è in<strong>di</strong>spensabile la preghiera, in particolare la richiesta <strong>di</strong> intercessione<br />
alla Vergine <strong>Maria</strong>, la quale svolge un ruolo particolare <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione nelle<br />
grazie legate alla scelte dello stato verginale (cf «Avviamento dei<br />
giovinetti…», OA II, 389; ve<strong>di</strong> anche l‘icona biblica dell‘annunciazionevisitazione).<br />
Ma anche l‘intercessione <strong>di</strong> S. Giuseppe è ritenuta dal Priore<br />
un mezzo importante perché coloro che sono in ricerca possano avere<br />
<strong>di</strong>scernimento sulla propria vocazione: ―(rivolgendosi a S. Giuseppe)<br />
Ottenete a costoro i lumi necessari e la buona volontà, affinché scelgano quello stato a cui<br />
sono chiamati; lo prendano con le debite <strong>di</strong>sposizioni del santo timor <strong>di</strong> Dio e vivano nel<br />
medesimo cristianamente fino alla morte‖ («Vita <strong>di</strong> S. Giuseppe», OA II, 487; cf<br />
anche ibidem, 484).<br />
210
6. LA NECESSITÀ DELL’ACCOMPAGNAMENTO<br />
DI UN PADRE SPIRITUALE<br />
Ogni chiamata <strong>di</strong> Gesú viene percepita per mezzo <strong>di</strong> segni<br />
interiori ed esteriori. Tali segni vanno interpretati non solo dalla coscienza<br />
personale ma anche con l‘aiuto <strong>di</strong> un padre spirituale. Anche l‘itinerario <strong>di</strong><br />
santificazione non può prescindere da un sostegno <strong>di</strong> un capace <strong>di</strong>rettore<br />
spirituale.<br />
Scrive a proposito: ―Bisogna che ciascuno usi i mezzi (per santificarsi)<br />
secondo la propria con<strong>di</strong>zione, stato, capacità e la propria possibilità; un illuminato<br />
<strong>di</strong>rettore sarà quin<strong>di</strong> il pilota delle navicella…tutto sarebbe inutile ad una nave se le<br />
mancasse un pilota bene ammaestrato e prudente‖ («Il Religioso al secolo», OA II,<br />
132-133; cf anche «Il conforto…», OA I, 44; Il Frassinetti de<strong>di</strong>ca ampio<br />
spazio a questo tema ne «La forza <strong>di</strong> un libretto», OA I, 545ss).<br />
La <strong>di</strong>rezione delle anime nella scelta dello stato è un‘opera <strong>di</strong><br />
illuminazione e <strong>di</strong> assistenza, che presuppone apertura e <strong>di</strong>alogo: ―un padre<br />
che consoli, un maestro che istruisca, un condottiero che gui<strong>di</strong>, un pastore che pasca…‖<br />
(«Gesú Cristo regola del sacerdote», OA II, 585). D'altronde sappiamo<br />
bene che Dio si serve <strong>di</strong> uomini ed in particolare dei suoi ministri per<br />
comunicare e per incontrarsi.<br />
P. Roberto Amici Fsmi<br />
Oristano Aprile 2003<br />
LO ZELO PER LA SANTIFICAZIONE E PER LA<br />
SALVEZZA DELLE ANIME<br />
NELLA VITA E NEL PENSIERO DI<br />
G. FRASSINETTI<br />
SOMMARIO<br />
Introduzione<br />
1. Lo zelo nella vita del Frassinetti<br />
2. Lo zelo nel pensiero del Frassinetti<br />
INTRODUZIONE<br />
La parola greca ζελσσ proviene da una ra<strong>di</strong>ce che significa «essere<br />
caldo», «accaldarsi», «andare in ebollizione», «avere il volto rosso per la<br />
passione». Di qui entusiasmarsi, appassionarsi, infervorarsi. In ebraico<br />
traduce la parola qinnah che designa il rossore che sale sul volto dell‘uomo<br />
passionale.<br />
211
Questa forma <strong>di</strong> fervore, <strong>di</strong> fuoco dell‘anima può provenire da<br />
sentimenti <strong>di</strong>versi che vanno dall‘amore <strong>di</strong>sinteressato fino alla piú sor<strong>di</strong>da<br />
invi<strong>di</strong>a, all‘o<strong>di</strong>o, al furore, al turbamento. Il valore <strong>di</strong> questa sorta <strong>di</strong><br />
passione veemente <strong>di</strong>pende dai moventi che la ispirano; esistono <strong>di</strong> fatto<br />
dei motivi egoistici che eccitano questa forma particolare <strong>di</strong> ardore, che<br />
vengono descritti nella Scrittura come una ―carie che entra nelle ossa‖ (Pr<br />
14,30) e che devasta il cuore dell‘uomo. Ma esiste anche una forma <strong>di</strong> zelo<br />
che invece è tutt‘altro che negativa. È una fiamma d‘amore purissima:<br />
―Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la<br />
morte è l’amore, tenace come gli impeti è la passione: le sue vampe son vampe <strong>di</strong> fuoco,<br />
una fiamma del (che proviene da) Signore. Le gran<strong>di</strong> acque non possono spegnere<br />
l’amore, né i fiumi travolgerlo…‖ (Ct 8,6-7).<br />
1. LO ZELO NELLA VITA DEL FRASSINETTI<br />
a) Durante gli stu<strong>di</strong> in seminario si <strong>di</strong>stinse oltre che<br />
nell‘appren<strong>di</strong>mento delle sacre <strong>di</strong>scipline, anche nella pietà e nello zelo per<br />
la santificazione e la salvezza delle anime, emergendo su tutti<br />
nell‘apostolato tra i giovani e negli oratori catechistici. Si evidenzia la sua<br />
sensibilità fin da giovane seminarista per la formazione dei piú piccoli! Già<br />
da studente «emergeva sugli altri per lo zelo della gloria <strong>di</strong> Dio e per il bene<br />
della gioventú, segnatamente negli oratori catechistici»; cf Summarium § 292.<br />
b) I primi tre anni <strong>di</strong> sacerdozio sono vissuti nella gioia <strong>di</strong> essere tutto<br />
per Dio, esercitando il ministero nella parrocchia <strong>di</strong> S. Stefano in Genova,<br />
lavorando con grande zelo nella pre<strong>di</strong>cazione, nelle confessioni, nella<br />
catechesi ai giovani ed ai piccoli, nell‘assistenza spirituale ai carcerati, nella<br />
cura ai giovani seminaristi che non convivevano nel seminario,<br />
convocandoli per lezioni teologiche, per esercizi spirituali, per piccoli<br />
impegni pastorali in aiuto ai parroci. In questi anni fu incaricato <strong>di</strong><br />
commentare il Vangelo della Domenica ai seminaristi interni ed esterni del<br />
Seminario <strong>di</strong> Genova.<br />
c) Gli impegni pastorali <strong>di</strong> Quinto e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina. Frassinetti dopo<br />
soli tre anni <strong>di</strong> sacerdozio fu destinato parroco a Quinto, dove sotto il suo<br />
operato la parrocchia fu ra<strong>di</strong>calmente trasformata: i fedeli accorrevano al<br />
suo confessionale, erano assidui alle sue pre<strong>di</strong>cazioni, fondò numerose<br />
associazioni, educò i giovani all‘amore per Dio e al culto della verginità,<br />
riformò i costumi del popolo, istituì corsi <strong>di</strong> catechismo, si de<strong>di</strong>cò alla<br />
promozione vocazionale, introdusse la pratica del mese mariano, assistette<br />
i malati <strong>di</strong> colera (che <strong>di</strong>lagò in Liguria nell‘estate del 1835). Tutto il suo<br />
tempo era per gli altri. A Quinto fece venire la sorella Paola e la volle<br />
212
collaboratrice nel settore della gioventú femminile: campo da cui germinò,<br />
sotto la <strong>di</strong>rezione del parroco, la fondazione dell‘Istituto <strong>di</strong> S. Dorotea, per<br />
la quale Frassinetti stese una prima forma <strong>di</strong> regola. Il metodo pastorale<br />
inventato a Quinto si perfezionò e si arricchì <strong>di</strong> nuove risorse nella sede<br />
parrocchiale <strong>di</strong> S. Sabina, della quale prese possesso col titolo <strong>di</strong> priore a<br />
soli 35 anni. Riempì la chiesa <strong>di</strong> fedeli come mai si era visto. Si impegnò e<br />
si orientò a suscitare vocazioni religiose costituendo due pie unioni: i <strong>Figli</strong> e<br />
le <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> per i giovani e le giovani che si consacravano<br />
a Dio vivendo al secolo (sono <strong>di</strong> questi anni «La monaca in casa» e «Il religioso<br />
al secolo»). Seguirono anni <strong>di</strong>fficili per il Frassinetti: il ritorno trionfale <strong>di</strong><br />
Gioberti, l‘antigesuitismo, gli schieramenti antiecclesiastici, le calunnie del<br />
Bonavino, il tempo <strong>di</strong> nascon<strong>di</strong>mento sotto il nome <strong>di</strong> «Prete Viale». Tali<br />
avvenimenti mettono in risalto quanto il Frassinetti seppe soffrire per la<br />
<strong>di</strong>fesa della verità e della Chiesa, la sua pazienza, la sua prudenza (e questo<br />
è senz‘altro una forma <strong>di</strong> zelo che ha condotto il priore ad una sorta <strong>di</strong><br />
martirio).<br />
d) L’apostolato della buona stampa: il Frassinetti percorse tutta l‘Italia<br />
con i suoi scritti (oltre cento opere tra libri e opuscoli), offrendo al clero il<br />
senso cattolico della teologia. Il suo zelo per la salvezza del popolo e della<br />
Chiesa lo condusse a schierarsi contro giansenisti e rigoristi e<br />
propagandando l‘apostolato della comunione eucaristica quoti<strong>di</strong>ana. Il suo<br />
apporto piú incisivo nell‘opera <strong>di</strong> evangelizzazione e <strong>di</strong> pubblicazione<br />
nacque dal riflusso esterno della sua virtú interna, che <strong>di</strong>venne, come si è<br />
visto, ardente zelo. Frassinetti scrive per la sua gente. La finalità <strong>di</strong> tutti i<br />
suoi scritti può essere compresa solo a partire dal suo ardente desiderio <strong>di</strong><br />
educare alle scelte cristiane piú mature. L‘attività della buona stampa si fa<br />
servizio <strong>di</strong> carità alle coscienze delle persone a lui affidate (a ragione il VI<br />
Consultore parla <strong>di</strong> «Carità intellettuale», pp. 45-46). Con la stampa<br />
Frassinetti continua a fare <strong>di</strong>rezione spirituale. Attraverso la sua teologia<br />
morale, intelligente continuatore ed interprete <strong>di</strong> S. Alfonso, mirò inoltre<br />
alla formazione <strong>di</strong> prudenti confessori 330, mentre con la pubblicazione <strong>di</strong><br />
Gesú Cristo Regola del sacerdote, dell‘apprezzatissimo «Manuale del<br />
330 «I sacerdoti or<strong>di</strong>nati prima del 1906 non potevano andare in<br />
confessionale senza aver letto le avvertenze della morale del Frassinetti,<br />
perché avendo avuti in seminario insegnamenti rigoristici, sentivano la<br />
necessità <strong>di</strong> orizzontarsi a mezzo del Frassinetti» (cf Summarium § 848).<br />
Un famoso giornale della Germania arrivò a chiamare il Compen<strong>di</strong>o del<br />
Frassinetti ―Fulcrum Coscientiarum‖ (cf Summarium Ad<strong>di</strong>tionale pp.<br />
136-137).<br />
213
parroco novello» e <strong>di</strong> altri preziosi opuscoli si preoccupò a formare<br />
l‘identità dei sacerdoti, una delle inquietu<strong>di</strong>ni che lo tennero impegnato per<br />
tutta la vita.<br />
Gli scritti del Frassinetti sono il ritratto della sua anima che<br />
procede con <strong>di</strong>screzione e in equilibrio calmo e libero. La sua ascetica ha le<br />
basi nella dottrina dogmatica e in una vasta e assidua esperienza delle<br />
anime (così lo definisce il Dizionario degli Istituti <strong>di</strong> Perfezione, vol. IV, voce<br />
Frassinetti, p. 586). Lo conferma il Frassinetti stesso parlando <strong>di</strong> sé e dei<br />
suoi scritti: ―il mio lavoro riguarda specialmente la pratica che importa molto piú della<br />
teorica; e in punto <strong>di</strong> pratica trentotto anni <strong>di</strong> quoti<strong>di</strong>ano esercizio sembrano darmi<br />
qualche <strong>di</strong>ritto a <strong>di</strong>scorrere in questa materia (la morale). Tuttavia mentre desidero <strong>di</strong><br />
far qualche bene, mi spaventa il solo pensiero <strong>di</strong> poter far qualche male. Egli è perciò, che<br />
non ho voluto fidarmi per nulla dei lunghi anni <strong>di</strong> confessionale; ed in quella vece ho<br />
voluto chieder lume al Signore ogni volta che ho preso la penna in mano; ed oltre a ciò<br />
nulla ho scritto, che non abbia prima consultato con uomini dotti, pii e sperimentati‖<br />
(Summarium Ad<strong>di</strong>zionale pp. 63-83). I suoi scritti sono dunque da lui stesso<br />
definiti come il risultato della sua quoti<strong>di</strong>ana esperienza <strong>di</strong> pastore, della<br />
richiesta <strong>di</strong> illuminazione al Signore e del prezioso contributo <strong>di</strong> esperti e <strong>di</strong><br />
fidati collaboratori (esperienza personale, preghiera e collaborazione).<br />
e) Le pie associazioni: per la conservazione e la <strong>di</strong>fesa della fede ideò<br />
e animò <strong>di</strong>versi sodalizi <strong>di</strong> cui lui era l‘anima, partecipando alle adunanze,<br />
proponendo ed illustrando argomenti e mezzi che contribuissero a<br />
approfon<strong>di</strong>re maggiormente l‘esperienza <strong>di</strong> fede delle anime a lui affidate,<br />
ad illuminarla, a farla desiderare. Tra queste è <strong>di</strong> nostro interesse la pia<br />
unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> il cui fine particolare era quello <strong>di</strong><br />
facilitare l‘accesso al sacerdozio <strong>di</strong> giovani volenterosi e rime<strong>di</strong>are alla<br />
scarsità del clero con sacerdoti ben formati. Lui stesso teneva in casa molti<br />
giovani, <strong>di</strong> cui stu<strong>di</strong>ava la <strong>di</strong>sposizione interiore, per avviarli poi agli stu<strong>di</strong><br />
sacri ed al sacerdozio. Egli stesso ammette questa sua indole particolare in<br />
uno dei suoi scritti: ―Appena fui or<strong>di</strong>nato sacerdote s’impossessò del mio cuore una<br />
brama ardente <strong>di</strong> giovare per quanto potessi nella mia nullità, confidando unicamente nel<br />
Divino Aiuto, al giovane clero e mi pareva che molto si sarebbe potuto fare a suo<br />
vantaggio‖ (Cf FASSIOLO, Vita…, p. 23; il brano è riportato nel Voto V, p.<br />
39, e VII, p. 49.<br />
f) Il suo zelo per la salvezza delle anime si tradusse anche in<br />
impegno sapiente per capire la società, per raccogliere le sfide del suo tempo.<br />
Nell‘Ottocento ligure, ancora illuminista e spesso agnostico, egli seppe<br />
mantenere ed essere costante proprio in quelle virtú che uomini anche <strong>di</strong><br />
notevole livello sociale misero da parte. Egli comprese ed amò il suo<br />
214
tempo e stu<strong>di</strong>ò i meto<strong>di</strong> piú idonei per evangelizzarlo. E così si adoperò<br />
per impe<strong>di</strong>re ai fedeli la fuga dalle proprie posizioni e responsabilità sociali.<br />
Egli cerca cioè <strong>di</strong> evitare che la vita cristiana si cristallizzi in una «struttura<br />
asettica», insensibile alle sfide della cultura e della società. La comunità dei<br />
credenti allora deve essere solidale con i valori etici tra<strong>di</strong>zionali, deve<br />
adempiere i doveri relativi alla propria con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vita e deve<br />
«primeggiare nelle opere buone». Solo in questo modo è possibile offrire a<br />
«quelli <strong>di</strong> fuori» una testimonianza <strong>di</strong> fede convincente ed «attraente». Si<br />
potrebbe <strong>di</strong>re con un espressione impropria ma chiarificatrice che il priore<br />
abbia intuito il rischio <strong>di</strong> un «effetto crisalide» per la fede cristiana. E per<br />
una efficace evangelizzazione santificò se stesso, creò associazioni e<br />
propose e <strong>di</strong>ffuse forme nuove, che poi trovarono larga applicazione nella<br />
Chiesa. Per vivere a Genova da sacerdote zelante, efficace e cre<strong>di</strong>bile<br />
nell‘insegnamento si richiedeva <strong>di</strong> superare la mentalità <strong>di</strong> quella<br />
infatuazione agnostica creata dai movimenti nazionalistici sulla scia del<br />
Mazzini e del Mameli. Il Frassinetti operò mentre le nuove mentalità<br />
sfociavano nei moti insurrezionali e per questo <strong>di</strong>chiaravano guerra alla<br />
Chiesa ed ai gesuiti. Egli, accusato <strong>di</strong> essere un filogesuita, dovette vivere<br />
per alcuni anni nascosto, come s‘è visto; mentre fin dalla sua or<strong>di</strong>nazione<br />
era <strong>di</strong>ventato bersaglio dei giansenisti, agnostici ed anticlericali. Ma la sua<br />
fede non restò nascosta e nulla lo arrestò nella sua missione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fensore e<br />
<strong>di</strong>ffusore della stessa (cf Voto V, p.39). Lo schema pedagogico<br />
complessivo della fisionomia spirituale del Frassinetti appare ispirato da<br />
quella che il VI consultore definisce la «carità pastorale» (Voto VI, p. 45) <strong>di</strong><br />
un parroco che conosce il suo popolo e la sua storia e sa <strong>di</strong> che cosa<br />
davvero ci sia bisogno.<br />
Ci viene dunque consegnata dalla storia la figura <strong>di</strong> un parroco<br />
dell‘Ottocento genovese non ripiegato su minute occupazioni <strong>di</strong> sagrestia,<br />
ma ben consapevole <strong>di</strong> quello che sta maturando nel tempo storico che fu<br />
suo. La consapevolezza delle sfide, che la cultura massonica e il ce<strong>di</strong>mento<br />
intellettuale giobertiniano pongono alla coscienza dei cristiani e alla vita<br />
della Chiesa, entra a buon <strong>di</strong>ritto come elemento costitutivo del progetto<br />
pastorale con cui Frassinetti si identifica. Di qui: la cura e la formazione<br />
spirituale ed intellettuale del clero e del laicato; la promozione <strong>di</strong> forme<br />
associative; la vigilanza nell‘impe<strong>di</strong>re infiltrazioni <strong>di</strong> mentalità e costumi<br />
alieni dalla schietta fede cattolica; il sentimento intenso del legame tra<br />
magistero e la persona del Pontefice Romano.<br />
Il Frassinetti ha compiutamente compreso che nelle lotte e nei<br />
programmi per un <strong>di</strong>verso assetto politico della penisola era presente un<br />
<strong>di</strong>segno culturale tendente a emarginare la Chiesa con le sue dottrine e le<br />
215
sue norme morali. Da questa comprensione delle sfide del suo tempo il<br />
progetto pastorale del Frassinetti trae le sue priorità: illuminazione e<br />
formazione delle coscienze, e poi valorizzazione della fede popolare<br />
fortemente legata al successore <strong>di</strong> Pietro e alla devozione mariana (cf Voto<br />
VI, pp.46-48).<br />
2. LO ZELO NEL PENSIERO DEL FRASSINETTI<br />
Innanzitutto lo zelo per la salvezza delle anime si ha e si coltiva in<br />
qualunque stato o con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vita in cui un cristiano si trovi. L‘anima <strong>di</strong><br />
chi ha fatto un percorso <strong>di</strong> fede, qualunque esso sia, poiché si è incontrata<br />
inevitabilmente con l‘amore <strong>di</strong> Dio (ve<strong>di</strong> l‘episo<strong>di</strong>o della donna samaritana<br />
in Gv 4) e ha saputo dunque <strong>di</strong> essere amata da Lui in modo del tutto<br />
speciale, non si accontenta <strong>di</strong> assicurarsi solo la propria salvezza, ma si<br />
impegna e si adopera pure per la salvezza e per la santificazione degli altri,<br />
―provando – scrive il Frassinetti – un gusto ineffabile nel condurre le anime a Dio‖<br />
(«Il conforto dell‘anima <strong>di</strong>vota», in O. A. vol. I, 75). Utilizzando una<br />
immagine tipicamente paolina il priore fa notare che ―Tutti i cristiani me<strong>di</strong>ante<br />
il battesimo sono arruolai e me<strong>di</strong>ante la cresima sono confermati fedeli soldati <strong>di</strong> Gesú<br />
Cristo…‖ («Ai cristiani», in O. A. vol. II, 328).<br />
C‘è però un rischio nella vita dei credenti – sostiene il Frassinetti<br />
– quello <strong>di</strong> rinchiudersi in una sorta <strong>di</strong> egoismo spirituale: ―Le anime agitate<br />
da importuni timori, che vorrebbero sempre assicurarsi (i. e. avere sicurezze<br />
personali) e si trovano ognora in maggiori incertezze, non hanno né tempo né voglia per<br />
pensare al bene altrui… la salute delle altre anime quasi <strong>di</strong>menticano; e anzi<br />
immaginando in tutto pericoli e <strong>di</strong>fficoltà, pensano non potere attendere alla salute <strong>di</strong><br />
quelle, senza <strong>di</strong>scapito della propria‖ («Il conforto dell‘anima <strong>di</strong>vota», in O. A.<br />
vol. I, 75). La preoccupazione che assilla il Priore non è dunque quella <strong>di</strong><br />
rinchiudersi in un circuito dove ha spazio solo l‘ammirata considerazione<br />
delle verità <strong>di</strong> fede e la consapevolezza della propria inadeguatezza. Se si<br />
vuole presentare la fede cristiana come una forza attiva, capace <strong>di</strong><br />
influenzare e <strong>di</strong> qualificare la vita dell‘uomo in ogni suo aspetto, i credenti<br />
non possono permettersi <strong>di</strong> cedere a tali tentazioni e conclude: ―Oh quante<br />
anime avrebbero tempo e capacità per cooperare a quell’opera <strong>di</strong>vina della salvazione<br />
delle anime… e dove consumano il loro tempo e la loro capacità?‖ (ibidem) …Nel<br />
tormentarsi e nel preoccuparsi solo della propria salvezza. E poi enumera<br />
una serie <strong>di</strong> possibili interventi che ogni fedele può mettere in azione nella<br />
propria vita. ―potete – scrive il Priore – correggere le anime peccatrici, potete<br />
ammonire le erranti, potete <strong>di</strong>rigere e consigliare le dubbiose, potete confermare le deboli,<br />
216
infervorare le tiepi<strong>di</strong>… e se altro non poteste e non sapeste fare, potete pregare per tutte‖<br />
(ibidem).<br />
C‘è inoltre un altro rischio (a cui si è appena accennato sopra):<br />
credere che l‘aspirazione e lo zelo per la salvezza delle anime debba<br />
appartenere solo agli «uomini apostolici», come li definisce il Frassinetti, i<br />
quali hanno consacrato la vita a tale ministero. Così il Priore risponde con<br />
un esempio e<strong>di</strong>ficante: ―S. <strong>Maria</strong> Maddalena de’ Pazzi 331 non aveva una missione<br />
apostolica, era una vergine consacrata alla quiete della contemplazione, chiusa tra le<br />
mura <strong>di</strong> un monastero; ma pure sarebbe cosa <strong>di</strong>fficile il trovare un uomo apostolico che<br />
nutrisse in cuore zelo piú ardente della salute delle anime…le pareva niente amare essa<br />
il Signore se tutto il mondo pure non l’amava‖ («Il conforto dell‘anima <strong>di</strong>vota», in<br />
O. A. vol. I, 78-79; cf anche «Il Pater noster <strong>di</strong> S. Teresa <strong>di</strong> Gesú», in O. A.<br />
vol. I, 274 e «La monaca in casa», in O. A. vol. II, 42.46. 81-84). S.<br />
Maddalena inoltre insegnava continuamente alle consorelle a lei affidate <strong>di</strong><br />
chiedere incessantemente al Signore la conversione dei peccatori attraverso<br />
<strong>di</strong>scipline, <strong>di</strong>giuni, veglie, orazioni, esortazioni, correzioni, penitenze che a<br />
volte duravano mesi interi per qualche peccatore che le veniva<br />
raccomandato. Per il Frassinetti è sufficiente questo esempio per<br />
convincersi che lo zelo ed il fervore per la santificazione delle anime è una<br />
virtú in<strong>di</strong>spensabile per quanti <strong>di</strong>cono <strong>di</strong> avere amore per il Signore.<br />
D‘altronde già S. Agostino aveva detto: Qui non zelat non amat (Chi non ha<br />
zelo, non ha amore).<br />
E poi c‘è da calcolare il grande vantaggio – <strong>di</strong>ce il Frassinetti – che<br />
può derivare dalla sollecitu<strong>di</strong>ne per la salvezza delle anime: le anime che<br />
aiuteremo a salvarsi potranno mai <strong>di</strong>menticarsi <strong>di</strong> noi? Queste pregheranno<br />
per quanti in terra avranno dato loro aiuti spirituali.<br />
Frassinetti mette in evidenza alcune forme <strong>di</strong> zelo cristiano:<br />
a) Lo zelo per quelli della propria famiglia.<br />
L‘ideale dello zelo nella carità si realizza anzitutto nell‘impegno per<br />
il bene delle persone che piú da vicino ci appartengono (padre, madre,<br />
fratelli, sorelle ecc.): ―nelle vostre famiglie promovete tutto il bene che potete… la<br />
frequenza ai sacramenti, la parola <strong>di</strong> Dio, le buone letture, la preghiera‖ («Ricor<strong>di</strong><br />
per una figlia che vuol essere tutta <strong>di</strong> Gesú», in O. A. vol. I, 642). A<br />
familiari va <strong>di</strong>retta la nostra attenzione e la nostra sollecitu<strong>di</strong>ne per condurli<br />
all‘amore per l‘Eucaristia e all‘ascolto della parola <strong>di</strong> Dio, alla<br />
331 Vergine consacrata nell’or<strong>di</strong>ne delle carmelitane (vissuta nel XVI<br />
sec.). Deve il suo appellativo «de’ Pazzi», che può far sorridere, alla<br />
famiglia <strong>di</strong> origine, una delle più celebri e importanti della città <strong>di</strong><br />
Firenze.<br />
217
valorizzazione delle feste liturgiche, spronarli a circondarsi <strong>di</strong> buone<br />
amicizie, ad avere un linguaggio pulito come si conviene, ad adempiere i<br />
doveri cristiani (cf le istruzioni ai genitori cristiani per trasmettere e vigilare<br />
sulla fede dei figli in «La <strong>di</strong>vozione illuminata», in O. A. II, 274ss). Piú che<br />
con le parole e con le esortazioni, è necessario – <strong>di</strong>ce il priore –<br />
raccomandare a Dio nella preghiera i propri cari, ―perché li illumini e li tocchi il<br />
cuore‖, e nutrirli con il buon esempio: ―Voi dovete essere il buon lievito, il buon<br />
odore, l’e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> tutti‖ («La monaca in casa», in O. A. vol. II, 43).<br />
b) Lo zelo della buona stampa.<br />
―Se Dio vi manda dei buoni libri, non teneteli nascosti, imprestateli, fateli<br />
girare <strong>di</strong> mano in mano, affinché molte anime se ne approfittino‖ («Ricor<strong>di</strong> per una<br />
figlia che vuol essere tutta <strong>di</strong> Gesú», in O. A. vol. I, 642; cf anche «Il<br />
religioso al secolo», in O. A. vol. II, 147; «Sull‘impiego del danaro», in O.<br />
A. vol II, 310; «Ai cristiani», in O. A. vol. II, 331; «Industrie spirituali», in<br />
O. A. vol I, 115; «Ricor<strong>di</strong> per un giovinetto cristiano», in O. A. vol I, 658).<br />
Rivolto poi ai confratelli il Frassinetti esprime tutto il suo fervore per<br />
l‘apostolato della buona stampa. Il priore viveva infatti nella trepidazione<br />
temendo che le stampe e gli opuscoli prodotti dai nemici della Chiesa<br />
potessero produrre nel popolo a lui consegnato un‘irreparabile<br />
allontanamento dai valori evangelici. ―Ancorché il nostro zelo ci dovesse cagionar<br />
qualche spesa, si soffra il sacrificio: trattasi <strong>di</strong> cosa troppo importante!‖ («Riflessioni<br />
proposte agli ecclesiastici», in O. A. vol. II, 528; cf anche «Gesú Cristo<br />
regola del sacerdote», in O. A. vol. II, 587; «Brevi parole ai sacerdoti<br />
fratelli», in O. A. vol. II, 610-611; «Propositi fatti per sé e per alcuni amici»,<br />
in O. A. vol. II, 619).<br />
c) Lo zelo che si manifesta nell‘aiuto vicendevole.<br />
Chi lavora da solo può essere soggetto ad errori, sviste, perché si<br />
lascia condurre dal suo spirito, che spesso è gonfio <strong>di</strong> superbia. Nel<br />
promuovere il bene è dunque necessario che il proprio entusiasmo sia in<br />
un certo senso «contenuto» dalla sapienza e dal parere degli altri. Si<br />
eviteranno in questo modo imprudenti scivoloni ed il tuo orgoglio sarà<br />
ri<strong>di</strong>mensionato, perché non solo tu avrai il merito del bene che farai (Cf<br />
«Industrie spirituali», in O. A. vol. I, 126-127). L‘aiuto vicendevole nello<br />
zelo per la redenzione delle anime oltre che offrire il prezioso sostegno <strong>di</strong><br />
altre anime zelanti permette anche <strong>di</strong> completarsi attraverso i buoni esempi<br />
che ci vengono offerti dagli altri: ―Quando trovate qualche persona impegnata nel<br />
fare il bene e veramente zelante, fate relazione colla medesima, e aiutatevi l’una con<br />
l’altra a procurare il bene… dovete procurarvi amiche e compagne veramente devote e<br />
desiderose <strong>di</strong> farsi sante perché quante piú ne avrete, avrete maggior numero <strong>di</strong> buoni<br />
esempi davanti agli occhi e tanto piú vi farete coraggio le une colle altre a far molto bene‖<br />
(«Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuol essere tutta <strong>di</strong> Gesú», in O. A. vol. I, 643<br />
218
Cf anche «La monaca in casa», in O. A. vol. II, 81; «Il religioso al secolo»,<br />
in O. A. vol. II, 146)<br />
d) C‘è infine uno zelo che si <strong>di</strong>mostra anche nelle piccole cose (a cui<br />
Frassinetti sembra tenere in modo particolare).<br />
La carità verso i poveri, lo zelo per l‘assistenza agli infermi, la<br />
premura nel sovvenire le necessità del prossimo, la prontezza nella<br />
<strong>di</strong>sponibilità a chi ti chiede, la cura dei piccoli, soprattutto <strong>di</strong> quelli<br />
trascurati dai genitori (cf «Ricor<strong>di</strong> per una figlia che vuol essere tutta <strong>di</strong><br />
Gesú», in O. A. vol. I, 643-644; cf anche «La monaca in casa», in O. A. vol.<br />
II, 44-45).<br />
Il criterio che muove e guida lo zelo cristiano è il desiderio che<br />
l‘altro s‘incontri con la misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Dio (cf il percorso che Gesú fa<br />
compiere alla donna Samaritana in Gv 4). Frassinetti lo lascia intendere<br />
quando <strong>di</strong>ce: ―procuratevi <strong>di</strong> eccitare negli altri la voglia <strong>di</strong> gustare un poco la dolcezza<br />
dell’amore <strong>di</strong> Dio‖ («La monaca in casa», in O. A. vol II, 44); ―Quanto tengo e<br />
quanto amo – fa <strong>di</strong>re il Frassinetti a <strong>Maria</strong> – a quelle anime le quali non solo si<br />
stu<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> amare esse il mio Divin <strong>Figli</strong>o, ma procurano ancora <strong>di</strong> far si che lo amino<br />
ancora le altre…non vi lasciate mai sfuggire l’opportunità <strong>di</strong> fare un sì bello acquisto‖<br />
(«Parole <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> SS. ai suoi <strong>di</strong>voti», in O. A. vol. II, 408).<br />
Altri rischi (peccati <strong>di</strong> zelo eccessivo).<br />
Lo zelo per la verità poi non può cedere a forme <strong>di</strong> prepotenza e<br />
aggressività: mai condanne, né rimproveri, né parole pungenti, né massime<br />
provocanti. Frassinetti <strong>di</strong>sapprova quelle forme <strong>di</strong> zelo amaro e iracondo<br />
che sfociano nell‘in<strong>di</strong>gnazione e nello sdegno. E‘ invece quanto mai<br />
opportuno adoperarsi con ogni mezzo per essere una «calamita» che sia<br />
capace <strong>di</strong> magnetizzare ed attirare l‘altro verso il Signore: ―La calamita è<br />
infatti l’immagine della dolce forza, dell’attrazione che hanno la carità, la benignità, la<br />
con<strong>di</strong>scendenza‖ («La monaca in casa», in O. A. vol. II, 45). Lo zelo inoltre<br />
non può deformarsi in presunzione, quando si confida troppo nei propri<br />
proponimenti, ci si appoggia solo sulla propria razionalità, abilità, furbizia,<br />
sugli sforzi personali, piuttosto che confidare nella grazia, nella<br />
provvidenza e nei meriti <strong>di</strong> Gesú Cristo (cf «Avvisi e pratiche per una vita<br />
devota», in O. A. vol. I, 137-138).<br />
P. Roberto Amici Fsmi<br />
219
ALCUNI RILIEVI CIRCA I VOTI DEL<br />
CONGRESSO SPECIALE SULLA EROICITÀ DELLE<br />
VIRTÚ DI G. FRASSINETTI<br />
SOMMARIO<br />
Premessa<br />
A. Alcuni profili biografici<br />
B. L‘esercizio delle virtú<br />
C. La capacità <strong>di</strong> capire la società, <strong>di</strong> penetrare nelle sfide del suo tempo<br />
D. L‘identità sacerdotale come unico centro irra<strong>di</strong>ante<br />
E. Spunti <strong>di</strong> attualità<br />
PREMESSA<br />
Il giorno 13 novembre 1990 si è riunito presso la sede dello Stato<br />
Vaticano il Congresso Speciale della Congregazione per le Cause dei Santi,<br />
220
costituito dal Promotore Generale della Fede, Antonio Petti, e Presidente<br />
del Congresso, dal relatore della Causa, P. Yvon Beaudoin, e da otto<br />
Consultori Teologi, per <strong>di</strong>scutere sulla eroicità delle virtú del Servo <strong>di</strong> Dio,<br />
Paolo Giuseppe <strong>Maria</strong> Frassinetti. Il risultato finale concernente il merito<br />
della causa è risultato <strong>di</strong> otto voti affermativi ed uno sospensivo. Il 14<br />
Maggio 1991 il santo Padre ha confermato il giu<strong>di</strong>zio positivo dei Teologi,<br />
<strong>di</strong>chiarando il Frassinetti «Venerabile» 332.<br />
Nello svolgimento della riunione i membri del Congresso si sono<br />
avvicendati nell‘illustrare i propri stu<strong>di</strong> in merito alla Causa e nel precisare<br />
le proprie conclusioni e valutazioni finali. Tutti i consultori hanno rilevato<br />
che la Positio 333 presenta una incomprensibile e inaccettabile carenza <strong>di</strong><br />
332 Notevole fu il ritardo del processo informativo, inaugurato il 28<br />
gennaio 1916, a 48 anni dalla morte del Frassinetti. Alcuni testimoni<br />
lamentano la scomparsa <strong>di</strong> numerose persone che avrebbero fornito una<br />
deposizione certamente più nutrita, e osservano inoltre che sarebbe stato<br />
meglio iniziare la causa con priorità su quella della sorella Paola, che<br />
cominciò nel 1895. bisogna però escludere che il ritardo sia <strong>di</strong>peso<br />
dall’insufficienza della fama <strong>di</strong> santità, che per altro è ampliamente e<br />
intensamente affermata dai 56 testimoni dei processi.<br />
333 Per i confratelli più giovani: con la parola «Positivo super virtutibus»<br />
(termine latino: ―affermazione, dato positivo‖ per Seneca; ―tema,<br />
argomento, con<strong>di</strong>zione, stato‖ per Quintiliano e Tacito) si vuole in<strong>di</strong>care<br />
la raccolta delle testimonianze <strong>di</strong>rette, dette anche ―de visu‖, o in<strong>di</strong>rette,<br />
dette anche ―de au<strong>di</strong>tu a videntibus‖ sulla personalità <strong>di</strong> G. Frassinetti, e<br />
la raccolta della documentazione probante l’eroicità delle virtù e le<br />
eventuali riserve. Essa è composta <strong>di</strong> alcune parti: 1) la Prenotatio<br />
(Presentazione) del p. Relatore; 2) l’ Informatio, con la quale vengono<br />
esposte e presentate le virtù teologali <strong>di</strong> fede, speranza e carità del<br />
Frassinetti, le sue virtù car<strong>di</strong>nali <strong>di</strong> prudenza, giustizia, temperanza e<br />
fortezza, le virtù <strong>di</strong> povertà, castità, obbe<strong>di</strong>enza ed umiltà, il<br />
comportamento <strong>di</strong> fronte alla morte ed infine alcune notizie su grazie e<br />
miracoli avvenuti dopo la sua morte; 3) il Summarium, cioè il catalogo<br />
che contiene le testimonianze del processo or<strong>di</strong>nario (Genova 1916-1921),<br />
del processo rogatoriale <strong>di</strong> Roma (1919), del processo apostolico (Genova<br />
1940-1943); 4) le Animadversiones, ad opera del Promotore Generale della<br />
Fede (p. Raphael Perez), che presentano alcune perplessità sul materiale<br />
probativo fornito dai processi, sulla pratica delle virtù, sull’atten<strong>di</strong>bilità<br />
delle testimonianze, 5) il Responsio, la replica cioè alle affermazioni<br />
sopramenzionate; 6) un Sommarium Ad<strong>di</strong>zionale in aggiunta al<br />
Responsio, contenente una serie <strong>di</strong> documenti probanti la pratica eroica<br />
221
metodologia, che ne rende <strong>di</strong>fficile e <strong>di</strong>sagevole la lettura. Secondo il primo<br />
dei teologi la causa per se stessa è degna <strong>di</strong> attenzione, ma danneggiata dal<br />
ritardo dei Processi, dalla scarsezza <strong>di</strong> contenuto delle testimonianze<br />
presentate nella Positivo, dalle affermazioni vaghe e generiche, dai<br />
documenti affastellati e confusi, dalla mancanza <strong>di</strong> un inquadramento<br />
storico e dall‘assenza degli apparati critici e scientifici 334 (impostazione<br />
scientifica precedente al Concilio…). Gli altri otto consultori che si sono<br />
alternati al primo votante hanno rilevato che le deficienze della Positio non<br />
riguardano la vali<strong>di</strong>tà dell‘esame in merito alla causa. L‘esercizio eroico<br />
delle virtú <strong>di</strong> G. Frassinetti risulta sufficientemente <strong>di</strong>mostrato dall‘insieme<br />
seppur confuso e non sistematico dell‘apparato probativo della Positivo e<br />
l‘imponente personalità del Frassinetti può costituire, a giu<strong>di</strong>zio dei votanti,<br />
un elemento equilibrante le imperfezioni della Positio. Dalle loro analisi è<br />
emerso un Frassinetti meritevole <strong>di</strong> considerazione e degno dell‘onore degli<br />
altari data la sua non comune statura <strong>di</strong> uomo, <strong>di</strong> cristiano, <strong>di</strong> sacerdote, <strong>di</strong><br />
parroco, <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>oso, <strong>di</strong> teologo, <strong>di</strong> scrittore, <strong>di</strong> educatore, <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>catore, <strong>di</strong><br />
confessore, <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore spirituale, <strong>di</strong> fondatore <strong>di</strong> opere pie, associazioni e<br />
congregazioni. Il Frassinetti rimane, a detta dei teologi votanti, uno<br />
splendente esemplare <strong>di</strong> sacerdote anche per la Chiesa del nostro tempo,<br />
un punto <strong>di</strong> riferimento equilibrato e sereno per la formazione etica e<br />
scientifica del giovane clero, una figura eccelsa <strong>di</strong> sacerdote ornamento e<br />
decoro del clero italiano, a tal punto tenuto in considerazione da far<br />
auspicare, accanto al riconoscimento dell‘onore degli altari, quello <strong>di</strong><br />
Dottore della Chiesa (II consultore).<br />
In queste pagine <strong>di</strong> sintesi si vuole evidenziare l‘attenzione che i<br />
teologi consultori hanno rivolto alla vita, alle opere, alle virtú <strong>di</strong> G.<br />
Frassinetti, quali sono stati i tratti piú importanti della sua personalità<br />
carismatica colti dalla loro sensibilità teologica e dalla loro preparazione<br />
scientifica, quali le tematiche ancora vive, quali gli stimoli ancora attuali,<br />
quali le prospettive da raccogliere e utilizzare al meglio, quali gli<br />
insegnamenti utili per gli ere<strong>di</strong> del Frassinetti, quali le urgenze da valutare,<br />
quali le aspettative…<br />
delle virtù; 7) un Summarium ex officio (detto anche Iu<strong>di</strong>cia), che<br />
raccoglie i giu<strong>di</strong>zi dei teologi censori riguardo gli scritti del Frassinetti; 8)<br />
ed infine un’ultima sezione de<strong>di</strong>cata alle grazie ed ai miracoli operati dal<br />
Frassinetti dopo la morte.<br />
334 Cf la conclusione del documento Relativo et Vota Congressus Peculiaris<br />
super Virtutibus, pp. 6-8 e 95-97.<br />
222
È in<strong>di</strong>scutibile dunque l‘utilità <strong>di</strong> conoscere ed analizzare le<br />
intuizioni e le opinioni <strong>di</strong> chi vive all‘esterno della Congregazione, ma che<br />
all‘interno della Chiesa è chiamato ha svolgere un così delicato impegno <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> ricerca, <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.<br />
Cosa dunque i teologi del Congresso hanno riconosciuto al<br />
Frassinetti? Quali particolari del suo stile <strong>di</strong> vita hanno permesso <strong>di</strong><br />
definirlo una imponente figura meritevole <strong>di</strong> considerazione? Quali gli<br />
orizzonti spirituali, carismatici e apostolici, dei quali i <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> ed i<br />
presbiteri <strong>di</strong> tutta la Chiesa sono chiamati a riappropriarsi? Attraverso quali<br />
percorsi mettersi in ascolto del Frassinetti?<br />
Rispondere a tutti questi interrogativi richiederebbe una<br />
preparazione che colui che vi parla sente <strong>di</strong> non possedere. E‘ possibile<br />
tuttavia iniziare a tracciare delle piste <strong>di</strong> lettura, <strong>di</strong> analisi, <strong>di</strong> confronto, a<br />
partire dalle aree tematiche che i teologi consultori hanno voluto mettere in<br />
evidenza.<br />
A) ALCUNI PROFILI BIOGRAFICI 335<br />
1. La famiglia <strong>di</strong> origine come sano ambiente <strong>di</strong> formazione<br />
cristiana: la cellula <strong>di</strong> una vitale santità cristiana per G. Frassinetti fu<br />
anzitutto il clima familiare <strong>di</strong> una solida pietà, <strong>di</strong> una educazione religiosa<br />
intensa e rigida. Da rilevare che all‘età <strong>di</strong> sei anni i genitori lo condussero al<br />
santuario detto della Madonnetta, dove manifestò il suo primo atto <strong>di</strong><br />
offerta insieme ad altri fanciulli. Conservò sempre un lieto ricordo <strong>di</strong><br />
questo episo<strong>di</strong>o, che costituì il trampolino <strong>di</strong> lancio per la sua intensa pietà<br />
mariana 336.<br />
2. Gli stu<strong>di</strong> in seminario, durante i quali si <strong>di</strong>stinse<br />
nell‘appren<strong>di</strong>mento delle sacre <strong>di</strong>scipline, nella pietà e nello zelo per la<br />
santificazione e la salvezza delle anime, emergendo su tutti nell‘apostolato<br />
tra i giovani e negli oratori catechistici. Si evidenzia la sua sensibilità fin da<br />
335 In questo paragrafo si vuole far notare l’importanza <strong>di</strong> certi dati<br />
biografici per la comprensione della personalità spirituale <strong>di</strong> G.<br />
Frassinetti.<br />
336 La <strong>di</strong>mensione mariana della spiritualità frassinettiana è a torto<br />
trascurata dai Consultori teologi. Un timido e vago accenno è presente<br />
nel IX voto.<br />
223
giovane seminarista per la formazione dei piú piccoli! Frequentò da alunno<br />
esterno gli stu<strong>di</strong> letterari, filosofici e teologici nel seminario arcivescovile <strong>di</strong><br />
Genova, dove conobbe e fu con<strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> Luigi Sturla e G.B. Cattaneo,<br />
suoi fedelissimi amici e sostenitori. Fu <strong>di</strong>scepolo <strong>di</strong> Antonio M. Gianelli,<br />
professore <strong>di</strong> retorica ed eloquenza, suo <strong>di</strong>rettore spirituale, dal quale<br />
apprese ed assorbì i piú puri ideali del sacerdozio e ne imitò le varie forme<br />
<strong>di</strong> apostolato. Col Gianelli fu sempre in intimi rapporti (alla scuola <strong>di</strong> un<br />
Santo!; cf voto IV, p. 24) 337.<br />
3. I primi tre anni <strong>di</strong> sacerdozio sono vissuti in somma pietà e<br />
gioia <strong>di</strong> essere tutto per Dio, esercitando il ministero nella parrocchia <strong>di</strong> S.<br />
Stefano in Genova, lavorando con grande zelo nella pre<strong>di</strong>cazione, nelle<br />
confessioni, nella catechesi ai giovani ed ai piccoli, nell‘assistenza spirituale<br />
ai carcerati, nella cura ai giovani seminaristi che non convivevano nel<br />
seminario, convocandoli per lezioni teologiche, per esercizi spirituali, per<br />
piccoli impegni pastorali in aiuto ai parroci. In questi anni fu incaricato <strong>di</strong><br />
commentare il Vangelo della Domenica ai seminaristi interni ed esterni del<br />
Seminario <strong>di</strong> Genova. Già da giovane sacerdote era completo (non aveva<br />
ancora compiuto i trent‘anni!).<br />
4. Gli impegni pastorali <strong>di</strong> Quinto e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Sabina. Frassinetti<br />
dopo soli tre anni <strong>di</strong> sacerdozio fu destinato parroco a Quinto, dove sotto<br />
il suo operato la parrocchia fu ra<strong>di</strong>calmente trasformata: i fedeli<br />
accorrevano al suo confessionale, erano assidui alle sue pre<strong>di</strong>cazioni, fondò<br />
numerose associazioni, educò i giovani all‘amore per Dio e al culto della<br />
verginità, riformò i costumi del popolo, istituì corsi <strong>di</strong> catechismo, si<br />
de<strong>di</strong>cò alla promozione vocazionale, introdusse la pratica del mese<br />
mariano, assistette i malati <strong>di</strong> colera, che <strong>di</strong>lagò in Liguria nell‘estate del<br />
1835. Tutto il suo tempo era per gli altri. A Quinto fece venire la sorella<br />
Paola e la volle collaboratrice nel settore della gioventú femminile: campo<br />
da cui germinò, sotto la <strong>di</strong>rezione del parroco, la fondazione dell‘Istituto <strong>di</strong><br />
S. Dorotea, per la quale Frassinetti stese una prima forma <strong>di</strong> regola. Ci<br />
sono alcuni testimoni del processo che si aspettavano <strong>di</strong> veder glorificato<br />
prima Giuseppe, al quale Paola, dopo Dio, doveva tutto (Summarium §<br />
171, 720). Il metodo pastorale inventato a Quinto si perfezionò e si arricchì<br />
<strong>di</strong> nuove risorse nella sede parrocchiale <strong>di</strong> S. Sabina, della quale prese<br />
337 Già da studente «emergeva sugli altri per lo zelo della gloria <strong>di</strong> Dio e<br />
per il bene della gioventù, segnatamente negli oratori catechistici»; cf<br />
Summarium § 292.<br />
224
possesso col titolo <strong>di</strong> priore a soli 35 anni 338. Riempì la chiesa <strong>di</strong> fedeli<br />
come mai si era visto. Si impegnò e si orientò a suscitare vocazioni religiose<br />
costituendo due pie unioni: i <strong>Figli</strong> e le <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> per i<br />
giovani e le giovani che si consacravano a Dio vivendo al secolo (sono <strong>di</strong><br />
questi anni «La monaca in casa» e «Il religioso al secolo»). Seguirono anni<br />
<strong>di</strong>fficili per il Frassinetti: il ritorno trionfale <strong>di</strong> Gioberti, l‘antigesuitismo, gli<br />
schieramenti antiecclesiastici, le calunnie del Bonavino, il tempo <strong>di</strong><br />
nascon<strong>di</strong>mento sotto il nome <strong>di</strong> «Prete Viale». Tali avvenimenti mettono in<br />
risalto quanto il Frassinetti seppe soffrire per la <strong>di</strong>fesa della verità e della<br />
Chiesa, la sua pazienza, la sua prudenza. Pubblicò nel 1865 il compen<strong>di</strong>o<br />
della teologia morale in due volumi, che con le sue 11 e<strong>di</strong>zioni (l‘ultima è<br />
del 1948), fu tradotto in francese (2 ed.) in Spagnolo (4ed.) ed in<br />
Portoghese, fu uno dei manuali piú utilizzati per la preparazione morale del<br />
giovane clero. Un‘altra celebre opera fu «Il manuale del Parroco Novello»,<br />
tradotta in <strong>di</strong>verse lingue e ripubblicata come XII e<strong>di</strong>z. nel 1964 dalle E<strong>di</strong>z.<br />
Paoline.<br />
5. L‘apostolato della buona stampa: il Frassinetti percorse tutta<br />
l‘Italia con i suoi scritti (oltre cento opere tra libri e opuscoli), offrendo al<br />
clero il senso cattolico della teologia, schierandosi contro giansenisti e<br />
rigoristi e propagandando l‘apostolato della comunione eucaristica<br />
quoti<strong>di</strong>ana. Il suo apporto piú incisivo nell‘opera <strong>di</strong> evangelizzazione e <strong>di</strong><br />
pubblicazione nacque dal riflusso esterno della sua virtú interna, che<br />
<strong>di</strong>venne, come si è visto, ardente zelo. Frassinetti scrive per la sua gente.<br />
Per lui la soli<strong>di</strong>tà d‘impianto nella formazione cristiana deve includere la<br />
formazione intellettuale accanto a quella catechetica e a quella piú<br />
specificatamente spirituale. La finalità <strong>di</strong> tutti i suoi scritti può essere<br />
compresa solo a partire dal suo ardente desiderio <strong>di</strong> educare alle scelte<br />
cristiane piú mature. L‘attività della buona stampa si fa servizio <strong>di</strong> carità alle<br />
coscienze delle persone a lui affidate (a ragione il VI Consultore parla <strong>di</strong><br />
«Carità Intellettuale», pp. 45-46). Con la stampa Frassinetti continua a fare<br />
<strong>di</strong>rezione spirituale. Attraverso la sua teologia morale, intelligente<br />
continuatore ed interprete <strong>di</strong> S. Alfonso, mirò inoltre alla formazione <strong>di</strong><br />
prudenti confessori 339, mentre con la pubblicazione <strong>di</strong> Gesú Cristo Regola<br />
338 Il parroco portava il titolo <strong>di</strong> priore in quanto S. Sabina era una chiesa<br />
benedettina costruita nel XI sec., demolita poi per il rior<strong>di</strong>namento<br />
urbano del XX sec.<br />
339 «I sacerdoti or<strong>di</strong>nati prima del 1906 non potevano andare in<br />
confessionale senza aver letto le avvertenze della morale del Frassinetti,<br />
perché avendo avuti in seminario insegnamenti rigoristici, sentivano la<br />
necessità <strong>di</strong> orizzontarsi a mezzo del Frassinetti» (cf Summarium § 848).<br />
225
del sacerdote, dell‘apprezzatissimo «Manuale del parroco novello» e <strong>di</strong> altri<br />
preziosi opuscoli si preoccupò a formare l‘identità dei sacerdoti, una delle<br />
inquietu<strong>di</strong>ni che lo tennero impegnato per tutta la vita.<br />
È sintomatico che l‘ultimo suo scritto, pubblicato post mortem,<br />
tratti dell‘Eucaristia: «Il Convito del Divino Amore», quasi un suo<br />
imprevisto testamento, frutto <strong>di</strong> tutta una vita, che lo fa risplendere, quale<br />
mirabile sintesi tra teologia dogmatico-morale e ministero parrocchiale,<br />
come uno dei piú vali<strong>di</strong> propugnatori della comunione frequente.<br />
Gli scritti del Frassinetti sono il ritratto della sua anima che<br />
procede con <strong>di</strong>screzione e in equilibrio calmo e libero. La sua ascetica ha le<br />
basi nella dottrina dogmatica e in una vasta e assidua esperienza delle<br />
anime (così lo definisce il Dizionario degli Istituti <strong>di</strong> Perfezione, vol. IV, voce<br />
Frassinetti, p. 586). Lo conferma il Frassinetti stesso parlando <strong>di</strong> sé e dei<br />
suoi scritti: «il mio lavoro riguarda specialmente la pratica che importa<br />
molto piú della teorica; e in punto <strong>di</strong> pratica trentotto anni <strong>di</strong> quoti<strong>di</strong>ano<br />
esercizio sembrano darmi qualche <strong>di</strong>ritto a <strong>di</strong>scorrere in questa materia (la<br />
morale). Tuttavia mentre desidero <strong>di</strong> far qualche bene, mi spaventa il solo<br />
pensiero <strong>di</strong> poter far qualche male. Egli è perciò, che non ho voluto<br />
fidarmi per nulla dei lunghi anni <strong>di</strong> confessionale; ed in quella vece ho<br />
voluto chieder lume al Signore ogni volta che ho preso la penna in mano;<br />
ed oltre a ciò nulla ho scritto, che non abbia prima consultato con uomini<br />
dotti, pii e sperimentati» (Summarium Ad<strong>di</strong>zionale pp. 63-83). I suoi scritti<br />
sono dunque da lui stesso definiti come il risultato della sua quoti<strong>di</strong>ana<br />
esperienza <strong>di</strong> pastore, della richiesta <strong>di</strong> illuminazione al Signore e del<br />
prezioso contributo <strong>di</strong> esperti e <strong>di</strong> fidati collaboratori (esperienza<br />
personale, preghiera e collaborazione).<br />
6. Le pie associazioni: per la conservazione e la <strong>di</strong>fesa della fede<br />
ideò e animò <strong>di</strong>versi sodalizi <strong>di</strong> cui lui era l‘anima, partecipando alle<br />
adunanze, proponendo ed illustrando argomenti e mezzi che<br />
contribuissero a approfon<strong>di</strong>re maggiormente l‘esperienza <strong>di</strong> fede delle<br />
anime a lui affidate, ad illuminarla, a farla desiderare. Tra queste è <strong>di</strong> nostro<br />
interesse la pia unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> il cui fine particolare<br />
era quello <strong>di</strong> facilitare l‘accesso al sacerdozio <strong>di</strong> giovani volenterosi e<br />
rime<strong>di</strong>are alla scarsità del clero con sacerdoti ben formati. Costituì dunque<br />
una specie <strong>di</strong> congregazione religiosa, ma volle che restasse secolare (!). I<br />
giovani che <strong>di</strong>mostravano <strong>di</strong> avere buona vocazione e rette intenzioni e<br />
non potevano pagare la formazione offerta in seminario, li affidò ai suoi<br />
Un famoso giornale della Germania arrivò a chiamare il Compen<strong>di</strong>o del<br />
Frassinetti ―Fulcrum Coscientiarum‖ (cf Summarium Ad<strong>di</strong>tionale pp.<br />
136-137).<br />
226
<strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, che erano come si è detto, religiosi al secolo. Lui<br />
stesso teneva in casa molti giovani, <strong>di</strong> cui stu<strong>di</strong>ava l‘indole, per avviarli poi<br />
agli stu<strong>di</strong> sacri ed al sacerdozio. Egli stesso ammette questa sua indole<br />
particolare in uno dei suoi scritti: ―Appena fui or<strong>di</strong>nato sacerdote s’impossessò del<br />
mio cuore una brama ardente <strong>di</strong> giovare per quanto potessi nella mia nullità, confidando<br />
unicamente nel Divino Aiuto, al giovane clero e mi pareva che molto si sarebbe potuto<br />
fare a suo vantaggio‖ (Cf Fassiolo, Vita…, p. 23; il brano è riportato nel Voto<br />
V, p. 39, e VII, p. 49.<br />
7. Il prezioso spirito <strong>di</strong> collaborazione. Frassinetti era solito<br />
formare un ―unum‖ con i suoi fidati collaboratori (quello che il nostro caro<br />
p. Falasca definisce «effetto Eucaristia»), <strong>di</strong> cui lui costituiva certamente<br />
l‘asse portante. Ne dà conferma per esempio l‘iniziativa in collaborazione<br />
con d. Luigi Sturla per i chierici ed i neo sacerdoti, un progetto che prese il<br />
nome <strong>di</strong> Congregazione del Beato Leonardo da Porto Maurizio; i continui<br />
contatti con G.B. Cattaneo, suo compagno <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> e fedelissimo amico e<br />
sostenitore, poi rettore del seminario arcivescovile <strong>di</strong> Genova; la sima<br />
profonda che nutriva per Antonio M. Gianelli, suo professore e suo fidato<br />
consigliere, che gli permise <strong>di</strong> mantenere intimi rapporti <strong>di</strong> collaborazione.<br />
Ma anche i suoi scritti testimoniano che Giuseppe sapeva lavorare in<br />
equipe; lui stesso scrisse: «nulla ha scritto che non abbia prima consultato<br />
con uomini dotti, pii e sperimentati» (cf Summarium Ad<strong>di</strong>tionale pp. 64-<br />
83).<br />
8. I limiti spaziali e la collocazione sociale furono ben definiti ed in<br />
certo modo ristretti: Frassinetti non lasciò mai Genova e ufficialmente<br />
ricoprì solo l‘incarico <strong>di</strong> parroco (a Quinto prima, a S. Sabina poi). Ma<br />
l‘efficacia dell‘opera del Frassinetti e la sua fama andarono ben al <strong>di</strong> là <strong>di</strong><br />
Genova e ben oltre a quanto comunemente suole accadere per una figura<br />
<strong>di</strong> parroco: egli fu infatti fecondo scrittore in vari campi delle scienze sacre,<br />
noto in tutto il mondo, i cui scritti numerosi furono presto tradotti in<br />
molte lingue. Inoltre, attorno ad una figura dai contorni esteriori ben<br />
stabiliti e circoscritti, la venerazione e la profonda stima si scopre subito ad<br />
ampio raggio e ben motivata presso i fedeli <strong>di</strong> tutti gli or<strong>di</strong>ni ecclesiali 340,<br />
nell‘arco <strong>di</strong> tempo che abbraccia non solo la sua vita terrena, ma anche gli<br />
ormai 133 anni che sono trascorsi dalla sua santa morte 341. Tale fenomeno<br />
340 «Quelli che lo credevano un santo non erano soltanto gente semplice, o<br />
frequentatori della chiesa o i beneficati dal Servo <strong>di</strong> Dio, ma anche<br />
persone colte, nobili e plebei…» (Summarium § 276).<br />
341 Perfino dagli oppositori del Frassinetti proviene una inequivocabile<br />
conferma della sua santità <strong>di</strong> vita: egli fu infatti oggetto <strong>di</strong> opposizione e<br />
227
a detta dei teologi consultori costituisce già un‘ottima base per un giu<strong>di</strong>zio<br />
positivo <strong>di</strong> virtú eroica.<br />
B) L’ESERCIZIO DELLE VIRTÚ<br />
1. Rilievi circa la fede. I suoi scritti rivelano da soli un‘anima che<br />
vive ciò che afferma. Se ne ha conferma in una vita votata all‘attività<br />
ministeriale con un tale <strong>di</strong>stacco dalle cose del mondo che a prima vista<br />
parrebbe ad<strong>di</strong>rittura eccessivo, ma che è conferma <strong>di</strong> chi accetta i criteri<br />
evangelici.<br />
2. La Speranza. Ne è prova la rivoluzione da lui operata nella<br />
metodologia e nella presentazione dei criteri base dei suoi scritti morali:<br />
l‘equilibrio e la mitezza che egli rivela nelle sue opere e che sappiamo<br />
applicava anche nei fatti in<strong>di</strong>cano che egli confidava nella salvezza eterna<br />
per sé e per gli altri. Del resto la povertà della sua vita, la rinuncia ai<br />
successi terreni, che pur avrebbe potuto avere a portata <strong>di</strong> mano, il<br />
coraggio <strong>di</strong> una vita sacerdotale integra pur sapendosi per questo deriso,<br />
o<strong>di</strong>ato e perseguitato da molti, e in specie da quella che appariva la forza<br />
politicamente vincente nel suo tempo, in<strong>di</strong>cano che il Frassinetti poneva<br />
altrove i suoi desideri (cf Voto III, p. 20).<br />
3. La Carità. La de<strong>di</strong>zione al confessionale senza risparmio <strong>di</strong><br />
tempo, senza eccezione <strong>di</strong> scomo<strong>di</strong>tà o <strong>di</strong> fatica, è prova <strong>di</strong> un amore<br />
davvero operoso per la Gloria <strong>di</strong> Dio e per la salvezza delle anime 342. Il<br />
Frassinetti insegnava d‘altronde che ―l‘amore <strong>di</strong> Dio si manifesta in due<br />
mo<strong>di</strong>: con l‘amore al patire e con lo zelo delle anime‖ (Summarium § 421).<br />
L‘amore al prossimo fu esercitato dal Frassinetti in mille industriose<br />
maniere e raggiungeva tutti i bisogni che affliggono l‘uomo.<br />
4. Prudenza. ―Nel suo <strong>di</strong>re nulla appariva <strong>di</strong> esagerato né <strong>di</strong><br />
affettato, ma tutto spirava una prudenza così fine, della quale solo lui<br />
<strong>di</strong> irrisione dai più temuti avversari della Chiesa (in un tempo segnato da<br />
illuminismo, giansenismo, massonismo, gallicanesimo, liberalismo…); cf<br />
Voto III, p. 19. inoltre nutrivano sentimenti <strong>di</strong> antipatia coloro che fra il<br />
clero vivevano in modo <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato e rilassato (cf Summarium, § 601).<br />
342 «La canonica <strong>di</strong> S. Sabina era sempre frequentata da sacerdoti, laici<br />
che andavano a consigliarsi con il priore, senza <strong>di</strong>re la numerosa<br />
corrispondenza che teneva continuamente anche con persone lontane» (cf<br />
Summarium § 411). «Era universalmente tenuto anche dal clero come<br />
uno dei primi, se non forse il primo, confessore della città» (cf<br />
Summarium § 151-152).<br />
228
sembrava capace‖ (Parole della sorella Paola; Summarium, § 602, riferito<br />
nel Voto II, p. 15). Una certa Francesca Paro<strong>di</strong> che lo ebbe come<br />
confessore per piú <strong>di</strong> un decennio lo giu<strong>di</strong>ca ―uomo prudente e ponderato<br />
in ogni sua azione. Gli effetti della sua <strong>di</strong>rezione spirituale e dei suoi<br />
consigli furono sempre ottimi‖ (cf Summarium 177, 411)<br />
5. Giustizia. Appare soprattutto dalla fedeltà del Frassinetti al suo<br />
«munus» <strong>di</strong> parroco in tutte le sue esigenze: l‘obbe<strong>di</strong>enza alla gerarchia, la<br />
<strong>di</strong>sponibilità verso la sua comunità parrocchiale, l‘ossequio all‘autorità<br />
civile, senza però inutili e pericolosi servilismi, la non ammissione <strong>di</strong> alcuna<br />
accettazione <strong>di</strong> persone.<br />
6. Fortezza. Risulta sufficientemente <strong>di</strong>mostrata dalla sua<br />
perseveranza nel genere sacrificato <strong>di</strong> vita parrocchiale, dalla pazienza nelle<br />
prove, che furono vere persecuzioni e misero a repentaglio la sua vita, dal<br />
silenzio che seppe mantenere in occasione della dolorosa esperienza<br />
relativa alla punizione canonica che gli fu inflitta a torto per la<br />
pubblicazione dell‘opuscolo sulle apparizioni della Val Polcevera. Alcuni<br />
testimoni fanno notare una costante uguaglianza d‘animo nelle piú varie<br />
vicende (Summarium § 523).<br />
7. Temperanza. Sembra risultare dalla misuratezza del riposo: un<br />
uomo tanto fedele come egli era all‘ufficio parrocchiale non avrebbe<br />
potuto produrre tanti scritti, se non avesse rubato tempo al sonno e al<br />
riposo.<br />
8. Consigli evangelici. I testi raccontano una lunga serie <strong>di</strong> episo<strong>di</strong>,<br />
dai quali risulta che la carità del Frassinetti si estendeva a tutti i bisogni che<br />
affliggevano gli uomini. Egli con<strong>di</strong>vise la vita dei poveri, esercitando la vera<br />
povertà evangelica; per sé aveva quasi meno del necessario. Così viene<br />
esaltata la sua vita molto povera, semplice, modesta, per la casa,<br />
l‘abbigliamento, il <strong>di</strong>stacco dai beni <strong>di</strong> questo mondo 343. Numerose poi<br />
sono le testimonianze sulla virtú della purezza, che praticò, inculcò, illustrò<br />
con i suoi scritti e fece fiorire rigogliosamente attorno a sé. Riguardo<br />
all‘obbe<strong>di</strong>enza, testimonia d. Stefano Olivari: ―Era obbe<strong>di</strong>entissimo alle<br />
autorità ecclesiastiche. Anche quando fu punito per quella storia<br />
dell‘apparizione, egli fu pienamente sottomesso. Ebbe certamente grande<br />
attaccamento alla <strong>Santa</strong> Sede, e fu questo uno dei motivi per cui ebbe<br />
persecuzioni‖ (Summarium § 852, 857).<br />
343 D. Giovanni Maggiolo racconta nella Positio che: «morì con soli 17<br />
sol<strong>di</strong> in tasca» (Summarium § 545).<br />
229
C) LA CAPACITÀ DI CAPIRE LA SOCIETÀ, DI<br />
PENETRARE NELLE SFIDE DEL SUO TEMPO<br />
Nell‘Ottocento ligure, ancora illuminista e spesso agnostico, egli<br />
seppe mantenere ed essere costante proprio in quelle virtú che uomini<br />
anche <strong>di</strong> notevole livello sociale misero da parte. Egli comprese ed amò il<br />
suo tempo e stu<strong>di</strong>ò i meto<strong>di</strong> piú idonei per evangelizzarlo. E per una<br />
efficace evangelizzazione santificò se stesso, creò associazioni e propose e<br />
<strong>di</strong>ffuse forme nuove, che poi trovarono larga applicazione nella chiesa. Ed<br />
accanto alla santità della vita volle far risplendere anche la cultura teologica,<br />
biblica, morale, ascetica come attestano i suoi numerosi scritti. Per vivere a<br />
Genova da sacerdote zelante ed efficace si richiedeva <strong>di</strong> superare la<br />
mentalità <strong>di</strong> quella infatuazione agnostica creata dai movimenti<br />
nazionalistici sulla scia del Mazzini e del Mameli. Il Frassinetti operò<br />
mentre le nuove mentalità sfociavano nei moti insurrezionali e per questo<br />
<strong>di</strong>chiaravano guerra alla Chiesa ed ai gesuiti. Egli, accusato <strong>di</strong> essere un<br />
filogesuita, dovette vivere per alcuni anni nascosto; mentre fin dalla sua<br />
or<strong>di</strong>nazione era <strong>di</strong>ventato bersaglio dei giansenisti, agnostici ed anticlericali.<br />
Ma la sua fede non restò nascosta e nulla lo arrestò nella sua missione <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fensore e <strong>di</strong>ffusore della stessa (cf Voto V, p.39). Lo schema pedagogico<br />
complessivo della fisionomia spirituale del Frassinetti appare ispirato da<br />
quella che il VI consultore definisce la «carità pastorale» (Voto VI, p. 45) <strong>di</strong><br />
un parroco che conosce il suo popolo e la sua storia e sa <strong>di</strong> che cosa<br />
davvero ci sia bisogno.<br />
Ci viene dunque consegnata dalla storia la figura <strong>di</strong> un parroco<br />
dell‘Ottocento genovese non ripiegato su minute occupazioni <strong>di</strong> sagrestia,<br />
ma ben consapevole <strong>di</strong> quello che sta maturando nel tempo storico che fu<br />
suo. La consapevolezza delle sfide, che la cultura massonica e il ce<strong>di</strong>mento<br />
intellettuale giobertiniano pongono alla coscienza dei cristiani e alla vita<br />
della Chiesa, entra a buon <strong>di</strong>ritto come elemento costitutivo del progetto<br />
pastorale con cui Frassinetti si identifica. Di qui: la cura e la formazione<br />
spirituale ed intellettuale del clero e del laicato; la promozione <strong>di</strong> forme<br />
associative; la vigilanza nell‘impe<strong>di</strong>re infiltrazioni <strong>di</strong> mentalità e costumi<br />
alieni dalla schietta fede cattolica; il sentimento intenso del legame tra<br />
magistero e la persona del Pontefice Romano.<br />
Il Frassinetti ha compiutamente compreso che nelle lotte e nei<br />
programmi per un <strong>di</strong>verso assetto politico della penisola era presente un<br />
<strong>di</strong>segno culturale tendente a emarginare la Chiesa con le sue dottrine e le<br />
sue norme morali. Da questa comprensione delle sfide del suo tempo il<br />
progetto pastorale del Frassinetti trae le sue priorità: illuminazione e<br />
formazione delle coscienze, e poi valorizzazione della fede popolare<br />
230
fortemente legata al successore <strong>di</strong> Pietro e alla devozione mariana (cf Voto<br />
VI, pp.46-48).<br />
D) L’IDENTITÀ SACERDOTALE COME UNICO CENTRO<br />
IRRADIANTE<br />
Nella coincidenza ed identificazione tra vita e ministero si svela la<br />
personalità <strong>di</strong> G. Frassinetti. Le sue risorse psicologiche, morali, spirituali,<br />
intellettuali sono tutte convogliate verso la realizzazione dell‘ideale<br />
sacerdotale ed apostolico. Le molteplici sfaccettature della sua attività<br />
possono essere tutte agevolmente ricondotte, come ad un centro irra<strong>di</strong>ante,<br />
al suo essere pastore d‘anime, all‘assenza in lui <strong>di</strong> fratture tra teoria (attività<br />
intellettuale) e prassi (attività ministeriale). Il fatto che la sua vita sia tutta<br />
assorbita nel ministero pastorale costituisce precisamente l‘in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong><br />
una figura cristiana che realizza compiutamente la «carità pastorale» (Voto<br />
VI, pp.43-45) richiesta dalla vocazione cristiana e dal sacramento<br />
dell‘Or<strong>di</strong>ne Sacro. La sua personale esperienza spirituale, il suo <strong>di</strong>ffuso<br />
Cristocentrismo (che lo spinge ad avere nella persona <strong>di</strong> Gesú l‘unica<br />
regola <strong>di</strong> vita) viene tradotto in linea pedagogica e formativa. L‘interesse<br />
vivo dei suoi interventi, la finalità <strong>di</strong> tutti i suoi scritti sono interamente<br />
protesi a formare le coscienze per aprirle alle scelte gran<strong>di</strong> e alle esigenze<br />
del vangelo.<br />
E) SPUNTI DI ATTUALITÀ<br />
Il V Consultore mette in rilievo l‘attualità della figura del<br />
Frassinetti nell‘esercizio della missione sacerdotale e nell‘educazione del<br />
giovane clero, attività per le quali de<strong>di</strong>cò tutte le sue energie e tutta la sua<br />
vita. Per il sacerdote del duemila – scrive il V Consultore – la figura<br />
carismatica del Frassinetti può offrire alcune precise in<strong>di</strong>cazioni: «quella <strong>di</strong><br />
non cedere alla moda del potere politico imperante, quella <strong>di</strong> andare a<br />
bussare <strong>di</strong> porta in porta per annunziare la parola <strong>di</strong> Dio e comunicare<br />
l‘invito alla salvezza <strong>di</strong> Cristo; quella <strong>di</strong> creare associazioni perché i cristiani<br />
non si sentano isolati bensì uniti nella carità <strong>di</strong> Cristo; quella <strong>di</strong> dare nel<br />
nostro mondo consumistico la testimonianza della povertà che apre la<br />
porta ai beati che vogliono entrare nel regno dei cieli» (cf Voto V, p. 42). Il<br />
VII Consultore conclude la sua analisi con parole che rivelano l‘in<strong>di</strong>scussa<br />
attualità della fisionomia spirituale del nostro Frassinetti. Scrive: ―G.<br />
Frassinetti mi sembra incarnare perfettamente in sé la spiritualità esposta<br />
231
nel decreto Presbyterorum Or<strong>di</strong>nis, cioè la spiritualità del sacerdote pastore <strong>di</strong><br />
anime. Questa bella figura <strong>di</strong> sacerdote si può presentare anche oggi come<br />
modello <strong>di</strong> quella santità sacerdotale, che i recenti sino<strong>di</strong> sembrano con<br />
forza riaffermare‖ (cf p.58).<br />
Per le sue iniziative, per i meto<strong>di</strong> pastorali, come ad esempio la<br />
Comunione frequente, per l‘istituzione <strong>di</strong> gruppi laicali impegnati, per la<br />
sua dottrina morale, il Frassinetti può essere considerato un «Profeta» dei<br />
tempi nuovi; molte delle sue intuizioni sono ormai <strong>di</strong>venute prassi <strong>di</strong> tutta<br />
la Chiesa.<br />
Tra i giovani era frequente la convinzione che ―non fosse il<br />
Frassinetti che operava, ma che Dio operasse in lui‖ (Summarium 529);<br />
―Egli ha fatto per la salvezza delle anime ciò che non farebbero 500 preti‖<br />
(Summarium 170, 716); ―Uno <strong>di</strong> quegli uomini usciti proprio dalle mani <strong>di</strong><br />
Dio; poi Egli perde lo scalpello e per cent‘anni non ne fa piú‖ (Summarium<br />
§ 175, 734). La figura sacerdotale del Frassinetti, risolta tutta nell‘impegno<br />
pastorale e nella formazione alla santità, ha – utilizzando le parole del VI<br />
Consultore (p.48) – non poco da <strong>di</strong>re ancora ai <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> e<br />
ai presbiteri <strong>di</strong> tutta la Chiesa.<br />
È mia convinzione che il profilo carismatico del Frassinetti possa<br />
aiutarci non poco a recuperare l‘identità <strong>di</strong> <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, che in numerosi<br />
casi sembra <strong>di</strong>ventata pericolosamente evanescente. Siamo Chiesa nella<br />
misura in cui sappiamo essere Congregazione, ed in virtú <strong>di</strong> «quel dono»<br />
concesso alla Congregazione stessa. Il riconoscimento non solo teorico del<br />
«Carisma del Fondatore» ha gran<strong>di</strong> vantaggi per la vita e per la<br />
sopravvivenza della Congregazione: ricompatta infatti l‘Istituto, offre una<br />
forte coesione ai membri, riafferma o ricostituisce la loro identità <strong>di</strong> fronte<br />
alla Chiesa ed alla Società, formula o riformula in un tutto coerente le varie<br />
proposte <strong>di</strong> formazione dei membri e soprattutto <strong>di</strong> conduzione delle<br />
opere 344.<br />
Il nostro Istituto trova o ritrova nel carisma del Fondatore la sua<br />
ragion d‘essere, senza per questo sentirci un settore a parte nella Chiesa<br />
(uno dei possibili rischi!) o avere la presunzione <strong>di</strong> organizzarci e trincerarci<br />
come impenetrabile chiesa, quanto piuttosto sentirci a <strong>di</strong>retto servizio <strong>di</strong><br />
essa attraverso il prolungamento del profilo carismatico del Fondatore<br />
nella nostra storia.<br />
Riscoprire, rivalutare, riappropriarci della fisionomia spirituale del<br />
Frassinetti, cogliendone le nuove possibili forme <strong>di</strong> attuazione, è il compito<br />
344 Mi riferisco alla pubblicazione <strong>di</strong> G. ROCCA, Il Carisma del Fondatore<br />
(Milano 1998) pp. 110-113.<br />
232
<strong>di</strong> tutti 345: dei professi studenti, dei giovani sacerdoti, <strong>di</strong> quanti sono<br />
impegnati nella formazione dei giovani alla vita religiosa ed al sacerdozio,<br />
dei religiosi fratelli (dai quali è nata la Congregazione!!!), dei parroci, dei<br />
confessori, degli animatori giovanili, <strong>di</strong> quanti sono de<strong>di</strong>ti all‘apostolato<br />
vocazionale, <strong>di</strong> chi si de<strong>di</strong>ca allo stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> coloro che amano scrivere, <strong>di</strong><br />
chi crede nello spirito <strong>di</strong> collaborazione, ed infine <strong>di</strong> chi è preposto al<br />
governo.<br />
P. Roberto Amici fsmi<br />
CHE GRAN SANTO È SAN GIUSEPPE !<br />
Riflessioni su «Amiamo San Giuseppe»<br />
Noviziato 2005/06<br />
Brzoz6wka 171 33-140 Lisia G6ra<br />
POLONIA<br />
SOMMARIO<br />
Prologo<br />
San Giuseppe un uomo giusto<br />
San Giuseppe nei vangeli<br />
Paragrafo I – Chi è San Giuseppe?<br />
Paragrafo II – Chi è San Giuseppe?<br />
Paragrafo III – Chi è San Giuseppe?<br />
Paragrafo IV – Se amiamo San Giuseppe onoriamo <strong>Maria</strong><br />
Paragrafo V – Se amiamo San Giuseppe amiamo Gesú<br />
345 Il compito <strong>di</strong> tutelare lo spirito dell’Istituto è affidato ai superiori<br />
maggiori. Ma il dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere e coltivare il carisma del fondatore<br />
incombe in primo luogo sull’istituzione religiosa collettiva, che per noi è<br />
rappresentata dal Capitolo Generale. Eventuali cambiamenti strutturali<br />
del carisma del fondatore o dell’istituto senza il consenso del Capitolo<br />
Generale sarebbero perciò illegittimi (Cf CIC 576, 631).<br />
233
Paragrafo VI - Se amiamo San Giuseppe, accostiamoci con frequenza alla<br />
santissima comunione<br />
Paragrafo VII - Se amiamo San Giuseppe, amiamo la castità<br />
Paragrafo VIII - Se amiamo San Giuseppe assicuriamoci una buona morte<br />
Il Frassinetti ci esorta alla devozione<br />
San Giuseppe patrono<br />
Preghiera a San Giuseppe<br />
PROLOGO<br />
Nel secondo periodo <strong>di</strong> Noviziato della Congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> 2005/06 che ha avuto luogo in Polonia, abbiamo<br />
vissuto tante esperienze significative che sono in<strong>di</strong>spensabili motivi per<br />
ringraziare il Signore per tutta la nostra vita.<br />
È stato un tempo bello e <strong>di</strong>fficile nel quale abbiamo vissuto<br />
esperienze in<strong>di</strong>menticabili, tempo che principalmente parlava al nostro<br />
cuore, per arrivare al punto <strong>di</strong> scoprire la propria vocazione.<br />
Alla fine <strong>di</strong> quest‘anno abbiamo desiderato realizzare una piccola<br />
opera come mezzo <strong>di</strong> ringraziamento, per tutti i doni ricevuti in quest‘anno<br />
che Dio ci ha dato la grazia <strong>di</strong> vivere, raccogliendo <strong>di</strong>versi testi, scritti e<br />
documenti dell‘Opera Ascetica <strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti, in particolare<br />
«Amiamo San Giuseppe», aggiungendo i nostri propri pensieri.<br />
Dunque, questo scritto ci parla dello sposo della nostra cara<br />
Patrona, San Giuseppe.<br />
Perciò chi dà prova <strong>di</strong> amare la nostra Madre <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>,<br />
deve amare anche San Giuseppe.<br />
Lo scopo <strong>di</strong> questo lavoretto è aumentare il desiderio <strong>di</strong> crescere<br />
nella devozione per il Santo piú casto che è esistito sulla terra: «SAN<br />
GIUSEPPE».<br />
SAN GIUSEPPE UN UOMO GIUSTO<br />
234
Parlare <strong>di</strong> San Giuseppe è abbastanza <strong>di</strong>fficile avendo presente il<br />
poco che si <strong>di</strong>ce nei vangeli <strong>di</strong> lui; ma veramente in questo silenzio lui si fa<br />
presente con il ruolo <strong>di</strong> padre putativo dello stesso Dio, il padre che<br />
educò il buon Gesú bambino e lo formò in tutto ciò che Gesú si serví per<br />
manifestarsi al mondo. ―Il bambino cresceva e si fortificava, pieno <strong>di</strong><br />
sapienza, e la Grazia <strong>di</strong> Dio era sopra <strong>di</strong> Lui‖. (Lc 2,40)<br />
San Giuseppe nel suo umile silenzio <strong>di</strong>mostra e ci dà un esempio<br />
della vera ubbi<strong>di</strong>enza e fiducia in Dio nel momento <strong>di</strong> accettare la paternità<br />
legale <strong>di</strong> Gesú. San Giuseppe me<strong>di</strong>ta nel suo interiore e senza capire gran<br />
ché; gli viene in sogno la rivelazione del Signore e <strong>di</strong>ce:<br />
―Giuseppe, figlio <strong>di</strong> Davide, non temere <strong>di</strong> prendere con te <strong>Maria</strong>, tua sposa,<br />
perché quel che è generato in Lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu<br />
lo chiamerai Gesú: Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati‖ (Mt 1,20-21)<br />
San Giuseppe è un uomo obbe<strong>di</strong>ente che, dopo la rivelazione <strong>di</strong><br />
Dio nel sogno, sposa <strong>Maria</strong> anche se Lei aspetta un figlio che non è suo.<br />
Giuseppe è un uomo giusto, che nel suo interiore accetta il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> Dio<br />
e prende <strong>Maria</strong> e prende <strong>Maria</strong> come sposa, prende il carico <strong>di</strong> padre <strong>di</strong> un<br />
figlio che sa che non è suo. Giuseppe possiamo <strong>di</strong>re che è una figura <strong>di</strong><br />
grande importanza nella storia della salvezza. Giuseppe è padre e sposo<br />
protettore che prende <strong>Maria</strong> e suo <strong>Figli</strong>o e fugge in Egitto per sfuggire alla<br />
persecuzione <strong>di</strong> Erode. Dopo la morte <strong>di</strong> Erode Giuseppe insieme a <strong>Maria</strong><br />
ritorna a Nazaret.<br />
Il Vangelo ci presenta sempre riunita la famiglia <strong>di</strong> Nazaret nei<br />
primi avvenimenti della infanzia <strong>di</strong> Gesú, dove è stato presente Giuseppe<br />
sempre insieme a <strong>Maria</strong>.<br />
SAN GIUSEPPE NEI VANGELI<br />
Mt 1,18-24<br />
San Giuseppe assume la paternità <strong>di</strong> Gesú<br />
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, dalla quale è nato Gesú chiamato Cristo.<br />
Ecco come avvenne la nascita <strong>di</strong> Gesú Cristo: sua madre <strong>Maria</strong>, essendo promessa sposa<br />
<strong>di</strong> Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito<br />
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripu<strong>di</strong>arla, decise <strong>di</strong> licenziarla in<br />
segreto.<br />
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del<br />
Signore e gli <strong>di</strong>sse: «Giuseppe, figlio <strong>di</strong> Davide, non temere <strong>di</strong> prendere con te <strong>Maria</strong>, tua<br />
235
sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, partorirà un figlio e tu<br />
lo chiamerai Gesú: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati.<br />
Destatosi dal sonno, Giuseppe come gli aveva or<strong>di</strong>nato l’angelo del Signore prese con sé<br />
la sua sposa, che egli la conoscesse, partorí un figlio che egli chiamò Gesú.<br />
Mt 2,19-23<br />
Fuga in Egitto e strage degli innocenti<br />
Erano appena partiti (i Magi), quando un angelo del Signore apparve in sogno a<br />
Giuseppe e gli <strong>di</strong>sse: «Alzati, pren<strong>di</strong> con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e<br />
resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo».<br />
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto<br />
dove rimase fino alla morte <strong>di</strong> Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal<br />
Signore per mezzo del profeta:<br />
Dall’Egitto ho chiamato il mio figlio.<br />
Mt 2,19-23<br />
Ritorno dall‘Egitto e <strong>di</strong>mora a Nazaret<br />
Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli <strong>di</strong>sse:<br />
«Alzati, pren<strong>di</strong> con te il bambino e sua madre e va’ nel paese <strong>di</strong> Israele; perché sono<br />
morti coloro che insi<strong>di</strong>avano la vita del bambino».<br />
Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese <strong>di</strong> Israele. Però<br />
saputo che era re della Giudea Archelao al posto <strong>di</strong> suo padre Erode, ebbe paura <strong>di</strong><br />
andarvi.<br />
Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad<br />
abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai<br />
profeti:<br />
«Sarà chiamato Nazareno».<br />
Mt 13,53-55<br />
Visita a Nazaret<br />
Terminate queste parabole, Gesú partí <strong>di</strong> là e venuto nella sua patria insegnava nelle<br />
loro sinagoghe e la gente rimaneva stupita e <strong>di</strong>ceva: ―Da dove mai viene a costui questa<br />
sapienza e questi miracoli?. Non egli forse il figlio del carpentiere?<br />
Lc 1,26-27<br />
Nell‘annunciazione<br />
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,<br />
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa <strong>di</strong> un uomo della casa <strong>di</strong> Davide,<br />
chiamato Giuseppe.<br />
Lc 2,3-7.15-16<br />
Nascita <strong>di</strong> Gesú<br />
236
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città.<br />
Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia <strong>di</strong> Davide, dalla città <strong>di</strong> Nazaret<br />
sali in Giudea alla città <strong>di</strong> Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con<br />
<strong>Maria</strong> sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono<br />
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo<br />
depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo.<br />
Appena gli angeli del cielo si furono allontanati per tornare in cielo, i pastori <strong>di</strong>cevano<br />
fra loro: An<strong>di</strong>amo fino a Betlemme, ve<strong>di</strong>amo questo avvenimento che il Signore ci ha<br />
fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono <strong>Maria</strong> e Giuseppe e il<br />
bambino, che giaceva nella mangiatoia.<br />
Lc 2,27<br />
Presentazione <strong>di</strong> Gesú al tempio<br />
Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio: e mentre i genitori vi portavano il<br />
bambino Gesú per adempiere la legge, lo prese fra le braccia e bene<strong>di</strong>sse Dio:<br />
Lc 2,33-34<br />
Profezia <strong>di</strong> Simeone<br />
Il padre e la madre <strong>di</strong> Gesú si stupivano delle cose che si <strong>di</strong>cevano <strong>di</strong> lui: Simeone li<br />
bene<strong>di</strong>sse e parlò a <strong>Maria</strong> sua madre.<br />
Lc 2,41-50<br />
Gesú tra i dottori<br />
I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa <strong>di</strong> Pasqua. Quando<br />
egli ebbe do<strong>di</strong>ci anni, vi salirono <strong>di</strong> nuovo secondo l’usanza ma trascorsi i giorni della<br />
festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesú rimase a Gerusalemme,<br />
senza che i genitori se ne accorgessero.<br />
Credendolo nella carovana, fecero una giornata <strong>di</strong> viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i<br />
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca <strong>di</strong> lui a Gerusalemme.<br />
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava<br />
e li interrogava. E tutti quelli che l’u<strong>di</strong>vano erano pieni <strong>di</strong> stupore per la sua intelligenza<br />
e le sue risposte.<br />
Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli <strong>di</strong>sse: <strong>Figli</strong>o perché ci hai fatto cosí?. Ecco<br />
tuo padre ed io, angosciati ti cercavamo.<br />
Ed egli rispose: Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del<br />
Padre mio? Ma essi non compresero le sue parole.<br />
Lc 4,22<br />
Gesú a Nazaret<br />
237
Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole <strong>di</strong> grazia che<br />
uscivano dalla sua bocca e <strong>di</strong>cevano: Non è il figlio <strong>di</strong> Giuseppe?<br />
Gv 1,43-45<br />
I primi <strong>di</strong>scepoli<br />
Il giorno dopo Gesú aveva stabilito <strong>di</strong> partire per la Galilea: incontrò Filippo e gli <strong>di</strong>sse:<br />
Seguimi. Filippo era <strong>di</strong> Betsaida, la città <strong>di</strong> Andrea e <strong>di</strong> Pietro. Filippo incontrò<br />
Natanaele w gli <strong>di</strong>sse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e<br />
i profeti, Gesú, figlio <strong>di</strong> Giuseppe <strong>di</strong> Nazaret.<br />
PARAGRAFO I<br />
CHI È SAN GIUSEPPE?<br />
Giuseppe è mio sposo, risponde <strong>Maria</strong>, sposo <strong>di</strong> me che sono la<br />
sposa dello Spirito, infatti, egli mi amò sempre in terra, con quella purità e<br />
Santità <strong>di</strong> affetto con la quale mi amano gli angeli del cielo.<br />
San Giuseppe è un uomo virtuoso, specialmente perché ha avuto<br />
la piú bella e privilegiata delle virtú cristiane «la castità perfetta».<br />
San Giuseppe è meritevole <strong>di</strong> essere il mio sposo per quella Santità<br />
e perfezione donata a Lui dalla grazia onnipotente <strong>di</strong> Dio.<br />
PARAGRAFO II<br />
CHI È SAN GIUSEPPE?<br />
San Giuseppe per me, risponde Gesú, fu l‘uomo che per volontà<br />
<strong>di</strong> Dio accettò <strong>di</strong> prendere il ruolo del mio padre putativo, un padre che<br />
con forza e umiltà mi insegnò a crescere come un uomo, portando avanti il<br />
<strong>di</strong>segno che Dio gli aveva rivelato. Giuseppe da me è stato amato e<br />
rispettato come padre, godendo in sé una vita <strong>di</strong> para<strong>di</strong>so in terra.<br />
Giuseppe non è stato risparmiato dai dolori e dalle tribolazioni<br />
che ha dovuto incontrare nel cammino della sua vita.<br />
PARAGRAFO III<br />
238
CHI È SAN GIUSEPPE?<br />
Le anime devote affermano che San Giuseppe è la<br />
rappresentazione umana della paternità <strong>di</strong> Dio verso Gesú. I devoti <strong>di</strong><br />
fronte alla ricca umanità <strong>di</strong> questo Santo, sentono che dopo Gesú e <strong>Maria</strong>,<br />
Giuseppe è la <strong>di</strong>mostrazione piú esemplare <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza e silenzio <strong>di</strong><br />
fronte alla volontà <strong>di</strong> Dio.<br />
La devozione a San Giuseppe è un collegamento <strong>di</strong>retto alla<br />
venerazione <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> e all‘adorazione <strong>di</strong> Gesú nella figura del Padre.<br />
Quin<strong>di</strong> amiamo San Giuseppe.<br />
PARAGRAFO IV<br />
SE AMIAMO SAN GIUSEPPE, ONORIAMO MARIA<br />
San Giuseppe è uomo umile e casto, che ha in sé un amore<br />
immensurabile per <strong>Maria</strong>.<br />
San Giuseppe ci dà la opportunità <strong>di</strong> gustare il grande merito <strong>di</strong><br />
potere amare e venerare <strong>Maria</strong> come la nostra madre, e <strong>di</strong> onorarla sopra<br />
ogni altra creatura.<br />
<strong>Maria</strong> è la piú bella e pura <strong>di</strong> tutte le creature, perfetta in Santità,<br />
piú <strong>di</strong> tutti i Santi.<br />
Perciò dobbiamo amare <strong>Maria</strong> con tutto il nostro cuore e con<br />
tutta la nostra fede, cosí per mezzo <strong>di</strong> Lei anche daremo bella prova <strong>di</strong><br />
amare il piú casto e obbe<strong>di</strong>ente degli uomini «San Giuseppe».<br />
PARAGRAFO V<br />
SE AMIAMO SAN GIUSEPPE AMIAMO GESÚ<br />
San Giuseppe desidera che il vero amore non ricada su <strong>di</strong> lui ma si<br />
rifletta nell‘oggetto del suo amore.<br />
Questo amore si percepisce nella cura che Giuseppe aveva verso<br />
suo figlio, Gesú. Lui ci <strong>di</strong>mostra un vero senso della paternità nella<br />
239
piccolezza del suo essere nonostante la sua povertà la preoccupazione, <strong>di</strong><br />
dare a Gesú tutto ciò che a Lui bisognava, alloggio, un buon cibo, vesti.<br />
San Giuseppe con la sua protezione non permetteva che nessuno desse<br />
noia o insultasse Gesú. Cosí San Giuseppe ci invita anche a noi <strong>di</strong><br />
preparare oggi nella nostra vita ciò che Gesú può desiderare.<br />
In questo compito rivestiamoci delle virtú cristiane, fede,<br />
speranza, umiltà, pazienza e la virtú delle virtú, la carità con la quale<br />
<strong>di</strong>mostreremo il vero amore, sull‘esempio che ci dà San Giuseppe.<br />
PARAGRAFO VI<br />
SE AMIAMO SAN GIUSEPPE, ACCOSTIAMOCI CON<br />
FREQUENZA ALLA SANTISSIMA COMUNIONE<br />
San Giuseppe custode del pane vivo e vero che è <strong>di</strong>sceso dal cielo,<br />
affidatogli dalla pietà celeste per mantenere, guidare e proteggere quel<br />
bimbo che si è convertito nel nostro alimento quoti<strong>di</strong>ano, Gesú.<br />
Questo suo ruolo era stato già attuato profeticamente da Giuseppe<br />
figlio <strong>di</strong> Giacobbe che provvide il pane al popolo affamato.<br />
È l‘alimento che purifica, che dà vita, che ogni giorno per l‘unione<br />
con Dio.<br />
San Giuseppe desidera e si rallegra quando ci accostiamo e ci<br />
nutriamo dell‘unico pane vero che alimenta le nostre anime e il nostro<br />
spirito.<br />
È il cibo che ci aiuta ad acquistare una virtú che a San Giuseppe<br />
piace tanto cioè la castità.<br />
PARAGRAFO VII<br />
SE AMIAMO SAN GIUSEPPE, AMIAMO LA CASTITÀ<br />
La castità è un dono <strong>di</strong> Dio, una grazia, un frutto dello Spirito, è la<br />
piú bella <strong>di</strong> tutte le virtú.<br />
240
Chi ama la castità può ottenere il grande merito <strong>di</strong> poter amare<br />
anche San Giuseppe, perché a San Giuseppe è questa la virtú che piace<br />
tanto.<br />
Quin<strong>di</strong> quelle persone che conservano intatta la loro castità,<br />
secondo il proprio stato, sono persone amatissime e privilegiate <strong>di</strong> San<br />
Giuseppe.<br />
Perciò chi dà prova <strong>di</strong> amare San Giuseppe, deve amare anche la<br />
castità. Dunque dobbiamo amare la castità e farla amare dagli altri, usando<br />
come mezzi: la grazia <strong>di</strong> Dio, la preghiera, l‘aiuto dei sacramenti.<br />
Alimentiamoci <strong>di</strong> quell‘esempio <strong>di</strong> castità della regina piú casta che<br />
è esistita sulla terra: la Vergine <strong>Maria</strong>.<br />
PARAGRAFO VIII<br />
SE AMIAMO SAN GIUSEPPE ASSICURIAMOCI <strong>UNA</strong> BUONA<br />
MORTE<br />
San Giuseppe vuole che ci salviamo, per poter stare insieme a lui<br />
in para<strong>di</strong>so.<br />
San Giuseppe interiormente ci ispira a scegliere i mezzi per<br />
assicurare una buona morte. Il primo è il condurre una buona vita poiché<br />
quale è la vita, tale è la morte. Questa vita ci parla della grazia che fa essere<br />
erede del regno <strong>di</strong> Dio.<br />
Procuriamo <strong>di</strong> conservare questa grazia evitando tutte le occasioni<br />
<strong>di</strong> peccato mortale, in modo che la morte non ci sorprenda in questo stato<br />
perché ci porterebbe a una sofferenza eterna nell‘inferno.<br />
Procuriamo <strong>di</strong> vivere in grazia <strong>di</strong> Dio. Evitiamo <strong>di</strong> cadere anche<br />
nel peccato veniale, perché quanto meno mettiamo da parte nostra la cura<br />
<strong>di</strong> evitare il peccato veniale, tanto piú facilmente potremmo cadere nel<br />
peccato mortale.<br />
Anche assicuriamoci per mezzo <strong>di</strong> una buona vita, <strong>di</strong> fare una<br />
buona morte, e la miglior morte che può fare un cristiano è la morte<br />
munita dei Santi Sacramenti, ricevuti per tempo.<br />
Nel momento <strong>di</strong> qualsiasi infermità normalmente non pensiamo<br />
alla morte ma alla guarigione. Invece dobbiamo fare tutto al contrario,<br />
dopo la prima visita me<strong>di</strong>ca già fare tutto il possibile per ricevere il<br />
sacramento della riconciliazione, anche in seguito il santo Olio, cosí<br />
241
troveremo la me<strong>di</strong>cina che conforta e allevia se non il corpo almeno<br />
l'anima.<br />
IL FRASSINETTI CI ESORTA ALLA DEVOZIONE!<br />
Giuseppe Frassinetti, si chiamava Giuseppe per questa e altre<br />
ragioni era fedelmente devoto a San Giuseppe.<br />
Che gran Santo è San Giuseppe! Esclama il Frassinetti.<br />
Egli fu prescelto da Dio quasi ad angelo custode visibile <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> e<br />
servo fedelissimo in tutti i pericoli, angustie e bisogni della vita <strong>di</strong> Lei, anzi<br />
a vero sposo <strong>di</strong> Essa che era sposa dello Spirito Santo, Regina degli angeli e<br />
<strong>di</strong> tutti i Santi, che meritò essere riputato, e realmente ne fece le parti come<br />
padre del Salvatore del mondo.<br />
Egli fece in terra vita <strong>di</strong> para<strong>di</strong>so, godendosi la continua<br />
compagnia della regina del cielo e dell‘Unigenito figlio <strong>di</strong> Dio umanato.<br />
Che gran Santo è San Giuseppe! Chi potrebbe <strong>di</strong>re quanto sia<br />
amato da <strong>Maria</strong>?<br />
E sarebbe possibile che vi fosse alcuno tra i cristiani amanti <strong>di</strong><br />
<strong>Maria</strong>, che non amasse San Giuseppe e non gli fosse devoto?<br />
E veramente cosa impossibile. Il fatto è che San Giuseppe è il<br />
Santo piú caro delle anime pie.<br />
Dunque, noi impegniamoci ad essere devoti <strong>di</strong> San Giuseppe,<br />
santificando il giorno della sua festa il 19 <strong>di</strong> Marzo, ricorrendo a lui in tutti<br />
bisogni e facendogli quoti<strong>di</strong>anamente qualche ossequio.<br />
Noi che professiamo questa singolare devozione affi<strong>di</strong>amoci a San<br />
Giuseppe con questa umile preghiera:<br />
Gloriosissimo San Giuseppe padre putativo <strong>di</strong> Gesú, vero sposo della<br />
benedetta Vergine <strong>Maria</strong>, protettore dei poveri agonizzanti, confidando nella vostra<br />
potentissima intercessione, io vi domando queste grazie; la prima che io serva Gesú con<br />
quella <strong>di</strong>ligenza ed amore, con cui lo avete servito voi; la seconda che io abbia per <strong>Maria</strong><br />
quella riverenza, ed insieme abbia in Lei quella confidenza, che avete avuto voi; la terza<br />
che Gesú e <strong>Maria</strong> assistano alla mia morte, come hanno assistito alla vostra. Cosí sia.<br />
242
SAN GIUSEPPE PATRONO:<br />
della Chiesa universale: in tutto il mondo cristiano San Giuseppe è<br />
venerato come il padre del buon Gesú. La chiesa lo riconosce come un<br />
personaggio storico importante nella storia della salvezza, anche perché lui<br />
è l‘esempio per tutti noi <strong>di</strong> umiltà e abbandono in Dio.<br />
della Congregazione: noi figli <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> con l‘amore<br />
che abbiamo verso <strong>Maria</strong> non possiamo <strong>di</strong>menticare il suo sposo che tanto<br />
l‘amò, cosi noi per mezzo della venerazione <strong>di</strong> San Giuseppe <strong>di</strong>mostreremo<br />
tutto l‘amore che abbiamo per <strong>Maria</strong>.<br />
dei lavoratori: San Giuseppe con il suo umile lavoro <strong>di</strong> falegname si<br />
sforzava giorno dopo giorno affinché né a Gesú né a <strong>Maria</strong> mancasse<br />
niente. Per questo tanti lavoratori si abbandonano in preghiera perché nella<br />
loro famiglia non manchi mai l‘essenziale.<br />
della buona Morte: San Giuseppe si preoccupa che viviamo insieme con<br />
lui nel para<strong>di</strong>so perciò ci invita a conseguire una buona morte per mezzo <strong>di</strong><br />
una buona vita e una vita vissuta e fortificata dai sacramenti per arrivare<br />
preparati ad una buona morte.<br />
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE<br />
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e<br />
fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua Ss.ma Sposa.<br />
Deh! Per quel sacro vincolo <strong>di</strong> carità che ti strinse all‘<strong>Immacolata</strong> Vergine,<br />
Madre d Dio, e per l‘amore paterno che portasti al fanciullo Gesú riguarda,<br />
te ne preghiamo, con occhio benigno la cara ere<strong>di</strong>tà che Gesú Cristo<br />
acquistò con il suo Sangue e con il tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri<br />
bisogni.<br />
Proteggi, o provvido custode della <strong>di</strong>vina Famiglia, l‘eletta prole <strong>di</strong><br />
Gesú Cristo, allontana da noi, o Padre amatissimo, queste peste <strong>di</strong> errori e<br />
<strong>di</strong> vizi, che ammorba il mondo.<br />
Assistici propizio dal cielo in queste lotta contro il potere delle<br />
tenebre, o nostro fortissimo Protettore, e come un tempo salvasti dalla<br />
morte la minacciata vita del pargoletto Gesú, cosi ora <strong>di</strong>fen<strong>di</strong> la <strong>Santa</strong><br />
Chiesa <strong>di</strong> Dio dalle ostili insi<strong>di</strong>e e da ogni avversità e sten<strong>di</strong> ognora sopra<br />
ciascuno <strong>di</strong> noi il tuo patrocinio affinché, a tuo esempio e con il tuo<br />
soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire<br />
l‘eterna in cielo. Amen<br />
243
(Leone XIII)<br />
19 Marzo Solennità<br />
1 Maggio Memoria<br />
Novizio Victor Rubio Gonzalez fsmi<br />
AMIAMO GESÚ<br />
E<br />
AMIAMO MARIA<br />
Riflessioni sugli scritti del Frassinetti<br />
Poiano – Verona Noviziato 2007/08<br />
SOMMARIO<br />
Prefazione<br />
Amiamo Gesú<br />
Introduzione<br />
Riassunto dell‘operetta ―Amiamo Gesú:<br />
Chi è Gesú<br />
Gesú conosciuto dai cattolici<br />
Gesú conosciuto dagli eretici, dagli scismatici e dai protestanti<br />
Gesú conosciuto dai pagani e dagli increduli<br />
Giustezza, santità e delizia dell‘amore <strong>di</strong> Gesú<br />
244
Per amare Gesú amiamo il prossimo<br />
Per amare Gesú amiamo la chiesa<br />
Per amare Gesú <strong>di</strong>fen<strong>di</strong>amo il suo onore<br />
Per amare Gesú uniamoci con Gesú<br />
Per amare Gesú assicuriamoci il para<strong>di</strong>so<br />
E <strong>Maria</strong>?<br />
Amiamo <strong>Maria</strong><br />
Introduzione<br />
Riassunto dell‘operetta ―Amiamo <strong>Maria</strong>‖<br />
Chi è <strong>Maria</strong> ?<br />
Dio ama <strong>Maria</strong><br />
Il para<strong>di</strong>so ama <strong>Maria</strong><br />
Preziosità e dolcezza dell‘amore <strong>di</strong> <strong>Maria</strong><br />
Chi ama <strong>Maria</strong> o<strong>di</strong>a il peccato<br />
Chi ama <strong>Maria</strong> ama le virtú cristiane<br />
Chi ama <strong>Maria</strong> promuove la sua devozione<br />
Chi ama <strong>Maria</strong> ama gesú<br />
Chi ama <strong>Maria</strong> riceve la santa comunione<br />
Chi ama <strong>Maria</strong> ha devozione a san Giuseppe<br />
Chi ama <strong>Maria</strong> recita l‘ave devotamente<br />
P. Giuseppe Frassinetti <strong>di</strong>rebbe oggi<br />
<strong>PREFAZIONE</strong><br />
Durante il mio anno del noviziato mi sono impegnato a conoscere<br />
soprattutto il Fondatore della congregazione Giuseppe Frassinetti, per<br />
vivere con lo spirito <strong>di</strong> questo grande uomo e nel futuro operare cosí come<br />
operava Lui.<br />
Tanti libri, tanti <strong>di</strong>scorsi scritti da Lui sono uno specchio della sua<br />
stessa vita. Come novizio desidero esercitarmi piú profondamente possibile<br />
nell‘amore verso Dio e nell‘amore verso la nostra patrona e madre<br />
<strong>Immacolata</strong> perché come religioso io sia un vero operatore della missione<br />
che è stata affidata da Dio alla congregazione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong>.<br />
Due piccoli libretti «Amiamo Gesú» e «Amiamo <strong>Maria</strong>», scritti dal<br />
venerabile fondatore, sono aiuto e guida nel mio cammino verso la santità.<br />
La loro semplicità e chiarezza aiuta a me<strong>di</strong>tarli senza grande sforzo<br />
della mente e per questo sono <strong>di</strong>sponibili a tutti: al bambino e all‘adulto.<br />
Giuseppe Frassinetti scriveva tutto ciò che praticava nella vita e<br />
non usciva niente dalla penna se non aveva prima praticato nella vita<br />
quoti<strong>di</strong>ana. Per questo libri <strong>di</strong> Frassinetti sono pieni della vita, pieni del<br />
245
senso, <strong>di</strong> quella profon<strong>di</strong>tà che tocca cuore dell‘uomo e lo aiuta a ripensare<br />
la propria vita. Questo piccolo lavoro che ho fatto mio mi ha aiutato e mi<br />
aiuta nel mio cammino verso la professione.<br />
AMIAMO GESÚ<br />
INTRODUZIONE<br />
Il <strong>di</strong>ciannovesimo secolo per la Chiesa cattolica fu particolarmente<br />
<strong>di</strong>fficile. Si crearono tanti gruppi scismatici, eretici, e tra questi la<br />
Massoneria, che con tutte le sue forze combattevano contro la Chiesa<br />
specialmente contro il papa.<br />
La chiesa Genovese ha subíto gran<strong>di</strong>ssimi danni spirituali infatti il<br />
popolo non riuscendo bene a <strong>di</strong>stinguere si lasciava trascinare dalla dottrina<br />
sbagliata. Per esempio Renan uno scrittore francese ha scritto un libro<br />
anticattolico che intitolato «Vie de Jésus». Ivi affermava che Gesú è<br />
soltanto uno dei tanti rivoluzionari <strong>di</strong> quello tempo.<br />
―Poiché lo zelo della tua casa mi ha <strong>di</strong>vorato, e gli oltraggi <strong>di</strong> chi ti<br />
oltraggia sono caduti su <strong>di</strong> me (salmo 69)‖ il Frassinetti, ha reagito subito e<br />
ha scritto una poesia dove si vede ―lo zelo per la casa <strong>di</strong> Dio‖.<br />
Renan<br />
In questo dì che non ha mane o sera,<br />
Ti generai dalla sostanza mia.<br />
Ti assi<strong>di</strong> alla mia destra e regna e impera<br />
Sopra il ciel, sulla terra e sulla ria<br />
Congrega della gente sozza e altera.<br />
Lo scettro tuo sì luminoso fia<br />
Che sarà sol della suprema sfera<br />
Dove luce ed amor ogni alma in<strong>di</strong>a.<br />
Così l‘Eterno al <strong>Figli</strong>o suo <strong>di</strong>letto,<br />
Fatto Gesú perché figliuolo a Lei<br />
Che fece al serpente antico il gran <strong>di</strong>spetto.<br />
E a Lui per contro un vile verme grida,<br />
ti traggo al suol che un pari mio tu sei!<br />
Schiacciate il verme blasfemo deicida.<br />
246
In quella situazione, dove la fede cattolica era sotto pericolo, il<br />
venerabile Frassinetti scrive il piccolo libretto «Amiamo Gesú» dove<br />
sottolinea l‘amore verso il papa e verso l‘Eucaristia. Il libro scritto da lui, è<br />
un appello a quelli che si sono allontanati da Gesú e a quelli che vogliono<br />
seguirLo da piú vicino.<br />
Il libretto è una «grande opera» che ci <strong>di</strong>ce che senza guida della<br />
Chiesa e senza i sacramenti non possiamo essere salvi. Se l‘uomo amando<br />
Gesú riceve ogni giorno l‘Eucaristia e la vive, secondo il Frassinetti, sarà<br />
sempre capace <strong>di</strong> affrontare il pericolo che viene dalle «potenze»<br />
<strong>di</strong>aboliche. Se è cosí, amiamo Gesú nell‘Eucaristia!<br />
RIASSUNTO DELL’OPERETTA «AMIAMO GESÚ»<br />
CHI È GESÚ<br />
La sacra scrittura, il libro dei libri, ci <strong>di</strong>ce che Gesú Cristo è<br />
l‘altissimo, amatissimo e unico <strong>Figli</strong>o <strong>di</strong> Dio, creatore del cielo e della terra,<br />
principio e fine, il Verbo che si è fatto uomo, Dio con noi, colui che è<br />
morto e risorto per la nostra salvezza.<br />
Ecco chi è Gesú: Amore infinito. Soltanto lui pretende il nostro<br />
amore, le nostre lo<strong>di</strong> e i nostri ringraziamenti. Lui è cosí grande, che i<br />
nostri atti <strong>di</strong> amore non bastano per ringraziarlo infinitamente e rispondere<br />
al suo amore. Né gli angeli né i santi, né la terra e tutto ciò che la contiene<br />
non riesce ad amare Gesú cosí come lui lo merita. Soltanto Dio può<br />
amarlo degnamente con il Suo infinito amore.<br />
Gesú merita grandemente il nostro amore: per la morte e per le<br />
sofferenze, per l‘Eucaristia, e per la de<strong>di</strong>zione. Lui è rimasto nell‘Eucaristia<br />
per essere vicino a noi, per consolarci ed amarci. Per noi si è umiliato,<br />
perché noi nel giorno della salvezza saremo glorificati.<br />
Ecco per tutto questo dobbiamo crescere nell‘amore <strong>di</strong> Cristo.<br />
Amiamo Gesú!<br />
GESÚ CONOSCIUTO DAI CATTOLICI<br />
Tutti i figli della Chiesa cattolica riconoscono Gesú come il<br />
Sommo sacerdote e il Pastore. Sempre e in ogni momento Lo adorano e<br />
con tutte le forze crescono nella fede e nell‘amore.<br />
247
Tutti i figli della Chiesa testimoniano che Gesú Cristo è il loro<br />
Salvatore e la loro Speranza. Rinunciano ad ogni cosa che può <strong>di</strong>struggere<br />
il loro amore verso Gesú.<br />
Nell‘antichità i cristiani vendevano le loro ricchezze, case, terre<br />
tutto ciò che possedevano. Vivevano nella penitenza, erano anche pronti a<br />
dar la vita per Gesú, il loro Maestro.<br />
Nella storia della Chiesa tantissimi cristiani si sono affidati a Gesú<br />
e al suo amore. Hanno rinunciato ai nobili titoli, alle ricchezze, al<br />
matrimonio per unirsi piú possibilmente al loro pre<strong>di</strong>letto Gesú <strong>di</strong> Nazaret.<br />
Noi che siamo nella Chiesa del Cristo siamo testimoni con le<br />
parole e con i fatti dell‘amore <strong>di</strong> Gesú versato su <strong>di</strong> noi. Amiamo Gesú.<br />
GESÚ CONOSCIUTO DAGLI ERETICI, DAGLI SCISMATICI E<br />
DAI PROTESTANTI<br />
Tutti gli eretici riconoscono Gesú come Salvatore e Redentore del<br />
mondo. Ma non riconoscono qualche punto della dottrina <strong>di</strong> Chiesa<br />
Cattolica. Per loro Gesú è inferiore al Padre e il Padre è superiore dal<br />
<strong>Figli</strong>o, al contrario <strong>di</strong> ciò che confessiamo noi.<br />
Gli scismatici confessano Gesú come Verbo eterno che s‘è fatto<br />
uomo, Salvatore del mondo, <strong>Figli</strong>o del eterno Padre, ma loro non sono<br />
sottomesi al Papa, vicario <strong>di</strong> Cristo, ai vescovi, e ciò significa che sono<br />
contro la Chiesa – Corpo <strong>di</strong> Gesú, arca della salvezza.<br />
Sia chiaro che Gesú è conosciuto dagli scismatici ed eretici i quali<br />
si definiscono Cristiani. Si, Lo conoscono, ma non Lo amano pienamente e<br />
non possono amarLo cosí come Lui lo merita. Fuori dalla Chiesa cattolica<br />
non si può amare Gesú, perché se non si ama la Chiesa corpo <strong>di</strong> Gesú non<br />
si ama Gesú ch‘è capo della Chiesa. Noi che Lo conosciamo amiamo Gesú.<br />
GESÚ CONOSCIUTO DAI PAGANI E DAGLI INCREDULI<br />
Dio all‘uomo ha dato due mezzi per conoscere la verità: la fede e<br />
la ragione. Ognuno che vuole sapere la verità deve avere la vera fede e la<br />
sana ragione. Se queste due non vanno d‘accordo, l‘uomo entrerà nella<br />
menzogna.<br />
Nella storia della Chiesa i pagani avendo sete della verità<br />
ricevevano subito la fede in Gesú Cristo. Si univano cosí intimamente<br />
nell‘amore <strong>di</strong> Gesú che erano anche pronti a soffrire per il nome <strong>di</strong> Lui.<br />
Riconoscevano Gesú come il loro maestro e salvatore, davano<br />
248
testimonianza <strong>di</strong> Lui come unico Bene. Guardando a Gesú crocifisso<br />
imparavano a essere santi e veri <strong>di</strong>scepoli della Sua maestà.<br />
Ci sono tanti pagani che non vogliono riconoscere Gesú come il<br />
loro maestro e unico Dio, perché Lui non è comodo per loro. La vita con e<br />
in Gesú chiede loro dei sacrifici, ma purtroppo loro amano la<br />
sod<strong>di</strong>sfazione derivante dai peccati. Hanno paura <strong>di</strong> stare vicino a Gesú<br />
perché non vogliono vedere i propri peccati e la propria impurità.<br />
Increduli, non vogliono crede a Gesú, perché sanno che amando Gesú si<br />
deve rinunciare ad ogni peccato, ma il peccato è il senso della loro vita.<br />
Sanno chi è Gesú, ma per la paura <strong>di</strong> aprire gli occhi stanno nella loro<br />
cecità.<br />
Nel caso <strong>di</strong> morte si aprono loro occhi e vedono la propria nullità,<br />
si pentono e chiedono perdono per i loro peccati. La vita senza fede è<br />
comoda quando siamo vivi e sani, ma quando viene il tempo, la fine della<br />
vita, ci pentiamo e chie<strong>di</strong>amo scusa. Ma chi sa se riusciremo a pentirci?<br />
Siamo felici, perché cre<strong>di</strong>amo nella verità e nell‘amore in Gesú<br />
Cristo. Non abbiamo paura a aprire gli occhi alla vera luce che ci illumina,<br />
perché nella luce <strong>di</strong> Cristo siamo veri figli <strong>di</strong> Dio. Amiamo Gesú.<br />
GIUSTEZZA, SANTITÀ E DELIZIA DELL’AMORE DI GESÚ<br />
Soltanto la bontà può essere amata. Se la bontà è grande, l‘amore<br />
per la bontà deve essere anche grande. Gesú come gran<strong>di</strong>ssima bontà, deve<br />
essere amato cosí, come è la sua bontà.<br />
Come è l‘oggetto amato cosí anche è l‘amore. Se la persona amata<br />
è nobile anche l‘amore è nobile. Gesú, nostro amore è il santo dei santi, ciò<br />
significa che il nostro amore per Lui è anche santo. Se il nostro amore è<br />
santo, la nostra anima è anche santa. Questo amore santifica colui chi ama<br />
Gesú.<br />
Chi ama Gesú ha i propri <strong>di</strong>fetti, ma l‘Amore amato li copre e<br />
corregge. Colui che ama Gesú è santo. Allora, chi vuole essere santo e<br />
ogni giorno santificarsi, deve in modo speciale amare Gesú.<br />
L‘amore <strong>di</strong> Gesú è l‘amore delizioso. Chi Lo ama non ha bisogno<br />
<strong>di</strong> niente perché amarlo significa essere felici. San Giovanni della Croce,<br />
questo grande innamorato <strong>di</strong> Gesú, scriveva inni per onorare l‘Amore <strong>di</strong><br />
Gesú. Chi Lo ama è nella eterna festa dello Spirito Santo.<br />
L‘amore è delizioso, lo sanno specialmente coloro che riescono a<br />
fare i sacrifici per Gesú, gli offrono le malattie i dolori che li<br />
249
accompagnano ogni giorno come sacrifici <strong>di</strong> Amore. Loro sono beati,<br />
veramente beati; possiamo chiamarli veri amanti <strong>di</strong> Dio.<br />
O voi povero popolo, che cercate le sod<strong>di</strong>sfazioni nel mondo! Se<br />
conosceste l‘amore delizioso <strong>di</strong> Gesú niente desiderereste se non essere<br />
zelanti nel amare il nostro Maestro.<br />
Noi che vogliamo essere felici, amiamo Gesú e saremo benedetti<br />
figli <strong>di</strong> Dio. Amiamo Gesú!<br />
PER AMARE GESÚ AMIAMO IL PROSSIMO<br />
L‘amore <strong>di</strong> Gesú vuole che noi amiamo il prossimo. Quante volte<br />
il buon Gesú ricorda a noi che dobbiamo amare gli altri anche i nemici?<br />
Ogni cosa fatta per prossimo, insegna il Signore, è fatta per Lui. Il pane<br />
dato, la consolazione, l‘aiuto, tutto quello che noi abbiamo dato al<br />
prossimo lo abbiamo dato a Gesú. Tutta le buone opere per il prossimo<br />
sono risposta alla domanda <strong>di</strong> Gesú: Tu Mi ami?<br />
Se amiamo Gesú, amiamo il prossimo! Non soltanto a parole ma<br />
anche con i fatti. L‘amore vostro verso i fratelli sia vero, cosí com‘è vero<br />
l‘amore <strong>di</strong> Gesú. Facciamo per il prossimo tutto ciò che possiamo, il bene<br />
del corpo come il bene dell‘anima.<br />
Qualcuno fa tanto bene per il prossimo, ma questo «bene» è<br />
riservato soltanto per il corpo. Non sempre ricor<strong>di</strong>amo l‘anima dell‘uomo<br />
che ha anche bisogno <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> aiuto. A che cosa serve il corpo se<br />
l‘anima è debole? Abbiamo cura per l‘anime dei fratelli per assicurare la vita<br />
eterna per se stessi e per loro.<br />
Ogni prossimo ha bisogno <strong>di</strong> aiuto! Aiutiamolo! Aiutiamolo con le<br />
preghiere, con gli atti d‘amore. Attiriamo i peccatori ai sacramenti <strong>di</strong>amo a<br />
loro conoscere l‘amore <strong>di</strong> Dio!<br />
L‘esercizio nella carità fraterna, corporale e spirituale, sia vera<br />
testimonianza che davvero amiamo Gesú!<br />
PER AMARE GESÚ AMIAMO LA CHIESA<br />
La Chiesa è sposa <strong>di</strong> Gesú, Lui l‘ha purificata e santificata con il<br />
suo preziosissimo sangue. Cristo ama la Chiesa e sempre intercede per Lei.<br />
Gesú ama la Chiesa e anche noi dobbiamo amarla. Se amiamo Gesú e<br />
o<strong>di</strong>amo la <strong>Santa</strong> Chiesa siamo menzogneri e falsi!<br />
250
La Chiesa e Gesú sono lo stesso corpo, dunque chi perseguita la<br />
Chiesa, perseguita Gesú. Chi o<strong>di</strong>a Gesú o<strong>di</strong>a la Chiesa. Se volgiamo amare<br />
Gesú, amiamo la Chiesa!<br />
Con la parola «Chiesa» non s‘intende la Chiesa fittizia, coloro che<br />
formano la «chiesa» con i loro capricci e desideri. Qua non si intende la<br />
Chiesa falsa ma la Chiesa vera, unica, fondata nella roccia <strong>di</strong> Pietro, dove<br />
sono i veri sacramenti, dove è la parola <strong>di</strong> Dio. Se volgiamo veramente<br />
amare Gesú dobbiamo obbe<strong>di</strong>re alla Chiesa, al Sommo Pontefice e ai<br />
Vescovi. Soltanto cosí possiamo veramente amare Gesú.<br />
Non tacciamo quando il nome della Chiesa è profanato, offeso.<br />
Difen<strong>di</strong>amola!<br />
Contentiamo la Chiesa partecipando alle pratiche che ci offre.<br />
Promoviamo le sue sante istituzioni, impegniamoci in tutto ciò che può<br />
aiutarla a glorificarsi e a crescere.<br />
Siamo obbe<strong>di</strong>enti alla santa Chiesa. Soltanto la Chiesa-Madre ci<br />
può guidare sulla strada giusta e vera. Siamo obbe<strong>di</strong>enti nella parola e<br />
nell‘opera, amando i decreti dell‘amatissima sposa <strong>di</strong> Gesú. Ascoltando la<br />
parola della Chiesa, ascoltiamo Gesú. Amiamo la santa Chiesa cosí come<br />
amiamo Gesú. Amiamo la Chiesa con tutto il cuore e nello stesso modo<br />
ameremo Gesú.<br />
PER AMARE GESÚ DIFENDIAMO IL SUO ONORE<br />
Nei nostri tempi molto spesso sentiamo le male<strong>di</strong>zioni contro<br />
Gesú; male<strong>di</strong>cendo vogliono cancellare il suo nome dalla terra. Coloro che<br />
amano Gesú debbono <strong>di</strong>fendere il suo nome e il suo onore.<br />
Sentendo le male<strong>di</strong>zioni contro il Cristo, non dobbiamo stare in<br />
silenzio, scappare o fingere che tutto va bene! Il figlio che non <strong>di</strong>fende il<br />
padre, non è figlio. Ma Gesú è <strong>di</strong> piú che un padre o un figlio. Dobbiamo<br />
essere forti soldati <strong>di</strong> Cristo, che danno battaglia a coloro che male<strong>di</strong>cono<br />
Gesú. Ma la nostra lotta non è come la loro lotta, la nostra battaglia si<br />
chiama Amore. Non stiamo lontano, ma con tutte le forze <strong>di</strong>fen<strong>di</strong>amo<br />
l‘onore <strong>di</strong> Gesú.<br />
Bene<strong>di</strong>ciamo il nome <strong>di</strong> Gesú, il suo amore, la sua Divinità e<br />
suggeriamo questo bellissimo atto agli altri, perché possano dare<br />
testimonianza agli altri che veramente sono veri <strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong> Cristo.<br />
Se amiamo Gesú, <strong>di</strong>stribuiamo agli altri libretti, immagini <strong>di</strong> Gesú,<br />
perché possa essere sempre nei pensieri, nei <strong>di</strong>scorsi e nelle loro opere.<br />
Diamo un buon esempio <strong>di</strong> vita cristiana, agli amici, parenti, vicini.<br />
251
Con questi e altri mo<strong>di</strong> dobbiamo <strong>di</strong>fendere l‘onore <strong>di</strong> Gesú.<br />
PER AMARE GESÚ UNIAMOCI CON GESÚ<br />
Colui chi ama desidera unirsi con la persona amata. Il vero amore<br />
unisce, cambia, da la sicurezza. Se veramente amiamo Gesú uniamoci con<br />
Lui.<br />
Il santissimo sacramento del altare: ecco il vero mistero che ha<br />
lasciato Gesú per noi. Soltanto con Gesú nell‘Eucaristia possiamo unirci in<br />
modo particolare, mangiando questo pane <strong>di</strong>ventiamo uno corpo e<br />
un‘anima con Gesú. Lui prima della passione ha lasciato questo<br />
sacramento perché potessimo stare sempre vicino a Lui anche se non<br />
possiamo immaginare tutto questo.<br />
Nella sua Potenza s‘è nascosto nel piccolo pezzo <strong>di</strong> pane, perché<br />
possiamo saziarci della sua presenza, e sentirci che non siamo da soli,<br />
sempre al nostro fianco è colui chi ci ama. Gesú desidera che siamo sempre<br />
uniti nell‘amore <strong>di</strong> Lui, perché possiamo <strong>di</strong>ventare sempre piú santi nella<br />
vita, che non sempre dà la sicurezza e benessere. Il tabernacolo deve essere<br />
un posto dove sono i nostri cuori, là dove è prigioniero d‘amore. Siamo<br />
sempre vicino al tabernacolo adorandoLo, non lasciamoLo da solo,<br />
permettiamo a Lui <strong>di</strong> sentire il calore del nostro cuore.<br />
Lui desidera unirsi con noi nell‘Eucaristia, perché soltanto in<br />
questo mistero possiamo essere con il nostro Salvatore un corpo e<br />
un‘anima. Lui è presente in questo pane, con il corpo e con l‘anima e ci<br />
aspetta, pronti ad accoglierlo nel nostro cuore.<br />
Chi ama Gesú veramente partecipa nel santo banchetto<br />
quoti<strong>di</strong>anamente e non può vivere senza <strong>di</strong> Lui neanche un giorno, ma<br />
desidera avere un cuore simile al cuore <strong>di</strong> Gesú. Restiamo dunque lontano<br />
dal peccato perché possiamo quoti<strong>di</strong>anamente unirci con Gesú-Amore.<br />
Soltanto la santa comunione può veramente santificare le nostre anime.<br />
Soltanto il corpo <strong>di</strong> Gesú può guarire le nostre ferite fatte dal peccato.<br />
Gesú Eucaristico, soltanto Lui ha potere <strong>di</strong> santificare le nostre anime.<br />
Dunque, se veramente amiamo Gesú riceviamolo nell‘Eucaristia e<br />
promoviamolo agli altri, perché uniti nel mistico corpo <strong>di</strong> Gesú potessimo<br />
<strong>di</strong>re con gioia e sincerità che veramente amiamo Gesú!<br />
PER AMARE GESÚ ASSICURIAMOCI IL PARADISO<br />
252
Che cosa vuole Gesú? Lui vuole che lo amiamo e cosi potremo<br />
possedere la vita eterna, là dove il nostro amore sarà vero, senza fine,<br />
eterno, là dove potremo guardare il volto <strong>di</strong> Lui e essere sempre felici nel<br />
eterno amore. Soltanto là, la creatura <strong>di</strong> Dio, libera da ogni peccato può<br />
<strong>di</strong>re: ―Lui è per me e io per Lui‖.<br />
Sia il nostro impegno assicurarci il para<strong>di</strong>so. Con questo impegno<br />
possiamo cambiare il mondo, cambiare noi stessi, sia questo impegno al<br />
primo posto della nostra vita, e tutto quello <strong>di</strong> cui avremo bisogno verrà<br />
automaticamente. Vogliamo guadagnare il para<strong>di</strong>so, perché nulla<br />
gioverebbe all‘uomo guadagnare l‘universo col danno della salute<br />
dell‘anima.<br />
Qualche volte <strong>di</strong>amo la grande importanza al mondo…ma<br />
ve<strong>di</strong>amo cosa fa chi vuole avere soltanto i beni del mondo. Colui che ha,<br />
perde, quando viene la morte. Se vogliamo assicurarci i beni <strong>di</strong> questo<br />
mondo che cosa guadagneremo? O, se morti tornassero a vivere <strong>di</strong> nuovo<br />
nella terra, sicuramente farebbero tutto in un altro modo…..<br />
Cercherebbero prima il regno <strong>di</strong> Dio.<br />
Noi che ancora siamo nella terra dei viventi, con tutte le nostre<br />
forze impegniamoci ad assicurarci il para<strong>di</strong>so. Cosí dobbiamo fare se<br />
veramente amiamo Gesú.<br />
E MARIA?<br />
Parlando <strong>di</strong> Gesú non possiamo <strong>di</strong>menticare <strong>Maria</strong>! Lei che ha<br />
portato il Salvatore al mondo, sempre sta vicino al suo figlio. <strong>Maria</strong> nella<br />
sua grandezza, <strong>Immacolata</strong>, sta sempre al nostro fianco e vuole guidarci a<br />
Gesú. Vuole che noi camminando per i dolori <strong>di</strong> questa vita potessimo<br />
entrare nella gioia eterna e unirci nella eternità con il vero Amore, Gesú<br />
Cristo.<br />
Non <strong>di</strong>mentichiamo <strong>Maria</strong>, ma corriamo nelle mani <strong>di</strong> Lei,<br />
affi<strong>di</strong>amo le nostre mancanze, i desideri, le ferite….e siamo sicuri che ci<br />
prenderà tra le sue braccia e ci porterà al suo figlio. Lei, soltanto lei, ci<br />
insegnerà che cosa è il vero amore, la vera vita e la cosa piú importante:<br />
amare Gesú. Affi<strong>di</strong>amoci a <strong>Maria</strong> e non saremo delusi.<br />
Siamo devoti <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> e così potremo <strong>di</strong>re veramente, che amiamo<br />
Gesú.<br />
AMIAMO MARIA<br />
253
―Vi eleggo per mia Signora e Madre mia singolare Avvocata<br />
e fermamente propongo <strong>di</strong> volervi sempre seguire e servire<br />
e <strong>di</strong> fare quanto potrò<br />
perché da altri siate servita.‖<br />
Giuseppe Frassinetti<br />
INTRODUZIONE<br />
Questa preghiera personale <strong>di</strong> venerabile Giuseppe, era recitata da<br />
Lui ogni giorno iniziando la giornata. Questa breve preghiera ci <strong>di</strong>ce tutto<br />
<strong>di</strong> Frassinetti: Chi era, con quali l‘ideali viveva e a chi affidava la sua<br />
esistenza umana. <strong>Maria</strong> era per Lui maestra nel cammino sacerdotale, il<br />
mezzo con quale curava l‘anime ferite e semplicemente Madre alla quale<br />
poteva nel ogni momento cercare l‘aiuto come all‘oasi dove stanchezza e<br />
fatica quoti<strong>di</strong>ana trovano riposo.<br />
―….e fermamente propongo <strong>di</strong> volervi sempre seguire e servire e<br />
<strong>di</strong> fare quanto potrò perché da altri siate servita.‖ Le pie unione, come<br />
<strong>Figli</strong>e e <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, numerosissimi <strong>di</strong>scorsi <strong>Maria</strong>ni (che ne<br />
rimangono oltre cento, <strong>di</strong> cui 74 stampati) preparati con cura e detti nel<br />
cuore. Ecco, Giuseppe Frassinetti è veramente <strong>Figli</strong>o <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> alla quale in<br />
ogni momento esclamava il suo: «TOTUS TUUS MARIA». Il piccolo<br />
libretto Amiamo <strong>Maria</strong> è il frutto <strong>di</strong> vita <strong>Maria</strong>na dove alla fine della Sua<br />
santa vita, ha scritto tutto quello, che ardente Amore verso Madonna a Lui<br />
dettava.<br />
<strong>Maria</strong> è una persona che adorano tutti i popoli, una persona che<br />
dà al mondo pace e speranza. Lei come nostra Madre è sempre vicino a<br />
noi, con il suo cuore materno prende noi suoi figli sulle spalle e sempre ci<br />
porta….porta dal <strong>Figli</strong>o suo Gesú.<br />
C‘è bisogno particolarmente oggi <strong>di</strong> affidare alla Madonna<br />
<strong>Immacolata</strong> i nostri cuori, perché tutti noi vogliamo in questo mondo<br />
camminare con sicurezza e pace.<br />
Questo lavoro, che ho scritto riflettendo sul libretto del Frassinetti<br />
«Amiamo <strong>Maria</strong>» mi aiuta personalmente ad approfon<strong>di</strong>re il mio legame<br />
per la grande e ammirevole persona <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, affinché nel mio cammino<br />
religioso <strong>di</strong>venti un vero testimone <strong>di</strong> Amore.<br />
RIASSUNTO DELL’OPERETTA «AMIAMO MARIA»<br />
254
CHI È MARIA ?<br />
<strong>Maria</strong> è figlia <strong>di</strong> Adamo e Eva ma figlia <strong>di</strong> Adamo e Eva innocenti,<br />
come se fosse nata prima del peccato. Lei è preservata da ogni peccato, è<br />
<strong>Immacolata</strong>. Dio, soltanto Lui, può conoscere com‘è grande la personalità<br />
<strong>di</strong> <strong>Maria</strong>, la castità <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> e la <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>. Con tutta l‘abbondanza <strong>di</strong><br />
grazia che Lei ha ricevuto da Dio, non poteva non <strong>di</strong>ventare la regina del<br />
cielo e della terra.<br />
<strong>Maria</strong> con la grandezza della sua verginità, la bellezza, la <strong>di</strong>gnità,<br />
piena <strong>di</strong> virtú non può essere conosciuta dagli Angeli dai santi e da noi<br />
uomini ma soltanto da Dio che tutto conosce e tutto penetra .<br />
Dunque, amiamo <strong>Maria</strong> che con tutta la sua bellezza e verginità<br />
concede tutti i suoi beni ai bisognosi.<br />
DIO AMA MARIA<br />
Dio ha riempito <strong>Maria</strong> <strong>di</strong> tutte le sue grazie e ama Lei piú <strong>di</strong> tutte<br />
le sue creature. Il nostro Creatore ha affidato il suo amatissimo figlio nelle<br />
mani della Madonna, perché sapeva che Lei con tutte le sue forze e<br />
capacità si sarebbe data alla missione della redenzione. Lei ha preso la<br />
croce del <strong>Figli</strong>o e l‘ha portata insieme con Lui, sapendo che colui che<br />
prende la sua croce non può non piacere a Dio, ma merita tutte le grazie,<br />
che Dio può abbondantemente versare su <strong>di</strong> noi. Dio ama <strong>Maria</strong>, perché<br />
Lei ha affidato tutta la sua volontà nelle mani del suo Creatore. Dio ama<br />
<strong>Maria</strong>! Amiamo dunque e noi <strong>Maria</strong><br />
IL PARADISO AMA MARIA<br />
Il para<strong>di</strong>so ama <strong>Maria</strong> per la sua bellezza e verginità. Gli angeli e i<br />
santi contemplando il suo volto trovano la gioia e pace nel loro cuore.<br />
Perché l‘amore <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> e cosi grande, che ognuno che si affida a Lei si<br />
sente cosi come nel para<strong>di</strong>so. <strong>Maria</strong> regina degli angeli, dei santi, degli<br />
apostoli, è sempre unita intimamente con loro per lodare, bene<strong>di</strong>re Dio,<br />
per adorare il Volto dell‘amatissimo Creatore e Padre. Il para<strong>di</strong>so non può<br />
immaginare la vita eterna senza <strong>Maria</strong>, perché Lei è come il sole che<br />
illumina e riscalda tutti quelli che La invocano. Il para<strong>di</strong>so ama <strong>Maria</strong> e io<br />
devo amarLa, per trovare la armonia della vita.<br />
255
PREZIOSITÀ E DOLCEZZA DELL’AMORE DI MARIA<br />
Dopo l‘amore <strong>di</strong> Dio, l‘amore piú puro e piú vero è l‘amore <strong>di</strong><br />
<strong>Maria</strong>. Lei, come Madre sa bene cosa abbiamo bisogno, cosa desideriamo,<br />
cosa aspettiamo. Se ci affi<strong>di</strong>amo nelle mani <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> vedremo che la nostra<br />
vita si cambierà sicuramente,vedremo il mondo con un nuovo sguardo,<br />
sguardo pieno <strong>di</strong> amore e <strong>di</strong> bontà.<br />
Dunque, offrendoci alla Madonna e all‘amore <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> saremo<br />
felici e porteremo molto frutto. Chi ama <strong>Maria</strong> non sarà confuso. Amiamo<br />
<strong>Maria</strong> !<br />
CHI AMA MARIA ODIA IL PECCATO<br />
Il peccato allontana l‘amore <strong>di</strong> Dio e anche l‘amore della<br />
Madonna. Chi ama veramente non può ferire la persona amata. Chi ama, è<br />
come la neve bianca, senza macchia. Se amiamo veramente la nostra<br />
Mamma, dobbiamo o<strong>di</strong>are il peccato, ma se siamo nel peccato c‘è sempre<br />
Lei, che ci accoglie cosi, come siamo, e ci porterà là, dove è il perdono e il<br />
vero amore. Chi o<strong>di</strong>a il peccato, ama <strong>Maria</strong>.<br />
CHI AMA MARIA AMA LE VIRTÚ CRISTIANE<br />
Chi ama, fa piacere alla persona amata. Chi ama <strong>Maria</strong> fa tutto per<br />
sod<strong>di</strong>sfare la Madonna. Per fare piacere a <strong>Maria</strong> e sod<strong>di</strong>sfarla, dobbiamo<br />
vivere come veri figli <strong>di</strong> Dio cioè fare esercizi nelle virtú cristiane, la<br />
preghiera mariana, atti <strong>di</strong> misericor<strong>di</strong>a, e tutto ciò ci aiuterà a far vedere<br />
che sul serio amiamo <strong>Maria</strong>.<br />
<strong>Maria</strong> ama particolarmente la virtú della castità, dunque<br />
esercitandoci in questa virtú ci aiuterà piú profondamente a unirci con Lei<br />
e nello stesso tempo <strong>di</strong>amo a vedere che veramente amiamo <strong>Maria</strong>.<br />
CHI AMA MARIA PROMUOVE LA SUA DEVOZIONE<br />
Chi veramente ama, non cerca i propri interessi ma si dona all‘altra<br />
persona, la adora, la ama e vive per lei.<br />
Chi ama, non può tacere e non <strong>di</strong>re che ama. Il vero amore è<br />
come il fuoco che si trasmette all‘altre persone.<br />
256
Chi ama la Madre <strong>di</strong> Dio non può tacere e riservare questo amore<br />
a se stesso, ma deve gridare che la ama, la venera, da esempi come amarla<br />
con tutto il cuore.<br />
Dunque, chi ama <strong>Maria</strong> promuove la devozione alla Madonna e<br />
con tutte le sue forze in ogni luogo fa conoscere ch‘è veramente amante e<br />
vero figlio <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>.<br />
CHI AMA MARIA AMA GESÚ<br />
Ci sono persone che visitano i santuari della Madonna, recitano<br />
tante preghiere a <strong>Maria</strong>, ma vivono nel peccato grave, o<strong>di</strong>ano Gesú. Si<br />
credono che essere devoti della Madonna, basterà per salvare l‘anima. Ma<br />
chi non ama Gesú, non può essere il vero amante <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>. Chi o<strong>di</strong>a Gesú<br />
o<strong>di</strong>a anche <strong>Maria</strong>. Non amare Gesú significa rinunciare all‘amore della<br />
Madre. Dunque chi o<strong>di</strong>a Gesú ma <strong>di</strong>ce che ama <strong>Maria</strong> è menzognero.<br />
Lei vuole, che siamo sulla strada <strong>di</strong> Gesú, tenendolo per mano e<br />
con tutto il cuore amandolo possiamo raggiungere la strada della santità.<br />
Facendo cosi, soltanto cosi, possiamo <strong>di</strong>re che veramente amiamo <strong>Maria</strong>.<br />
Dunque chi ama Gesú, con tutto il cuore, con tutta l‘anima, e<br />
soltanto a lui si affida, può veramente <strong>di</strong>re che ama <strong>Maria</strong>.<br />
CHI AMA MARIA RICEVE LA SANTA COMUNIONE<br />
Il sacramento piú grande che ci ha lasciato Gesú è il sacramento<br />
della Eucaristia. Per questo sacramento Gesú viene da noi dalle mani dei<br />
sacerdoti e ci da tutte le grazie perchè siamo salvati.<br />
Soltanto l‘Eucaristia può aiutarci a crescere nell‘amore <strong>di</strong> Gesú.<br />
Colui, che riceve l‘Eucaristia può avere l‘intimità con il Signore, colui che<br />
dà la sicurezza e il benessere nella terra dei viventi.<br />
Colui che vuole veramente amare Gesú, non ha altri mo<strong>di</strong> che<br />
partecipare alla santa Messa e ricevere la santa comunione. Ricevendo la<br />
comunione ci leghiamo intimamente con <strong>Maria</strong> e Gesú e il loro amore<br />
scende su <strong>di</strong> noi.<br />
Dunque prepariamoci a ricevere il Pane del cielo e potremo<br />
crescere nell‘amore <strong>di</strong> Gesú e <strong>di</strong> <strong>Maria</strong>.<br />
CHI AMA MARIA HA DEVOZIONE A SAN GIUSEPPE<br />
257
O, come è grande san Giuseppe! Lui fu scelto come l‘angelo<br />
custode <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> e <strong>di</strong> Gesú. Viveva dunque nella santità, dando l‘esempio<br />
della vera e santa vita famigliare. La Madre <strong>di</strong> Dio ama san Giuseppe e chi<br />
può <strong>di</strong>struggere questa amore ?<br />
Se <strong>Maria</strong> ama Giuseppe, anche noi dobbiamo amarlo. Lui è<br />
pronto a darci tutte le grazie, specialmente tante grazie durante l‘agonia<br />
della morte.<br />
Con tutte le forze impegniamoci a venerare san Giuseppe e<br />
pren<strong>di</strong>amo esempio da Lui e <strong>di</strong>ventiamo simili a san Giuseppe, e cosi ci<br />
daremo testimonianza che davvero amiamo <strong>Maria</strong>.<br />
CHI AMA MARIA RECITA L’AVE DEVOTAMENTE<br />
L‘Ave <strong>Maria</strong> è la piú bella preghiera del mondo. Ma è cosa triste<br />
che questa preghiera è spesso recitata senza devozione.<br />
Dobbiamo recitare questa bellissima preghiera con tanta<br />
devozione, scendere nella profon<strong>di</strong>tà della preghiera, perché possiamo<br />
ammirarla, e con tanta devozione venerare <strong>Maria</strong> cosi, come l‘angelo l‘ha<br />
venerata.<br />
Or<strong>di</strong>niamo noi stessi alla attenzione nella recita della preghiera<br />
―Ave‖, perchè possiamo dare a <strong>Maria</strong> il frutto del nostro amore.<br />
P. GIUSEPPE FRASSINETTI DIREBBE OGGI<br />
Vedo che la civilizzazione sempre va avanti, mai sta fermo, le<br />
gente che corre…. E con tutto il movimento che c‘è si perde il senso della<br />
<strong>di</strong>gnità dell‘uomo, si perde il senso <strong>di</strong> essere figli <strong>di</strong> Dio.<br />
Or<strong>di</strong>natevi la vostra vita, fermatevi, corretevi nelle mani <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> e<br />
chiedetevi l‘aiuto alla Madonna! Lei come Madre sa meglio che cosa è la<br />
vita, la felicità, l‘amore. Io ho affidato il mio cuore nelle mani <strong>di</strong> <strong>Maria</strong> e<br />
non sono stato mai deluso.<br />
Nov. Raimundas Jurolaitis fsmi<br />
258
L'AMICIZIA SPIRITUALE IN GIUSEPPE<br />
FRASSINETTI<br />
SOMMARIO<br />
Introduzione<br />
1. L`amicizia in Giuseppe Frassinetti attraverso tre esperienze fondanti<br />
2. Il 1848: l‘incontro con la spiritualità carmelitana e i primi gruppi amicali<br />
3. Gli scritti<br />
4. La dottrina<br />
5. Aspetti relativi alla <strong>di</strong>mensione apostolica<br />
6. Riflessioni conclusive<br />
INTRODUZIONE<br />
L‘amicizia è una manifestazione anzi un‘esaltazione della vita<br />
comunitaria e della Koinonia secondo lo spirito del secondo capitolo degli<br />
259
Atti degli Apostoli. Essa si fonda su un intenso rapporto spirituale fondato<br />
sulla preghiera e sulla vita eucaristica.<br />
L‘amicizia nell'esperienza della vita spirituale e in particolare della<br />
vita consacrata ha conosciuto <strong>di</strong>verse stagioni. Con il Frassinetti essa viene<br />
rimessa in luce in forza <strong>di</strong> considerazioni teologiche: Cristo visibilizza<br />
un‘amicizia <strong>di</strong>vina: ―Non vi chiamo piú servi ma amici, perché vi ho<br />
rivelato tutto ciò che il Padre mi ha fatto conoscere‖ (Gv 15,15),<br />
1. L`AMICIZIA IN GIUSEPPE FRASSINETTI ATTRAVERSO<br />
TRE ESPERIENZE FONDANTI<br />
1.1. L'Ambiente domestico<br />
I documenti raccolti in occasione del processo <strong>di</strong> canonizzazione<br />
<strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti testimoniano che il rapporto con la sorella Paola e i<br />
fratelli, Francesco, Giovanni e Raffaele, anch'essi sacerdoti, fu improntato<br />
ad un senso <strong>di</strong> profonda amicizia, fondato sul medesimo amore verginale a<br />
Cristo e sul medesimo slancio apostolico per la salvezza degli uomini.<br />
Giovanni e Raffaele furono <strong>di</strong> grande aiuto a don Giuseppe durante il suo<br />
esilio a S. Cipriano, facendosi carico in prima persona della cura pastorale<br />
<strong>di</strong> S. Sabina, che il Priore dovette abbandonare suo malgrado. Con Paola,<br />
in particolare, il Priore con<strong>di</strong>vise il travaglio della sua vocazione, stilando<br />
per lei e le prime compagne (le <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Fede), una regola <strong>di</strong> vita<br />
consacrata.<br />
1.2 L'ambiente sacerdotale<br />
Le prime e piú importanti amicizie sacerdotali del Frassinetti si<br />
possono senz‘altro ricondurre all‘ambiente della Congregazione del beato<br />
Leonardo da Porto Maurizio. L'opera, che ebbe vita dal 1831 al 1848,<br />
venne fondata dal Priore e dall'amico Luigi Sturla con l‘intento <strong>di</strong> rinnovare<br />
la spiritualità del giovane clero, elevarne la cultura religiosa, ripristinando<br />
nel contempo la <strong>di</strong>sciplina ecclesiastica oramai decaduta. Si proponeva<br />
sostanzialmente due finalità: la reciproca santificazione e la <strong>di</strong>fesa della<br />
Chiesa e della Fede cattolica, minacciate dalla cultura laica e anticlericale da<br />
un lato e dal protestantesimo dall‘altra. L‘orientamento della<br />
Congregazione era pertanto filo-romano, antigiansenista (vicino alla<br />
dottrina alfonsiana) e filogesuitico. Nacque inizialmente con l‘intento <strong>di</strong><br />
congregare i giovani ecclesiastici collaboratori delle Pie Opere <strong>di</strong> San<br />
Raffaele e <strong>Santa</strong> Dorotea, in un secondo momento la sua proposta fu<br />
allargata anche al clero <strong>di</strong>ocesano. Nel 1834 viene istituita un‘Accademia <strong>di</strong><br />
Stu<strong>di</strong> Ecclesiastici, il cui regolamento fu scritto dallo stesso Frassinetti.<br />
260
Dal punto <strong>di</strong> vista della <strong>di</strong>sciplina spirituale all‘interno del gruppo<br />
si praticava il metodo <strong>di</strong> vita e la correzione fraterna, due elementi che<br />
costituiranno in seguito l'asse portante delle Amicizie spirituali.<br />
Sappiamo che Luigi Sturla, Giovan Battista Cattaneo e Giuseppe<br />
Frassinetti formarono una «consulta segreta», con l‘intento <strong>di</strong> vivere una<br />
spiritualità piú intensa e impegnata attraverso un metodo <strong>di</strong> vita speciale.<br />
Oltre alle amicizie sacerdotali nate all‘interno della Congregazione<br />
del Beato Leonardo, ricor<strong>di</strong>amo, tra le tante, quelle con don Giovanni<br />
Bosco, don Luca dei conti Passi, padre Antonio Ballerini S.J., don<br />
Domenico Pestarino e don Giacinto Bianchi (quest‘ultimo visse a lungo<br />
nella canonica del Frassinetti accogliendolo morente tra le sue braccia).<br />
1.3 L’ambiente apostolico<br />
L'ambiente apostolico piú significativo, in cui Frassinetti conobbe<br />
le <strong>di</strong>namiche spirituali e pedagogiche dell‘amicizia, fu senz'altro quello delle<br />
Opere <strong>di</strong> San Raffaele e <strong>Santa</strong> Dorotea. Ricor<strong>di</strong>amo che nel 1829 il<br />
bergamasco don Luca dei conti Passi fu a Genova e fece conoscere le due<br />
opere, fondate con il fratello don Marco, alle parrocchie citta<strong>di</strong>ne. Suo<br />
prezioso continuatore fu don Luigi Sturla. Le Opere avevano come finalità<br />
primaria l'istruzione catechistica dei fanciulli e delle fanciulle del popolo. Il<br />
metodo educativo si basava sull'amicizia e sulla correzione fraterna, finalità<br />
poi assunte in pieno dall‘Istituto <strong>di</strong> Paola, che mutò il nome in quello <strong>di</strong><br />
Suore <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Dorotea.<br />
2. IL 1848: L'INCONTRO CON LA SPIRITUALITA'<br />
CARMELITANA E I PRIMI GRUPPI AMICALI<br />
2.1 L’incontro con la spiritualità carmelitana<br />
Nel 1848 Frassinetti conobbe l‘esperienza dell‘esilio, come altri<br />
esponenti della Congregazione del Beato Leonardo, venendo accusato <strong>di</strong><br />
filogesuitismo da parte dei sostenitori degli ideali liberali e rivoluzionari. A<br />
San Cipriano, ospite dell‘amico Campanella, in una situazione <strong>di</strong> riposo<br />
forzato, poté de<strong>di</strong>carsi alla lettura dei mistici carmelitani. Da santa Teresa,<br />
<strong>di</strong> cui lesse la Vita e il Cammino <strong>di</strong> Perfezione, apprese in particolare la<br />
dottrina sulla preghiera e sulle amicizie spirituali.<br />
261
Della Vita, scritta dalla <strong>Santa</strong> intorno al 1565, per volere dei padri<br />
Domenico Bañez e Garzia de Toledo, Frassinetti cita in particolare il<br />
capitolo XVI, che tratta del cammino dell‘orazione e dei gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> perfezione<br />
nella vita mistica, dall‘esperienza del vuoto interiore fino alla morte della<br />
volontà e all‘abbandono pieno in Dio. Frassinetti pone attenzione sul terzo<br />
grado dell‘orazione, quello dell'unione. A questo proposito, parlando<br />
dell‘amicizia che unisce le persone spirituali (non piú <strong>di</strong> cinque), Teresa<br />
spiega quali finalità si propone questo vincolo amicale: il <strong>di</strong>singannarsi a<br />
vicenda, il correggersi dei <strong>di</strong>fetti e l'incitarsi a servire meglio il Signore con<br />
carità e desiderio <strong>di</strong> vicendevole profitto.<br />
Osserviamo che, nell‘esperienza personale della <strong>Santa</strong>, le persone<br />
scelte per queste sante amicizie non furono esclusivamente delle donne o<br />
delle religiose ma troviamo anche dei sacerdoti, come il suo confessore<br />
Garcia de Toledo e il domenicano Pedro Ibañez, Francisco da Salcedo e<br />
Giuliano d‘Avila parenti della <strong>Santa</strong>.<br />
Del Cammino <strong>di</strong> Perfezione Frassinetti cita in particolare i capitoli<br />
VII e XXXII. Lo scritto fu or<strong>di</strong>nato alla <strong>Santa</strong> da Domenico Bañez per<br />
l‘insistenza delle monache che desideravano avere qualche insegnamento<br />
pratico sull‘orazione. Si tratta in sostanza <strong>di</strong> un commento al Pater Noster.<br />
Teresa, prima <strong>di</strong> affrontare le singole petizioni, si sofferma su tre realtà che<br />
stanno alla base dell‘orazione e recano una profonda pace interiore: l‘amore<br />
vicendevole, il <strong>di</strong>stacco dalle creature e l‘umiltà. L‘amore fraterno che<br />
dobbiamo portarci vicendevolmente deve essere puro e spirituale, un<br />
amore dove non si cerca il ricambio ma solo il progresso dell‘altro. Questo<br />
amore rende buono l'altro, è un amore che compatisce ma che sa anche<br />
correggere in vista <strong>di</strong> una maggiore perfezione.<br />
Il <strong>di</strong>stacco dalle creature è pure una con<strong>di</strong>zione essenziale perché<br />
la preghiera sia pura e gra<strong>di</strong>ta a Dio. Il <strong>di</strong>stacco deve essere interno ed<br />
esterno, in sostanza esso coincide con il rinnegamento <strong>di</strong> se stessi.<br />
Infine è necessaria l‘umiltà, che significa lasciarsi guidare dallo<br />
Spirito Santo nel cammino della croce. Solo nell‘esperienza della croce<br />
infatti si autentica il desiderio della santità. Teresa in sostanza pone alla<br />
base dell‘orazione le due virtú dell‘amore e dell‘umiltà. e riba<strong>di</strong>sce che<br />
l'amore vicendevole costituisce un aiuto per compiere il passaggio da<br />
persone terrene a persone spirituali. L‘amore <strong>di</strong> amicizia è considerata<br />
pertanto non un aggiunta superflua al cammino <strong>di</strong> perfezione ma un punto<br />
<strong>di</strong> partenza in<strong>di</strong>spensabile.<br />
262
Oltre a Teresa, Frassinetti lesse anche la Notte oscura <strong>di</strong> San<br />
Giovanni della Croce. Nel primo capitolo, che il Priore cita spesso nei suoi<br />
scritti, si parla appunto dell‘amicizia. Si considera l‘affetto veramente<br />
spirituale, affermando che crescendo questo cresce anche l‘amore a Dio e<br />
viceversa. Del mistico carmelitano Frassinetti riprende anche la<br />
considerazione che l'amore cresce in forza della somiglianza che produce<br />
tra le persone che si scelgono reciprocamente.<br />
Insieme a Teresa d‘Avila e a San Giovanni della Croce, Frassinetti<br />
lesse con interesse anche <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> Maddalena de‘ Pazzi, il cui ardore<br />
apostolico infatti proporrà in seguito alle <strong>Figli</strong>e della Pia Unione.<br />
2.2. I primi gruppi amicali<br />
È interessante notare che proprio nell‘anno in cui Frassinetti<br />
approfondì lo stu<strong>di</strong>o dei mistici carmelitani (1848), si formò anche il primo<br />
gruppo amicale, <strong>di</strong> cui vi è traccia nelle lettere del Priore a suor Carlotta<br />
Gibelli (cfr. Lettere VII-IX in OA, vol. II). Si possono così ricostruire i<br />
nomi del primo gruppo amicale: Giuseppe Frassinetti, il sacerdote Giovan<br />
Battista Cattaneo, che fu poi rettore del Seminario <strong>di</strong> Genova, suor<br />
Carlotta Gibelli della Congregazione del Cenacolo e la sua vicaria, Rosa<br />
Cordone, futura <strong>Figli</strong>a <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> e all'epoca ancora<br />
giovanissima.<br />
Nonostante negli scritti programmatici sull‘argomento (si veda Le<br />
Amicizie spirituali del 1853) Frassinetti suggerisca <strong>di</strong> formare piccoli gruppi,<br />
non piú <strong>di</strong> cinque persone, ed omogenei, in realtà questo primo sodalizio si<br />
presenta <strong>di</strong>fferenziato quanto a sesso, stato <strong>di</strong> vita ed età: troviamo infatti<br />
uomini e donne, sacerdoti, religiose e laici persone mature e giovani.<br />
3. GLI SCRITTI<br />
Sono numerosi gli scritti che <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente<br />
trattano il tema dell'amicizia, a testimonianza del peso che questa<br />
<strong>di</strong>mensione ebbe nella vita e nel pensiero del Frassinetti. Nonostante il<br />
Priore possa considerarsi tra i maggiori <strong>di</strong>ffusori della dottrina teresiana nel<br />
suo tempo, questi scritti <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>versa, pastorale, dottrinale,<br />
devozionale, ascetica, parenetica, storico-biografica, giuri<strong>di</strong>ca, sono sempre<br />
in bilico tra una dottrina tra<strong>di</strong>zionale, su cui pesano i sospetti per le<br />
«amicizie particolari», e la spiritualità teresiana, fondata su una visione<br />
teo-antropologica dell'amicizia decisamente positiva.<br />
263
Gli scritti abbracciano un arco cronologico molto ampio, dal 1837<br />
al 1864. In or<strong>di</strong>ne cronologico citiamo: Riflessioni proposte agli ecclesiastici del<br />
1837, in cui si affronta per la prima volta il tema dell'unione sacerdotale,<br />
poi ripreso in Brevi parole ai sacerdoti fratelli; La gemma delle fanciulle cristiane del<br />
1841, in cui si accenna al rapporto tra amicizia e verginità; La forza <strong>di</strong> un<br />
libretto, dello stesso anno, che drammatizza i contenuti del testo succitato;<br />
del 1848 sono le lettere a suor Carlotta Gibelli da cui ricaviamo notizie<br />
sulla formazione del primo gruppo amicale; Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> una <strong>Figli</strong>a che vuole<br />
essere tutta <strong>di</strong> Gesú del 1851, il cui il <strong>di</strong>scorso, in<strong>di</strong>rizzato alle adolescenti,<br />
mira a incoraggiare la pratiche delle sante amicizie, anche in vista <strong>di</strong> un<br />
maggior impegno apostolico; Ricor<strong>di</strong> per un giovinetto cristiano dello stesso<br />
anno, dove i medesimi contenuti sono presentati ad un pubblico maschile;<br />
Le amicizie spirituali, imitazione <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> Teresa del 1853, che può considerasi il<br />
testo programmatico; [Regola della] Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
<strong>Immacolata</strong> del 1856, in cui si accenna, nelle relazioni interne al gruppo, alla<br />
delicatezza e alla squisitezza del tratto umano e cristiano che bisogna<br />
riservare alle sorelle; La monaca in casa del 1859, che destina all‘argomento<br />
un intero capitolo, presentando l'amicizia quale fondamentale mezzo <strong>di</strong><br />
santificazione personale; Industrie spirituali del 1860, che in<strong>di</strong>rettamente<br />
accenna all'argomento a proposito dell'unione tra buoni; Memorie sulla vita<br />
della Pia zitella Rosa Cordone del 1859, cui fa seguito nell'anno successivo un<br />
altro racconto biografico, Il modello della povera fanciulla Rosina Pedemonte,<br />
opere nelle quali Frassinetti presenta, attraverso due modelli virtuosi,<br />
l‘amicizia spirituale tra un sacerdote e un‘anima consacrata; Regola della Pia<br />
Unione dei <strong>Figli</strong> <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> del 1861, in cui vengono riproposte al<br />
maschile le esortazioni già in<strong>di</strong>rizzate alla Pia Unione femminile; Proposta<br />
agli Ecclesiastici del 1861, in cui l‘amicizia è presentata come elemento<br />
pedagogico essenziale nella formazione spirituale dei sacerdoti; Il Religioso al<br />
secolo del 1864 che, come la Monaca in casa, costituisce un <strong>di</strong>rettorio per i<br />
consacrati al secolo; Propositi fatti per sé e per alcuni amici, uscito postumo nel<br />
1879, che rappresenta un ulteriore approfon<strong>di</strong>mento dei precedenti<br />
<strong>di</strong>scorsi rivolti ai sacerdoti; Dissertazione sulla comunione quoti<strong>di</strong>ana del 1865 e<br />
Convitto del <strong>di</strong>vino amore del 1868, che trattano il rapporto tra amicizia ed<br />
Eucaristia, presentando il rapporto tra Cristo e l'anima nei termini <strong>di</strong> una<br />
dolce unione.<br />
In sostanza l‘amicizia è presentata sia come mezzo ascetico, in vista<br />
<strong>di</strong> una crescita personale e comunitaria, sia come mezzo apostolico, per la<br />
promozione del Regno <strong>di</strong> Dio, sempre e comunque in relazione alla<br />
fondamentale vocazione alla santità. Quando Frassinetti si rivolge ai ragazzi<br />
264
la <strong>di</strong>mensione apostolica dell‘amicizia ha la priorità rispetto alla <strong>di</strong>mensione<br />
della santificazione. Quando invece si rivolge alla fanciulle l'or<strong>di</strong>ne è<br />
invertito, l‘amicizia è prima <strong>di</strong> tutto aiuto alla vicendevole santificazione e<br />
in secondo luogo mezzo per fare del bene al prossimo. Rivolgendosi agli<br />
ecclesiastici, il Priore sottolinea l‘importanza dell'amicizia per la formazione<br />
sacerdotale e l‘aiuto che essa può dare in vista dell‘impegno apostolico.<br />
4. LA DOTTRINA<br />
4.1. Fondamento biblico e cristologico<br />
Frassinetti costruisce il fondamento biblico cristologico<br />
dell‘amicizia seguendo il filone sapienziale e paolino.<br />
Prendendo le mosse da Sap 2, 17, afferma che Dio ama tutte le<br />
anime perché sono le sue creature. Cristo, rivelatore del Padre, versando il<br />
suo sangue <strong>di</strong>mostra quale grande valore abbia la creatura umana agli occhi<br />
<strong>di</strong> Dio. Da questa considerazione dell'amore infinito <strong>di</strong> Dio, Frassinetti fa<br />
scaturire come conseguenza la giustificazione piú autorevole dei legami<br />
d‘amore tra gli uomini, in quanto ogni uomo deve essere imitatore <strong>di</strong> Cristo<br />
(come <strong>di</strong>ce Paolo in 1 Cor 4,16: ―Fatevi miei imitatori, come io lo sono <strong>di</strong><br />
Cristo‖).<br />
Riguardo all‘amicizia poi afferma che, se tra le persone piú amanti<br />
<strong>di</strong> Dio ve ne fossero alcune con le quali fossimo uniti con vincolo <strong>di</strong><br />
particolare amicizia, col fine <strong>di</strong> amare meglio il Signore, a queste creature<br />
dovremmo portare anche «speciale amore», perché esse ―aiutandoci in<br />
maniera particolare a farci crescere nell'amore <strong>di</strong> Dio hanno particolare<br />
<strong>di</strong>ritto all'amore nostro‖.<br />
In Prov 8, 17 il Signore afferma <strong>di</strong> amare coloro che lo amano. Dio<br />
allora paga amore con amore. Conclude quin<strong>di</strong> Frassinetti che noi certo<br />
dobbiamo amare tutti, ma piú intensamente le anime piú amanti <strong>di</strong> Dio.<br />
Prendendo spunto da queste considerazioni, Halina Kocwin ne trae alcune<br />
importanti conseguenze:<br />
- le preferenze affettive nel Frassinetti non chiudono all’amore verso gli altri.<br />
L‘amicizia, che è un amore squisito, non esclude nessuno, anzi è un modo<br />
concreto <strong>di</strong> esprimere e rivelare l‘amore universale <strong>di</strong> Dio, che <strong>di</strong>venta<br />
amore <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>lezione personale. Siamo pertanto all'interno <strong>di</strong> una moderna<br />
teologia della rivelazione.<br />
265
- l’amore ha comunque la grande priorità nell’amicizia e ne dà ragione.<br />
L‘amicizia trova in Dio la sua sorgente e il suo traguardo. L‘amicizia umana<br />
imita l'amore <strong>di</strong> Dio per le sue creature ed è finalizzata ad amare piú<br />
intensamente Dio.<br />
- La specificità <strong>di</strong> questa amicizia sta non solo nell’intensità dell’amore ma<br />
nella motivazione che porta a stringerla: ossia la scelta <strong>di</strong> seguire Gesú Cristo e piacere a<br />
Lui solo. Si tratta <strong>di</strong> un amore che unisce le persone amiche anche in<br />
funzione <strong>di</strong> un fine nobile, reale e ben chiaro. È un amore governato dalla<br />
libertà, dalla carità e dalla verità. Infine è un amore che orienta all'operosità<br />
e alla proiezione verso gli altri.<br />
4.2. Finalità primaria: la santità personale e comunitaria<br />
La meta <strong>di</strong> queste sante amicizie è per Frassinetti ―crescere e far<br />
crescere nell'amore <strong>di</strong> Dio‖.<br />
Alle ragazze desiderose <strong>di</strong> conseguire la perfezione attraverso la<br />
pratica dei consigli evangelici, Frassinetti in<strong>di</strong>ca l‘amicizia e la verginità<br />
come i mezzi piú efficaci per raggiungere tale fine (cfr. La monaca in casa o<br />
La forza <strong>di</strong> un libretto).<br />
4.3. Natura: l’amore ad imitazione <strong>di</strong> Cristo<br />
La natura <strong>di</strong> queste amicizie è per il Priore «l‘esercizio della carità»,<br />
ossia l‘amore <strong>di</strong>sinteressato ad imitazione <strong>di</strong> Cristo.<br />
Afferma: ―È un amore che non ha né molto né poco <strong>di</strong> proprio<br />
interesse, tutto quel che desidera e vuole, è <strong>di</strong> vedere quell'anima ricca dei<br />
beni del cielo‖. Frassinetti si preoccupa <strong>di</strong> precisare che questo sentimento<br />
è <strong>di</strong>verso dalle «amicizie particolari», che nascono dalla semplice simpatia<br />
naturale e dall‘esteriorità: ―Nascono dal fango - afferma - e finiscono nel<br />
fango‖. Questo tipo <strong>di</strong> amicizia scaturisce invece dalla carità <strong>di</strong> Dio:<br />
―Proviene dal cielo e si rivolge al cielo‖. Come afferma S. Teresa, essa<br />
serve per <strong>di</strong>singannarsi e illuminarsi a vicenda, per una reciproca vigilanza<br />
al fine <strong>di</strong> avvisarsi dei <strong>di</strong>fetti e dei propri limiti e, soprattutto per incitarsi a<br />
piacere sempre <strong>di</strong> piú a Dio.<br />
4.4. Frutti dell’amicizia<br />
Dopo aver stabilito la natura <strong>di</strong> quest'amicizia, Frassinetti espone i<br />
beni e i frutti che essa produce.<br />
266
―Le anime <strong>di</strong>fettose - afferma - o ancora fredde nell‘amore <strong>di</strong> Dio<br />
per le preghiere e pei meriti delle anime piú perfette e piú fervorose con le<br />
quali sono unite, otterranno la grazia <strong>di</strong> liberarsi dai propri <strong>di</strong>fetti,<br />
d‘infervorarsi nel <strong>di</strong>vino amore, e finalmente <strong>di</strong> arrivare con esse al<br />
soggiorno dell‘eterna vita‖.<br />
I frutti sono piú gran<strong>di</strong> quanto piú l‘anima colla quale si stringe il<br />
patto è amica <strong>di</strong> Dio. Riprendendo S. Teresa, afferma che l'anima amante<br />
<strong>di</strong> Dio entra in tale confidenza e familiarità con Signore che arriva un<br />
momento in cui ―si comandano a vicenda‖. L‘anima adempie ciò che Dio<br />
comanda e Dio compie ciò che l‘anima desidera. ―Beate quelle anime che<br />
hanno tale amica!‖<br />
Perciò, sulla scia <strong>di</strong> S. Teresa, afferma che per arrivare a possiede<br />
Dio, è buon mezzo ―trattare e conferire coi suoi amici‖. Riporta la<br />
testimonianza della <strong>Santa</strong> che asseriva: ―Se io non mi trovo all‘inferno è per<br />
l‘aiuto <strong>di</strong> tali persone, le quali sempre procurai che mi raccomandassero al<br />
Signore‖.<br />
A conferma <strong>di</strong> ciò, il Priore cita anche S. Giovanni della Croce:<br />
―Quando l‘affezione è puramente spirituale crescendo essa, cresce anche<br />
quella <strong>di</strong> Dio [...] imperciocché ha questo lo spirito <strong>di</strong> Dio, che accresce il<br />
bene col bene, per la somiglianza e conformità che è fra loro‖.<br />
4.5. Modalità concrete per l'esercizio delle sante amicizie<br />
Frassinetti dà quin<strong>di</strong> alcune in<strong>di</strong>cazioni concrete su come<br />
costituire questi gruppi amicali.<br />
Il gruppo sia costituito con cinque persone, possibilmente dello<br />
stesso sesso. Le persone siano libere <strong>di</strong> poter <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> se stesse o<br />
abbiano il «consenso dei maggiori».<br />
La scelta deve essere fatta tra coloro con le quali vi è già un<br />
rapporto <strong>di</strong> confidenza e familiarità e desiderino ―servire bene il Signore e<br />
farsi sante‖.<br />
Non importa se le amiche mostrano <strong>di</strong> avere dei <strong>di</strong>fetti ―e anche<br />
molti <strong>di</strong>fetti, ne avete molti forse anche voi‖. Esorta perciò: ―Dovete<br />
quin<strong>di</strong> a vicenda compatirvi [...] vi deve bastare che abbiano il desiderio <strong>di</strong><br />
emendarsene e <strong>di</strong> crescere nell‘amore <strong>di</strong> Dio, senza il quale non si fa nulla‖.<br />
267
Nella Monaca in casa specifica poi quali siano i <strong>di</strong>fetti che si<br />
possono tollerare e quelli che invece non si possono tollerare, per cui è<br />
sconsigliabile stringere un vero patto <strong>di</strong> amicizia. Tra i <strong>di</strong>fetti che si<br />
possono accettare vi sono: quello <strong>di</strong> risentirsi per le correzioni,<br />
l‘impetuosità nell‘agire, l‘essere alle volte importune nel fare domande,<br />
attaccate alle proprie como<strong>di</strong>tà e materiali nelle devozioni. Tra i <strong>di</strong>fetti<br />
intollerabili: il gusto <strong>di</strong> raccontare le debolezze altrui, la vanità e il voler<br />
apparire, la capriciosità nel fare il bene, la finzione e doppiezza <strong>di</strong> cuore.<br />
L‘amicizia si costituisce intorno ad alcuni elementi fondamentali,<br />
senza i quali sarebbe un semplice sentimento che non vede un progresso: la<br />
preghiera reciproca, sostenuta dal sacrificio e dallo spirito <strong>di</strong> penitenza, gli<br />
incontri comunitari, destinati a far crescere la vita spirituale e fraterna e ad<br />
affinare l‘amicizia nel senso della purezza e della santità, il tripode costituito<br />
da metodo <strong>di</strong> vita, auto accusa e correzione fraterna.<br />
Afferma Frassinetti a proposito della preghiera nell‘ambito delle<br />
Amicizie spirituali: ―Da qui in avanti pregheremo il Signore a vicenda, perché<br />
ci <strong>di</strong>a questa grazia <strong>di</strong> dare intieramente a Lui il nostro cuore, e <strong>di</strong> non<br />
avere altro desiderio in terra, che quello della nostra santificazione‖. ―Per<br />
questa unione - scrive a suor Carlotta Gibelli - non si devono fare lunghe<br />
orazioni ma solo brevi affetti fervorosi nei quali specialmente si domanda<br />
per sé e per le anime compagne: l° la grazia della piú profonda umiltà; 2° la<br />
grazia <strong>di</strong> cangiare sempre in meglio tutti i giorni che ci dà la vita; 3° la<br />
grazia della perseveranza finale‖.<br />
Altro elemento costitutivo delle Amicizie sono gli incontri<br />
comunitari, da farsi nelle case, riscoperte come cenacoli <strong>di</strong> preghiera. Essi<br />
hanno lo scopo <strong>di</strong> favorire la comunicazione e la con<strong>di</strong>visione delle finalità<br />
e degli ideali che uniscono le amiche. Non si tratta <strong>di</strong> una comunicazione<br />
solo gradevole e occasionale o <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> idee personali o,<br />
peggio, <strong>di</strong> commenti sui fatti altrui; si tratta invece <strong>di</strong> pregare insieme e <strong>di</strong><br />
―ragionare delle cose <strong>di</strong> Dio‖. A tal fine può essere utile la lettura <strong>di</strong> libri<br />
devoti e il raccontarsi esempi e<strong>di</strong>ficanti col fine <strong>di</strong> infervorarsi a vicenda<br />
nell'esercizio delle virtú,<br />
Infine Frassinetti in<strong>di</strong>ca un cammino <strong>di</strong> vita spirituale fondato su<br />
un tripode costituito dal metodo <strong>di</strong> vita, dalla pratica dell'autoaccusa e della<br />
correzione fraterna.<br />
268
Il metodo <strong>di</strong> vita ha come centro l‘atto <strong>di</strong> offerta (espresso come<br />
una preghiera <strong>di</strong> abbandono). Esso comprende un impegno per una vita<br />
sacramentale intensa, regolata sempre dal <strong>di</strong>rettore spirituale, la pratica<br />
della preghiera mentale e vocale che accompagna costantemente la<br />
giornata, uno spirito <strong>di</strong> mortificazione, un affinamento della vita interiore<br />
attraverso buone letture spirituali, la preghiera reciproca per ottenere le tre<br />
grazie <strong>di</strong> cui si è già parlato.<br />
La pratica dell‘autoaccusa consiste nel sapersi esaminare ad alta<br />
voce. ―Infine darete conto dell'adempimento del metodo <strong>di</strong> vita,<br />
accusandovi delle mancanze che aveste commesso nel medesimo‖.<br />
La correzione fraterna è finalizzata al servizio caritatevole della<br />
verità: ―vicendevolmente e caritativamente vi avviserete dei vostri <strong>di</strong>fetti‖.<br />
Scrive Frassinetti nella Monaca in casa: ―La correzione è la piú grande carità<br />
verso Dio, cui non si può fare cosa piú gra<strong>di</strong>ta che adoperarsi a purificare<br />
le anime tanto amate. Sarà pure la piú grande carità verso le vostre amiche,<br />
alle quali è impossibile facciate un bene maggiore <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> adoprarvi per<br />
renderle piú pure e perciò piú gra<strong>di</strong>te agli occhi <strong>di</strong> Dio‖.<br />
Scrive a questo proposito Halina Kocwin: ―Si tratta <strong>di</strong> una grande<br />
saggezza pastorale ed educativa in quanto esige verità, carità e libertà [...]. Il<br />
Frassinetti insiste sulla libertà nella correzione amichevole <strong>di</strong>cendo che le<br />
amiche non dovrebbero vergognarsi o aver timore <strong>di</strong> compiere le cose<br />
giuste per il vero bene e per la crescita delle persone alle quali vogliono il<br />
vero bene. Alla libertà unisce la carità, che sa rispettare anche i limiti della<br />
persona umana, perciò anche la correzione dovrebbe essere fatta nel<br />
momento giusto, con delicatezza e caritatevolmente‖.<br />
4.6. Finalità apostolica ed ecclesiale<br />
L‘amicizia infine non va considerata solo in relazione al vantaggio<br />
personale o del piccolo gruppo, ma deve essere intesa come ricchezza per<br />
l'intera Chiesa. L‘amicizia infatti è volta a ―promuovere in sé e negli altri la<br />
gloria della <strong>di</strong>vina maestà‖.<br />
In appen<strong>di</strong>ce alla Monaca in casa pubblica Stimolo allo zelo per la salute<br />
delle anime, tratto da S. <strong>Maria</strong> Maddalena de‘ Pazzi, che costituisce quasi un<br />
<strong>di</strong>ttico con le Amicizie spirituali. Scrive: ―Poiché uno dei principali frutti<br />
delle amicizie spirituali dovrà essere l‘esercizio dello zelo per la salute delle<br />
anime, è bene aggiungere uno stimolo vivo e pungente che, a cosí <strong>di</strong>re. non<br />
lasci né quietare, né riposare mai le anime amanti <strong>di</strong> Dio, strette tra loro in<br />
269
santa spirituale amicizia, ma sempre le risvegli e le sproni e le spinga a far<br />
quanto possono pel bene <strong>di</strong> tutte le anime‖.<br />
Frassinetti allora invita ad un atteggiamento <strong>di</strong> apertura, ad uscire<br />
da se stessi, a prendere iniziative per andare incontro all‘altro per<br />
camminare insieme. Scopo ultimo dell‘amicizia, insieme all‘aiuto reciproco<br />
in vista della crescita spirituale e della santificazione personale, è dunque<br />
promuovere il bene dell‘altro e far crescere il Regno <strong>di</strong> Dio su questa terra.<br />
5. ASPETTI RELATIVI ALLA DIMENSIONE APOSTOLICA<br />
Se osserviamo la natura e le finalità delle numerose associazioni<br />
promosse o fondate dal priore Frassinetti, possiamo rilevare che in molte<br />
<strong>di</strong> esse vi è, quale anima nascosta, l‘amicizia. In particolare questo è<br />
evidente nella Pia Unione delle anime che desiderano farsi sante e<br />
nell‘associazione delle Madri cristiane, entrambe animate dalle <strong>Figli</strong>e della<br />
Pia Unione <strong>di</strong> S. <strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong> <strong>di</strong> Genova e <strong>di</strong> Mornese.<br />
L‘amicizia nel Frassinetti deve essere considerata a partire<br />
dall‘orizzonte pastorale in cui egli operò, ossia la parrocchia. Essa è infatti<br />
mezzo privilegiato per raggiungere una santità parrocchiale. In questo<br />
modo egli intese anche l‘apostolato della Pia Unione delle <strong>Figli</strong>e <strong>di</strong> <strong>Santa</strong><br />
<strong>Maria</strong> <strong>Immacolata</strong>, cosí come si rileva anche nel suo scritto La missione delle<br />
fanciulle cristiane del 1863.<br />
Questa prospettiva appare piú chiara se rapportata ad altre<br />
esperienze, come ad esempio quella delle Amicizie Cristiane, che - come<br />
abbiamo visto in precedenza- si costituirono nella forma <strong>di</strong> circoli privati, i<br />
cui componenti erano in genere dell‘alta società. Diversa fu anche la<br />
proposta <strong>di</strong> S. Teresa, che in sostanza consigliava la pratica dell‘amicizia<br />
spirituale nell‘ambito del monastero, col fine <strong>di</strong> cementare la vita fraterna<br />
tra le monache ed elevarne la spiritualità. Don Giovanni Bosco,<br />
contemporaneo del Frassinetti, propose invece l‘amicizia a partire da un<br />
altro orizzonte, quello dell‘oratorio, ambiente nel quale si attuavano i<br />
principi della pedagogia cristiana destinata ai giovani.<br />
6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE<br />
270
Accenniamo, in fase <strong>di</strong> conclusione, ad alcune riflessioni<br />
suscettibili <strong>di</strong> ulteriori approfon<strong>di</strong>menti:<br />
- La proposta delle sante amicizie in Giuseppe Frassinetti si<br />
inquadra in una visione <strong>di</strong> realismo spirituale, che poggia su una solida<br />
teologia cristocentrica, ed è improntata a <strong>di</strong>screzione ed equilibrio, capace<br />
<strong>di</strong> tenere insieme natura e grazia, <strong>di</strong>mensione ascetica e mistica, realtà<br />
personale e comunitaria, esigenza <strong>di</strong> interiorizzazione e slancio apostolico.<br />
- Il pensiero frassinettiano apporta un originale contributo <strong>di</strong><br />
ottimismo cristiano nel secolo dei sospetti, l‘Ottocento, e spinge in avanti<br />
la riflessione teologica e antropologica verso gli orizzonti del personalismo<br />
cristiano del XX secolo.<br />
- L‘amicizia spirituale congiunta alla <strong>di</strong>rezione spirituale<br />
costituiscono due mezzi essenziali per vivere la santità come esperienza<br />
ecclesiale. L‘amicizia rappresenta la <strong>di</strong>mensione comunitaria, la <strong>di</strong>rezione la<br />
<strong>di</strong>mensione progressiva (o guidata) della santità. Frassinetti sembra quasi<br />
anticipare la visione moderna della Chiesa come «corpo mistico».<br />
- L‘amicizia è vista nel respiro <strong>di</strong> una teologia della rivelazione, che<br />
poggia sul fondamento scritturistico e cristologico, si innesta nella<br />
riflessione patristica <strong>di</strong> Agostino e Tommaso, e viene alimentata dalla<br />
teologia affettiva <strong>di</strong> Francesco d‘Assisi e Teresa d‘Avila.<br />
- Questa tematica ha dei risvolti psicologici e antropologici che<br />
preludono al personalismo cristiano (cosí come verrà espresso da E.<br />
Mounier): l‘uomo esiste per l‘altro, per amare l‘altro, incontra se stesso<br />
pienamente nella relazione <strong>di</strong> amicizia che ha, come elementi <strong>di</strong>stintivi, la<br />
confidenza (che nasce nel terreno dell‘intimità), la reciproca conoscenza<br />
(attraverso l‘intimità si raggiunge l‘interiorità della persona, dove risiede la<br />
verità), la fedeltà (l‘amicizia, dono <strong>di</strong> Dio, è anche impegno personale per<br />
custo<strong>di</strong>rla).<br />
<strong>Maria</strong> Francesca Porcella<br />
271
INDICE<br />
Una prefazione necessaria pag 1<br />
Introduzione pag 3<br />
Influsso <strong>di</strong> sant‘Alfonso sul Frassinetti<br />
nella pastorale della confessione (Luciano Bosia) pag. 5<br />
Il Frassinetti e lo zelo catechistico (Antonio Rime<strong>di</strong>o) pag 36<br />
Il Priore Giuseppe Frassinetti e la spiritualità<br />
dell‘Ottocento genovese (Augusto De Angelis) pag 44<br />
Il Frassinetti e il problema delle vocazioni<br />
Ecclesiastiche (Sergio De Angelis) pag 68<br />
Voi pregherete cosí. Excursus sul Pater noster <strong>di</strong> <strong>Santa</strong><br />
Teresa <strong>di</strong> Gesú (Enrico Spano e Giovanni Passero) pag 106<br />
Tracce <strong>di</strong> Spiritualità pag 123<br />
La consacrazione dei laici (Hernan Villalobos) pag 125<br />
Giuseppe Frassinetti anima eucaristica (Marcello De Hann) pag 140<br />
La potenza della Parola nell‘azione pastorale <strong>di</strong><br />
Giuseppe Frassinetti (Roberto Amici) pag 149<br />
272
Giuseppe e Paola: fraternità e santità (Daniele Bruzzone) pag 157<br />
Il primato della santità nella pedagogia pastorale<br />
<strong>di</strong> Giuseppe Frassinetti (<strong>Maria</strong> Francesca Porcella) pag 169<br />
Desiderio <strong>di</strong> perfezione e metodo <strong>di</strong> vita interiore:<br />
per una pedagogia della santità secondo Giuseppe<br />
Frassinetti (Daniele Bruzone) pag 191<br />
La scelta dello stato <strong>di</strong> vita e l‘appello alla<br />
verginità (Roberto Amici) pag. 205<br />
Lo zelo per la santificazione e per la salvezza<br />
delle anime nella vita e nel pensiero <strong>di</strong> Giuseppe<br />
Frassinetti (Roberto Amici) pag 212<br />
Alcuni rilievi circa i voti del congresso speciale sulla<br />
eroicità delle virtú <strong>di</strong> G. Frassinetti (Roberto Amici) pag 221<br />
Che gran santo è San Giuseppe (Victor Rubio) pag 234<br />
Amiamo Gesú e amiamo <strong>Maria</strong> (Raimundas Jurolaitis) pag 245<br />
L‘amicizia spirituale in Giuseppe<br />
Frassinetti (<strong>Maria</strong> Francesca Porcella) pag 260<br />
273