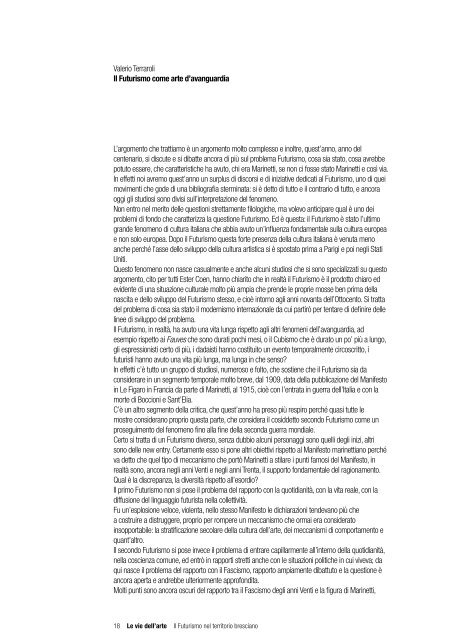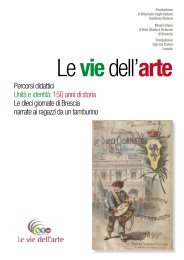Percorsi didattici Il Futurismo nel territorio bresciano ... - Vie dell'Arte
Percorsi didattici Il Futurismo nel territorio bresciano ... - Vie dell'Arte
Percorsi didattici Il Futurismo nel territorio bresciano ... - Vie dell'Arte
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Valerio Terraroli<br />
<strong>Il</strong> <strong>Futurismo</strong> come arte d’avanguardia<br />
L’argomento che trattiamo è un argomento molto complesso e inoltre, quest’anno, anno del<br />
centenario, si discute e si dibatte ancora di più sul problema <strong>Futurismo</strong>, cosa sia stato, cosa avrebbe<br />
potuto essere, che caratteristiche ha avuto, chi era Marinetti, se non ci fosse stato Marinetti e così via.<br />
In effetti noi avremo quest’anno un surplus di discorsi e di iniziative dedicati al <strong>Futurismo</strong>, uno di quei<br />
movimenti che gode di una bibliografia sterminata: si è detto di tutto e il contrario di tutto, e ancora<br />
oggi gli studiosi sono divisi sull’interpretazione del fenomeno.<br />
Non entro <strong>nel</strong> merito delle questioni strettamente filologiche, ma volevo anticipare qual è uno dei<br />
problemi di fondo che caratterizza la questione <strong>Futurismo</strong>. Ed è questa: il <strong>Futurismo</strong> è stato l’ultimo<br />
grande fenomeno di cultura italiana che abbia avuto un’influenza fondamentale sulla cultura europea<br />
e non solo europea. Dopo il <strong>Futurismo</strong> questa forte presenza della cultura italiana è venuta meno<br />
anche perché l’asse dello sviluppo della cultura artistica si è spostato prima a Parigi e poi negli Stati<br />
Uniti.<br />
Questo fenomeno non nasce casualmente e anche alcuni studiosi che si sono specializzati su questo<br />
argomento, cito per tutti Ester Coen, hanno chiarito che in realtà il <strong>Futurismo</strong> è il prodotto chiaro ed<br />
evidente di una situazione culturale molto più ampia che prende le proprie mosse ben prima della<br />
nascita e dello sviluppo del <strong>Futurismo</strong> stesso, e cioè intorno agli anni novanta dell’Ottocento. Si tratta<br />
del problema di cosa sia stato il modernismo internazionale da cui partirò per tentare di definire delle<br />
linee di sviluppo del problema.<br />
<strong>Il</strong> <strong>Futurismo</strong>, in realtà, ha avuto una vita lunga rispetto agli altri fenomeni dell’avanguardia, ad<br />
esempio rispetto ai Fauves che sono durati pochi mesi, o il Cubismo che è durato un po’ più a lungo,<br />
gli espressionisti certo di più, i dadaisti hanno costituito un evento temporalmente circoscritto, i<br />
futuristi hanno avuto una vita più lunga, ma lunga in che senso?<br />
In effetti c’è tutto un gruppo di studiosi, numeroso e folto, che sostiene che il <strong>Futurismo</strong> sia da<br />
considerare in un segmento temporale molto breve, dal 1909, data della pubblicazione del Manifesto<br />
in Le Figaro in Francia da parte di Marinetti, al 1915, cioè con l’entrata in guerra dell’Italia e con la<br />
morte di Boccioni e Sant’Elia.<br />
C’è un altro segmento della critica, che quest’anno ha preso più respiro perché quasi tutte le<br />
mostre considerano proprio questa parte, che considera il cosiddetto secondo <strong>Futurismo</strong> come un<br />
proseguimento del fenomeno fino alla fine della seconda guerra mondiale.<br />
Certo si tratta di un <strong>Futurismo</strong> diverso, senza dubbio alcuni personaggi sono quelli degli inizi, altri<br />
sono delle new entry. Certamente esso si pone altri obiettivi rispetto al Manifesto marinettiano perché<br />
va detto che quel tipo di meccanismo che portò Marinetti a stilare i punti famosi del Manifesto, in<br />
realtà sono, ancora negli anni Venti e negli anni Trenta, il supporto fondamentale del ragionamento.<br />
Qual è la discrepanza, la diversità rispetto all’esordio?<br />
<strong>Il</strong> primo <strong>Futurismo</strong> non si pose il problema del rapporto con la quotidianità, con la vita reale, con la<br />
diffusione del linguaggio futurista <strong>nel</strong>la collettività.<br />
Fu un’esplosione veloce, violenta, <strong>nel</strong>lo stesso Manifesto le dichiarazioni tendevano più che<br />
a costruire a distruggere, proprio per rompere un meccanismo che ormai era considerato<br />
insopportabile: la stratificazione secolare della cultura dell’arte, dei meccanismi di comportamento e<br />
quant’altro.<br />
<strong>Il</strong> secondo <strong>Futurismo</strong> si pose invece il problema di entrare capillarmente all’interno della quotidianità,<br />
<strong>nel</strong>la coscienza comune, ed entrò in rapporti stretti anche con le situazioni politiche in cui viveva; da<br />
qui nasce il problema del rapporto con il Fascismo, rapporto ampiamente dibattuto e la questione è<br />
ancora aperta e andrebbe ulteriormente approfondita.<br />
Molti punti sono ancora oscuri del rapporto tra il Fascismo degli anni Venti e la figura di Marinetti,<br />
<strong>Il</strong> <strong>Futurismo</strong> come arte d’avanguardia<br />
tra il Fascismo degli anni Trenta e la figura ad esempio di Fillia, di Tato, di Prampolini, di quei futuristi<br />
della seconda generazione che in realtà intesero piegare il linguaggio futurista a valori ideologici, a<br />
valori di messaggio legati alla fenomenologia politica.<br />
Quello che resta del <strong>Futurismo</strong> è in realtà un’eredità importante che ha influenzato fenomeni culturali<br />
ed artistici in tutta Europa e che in qualche modo riemerge per certi aspetti anche <strong>nel</strong>l’arte europea e<br />
non solo europea degli anni Cinquanta e Sessanta; questa è la motivazione per la quale chi visiterà la<br />
mostra a Milano troverà l’inizio dedicato agli scapigliati, cioè all’esordio del <strong>Futurismo</strong>, e alla fine Burri<br />
e Fontana.<br />
Perché ci sono Burri e Fontana? Perché in qualche modo (a parte che Burri ebbe consuetudine<br />
con i futuristi che ormai erano anziani, ad esempio con Balla) l’idea della polimatericità, della<br />
gestualità, l’idea della violenza <strong>nel</strong>l’operazione artistica, l’idea dello straniamento dello spettatore<br />
rispetto all’oggetto che guarda, è una eredità futurista. E allora in questo senso possiamo dire che il<br />
<strong>Futurismo</strong> ha una sua attualità oggi, al di là della sua attualità storica e culturale, proprio per queste<br />
valenze che vengono messe il evidenza, che passano il testimone al futuro.<br />
Dicevo poi che l’altra questione è dove nasca o come possa nascere il problema <strong>Futurismo</strong>;<br />
certamente diciamo che il punto di partenza è il discorso modernista e proprio per darvi un esempio<br />
di questo problema vi propongo un’immagine che è in realtà un fotomontaggio del 1931 di uno dei<br />
1200 futuristi italiani, perché in realtà i sei futuristi dell’inizio erano un manipolo ristretto, anzi all’inizio<br />
era solo Marinetti il futurista, ma con la pubblicazione del Manifesto <strong>nel</strong> 1909, poi quello della pittura<br />
del 1910 e quello della scultura del 1911, ci fu un proliferare in Italia di artisti che si dichiararono<br />
futuristi e che sottoscrissero i manifesti e tra questi anche vari fotografi. L’autore dell’immagine è un<br />
fotografo torinese, Gramaglia, che <strong>nel</strong> 1931 propone questo fotomontaggio interessante e spiritoso,<br />
che da l’idea di come lo spirito futurista venga vissuto negli anni Trenta.<br />
Quello che vedete è in realtà <strong>nel</strong>la parte centrale una cronofotografia, un fotogramma ripetuto<br />
che rappresenta un operaio in una fabbrica alla catena di montaggio mentre <strong>nel</strong>la parte inferiore<br />
compare palazzo Madama, che è quanto di più stratificato storicamente a Torino si possa vedere.<br />
Quindi questo operaio che si muove diventa una specie di missile che come una bomba attraversa<br />
palazzo Madama e lo rompe, lo frantuma. Quale immagine più significativa poteva esserci del nuovo<br />
che distrugge il vecchio? Quindi con una scelta non di continuità con il passato, ma di cesura con il<br />
passato.<br />
Questo è importante perché tante volte si tende, soprattutto quando si parla di arte contemporanea, a<br />
cercare di creare delle continuità con l’arte antica, ma uno dei caratteri dell’arte contemporanea, che<br />
è anche la sua ragion d’essere, sta <strong>nel</strong>la frattura definitiva del rapporto verso il passato. Questo non<br />
vuol dire che non ne tenga conto, perché certamente la cultura, le conoscenze, la stratificazione di<br />
generazioni è un portato che ognuno ha dentro di sé, ma non c’è una continuità in senso darwiniano,<br />
c’è una frattura di cui bisogna sempre tenere conto e credo che sia importante farlo capire anche<br />
alle giovani generazioni proprio perché il Novecento segna per tanti aspetti, non solo per l’arte, questa<br />
separazione rispetto ai secoli precedenti.<br />
Notate che il titolo del fotomontaggio non è <strong>Futurismo</strong> ma Modernismo; questo vuol dire che anche<br />
un artista futurista ritiene che la parola che può dare il senso reale di questa immagine non sia<br />
l’abusato termine <strong>Futurismo</strong> (siamo <strong>nel</strong> 1931 e quindi era già stato usato troppe volte), ma il termine<br />
modernità.<br />
La modernità è la capacità di leggere il contemporaneo, l’operaio che lavora, l’operaio della fabbrica<br />
che distrugge il passato e quindi tutto quello che è una stratificazione considerata obsoleta.<br />
Certo che questo tipo di operazione è un’operazione violenta che si giustifica con le parole di<br />
Marinetti del Manifesto del 1909.<br />
Ma come è nato quel movimento?<br />
Esso prendeva le mosse da un fenomeno artistico squisitamente italiano, ma con radici<br />
esplicitamente europee, che è il movimento del Divisionismo.<br />
In realtà anche il Divisionismo è un frutto di un albero molto più ampio, con radici profonde, con<br />
ramificazioni europee che è il grande albero del Simbolismo, della cultura simbolista che ha<br />
caratterizzato l’Europa e l’Italia <strong>nel</strong>l’ultimo ventennio del 1800 e di cui D’Annunzio era uno dei grandi<br />
alfieri.<br />
18 Le vie dell’arte <strong>Il</strong> <strong>Futurismo</strong> <strong>nel</strong> <strong>territorio</strong> <strong>bresciano</strong> 19 Le vie dell’arte <strong>Il</strong> <strong>Futurismo</strong> <strong>nel</strong> <strong>territorio</strong> <strong>bresciano</strong>