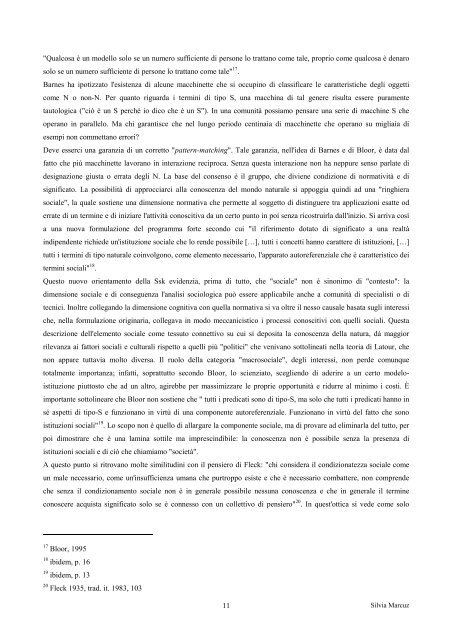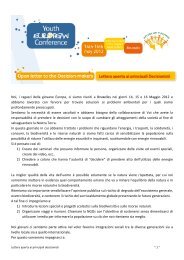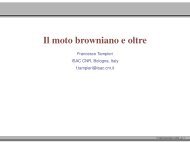Teorie di sociologia della scienza nel XX secolo Silvia Marcuz
Teorie di sociologia della scienza nel XX secolo Silvia Marcuz
Teorie di sociologia della scienza nel XX secolo Silvia Marcuz
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
"Qualcosa è un modello solo se un numero sufficiente <strong>di</strong> persone lo trattano come tale, proprio come qualcosa è denaro<br />
solo se un numero sufficiente <strong>di</strong> persone lo trattano come tale" 17 .<br />
Barnes ha ipotizzato l'esistenza <strong>di</strong> alcune macchinette che si occupino <strong>di</strong> classificare le caratteristiche degli oggetti<br />
come N o non-N. Per quanto riguarda i termini <strong>di</strong> tipo S, una macchina <strong>di</strong> tal genere risulta essere puramente<br />
tautologica ("ciò è un S perché io <strong>di</strong>co che è un S"). In una comunità possiamo pensare una serie <strong>di</strong> macchine S che<br />
operano in parallelo. Ma chi garantisce che <strong>nel</strong> lungo periodo centinaia <strong>di</strong> macchinette che operano su migliaia <strong>di</strong><br />
esempi non commettano errori?<br />
Deve esserci una garanzia <strong>di</strong> un corretto "pattern-matching". Tale garanzia, <strong>nel</strong>l'idea <strong>di</strong> Barnes e <strong>di</strong> Bloor, è data dal<br />
fatto che più macchinette lavorano in interazione reciproca. Senza questa interazione non ha neppure senso parlate <strong>di</strong><br />
designazione giusta o errata degli N. La base del consenso è il gruppo, che <strong>di</strong>viene con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> normatività e <strong>di</strong><br />
significato. La possibilità <strong>di</strong> approcciarci alla conoscenza del mondo naturale si appoggia quin<strong>di</strong> ad una "ringhiera<br />
sociale", la quale sostiene una <strong>di</strong>mensione normativa che permette al soggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere tra applicazioni esatte od<br />
errate <strong>di</strong> un termine e <strong>di</strong> iniziare l'attività conoscitiva da un certo punto in poi senza ricostruirla dall'inizio. Si arriva così<br />
a una nuova formulazione del programma forte secondo cui "il riferimento dotato <strong>di</strong> significato a una realtà<br />
in<strong>di</strong>pendente richiede un'istituzione sociale che lo rende possibile […], tutti i concetti hanno carattere <strong>di</strong> istituzioni, […]<br />
tutti i termini <strong>di</strong> tipo naturale coinvolgono, come elemento necessario, l'apparato autoreferenziale che è caratteristico dei<br />
termini sociali" 18 .<br />
Questo nuovo orientamento <strong>della</strong> Ssk evidenzia, prima <strong>di</strong> tutto, che "sociale" non è sinonimo <strong>di</strong> "contesto": la<br />
<strong>di</strong>mensione sociale e <strong>di</strong> conseguenza l'analisi sociologica può essere applicabile anche a comunità <strong>di</strong> specialisti o <strong>di</strong><br />
tecnici. Inoltre collegando la <strong>di</strong>mensione cognitiva con quella normativa si va oltre il nesso causale basata sugli interessi<br />
che, <strong>nel</strong>la formulazione originaria, collegava in modo meccanicistico i processi conoscitivi con quelli sociali. Questa<br />
descrizione dell'elemento sociale come tessuto connettivo su cui si deposita la conoscenza <strong>della</strong> natura, dà maggior<br />
rilevanza ai fattori sociali e culturali rispetto a quelli più "politici" che venivano sottolineati <strong>nel</strong>la teoria <strong>di</strong> Latour, che<br />
non appare tuttavia molto <strong>di</strong>versa. Il ruolo <strong>della</strong> categoria "macrosociale", degli interessi, non perde comunque<br />
totalmente importanza; infatti, soprattutto secondo Bloor, lo scienziato, scegliendo <strong>di</strong> aderire a un certo modeloistituzione<br />
piuttosto che ad un altro, agirebbe per massimizzare le proprie opportunità e ridurre al minimo i costi. È<br />
importante sottolineare che Bloor non sostiene che " tutti i pre<strong>di</strong>cati sono <strong>di</strong> tipo-S, ma solo che tutti i pre<strong>di</strong>cati hanno in<br />
sé aspetti <strong>di</strong> tipo-S e funzionano in virtù <strong>di</strong> una componente autoreferenziale. Funzionano in virtù del fatto che sono<br />
istituzioni sociali" 19 . Lo scopo non è quello <strong>di</strong> allargare la componente sociale, ma <strong>di</strong> provare ad eliminarla del tutto, per<br />
poi <strong>di</strong>mostrare che è una lamina sottile ma imprescin<strong>di</strong>bile: la conoscenza non è possibile senza la presenza <strong>di</strong><br />
istituzioni sociali e <strong>di</strong> ciò che chiamiamo "società".<br />
A questo punto si ritrovano molte similitu<strong>di</strong>ni con il pensiero <strong>di</strong> Fleck: "chi considera il con<strong>di</strong>zionatezza sociale come<br />
un male necessario, come un'insufficienza umana che purtroppo esiste e che è necessario combattere, non comprende<br />
che senza il con<strong>di</strong>zionamento sociale non è in generale possibile nessuna conoscenza e che in generale il termine<br />
conoscere acquista significato solo se è connesso con un collettivo <strong>di</strong> pensiero" 20 . In quest'ottica si vede come solo<br />
17<br />
Bloor, 1995<br />
18<br />
ibidem, p. 16<br />
19<br />
ibidem, p. 13<br />
20<br />
Fleck 1935, trad. it. 1983, 103<br />
11<br />
<strong>Silvia</strong> <strong>Marcuz</strong>