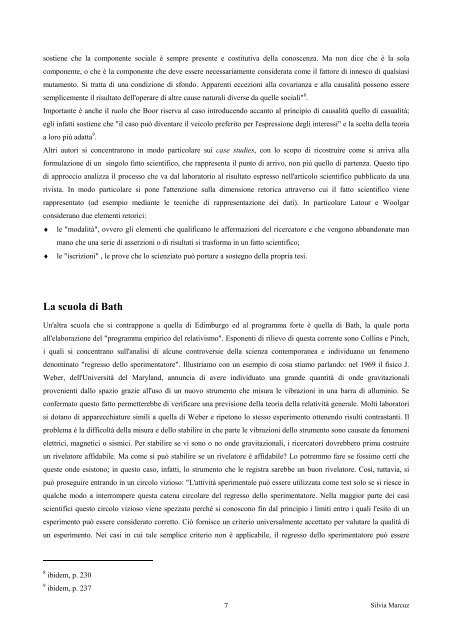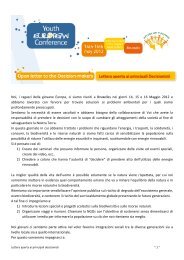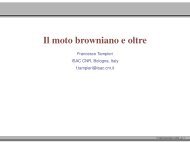Teorie di sociologia della scienza nel XX secolo Silvia Marcuz
Teorie di sociologia della scienza nel XX secolo Silvia Marcuz
Teorie di sociologia della scienza nel XX secolo Silvia Marcuz
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
sostiene che la componente sociale è sempre presente e costitutiva <strong>della</strong> conoscenza. Ma non <strong>di</strong>ce che è la sola<br />
componente, o che è la componente che deve essere necessariamente considerata come il fattore <strong>di</strong> innesco <strong>di</strong> qualsiasi<br />
mutamento. Si tratta <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> sfondo. Apparenti eccezioni alla covarianza e alla causalità possono essere<br />
semplicemente il risultato dell'operare <strong>di</strong> altre cause naturali <strong>di</strong>verse da quelle sociali" 8 .<br />
Importante è anche il ruolo che Boor riserva al caso introducendo accanto al principio <strong>di</strong> causalità quello <strong>di</strong> casualità;<br />
egli infatti sostiene che "il caso può <strong>di</strong>ventare il veicolo preferito per l'espressione degli interessi" e la scelta <strong>della</strong> teoria<br />
a loro più adatta 9 .<br />
Altri autori si concentrarono in modo particolare sui case stu<strong>di</strong>es, con lo scopo <strong>di</strong> ricostruire come si arriva alla<br />
formulazione <strong>di</strong> un singolo fatto scientifico, che rappresenta il punto <strong>di</strong> arrivo, non più quello <strong>di</strong> partenza. Questo tipo<br />
<strong>di</strong> approccio analizza il processo che va dal laboratorio al risultato espresso <strong>nel</strong>l'articolo scientifico pubblicato da una<br />
rivista. In modo particolare si pone l'attenzione sulla <strong>di</strong>mensione retorica attraverso cui il fatto scientifico viene<br />
rappresentato (ad esempio me<strong>di</strong>ante le tecniche <strong>di</strong> rappresentazione dei dati). In particolare Latour e Woolgar<br />
considerano due elementi retorici:<br />
♦ le "modalità", ovvero gli elementi che qualificano le affermazioni del ricercatore e che vengono abbandonate man<br />
mano che una serie <strong>di</strong> asserzioni o <strong>di</strong> risultati si trasforma in un fatto scientifico;<br />
♦ le "iscrizioni" , le prove che lo scienziato può portare a sostegno <strong>della</strong> propria tesi.<br />
La scuola <strong>di</strong> Bath<br />
Un'altra scuola che si contrappone a quella <strong>di</strong> E<strong>di</strong>mburgo ed al programma forte è quella <strong>di</strong> Bath, la quale porta<br />
all'elaborazione del "programma empirico del relativismo". Esponenti <strong>di</strong> rilievo <strong>di</strong> questa corrente sono Collins e Pinch,<br />
i quali si concentrano sull'analisi <strong>di</strong> alcune controversie <strong>della</strong> <strong>scienza</strong> contemporanea e in<strong>di</strong>viduano un fenomeno<br />
denominato "regresso dello sperimentatore". Illustriamo con un esempio <strong>di</strong> cosa stiamo parlando: <strong>nel</strong> 1969 il fisico J.<br />
Weber, dell'Università del Maryland, annuncia <strong>di</strong> avere in<strong>di</strong>viduato una grande quantità <strong>di</strong> onde gravitazionali<br />
provenienti dallo spazio grazie all'uso <strong>di</strong> un nuovo strumento che misura le vibrazioni in una barra <strong>di</strong> alluminio. Se<br />
confermato questo fatto permetterebbe <strong>di</strong> verificare una previsione <strong>della</strong> teoria <strong>della</strong> relatività generale. Molti laboratori<br />
si dotano <strong>di</strong> apparecchiature simili a quella <strong>di</strong> Weber e ripetono lo stesso esperimento ottenendo risulti contrastanti. Il<br />
problema è la <strong>di</strong>fficoltà <strong>della</strong> misura e dello stabilire in che parte le vibrazioni dello strumento sono causate da fenomeni<br />
elettrici, magnetici o sismici. Per stabilire se vi sono o no onde gravitazionali, i ricercatori dovrebbero prima costruire<br />
un rivelatore affidabile. Ma come si può stabilire se un rivelatore è affidabile? Lo potremmo fare se fossimo certi che<br />
queste onde esistono; in questo caso, infatti, lo strumento che le registra sarebbe un buon rivelatore. Così, tuttavia, si<br />
può proseguire entrando in un circolo vizioso: "L'attività sperimentale può essere utilizzata come test solo se si riesce in<br />
qualche modo a interrompere questa catena circolare del regresso dello sperimentatore. Nella maggior parte dei casi<br />
scientifici questo circolo vizioso viene spezzato perché si conoscono fin dal principio i limiti entro i quali l'esito <strong>di</strong> un<br />
esperimento può essere considerato corretto. Ciò fornisce un criterio universalmente accettato per valutare la qualità <strong>di</strong><br />
un esperimento. Nei casi in cui tale semplice criterio non è applicabile, il regresso dello sperimentatore può essere<br />
8<br />
ibidem, p. 230<br />
9<br />
ibidem, p. 237<br />
7<br />
<strong>Silvia</strong> <strong>Marcuz</strong>