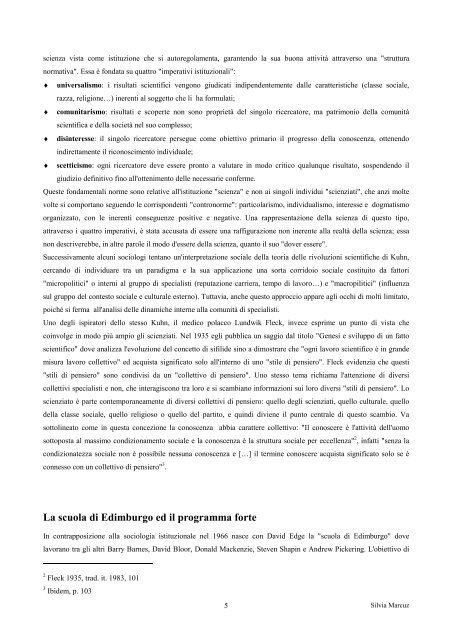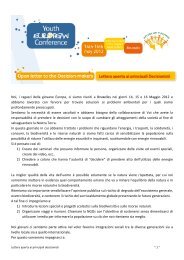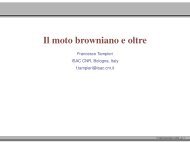Teorie di sociologia della scienza nel XX secolo Silvia Marcuz
Teorie di sociologia della scienza nel XX secolo Silvia Marcuz
Teorie di sociologia della scienza nel XX secolo Silvia Marcuz
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>scienza</strong> vista come istituzione che si autoregolamenta, garantendo la sua buona attività attraverso una "struttura<br />
normativa". Essa è fondata su quattro "imperativi istituzionali":<br />
♦ universalismo: i risultati scientifici vengono giu<strong>di</strong>cati in<strong>di</strong>pendentemente dalle caratteristiche (classe sociale,<br />
razza, religione…) inerenti al soggetto che li ha formulati;<br />
♦ comunitarismo: risultati e scoperte non sono proprietà del singolo ricercatore, ma patrimonio <strong>della</strong> comunità<br />
scientifica e <strong>della</strong> società <strong>nel</strong> suo complesso;<br />
♦ <strong>di</strong>sinteresse: il singolo ricercatore persegue come obiettivo primario il progresso <strong>della</strong> conoscenza, ottenendo<br />
in<strong>di</strong>rettamente il riconoscimento in<strong>di</strong>viduale;<br />
♦ scetticismo: ogni ricercatore deve essere pronto a valutare in modo critico qualunque risultato, sospendendo il<br />
giu<strong>di</strong>zio definitivo fino all'ottenimento delle necessarie conferme.<br />
Queste fondamentali norme sono relative all'istituzione "<strong>scienza</strong>" e non ai singoli in<strong>di</strong>vidui "scienziati", che anzi molte<br />
volte si comportano seguendo le corrispondenti "contronorme": particolarismo, in<strong>di</strong>vidualismo, interesse e dogmatismo<br />
organizzato, con le inerenti conseguenze positive e negative. Una rappresentazione <strong>della</strong> <strong>scienza</strong> <strong>di</strong> questo tipo,<br />
attraverso i quattro imperativi, è stata accusata <strong>di</strong> essere una raffigurazione non inerente alla realtà <strong>della</strong> <strong>scienza</strong>; essa<br />
non descriverebbe, in altre parole il modo d'essere <strong>della</strong> <strong>scienza</strong>, quanto il suo "dover essere".<br />
Successivamente alcuni sociologi tentano un'interpretazione sociale <strong>della</strong> teoria delle rivoluzioni scientifiche <strong>di</strong> Kuhn,<br />
cercando <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare tra un para<strong>di</strong>gma e la sua applicazione una sorta corridoio sociale costituito da fattori<br />
"micropolitici" o interni al gruppo <strong>di</strong> specialisti (reputazione carriera, tempo <strong>di</strong> lavoro…) e "macropilitici" (influenza<br />
sul gruppo del contesto sociale e culturale esterno). Tuttavia, anche questo approccio appare agli occhi <strong>di</strong> molti limitato,<br />
poiché si ferma all'analisi delle <strong>di</strong>namiche interne alla comunità <strong>di</strong> specialisti.<br />
Uno degli ispiratori dello stesso Kuhn, il me<strong>di</strong>co polacco Lundwik Fleck, invece esprime un punto <strong>di</strong> vista che<br />
coinvolge in modo più ampio gli scienziati. Nel 1935 egli pubblica un saggio dal titolo "Genesi e sviluppo <strong>di</strong> un fatto<br />
scientifico" dove analizza l'evoluzione del concetto <strong>di</strong> sifilide sino a <strong>di</strong>mostrare che "ogni lavoro scientifico è in grande<br />
misura lavoro collettivo" ed acquista significato solo all'interno <strong>di</strong> uno "stile <strong>di</strong> pensiero". Fleck evidenzia che questi<br />
"stili <strong>di</strong> pensiero" sono con<strong>di</strong>visi da un "collettivo <strong>di</strong> pensiero". Uno stesso tema richiama l'attenzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi<br />
collettivi specialisti e non, che interagiscono tra loro e si scambiano informazioni sui loro <strong>di</strong>versi "stili <strong>di</strong> pensiero". Lo<br />
scienziato è parte contemporaneamente <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi collettivi <strong>di</strong> pensiero: quello degli scienziati, quello culturale, quello<br />
<strong>della</strong> classe sociale, quello religioso o quello del partito, e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>viene il punto centrale <strong>di</strong> questo scambio. Va<br />
sottolineato come in questa concezione la conoscenza abbia carattere collettivo: "Il conoscere è l'attività dell'uomo<br />
sottoposta al massimo con<strong>di</strong>zionamento sociale e la conoscenza è la struttura sociale per eccellenza" 2 , infatti "senza la<br />
con<strong>di</strong>zionatezza sociale non è possibile nessuna conoscenza e […] il termine conoscere acquista significato solo se è<br />
connesso con un collettivo <strong>di</strong> pensiero" 3 .<br />
La scuola <strong>di</strong> E<strong>di</strong>mburgo ed il programma forte<br />
In contrapposizione alla <strong>sociologia</strong> istituzionale <strong>nel</strong> 1966 nasce con David Edge la "scuola <strong>di</strong> E<strong>di</strong>mburgo" dove<br />
lavorano tra gli altri Barry Barnes, David Bloor, Donald Mackenzie, Steven Shapin e Andrew Pickering. L'obiettivo <strong>di</strong><br />
2 Fleck 1935, trad. it. 1983, 101<br />
3 Ibidem, p. 103<br />
5<br />
<strong>Silvia</strong> <strong>Marcuz</strong>