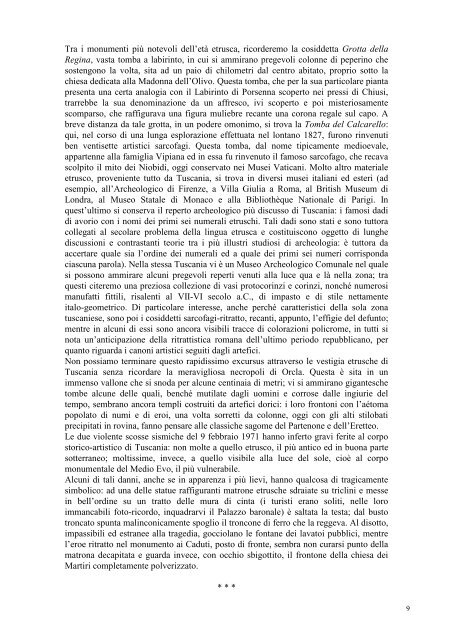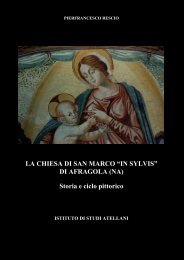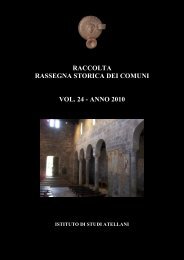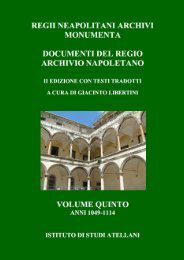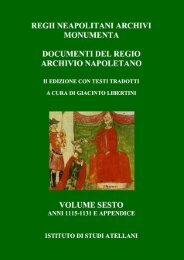raccolta rassegna storica dei comuni vol. 3 - Istituto studi atellani
raccolta rassegna storica dei comuni vol. 3 - Istituto studi atellani
raccolta rassegna storica dei comuni vol. 3 - Istituto studi atellani
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tra i monumenti più note<strong>vol</strong>i dell’età etrusca, ricorderemo la cosiddetta Grotta della<br />
Regina, vasta tomba a labirinto, in cui si ammirano prege<strong>vol</strong>i colonne di peperino che<br />
sostengono la <strong>vol</strong>ta, sita ad un paio di chilometri dal centro abitato, proprio sotto la<br />
chiesa dedicata alla Madonna dell’Olivo. Questa tomba, che per la sua particolare pianta<br />
presenta una certa analogia con il Labirinto di Porsenna scoperto nei pressi di Chiusi,<br />
trarrebbe la sua denominazione da un affresco, ivi scoperto e poi misteriosamente<br />
scomparso, che raffigurava una figura muliebre recante una corona regale sul capo. A<br />
breve distanza da tale grotta, in un podere omonimo, si trova la Tomba del Calcarello:<br />
qui, nel corso di una lunga esplorazione effettuata nel lontano 1827, furono rinvenuti<br />
ben ventisette artistici sarcofagi. Questa tomba, dal nome tipicamente medioevale,<br />
appartenne alla famiglia Vipiana ed in essa fu rinvenuto il famoso sarcofago, che recava<br />
scolpito il mito <strong>dei</strong> Niobidi, oggi conservato nei Musei Vaticani. Molto altro materiale<br />
etrusco, proveniente tutto da Tuscania, si trova in diversi musei italiani ed esteri (ad<br />
esempio, all’Archeologico di Firenze, a Villa Giulia a Roma, al British Museum di<br />
Londra, al Museo Statale di Monaco e alla Bibliothèque Nationale di Parigi. In<br />
quest’ultimo si conserva il reperto archeologico più discusso di Tuscania: i famosi dadi<br />
di avorio con i nomi <strong>dei</strong> primi sei numerali etruschi. Tali dadi sono stati e sono tuttora<br />
collegati al secolare problema della lingua etrusca e costituiscono oggetto di lunghe<br />
discussioni e contrastanti teorie tra i più illustri <strong>studi</strong>osi di archeologia: è tuttora da<br />
accertare quale sia l’ordine <strong>dei</strong> numerali ed a quale <strong>dei</strong> primi sei numeri corrisponda<br />
ciascuna parola). Nella stessa Tuscania vi è un Museo Archeologico Comunale nel quale<br />
si possono ammirare alcuni prege<strong>vol</strong>i reperti venuti alla luce qua e là nella zona; tra<br />
questi citeremo una preziosa collezione di vasi protocorinzi e corinzi, nonché numerosi<br />
manufatti fittili, risalenti al VII-VI secolo a.C., di impasto e di stile nettamente<br />
italo-geometrico. Di particolare interesse, anche perché caratteristici della sola zona<br />
tuscaniese, sono poi i cosiddetti sarcofagi-ritratto, recanti, appunto, l’effigie del defunto;<br />
mentre in alcuni di essi sono ancora visibili tracce di colorazioni policrome, in tutti si<br />
nota un’anticipazione della ritrattistica romana dell’ultimo periodo repubblicano, per<br />
quanto riguarda i canoni artistici seguiti dagli artefici.<br />
Non possiamo terminare questo rapidissimo excursus attraverso le vestigia etrusche di<br />
Tuscania senza ricordare la meravigliosa necropoli di Orcla. Questa è sita in un<br />
immenso vallone che si snoda per alcune centinaia di metri; vi si ammirano gigantesche<br />
tombe alcune delle quali, benché mutilate dagli uomini e corrose dalle ingiurie del<br />
tempo, sembrano ancora templi costruiti da artefici dorici: i loro frontoni con l’aétoma<br />
popolato di numi e di eroi, una <strong>vol</strong>ta sorretti da colonne, oggi con gli alti stilobati<br />
precipitati in rovina, fanno pensare alle classiche sagome del Partenone e dell’Eretteo.<br />
Le due violente scosse sismiche del 9 febbraio 1971 hanno inferto gravi ferite al corpo<br />
storico-artistico di Tuscania: non molte a quello etrusco, il più antico ed in buona parte<br />
sotterraneo; moltissime, invece, a quello visibile alla luce del sole, cioè al corpo<br />
monumentale del Medio Evo, il più vulnerabile.<br />
Alcuni di tali danni, anche se in apparenza i più lievi, hanno qualcosa di tragicamente<br />
simbolico: ad una delle statue raffiguranti matrone etrusche sdraiate su triclini e messe<br />
in bell’ordine su un tratto delle mura di cinta (i turisti erano soliti, nelle loro<br />
immancabili foto-ricordo, inquadrarvi il Palazzo baronale) è saltata la testa; dal busto<br />
troncato spunta malinconicamente spoglio il troncone di ferro che la reggeva. Al disotto,<br />
impassibili ed estranee alla tragedia, gocciolano le fontane <strong>dei</strong> lavatoi pubblici, mentre<br />
l’eroe ritratto nel monumento ai Caduti, posto di fronte, sembra non curarsi punto della<br />
matrona decapitata e guarda invece, con occhio sbigottito, il frontone della chiesa <strong>dei</strong><br />
Martiri completamente polverizzato.<br />
* * *<br />
9