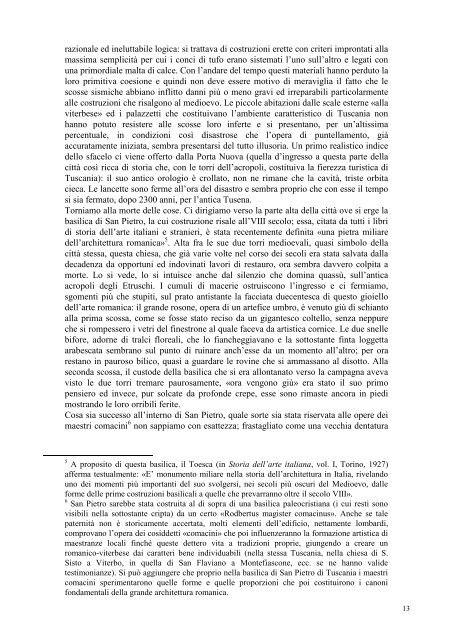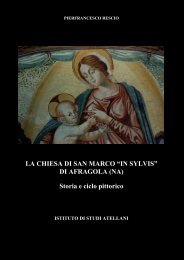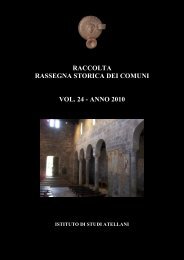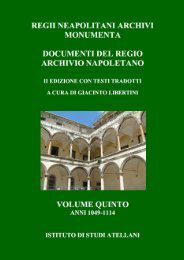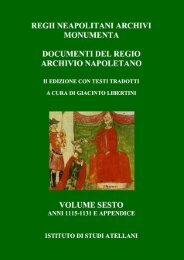raccolta rassegna storica dei comuni vol. 3 - Istituto studi atellani
raccolta rassegna storica dei comuni vol. 3 - Istituto studi atellani
raccolta rassegna storica dei comuni vol. 3 - Istituto studi atellani
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
azionale ed ineluttabile logica: si trattava di costruzioni erette con criteri improntati alla<br />
massima semplicità per cui i conci di tufo erano sistemati l’uno sull’altro e legati con<br />
una primordiale malta di calce. Con l’andare del tempo questi materiali hanno perduto la<br />
loro primitiva coesione e quindi non deve essere motivo di meraviglia il fatto che le<br />
scosse sismiche abbiano inflitto danni più o meno gravi ed irreparabili particolarmente<br />
alle costruzioni che risalgono al medioevo. Le piccole abitazioni dalle scale esterne «alla<br />
viterbese» ed i palazzetti che costituivano l’ambiente caratteristico di Tuscania non<br />
hanno potuto resistere alle scosse loro inferte e si presentano, per un’altissima<br />
percentuale, in condizioni così disastrose che l’opera di puntellamento, già<br />
accuratamente iniziata, sembra presentarsi del tutto illusoria. Un primo realistico indice<br />
dello sfacelo ci viene offerto dalla Porta Nuova (quella d’ingresso a questa parte della<br />
città così ricca di storia che, con le torri dell’acropoli, costituiva la fierezza turistica di<br />
Tuscania): il suo antico orologio è crollato, non ne rimane che la cavità, triste orbita<br />
cieca. Le lancette sono ferme all’ora del disastro e sembra proprio che con esse il tempo<br />
si sia fermato, dopo 2300 anni, per l’antica Tusena.<br />
Torniamo alla morte delle cose. Ci dirigiamo verso la parte alta della città ove si erge la<br />
basilica di San Pietro, la cui costruzione risale all’VIII secolo; essa, citata da tutti i libri<br />
di storia dell’arte italiani e stranieri, è stata recentemente definita «una pietra miliare<br />
dell’architettura romanica» 5 . Alta fra le sue due torri medioevali, quasi simbolo della<br />
città stessa, questa chiesa, che già varie <strong>vol</strong>te nel corso <strong>dei</strong> secoli era stata salvata dalla<br />
decadenza da opportuni ed indovinati lavori di restauro, ora sembra davvero colpita a<br />
morte. Lo si vede, lo si intuisce anche dal silenzio che domina quassù, sull’antica<br />
acropoli degli Etruschi. I cumuli di macerie ostruiscono l’ingresso e ci fermiamo,<br />
sgomenti più che stupiti, sul prato antistante la facciata duecentesca di questo gioiello<br />
dell’arte romanica: il grande rosone, opera di un artefice umbro, è venuto giù di schianto<br />
alla prima scossa, come se fosse stato reciso da un gigantesco coltello, senza neppure<br />
che si rompessero i vetri del finestrone al quale faceva da artistica cornice. Le due snelle<br />
bifore, adorne di tralci floreali, che lo fiancheggiavano e la sottostante finta loggetta<br />
arabescata sembrano sul punto di ruinare anch’esse da un momento all’altro; per ora<br />
restano in pauroso bilico, quasi a guardare le rovine che si ammassano al disotto. Alla<br />
seconda scossa, il custode della basilica che si era allontanato verso la campagna aveva<br />
visto le due torri tremare paurosamente, «ora vengono giù» era stato il suo primo<br />
pensiero ed invece, pur solcate da profonde crepe, esse sono rimaste ancora in piedi<br />
mostrando le loro orribili ferite.<br />
Cosa sia successo all’interno di San Pietro, quale sorte sia stata riservata alle opere <strong>dei</strong><br />
maestri comacini 6 non sappiamo con esattezza; frastagliato come una vecchia dentatura<br />
5 A proposito di questa basilica, il Toesca (in Storia dell’arte italiana, <strong>vol</strong>. I, Torino, 1927)<br />
afferma testualmente: «E’ monumento miliare nella storia dell’architettura in Italia, rivelando<br />
uno <strong>dei</strong> momenti più importanti del suo s<strong>vol</strong>gersi, nei secoli più oscuri del Medioevo, dalle<br />
forme delle prime costruzioni basilicali a quelle che prevarranno oltre il secolo VIII».<br />
6 San Pietro sarebbe stata costruita al di sopra di una basilica paleocristiana (i cui resti sono<br />
visibili nella sottostante cripta) da un certo «Rodbertus magister comacinus». Anche se tale<br />
paternità non è <strong>storica</strong>mente accertata, molti elementi dell’edificio, nettamente lombardi,<br />
comprovano l’opera <strong>dei</strong> cosiddetti «comacini» che poi influenzeranno la formazione artistica di<br />
maestranze locali finché queste dettero vita a tradizioni proprie, giungendo a creare un<br />
romanico-viterbese dai caratteri bene individuabili (nella stessa Tuscania, nella chiesa di S.<br />
Sisto a Viterbo, in quella di San Flaviano a Montefiascone, ecc. se ne hanno valide<br />
testimonianze). Si può aggiungere che proprio nella basilica di San Pietro di Tuscania i maestri<br />
comacini sperimentarono quelle forme e quelle proporzioni che poi costituirono i canoni<br />
fondamentali della grande architettura romanica.<br />
13