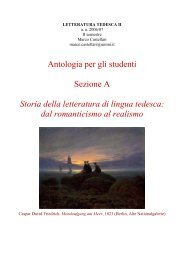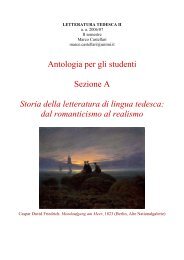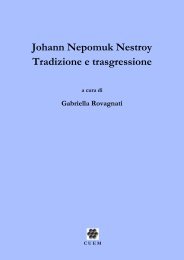Marco Castellari La presenza di Hölderlin nell'“Antigone” di Brecht
Marco Castellari La presenza di Hölderlin nell'“Antigone” di Brecht
Marco Castellari La presenza di Hölderlin nell'“Antigone” di Brecht
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
144 <strong>Marco</strong> <strong>Castellari</strong><br />
razione brechtiana. Dopo una ricognizione preliminare della <strong>presenza</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Hölderlin</strong> nell’intera opera <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong> sullo sfondo della ricezione complessiva<br />
del poeta svevo nel primo Novecento (1.), lo stu<strong>di</strong>o muoverà a<br />
una <strong>di</strong>samina puntuale del “problema-<strong>Hölderlin</strong>” nell’Antigone brechtiana<br />
attraverso la presentazione <strong>di</strong> fonti ancora ignote alla critica e la rilettura <strong>di</strong><br />
dati noti in chiave integralmente hölderliniana, giungendo fra l’altro a<br />
determinare per la prima volta con esattezza l’e<strong>di</strong>zione dalla quale <strong>Brecht</strong><br />
trasse la traduzione <strong>di</strong> <strong>Hölderlin</strong> (2.); infine, si accennerà alla possibilità <strong>di</strong><br />
utilizzare i risultati ottenuti per un riposizionamento funzionale della rielaborazione<br />
<strong>di</strong> <strong>Brecht</strong> nel contesto della vivace <strong>presenza</strong> <strong>di</strong> <strong>Hölderlin</strong> nel<br />
teatro novecentesco <strong>di</strong> lingua tedesca (3.).<br />
1. <strong>Hölderlin</strong> nell’opera <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong><br />
I dati che emergono con più forza dallo spoglio dell’opera <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong><br />
alla ricerca <strong>di</strong> una pur vaga <strong>presenza</strong> hölderliniana sono <strong>di</strong>scontinuità e<br />
contrad<strong>di</strong>ttorietà. Il primo 3 testo brechtiano a denunciare un rapporto intertestuale<br />
4 con l’opera <strong>di</strong> <strong>Hölderlin</strong> è Die Heilige Johanna der Schlachthöfe<br />
(1931): nel decimo quadro, infatti, il gioco paro<strong>di</strong>stico che domina l’intera<br />
pièce trova espressione in una descrizione epico-patetica della caduta dei<br />
prezzi, il cui destino è evocato rielaborando in regime lu<strong>di</strong>co celebri versi<br />
hölderliniani:<br />
Den Preisen nämlich<br />
War es gegeben, von Notierung zu Notierung zu fallen<br />
Wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen<br />
Tief ins Unendliche hinab. Bei 30 erst hielten sie. 5<br />
3 Ancora tutto da <strong>di</strong>mostrare è il rinvenimento <strong>di</strong> reminiscenze <strong>di</strong> Hälfte des Lebens<br />
nella poesia giovanile brechtiana Goldene Früchte hängen (1914, BW XIII: 75), ipotizzato in<br />
BERG/JESKE 1998: 91.<br />
4 Gérard Genette ha come noto in<strong>di</strong>cato con hypertextualité ogni relazione trasformativa<br />
(<strong>di</strong>retta e/o in<strong>di</strong>retta, vale a <strong>di</strong>re imitativa) che lega un dato testo (hypertexte) a un altro<br />
anteriore (hypotexte) secondo un regime lu<strong>di</strong>co, satirico o serio (GENETTE 1982: 11sgg.).<br />
A una definizione “stretta”, descrittiva del concetto (qui però: Intertextualität) si rifà anche<br />
Werner Frick, proprio nell’analisi dell’Antigone <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong> e <strong>di</strong> altre trasformazioni moderne<br />
della trage<strong>di</strong>a greca: alle sue preziose riflessioni metodologiche sulla vali<strong>di</strong>tà delle<br />
categorie genettiane per questo preciso settore <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> e alle sue con<strong>di</strong>visibili riserve rispetto<br />
all’applicabilità della concezione ontologica <strong>di</strong> intertestualità a testi della klassische<br />
Moderne riman<strong>di</strong>amo per un approfon<strong>di</strong>mento (FRICK 1998: 30sgg.). Sulla scia <strong>di</strong> Frick<br />
useremo dunque i termini “intertestuale” ovvero “intertestualità” per in<strong>di</strong>care la relazione<br />
trasformativa che intercorre fra “ipotesto” e “ipertesto”. In Genette hypertextualité e intertextualité<br />
sono due <strong>di</strong>fferenti tipi <strong>di</strong> relazione transtestuale: la semplificazione operata da<br />
Frick è ben motivata dal carattere particolare dei testi oggetto del suo, e del nostro, stu<strong>di</strong>o:<br />
in essi, infatti, citazione letterale, trasformazione <strong>di</strong>retta e imitazione si sovrappongono,<br />
come vedremo ampiamente, fino all’imperscrutabilità.<br />
5 BW III: 211sg. Si confronti l’ultima strofe <strong>di</strong> Hyperions Schiksaalslied, canto intonato