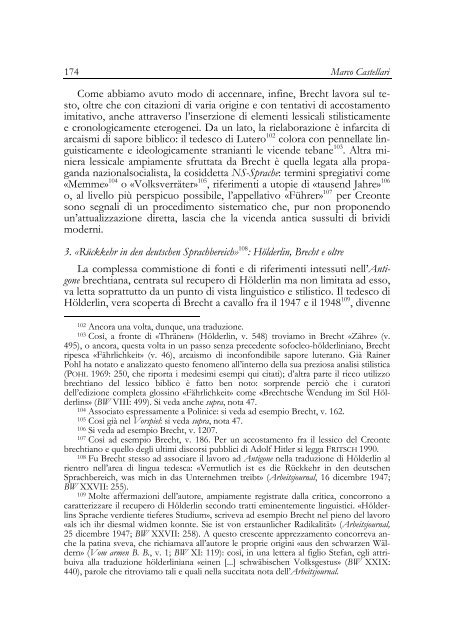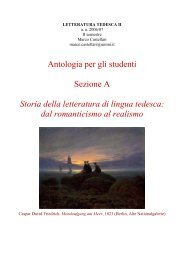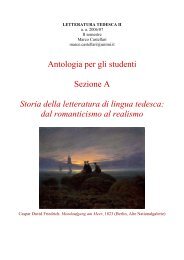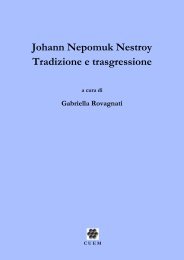Marco Castellari La presenza di Hölderlin nell'“Antigone” di Brecht
Marco Castellari La presenza di Hölderlin nell'“Antigone” di Brecht
Marco Castellari La presenza di Hölderlin nell'“Antigone” di Brecht
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
174 <strong>Marco</strong> <strong>Castellari</strong><br />
Come abbiamo avuto modo <strong>di</strong> accennare, infine, <strong>Brecht</strong> lavora sul testo,<br />
oltre che con citazioni <strong>di</strong> varia origine e con tentativi <strong>di</strong> accostamento<br />
imitativo, anche attraverso l’inserzione <strong>di</strong> elementi lessicali stilisticamente<br />
e cronologicamente eterogenei. Da un lato, la rielaborazione è infarcita <strong>di</strong><br />
arcaismi <strong>di</strong> sapore biblico: il tedesco <strong>di</strong> Lutero 102 colora con pennellate linguisticamente<br />
e ideologicamente stranianti le vicende tebane 103 . Altra miniera<br />
lessicale ampiamente sfruttata da <strong>Brecht</strong> è quella legata alla propaganda<br />
nazionalsocialista, la cosiddetta NS-Sprache: termini spregiativi come<br />
«Memme» 104 o «Volksverräter» 105 , riferimenti a utopie <strong>di</strong> «tausend Jahre» 106<br />
o, al livello più perspicuo possibile, l’appellativo «Führer» 107 per Creonte<br />
sono segnali <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento sistematico che, pur non proponendo<br />
un’attualizzazione <strong>di</strong>retta, lascia che la vicenda antica sussulti <strong>di</strong> brivi<strong>di</strong><br />
moderni.<br />
3. «Rückkehr in den deutschen Sprachbereich» 108 : <strong>Hölderlin</strong>, <strong>Brecht</strong> e oltre<br />
<strong>La</strong> complessa commistione <strong>di</strong> fonti e <strong>di</strong> riferimenti intessuti nell’Antigone<br />
brechtiana, centrata sul recupero <strong>di</strong> <strong>Hölderlin</strong> ma non limitata ad esso,<br />
va letta soprattutto da un punto <strong>di</strong> vista linguistico e stilistico. Il tedesco <strong>di</strong><br />
<strong>Hölderlin</strong>, vera scoperta <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong> a cavallo fra il 1947 e il 1948 109 , <strong>di</strong>venne<br />
102 Ancora una volta, dunque, una traduzione.<br />
103 Così, a fronte <strong>di</strong> «Thränen» (<strong>Hölderlin</strong>, v. 548) troviamo in <strong>Brecht</strong> «Zähre» (v.<br />
495), o ancora, questa volta in un passo senza precedente sofocleo-hölderliniano, <strong>Brecht</strong><br />
ripesca «Fährlichkeit» (v. 46), arcaismo <strong>di</strong> inconfon<strong>di</strong>bile sapore luterano. Già Rainer<br />
Pohl ha notato e analizzato questo fenomeno all’interno della sua preziosa analisi stilistica<br />
(POHL 1969: 250, che riporta i medesimi esempi qui citati); d’altra parte il ricco utilizzo<br />
brechtiano del lessico biblico è fatto ben noto: sorprende perciò che i curatori<br />
dell’e<strong>di</strong>zione completa glossino «Fährlichkeit» come «<strong>Brecht</strong>sche Wendung im Stil <strong>Hölderlin</strong>s»<br />
(BW VIII: 499). Si veda anche supra, nota 47.<br />
104 Associato espressamente a Polinice: si veda ad esempio <strong>Brecht</strong>, v. 162.<br />
105 Così già nel Vorspiel: si veda supra, nota 47.<br />
106 Si veda ad esempio <strong>Brecht</strong>, v. 1207.<br />
107 Così ad esempio <strong>Brecht</strong>, v. 186. Per un accostamento fra il lessico del Creonte<br />
brechtiano e quello degli ultimi <strong>di</strong>scorsi pubblici <strong>di</strong> Adolf Hitler si legga FRITSCH 1990.<br />
108 Fu <strong>Brecht</strong> stesso ad associare il lavoro ad Antigone nella traduzione <strong>di</strong> <strong>Hölderlin</strong> al<br />
rientro nell’area <strong>di</strong> lingua tedesca: «Vermutlich ist es <strong>di</strong>e Rückkehr in den deutschen<br />
Sprachbereich, was mich in das Unternehmen treibt» (Arbeitsjournal, 16 <strong>di</strong>cembre 1947;<br />
BW XXVII: 255).<br />
109 Molte affermazioni dell’autore, ampiamente registrate dalla critica, concorrono a<br />
caratterizzare il recupero <strong>di</strong> <strong>Hölderlin</strong> secondo tratti eminentemente linguistici. «<strong>Hölderlin</strong>s<br />
Sprache ver<strong>di</strong>ente tieferes Stu<strong>di</strong>um», scriveva ad esempio <strong>Brecht</strong> nel pieno del lavoro<br />
«als ich ihr <strong>di</strong>esmal widmen konnte. Sie ist von erstaunlicher Ra<strong>di</strong>kalität» (Arbeitsjournal,<br />
25 <strong>di</strong>cembre 1947; BW XXVII: 258). A questo crescente apprezzamento concorreva anche<br />
la patina sveva, che richiamava all’autore le proprie origini «aus den schwarzen Wäldern»<br />
(Vom armen B. B., v. 1; BW XI: 119): così, in una lettera al figlio Stefan, egli attribuiva<br />
alla traduzione hölderliniana «einen [...] schwäbischen Volksgestus» (BW XXIX:<br />
440), parole che ritroviamo tali e quali nella succitata nota dell’Arbeitsjournal.