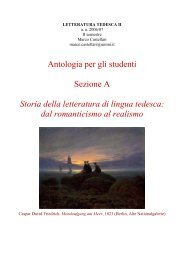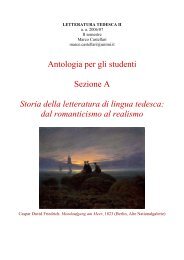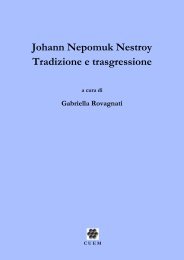Marco Castellari La presenza di Hölderlin nell'“Antigone” di Brecht
Marco Castellari La presenza di Hölderlin nell'“Antigone” di Brecht
Marco Castellari La presenza di Hölderlin nell'“Antigone” di Brecht
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
146 <strong>Marco</strong> <strong>Castellari</strong><br />
niana Der Tod des Empedokles su questo testo 10 , voci recenti hanno evidenziato<br />
tratti che avvicinano le due opere, pur senza giungere alla <strong>di</strong>mostrazione<br />
<strong>di</strong> un rapporto intertestuale in senso stretto 11 . <strong>La</strong> <strong>di</strong>ffusa convinzione<br />
che <strong>Brecht</strong> si sia basato unicamente sulla fonte antica 12 , tuttavia,<br />
pare non tenere conto <strong>di</strong> alcuni in<strong>di</strong>zi testuali degni <strong>di</strong> rivalutazione 13 , che<br />
permetterebbero <strong>di</strong> scoprire un’ine<strong>di</strong>ta e già feconda ricezione hölderliniana<br />
nel <strong>Brecht</strong> degli anni ’30. A rendere arduo l’accostamento fra i due<br />
autori, d’altra parte, concorrono come vedremo le successive affermazioni<br />
brechtiane in merito e, su un piano storico-culturale più ampio, la problematicità<br />
del rapporto <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong> con le vicende della riscoperta hölderliniana<br />
primo-novecentesca. Rimane il fatto che in Der Schuh des Empedokles,<br />
come nel complesso dell’opera brechtiana dei primi anni dell’esilio, si palesa<br />
una nuova modalità <strong>di</strong> recupero dei classici, in cui il mero sfruttamento,<br />
spesso <strong>di</strong>ssacratorio, del «Materialwert» lascia spazio a una procedura<br />
più complessa. Si tratta pur sempre <strong>di</strong> una lettura critica e in qualche<br />
modo “correttiva”, ma mai più <strong>di</strong>sgiunta da una preciso impegno politico-<br />
10 Così già Edgar Marsch nel suo fondamentale commento alla lirica brechtiana<br />
(MARSCH 1974: 278); più recentemente hanno espresso simili considerazioni i curatori<br />
dell’e<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> Berlino e Francoforte (BW XII: 366) come pure Frank Dietrich Wagner,<br />
che afferma senza alcuna esitazione: «Selbst in<strong>di</strong>rekte Anspielungen auf <strong>Hölderlin</strong>s Empedokles-Dichtungen<br />
fehlen» (WAGNER 2000: 595; la medesima posizione in sintesi in<br />
WAGNER 2001). Anche Marion <strong>La</strong>usberg, nel suo stu<strong>di</strong>o sulla <strong>presenza</strong> <strong>di</strong> figure e tematiche<br />
antiche nella lirica brechtiana, non attribuisce a <strong>Hölderlin</strong> alcun ruolo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione<br />
fra il poeta novecentesco e il filosofo siceliota; piuttosto, secondo la stu<strong>di</strong>osa, l’interesse<br />
per Empedocle potrebbe essere spiegato alla luce della nota, profonda conoscenza brechtiana<br />
<strong>di</strong> Lucrezio (LAUSBERG 1999: 167sgg.). Più possibilista la pur datata lettura <strong>di</strong><br />
Klaus Detlef Müller, che legge l’operazione <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong> come demistificazione della vicenda<br />
presentata nel dramma <strong>di</strong> <strong>Hölderlin</strong> (MÜLLER 1979: 218).<br />
11 Si veda in particolare l’acuto lavoro <strong>di</strong> Armin Schäfer, che ha il merito <strong>di</strong> muovere a<br />
un’analisi <strong>di</strong> Der Schuh des Empedokles sullo sfondo del rapporto brechtiano con la tra<strong>di</strong>zione<br />
e, per contrasto, dello sfruttamento nazionalsocialista dei classici, in particolare <strong>di</strong><br />
<strong>Hölderlin</strong>. Sulla <strong>presenza</strong> del Tod des Empedokles nella rilettura brechtiana della morte<br />
dell’Agrigentino, però, Schäfer non va oltre la cauta esplorazione <strong>di</strong> parallelismi tipologici<br />
e la postulazione <strong>di</strong> un vago recupero d’intenti (SCHÄFER 2001: 88).<br />
12 Diogene <strong>La</strong>erzio (Vite dei filosofi, VIII 51-58), che funse da principale riferimento<br />
anche per <strong>Hölderlin</strong>. <strong>Brecht</strong> lesse lo scrittore tardo-antico nell’e<strong>di</strong>zione tedesca a cura <strong>di</strong><br />
Otto Apelt, pubblicata a Lipsia nel 1921, che Frank Dietrich Wagner in<strong>di</strong>ca perentoriamente<br />
come «<strong>di</strong>e einzige Quelle» (WAGNER 2000: 595).<br />
13 Fin dal titolo, la poesia <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong> pare denunciare una trasformazione semantica<br />
(transmotivation, secondo la terminologia <strong>di</strong> GENETTE 1982: 379sgg.) del dramma hölderliniano:<br />
la sostituzione della «morte» con il «sandalo», infatti, è segnale paratestuale <strong>di</strong> un<br />
processo complessivo, poi approfon<strong>di</strong>to nel testo. <strong>Brecht</strong> sposta la focalizzazione dai<br />
tratti miracolosi e mistici della morte del filosofo al dato materiale e mondano del sandalo,<br />
prova quanto mai terrena del quanto mai terreno messaggio del suo Empedocle.<br />
Altri dati testuali e la ricostruzione della plausibilità <strong>di</strong> una conoscenza del dramma hölderliniano<br />
da parte <strong>di</strong> <strong>Brecht</strong>, ad esempio sulla base della fortuna teatrale <strong>di</strong> Der Tod des<br />
Empedokles a partire dagli anni ’20, potrebbero confermare questa ipotesi.