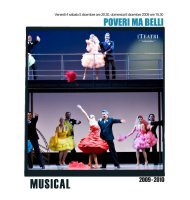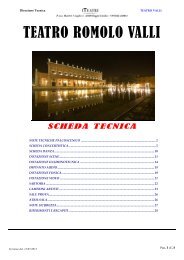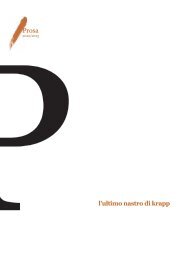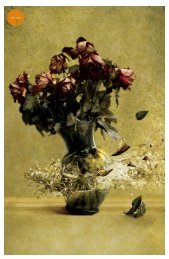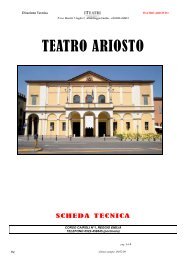Libretto - I Teatri
Libretto - I Teatri
Libretto - I Teatri
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Alidoro, in vesti da mendicante, a commentare insieme al coro la frenesia delle<br />
sorelle Tisbe e Clorinda e la persecuzione della protagonista: «nel cervello una<br />
fucina sta le pazze a martellar», dice Alidoro. E il coro, di rimando: «già nel capo<br />
una fucina sta le donne a martellar». “Buffa”, dunque, è La Cenerentola perché<br />
risponde a tutti gli stereotipi del genere, dal travestimento agli inganni, dalla lotta<br />
fra amore e ambizione alle cadute repentine da una condizione all’altra: povertà e<br />
ricchezza, felicità e infelicità. Ma “seria”, o almeno intrisa di elementi seri, perché<br />
inscena il vacillare della ragione di fronte a sentimenti elementari come la gelosia,<br />
l’invidia, l’ambizione, l’amore stesso. Stando alla testimonianza del librettista,<br />
Ferretti, Rossini aveva accolto con un’improvvisa accensione di interesse il titolo<br />
Cendrillon fra i molti che gli erano stati proposti, e che aveva ascoltato snocciolare<br />
dal poeta con un senso crescente di noia e rassegnazione. È possibile che fin dal<br />
principio egli abbia avuto già in mente quel che l’opera avrebbe potuto diventare.<br />
Più probabile, però, che egli intuisse come l’argomento di una favola così semplice<br />
– o meglio: semplice come semplici sono sempre gli archetipi – gli avrebbe lasciato<br />
la più ampia libertà nel trattamento dei personaggi e della materia musicale. Se fu<br />
così, l’intuizione si rivelò giusta: La Cenerentola stimolò la miglior vena creativa di<br />
Rossini e il suo gusto per la varietà delle soluzioni musicali, profuse in quest’opera<br />
con un’abbondanza che non ha eguali nelle sue altre composizioni di quel periodo.<br />
A confermare questa circostanza c’è anche la scarsità dei cosiddetti “autoimprestiti”,<br />
singoli numeri musicali già scritti in precedenza per un’altra opera e riutilizzati<br />
con disinvoltura in una nuova partitura. Rossini faceva abitualmente ampio ricorso<br />
a questo stratagemma, sia perché lo aiutava nei ritmi velocissimi di scrittura ai<br />
quali era forzato, sia perché da alcune opere non c’era da aspettarsi che circolassero<br />
molto e archiviarne in modo definitivo la musica avrebbe significato, agli<br />
occhi dell’autore, sacrificarla inutilmente. La Cenerentola, da questo punto di vista,<br />
abbonda di musica nuova, com posta più o meno nell’arco di un mese: sappiamo<br />
infatti che il titolo venne proposto da Ferretti a Rossini due giorni prima del<br />
Natale 1816 e che il 25 gennaio 1817 l’opera debuttò al Teatro Valle di Roma.<br />
Come sempre accadeva in casi come questi, quando i tempi erano così ridotti, il<br />
compositore scriveva a mano a mano che riceveva i nuovi versi dal poeta, così che<br />
parole e musica progredivano in parallelo, seguendo la sceneggiatura generale – il<br />
«program ma», si diceva allora – che Ferretti aveva preparato subito dopo la decisione<br />
di lavorare al soggetto. Per snellire il lavoro Rossini, come altre volte gli<br />
era accaduto, si era rivolto a un aiutante, un compositore di origine marchigiana<br />
attivo alla Chiesa Nuova di Roma, tale Luca Agolini, noto nell’ambiente come<br />
“Luchetto lo zoppo”. Il suo apporto non fu di poco peso anche se – come vedremo<br />
87