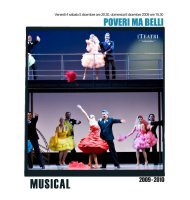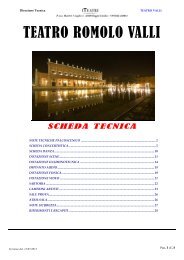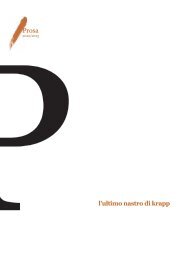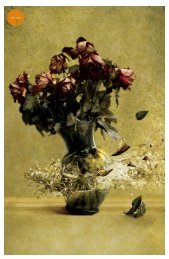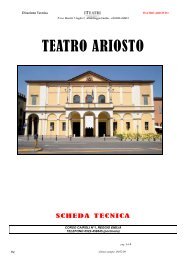Libretto - I Teatri
Libretto - I Teatri
Libretto - I Teatri
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
88<br />
– venne eliminato del tutto a partire dai successivi allestimenti dell’opera. Certo<br />
è che il sistema di velocizzazione più a portata di mano di Rossini, quello degli<br />
“autoimprestiti”, appunto, venne usato con una parsimonia sorprendente, anche se<br />
in posizioni di tutto rilievo. Due soltanto, infatti, sono i brani importati da altre<br />
opere, ma si tratta dell’Ouverture e del Finale, dunque dell’apertura e della conclusione<br />
dell’opera. L’Ouverture venne presa da La Gazzetta, opera che aveva debuttato<br />
qualche mese prima a Napoli (Tea tro dei Fiorentini, 26 settembre 1816), ma<br />
che d’altra parte era una sorta di compilazione di pagine prese da opere precedenti<br />
e che Rossini riteneva forse nociva per una pagina così equilibrata e ricca come la<br />
sinfonia introduttiva, ora spostata di peso all’inizio di La Cenerentola. Per il finale,<br />
invece, Rossini corse un rischio prendendo a prestito un passaggio altamente riconoscibile<br />
del Barbiere di Siviglia, opera che aveva debuttato sempre a Roma un<br />
anno prima e che, dopo il celebre e forse pilotato tonfo della “prima”, aveva raccolto<br />
un successo clamoroso. Si trattava dell’aria di Almaviva «Cessa più di resistere»,<br />
un brano particolarmente difficoltoso per una voce di tenore e che, concepito per<br />
il primo interprete del ruolo, Manuel Garcìa, sarebbe stata inevitabilmente tagliata<br />
o in presenza di cantanti meno dotati. Rossini pensò allora di passarla a una voce<br />
femminile e ne fece la base del Rondò «Non più mesta accanto al fuoco starò<br />
sola a gorgheggiar», ultimo intervento di Cenerentola al quale si aggiunge il coro<br />
per la chiusa dell’opera. Il rischio consisteva da un lato nel fatto che il pubblico<br />
di quei tempi non amava particolarmente simili riprese, dall’altro nella presenza,<br />
nel cast di La Cenerentola, di cantanti che avevano già partecipato all’allestimento<br />
del Barbiere, come Geltrude Righetti-Giorgi e Zenobio Vitarelli, rispettivamente<br />
Resina e Basilio un anno prima.<br />
Proprio l’azzardo e l’evidenza di questi autoimprestiti, oltretutto così con tenuti<br />
nel numero, da però conto del ruolo che Rossini aveva attribuito loro in questa<br />
occasione: non una scorciatoia per sveltire il lavoro o per ottenere il massimo<br />
dell’effetto con il minimo sforzo, ma una sorta di trasfigurazione del la scrittura<br />
che da un contesto determinato sale verso le vette di un’astrazione metafisica. È<br />
come se Rossini, detto altrimenti, si staccasse dalla storia che sta raccontando per<br />
applicarvi una formula di belcanto allo stato puro, quasi a rimarcare che il gioco<br />
e la tecnica belcantistica hanno sempre come appro do ideale una sopraelevazione<br />
rispetto ai casi del dramma e della commedia, dunque una uscita dai canoni narrativi<br />
il cui effetto risulta inevitabilmente straniante per una coscienza intimamente<br />
“narrativa” com’è quella moderna.<br />
Una musica che non sia narrazione, appunto, ma riflessione su se stessa, omaggio<br />
a se stessa; una musica che non metta in scena veri e propri perso naggi, con le