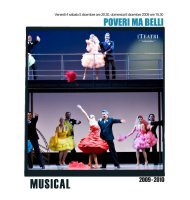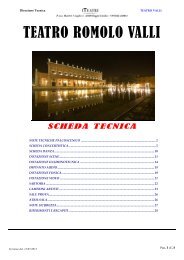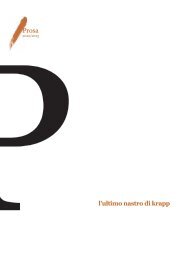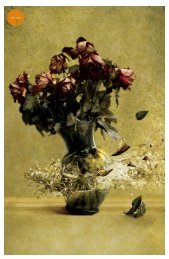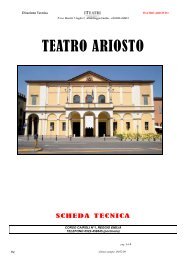Libretto - I Teatri
Libretto - I Teatri
Libretto - I Teatri
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
90<br />
dunque di ogni singolo personaggio. La formula è quella del tema con variazioni:<br />
Clorinda espone il tema con secchezza, Ramiro ne propone una prima variazione<br />
riccamente ornata, vale a dire aristocratica, quindi Cenerentola stessa ne esegue<br />
una variazione esuberante, con salti che spiccano verso l’alto, mentre Dandini segue<br />
un ritmo di terzine che già piegano verso uno stile più basso, tendente al buffo.<br />
Stili diversi che Rossini riunisce poi con un solo gesto, sintetico e geniale, nella<br />
cadenza conclusiva.<br />
Sulla base di quanto è stato detto, l’ambivalenza di La Cenerentola comin cia a<br />
chiarirsi. È un’opera buffa, ma al suo interno contiene passaggi vocali in stile serio<br />
che per un verso connotano i travestimenti e i percorsi dei suoi protagonisti, per<br />
un altro ne ibridano il linguaggio collocandolo al di là di ciò che in quell’epoca<br />
si attribuiva al comico tout court. È un’opera di masche re, non di personaggi, e di<br />
maschere che contengono ciascuna un doppio al proprio interno: Cenerentola è<br />
serva e principessa, Dandini servitore e princi pe, come Ramiro, mentre Alidoro<br />
è precettore e mendicante. Malgrado queste doppiezze, inoltre, ogni maschera è<br />
attentamente individualizzata, anche se per ottenere questo effetto Rossini deve<br />
lavorare proprio sul passaggio da un polo all’altro di ciascun carattere, adeguando<br />
lo stile vocale ai travestimenti e ai ruoli ricoperti volta per volta. Infine è un’opera<br />
nella quale l’individuazione non passa per le arie solistiche, ma per i pezzi d’insieme.<br />
Il paradosso è solo apparente. Le arie solistiche, la maggior parte delle quali è<br />
riservata all’unico carattere integralmente buffo, quello di Don Magnifico, servono<br />
meno a de finire un carattere che non a ratificare una definizione già data nei pezzi<br />
di insieme, all’interno dei quali hanno luogo le trasformazioni e i passaggi da un<br />
polo all’altro della posizione sociale. Lo si può verificare nel magnifico Sestetto<br />
che nell’Atto II funge da vero e proprio finale anticipato – «Questo è un nodo avviluppato»<br />
– capolavoro di finezza polifonica e di efficacia rappresentativa. Ma lo<br />
si può vedere, ripercorrendo all’indietro La Cenerentola, anche nel Finale dell’Atto<br />
I, nel Quintetto «Signor, una parola», nel coro che chiude l’Introduzione dell’opera:<br />
tutte scene che culminano nella confusione, nel rovesciamen to dei ruoli, nella<br />
dichiarazioni di follia personale o collettiva, quasi che dopo ogni appuntamento<br />
corale l’individuazione dei personaggi avesse avuto solo lo scopo di stranire i personaggi<br />
della commedia, e anzitutto quelli che restano fissi in tanto movimento,<br />
Don Magnifico, Clorinda e Tisbe.<br />
Ma l’ambivalenza delle situazioni di La Cenerentola è anche il risultato di una<br />
sottrazione: quella degli elementi magici e fiabeschi della favola di Perrault, del<br />
tutto assenti nella versione di Ferretti e Rossini. Che alcuni dettagli, come la so-