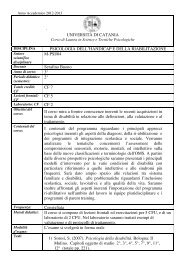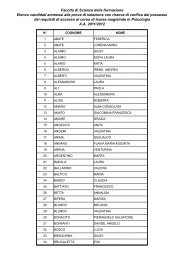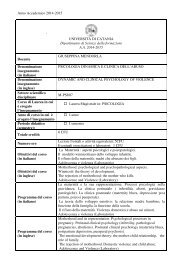Paralisi cerebrali infantili e paraplegie spastiche ereditarie - TESTO
Paralisi cerebrali infantili e paraplegie spastiche ereditarie - TESTO
Paralisi cerebrali infantili e paraplegie spastiche ereditarie - TESTO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
09-capitolo 19-07-2006 10:31 Pagina 269<br />
9 – PARALISI CEREBRALI INFANTILI E PARAPLEGIE SPASTICHE EREDITARIE<br />
Criteri diagnostici. Secondo Fink e collaboratori l’HSP<br />
può essere diagnosticata in presenza di [35-38]:<br />
• segni neurologici caratteristici, quali debolezza muscolare<br />
e spasticità bilaterale e simmetrica agli arti inferiori (a<br />
esordio insidioso e carattere progressivo);<br />
• obiettività neurologica di deficit simmetrici dei tratti corticospinali<br />
che interessino le estremità inferiori (ipostenia<br />
spastica degli arti inferiori, iperreflessia e Babinski positivo),<br />
associata a lieve deficit della sensibilità vibratoria<br />
(nelle gambe), piede cavo e ipertono della vescica urinaria;<br />
• familiarità per questi disturbi con modello di trasmissione<br />
dominante, recessivo o legato al sesso;<br />
• esclusione (attraverso indagini di laboratorio, studi neurofisiologici<br />
e neuroradiologici) di altre malattie in diagnosi<br />
differenziale (vedi oltre) [35-38, 109].<br />
Diagnosi differenziale<br />
Vanno escluse le seguenti condizioni cliniche [9, 35-38, 44]:<br />
• anomalie strutturali dell’encefalo o del midollo spinale:<br />
malformazione di Arnold-Chiari, spondilolisi cervicale o<br />
lombare, Sindrome della corda ritenuta (tethered cord), neoplasie<br />
a carico del midollo spinale, granulomi (ad es., tubercolosi)<br />
a carico di vertebre o del midollo spinale.<br />
Abitualmente la clinica (presenza di atassia, di coinvolgimento<br />
delle estremità superiori, radicolopatia, dolore, perdita della<br />
sensibilità con segni di livello) e un decorso subacuto aiutano<br />
nella diagnostica differenziale, ma sono le immagini (radiografia<br />
tradizionale, RM o arteriografia) generalmente a dimostrare<br />
la natura malformativa o meno del fenomeno clinico;<br />
• malattie degenerative: sclerosi multipla, sclerosi laterale<br />
amiotrofica, sclerosi laterale primaria, atassie spinocerebellari<br />
(inclusa la malattia di Machado-Joseph). La clinica in queste<br />
malattie è abitualmente differente e anche in questo caso gli<br />
esami di laboratorio (esame del liquor), neurofisiologici (elettromiografia,<br />
potenziali evocati, potenziali somatosensitivi) e<br />
strumentali (RM) aiuteranno a dirimere i dubbi diagnostici;<br />
• l e u c o d i s t r o f i e: adrenoleucodistrofia, adrenoleuconeuropatia,<br />
leucodistrofia metacromatica, malattia di Krabbe. La<br />
modalità di <strong>ereditarie</strong>tà, i segni associati (ritardo psicomotorio,<br />
deterioramento cognitivo, neuropatia), gli esami strumentali<br />
(RM, spettroscopia), ma soprattutto i dosaggi enzimatici,<br />
sono di fondamentale importanza ai fini diagnostici;<br />
• malattie metaboliche: degenerazione subacuta combinata,<br />
encefalopatia mitocondriale, abetalipoproteinemia, deficit<br />
di vitamina E. In genere in questi casi vi sono molte<br />
manifestazioni cliniche associate, che sono di per sé diagnostiche<br />
(ad es., retinite, neuropatia, bassa statura, ecc.);<br />
anche in questi casi si hanno dei quadri di neuroimmagini<br />
tipici e il dosaggio enzimatico è dirimente;<br />
• malattie infettive: sifilide terziaria o sifilide acquisita,<br />
paraparesi spastica tropicale, Sindrome da immunodeficienza<br />
acquisita (AIDS). Queste sono forme più rare in età<br />
pediatrica a decorso subacuto e con parametri di laboratorio<br />
molto chiari nella maggior parte dei casi;<br />
• altre forme: distonia DOPA-responsiva (sensibile alla somministrazione<br />
di DOPA, che è di per sé un test diagnostico).<br />
Variabilità genetica delle HSP<br />
e meccanismi patogenetici<br />
269<br />
Esistono forme di HSP autosomiche dominanti, recessive e<br />
legate al sesso. Ciascuna di queste forme è geneticamente<br />
eterogenea: mutazioni in geni diversi causano fenotipi non<br />
distinguibili clinicamente. I loci genetici dell’HSP vengono<br />
chiamati loci SPG (dall’inglese spastic gait) [35-38, 57]. Se<br />
ne conoscono a oggi 24 e sono numerati secondo la sequenza<br />
temporale con la quale sono stati identificati per analisi di<br />
linkage o per ricerca di mutazioni (il locus SPG18, sebbene<br />
già identificato, non è stato ancora pubblicato) (Tab. 9.2).<br />
La patogenesi delle HSP appare ancora oggi poco chiara e<br />
ciò è legato all’identificazione molto recente della maggior<br />
parte dei geni che causano tali forme [35, 68, 81, 85, 93, 113,<br />
136, 151]. Considerata l’estrema variabilità clinica delle HSP<br />
– l’HSP è più un gruppo di affezioni che una singola entità clinica<br />
– e l’elevato numero di geni coinvolti su diversi cromosomi,<br />
è facile ipotizzare che le proteine coinvolte nella patogenesi<br />
delle HSP siano coinvolte in numerosi meccanismi e<br />
vie biochimiche (Tab. 9.2). Tra questi meccanismi vi sono:<br />
• fosforilazione ossidativa (la SPG13/caperonina e la<br />
SPG7/paraplegina sono proteine mitocondriali);<br />
• trasporto assonale (la SPG10/KIF5 è una molecola implicata<br />
nel movimento e nel trasporto assonale e la SPG4/spastina<br />
interagisce con i microtubuli);<br />
• mielinizzazione e conservazione della struttura della mielina<br />
(la PLP/SPG2 è una proteina intrinseca della mielina);<br />
• sviluppo embrionario dei tratti corticospinali (la SPG1 è<br />
implicata nella produzione di proteine di adesione molecolare<br />
L1 CAM). Non è ancora chiaro se tali meccanismi agiscano<br />
secondo vie separate o convergano in un’unica via comune.<br />
HSP autosomiche dominanti. Sono state identificate<br />
diverse forme di HSP a trasmissione autosomica dominante<br />
(AD) (Tab. 9.2). La forma più comune (37-45% di tutte<br />
le forme di HSP AD) è la SPG4 (cromosoma 2p22), una<br />
HSP non complicata o talora associata con altri segni neurologici<br />
a insorgenza più tardiva [54-72]. Tranne che per le<br />
forme SPG3 e SPG8, tutte le altre forme sono state osservate<br />
in singoli nuclei familiari e sono rare.<br />
Come già accennato, non è possibile distinguere le varie<br />
forme di HSP dominanti solo in base a criteri clinici, in quanto<br />
la maggior parte di esse sono forme non complicate, e quindi<br />
per definizione (vedi sopra Criteri diagnostici [35-38]) non presentano<br />
segni neurologi associati distintivi. Si pensa che tutte<br />
queste forme (Tab. 9.3) siano causate da geni di una stessa<br />
superfamiglia – quindi con una funzione comune – o che le proteine<br />
prodotte convergano in una via comune (che causerebbe<br />
degenerazione assonale dei tratti corticospinali). Anche il criterio<br />
dell’età d’esordio non viene più utilizzato perché assai variabile<br />
(vedi sopra e Tab. 9.3). L’unica eccezione è forse rappresentata<br />
dalla SPG4, che è associata in alcune – ma non tutte –<br />
forme a deficit cognitivo (subclinico o del tipo demenza senile).<br />
In alcune forme di HSP si può notare, all’interno dei nuclei<br />
familiari, il fenomeno dell’anticipazione con comparsa di<br />
segni clinici di maggior gravità a età sempre più giovani.