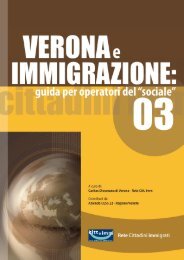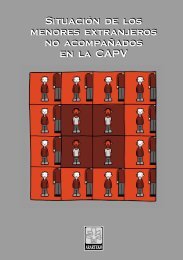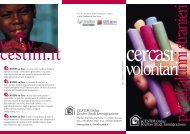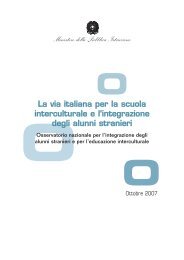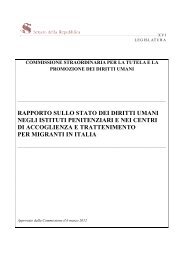- Page 1: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA F
- Page 5 and 6: INDICE PREMESSA ...................
- Page 7: Conclusioni .......................
- Page 10 and 11: X Inoltre, una volta acquisiti i co
- Page 12 and 13: XII Inoltre, per la realizzazione d
- Page 15 and 16: INTRODUZIONE L’oggetto di ricerca
- Page 17 and 18: zato, ho optato per la redazione di
- Page 19 and 20: CAPITOLO PRIMO QUESTIONI DI METODO,
- Page 21 and 22: no: dalla carenza di obiettività e
- Page 23: delle procedure osservative subentr
- Page 27 and 28: e “[…] con parole sue, scelte l
- Page 29 and 30: . come tecnica accostata ad altri s
- Page 31 and 32: spetti una volta che sono rientrato
- Page 33 and 34: posizione di ascolto attivo, cercan
- Page 35 and 36: 1. Esperienza formativa e lavorativ
- Page 37 and 38: tale incontro che, approfittando de
- Page 39 and 40: ire la comprensione del lavoro nel
- Page 41 and 42: azionali orientate alla massimizzaz
- Page 43 and 44: CAPITOLO SECONDO SENEGAL: UN PAESE
- Page 45 and 46: Tab. 2.1. Stranieri in Senegal, 197
- Page 47 and 48: dalla capitale si manifesta nella d
- Page 49 and 50: […] Sì, ma non sono come gli inv
- Page 51 and 52: oghe in direzione delle Isole Canar
- Page 53 and 54: nesse vie sterrate di Darou Fall -
- Page 55 and 56: […] distinguersi le prestazioni d
- Page 57 and 58: ziati di pace tra lo stato senegale
- Page 59 and 60: per coloro i quali intendo lasciare
- Page 61 and 62: numeri di uomini originari della va
- Page 63 and 64: Tab. 2.2. Percentuale di popolazion
- Page 65 and 66: Non siamo sviluppati, c’è stato
- Page 67 and 68: o, in alternativa, un valido access
- Page 69 and 70: è essa stessa a confermare la gene
- Page 71 and 72: Tab. 2.7. Stock di emigranti senega
- Page 73 and 74: gono che il flusso d’emigrazione
- Page 75:
lazione giovane ed in piena età at
- Page 78 and 79:
congiuntamente alla prossimità geo
- Page 80 and 81:
particolare per questo paese, o all
- Page 82 and 83:
il mio babbo vive lì… sono andat
- Page 84 and 85:
66 No no, sono arrivata [in Spagna,
- Page 86 and 87:
68 lia e sono rimasto […]. Nell
- Page 88 and 89:
2. MOBILITÀ, INSERIMENTO LAVORATIV
- Page 90 and 91:
Così come sembra emergere anche da
- Page 92 and 93:
campagne del sud Italia è stato ap
- Page 94 and 95:
settore industriale del nord Italia
- Page 96 and 97:
78 gira e rigira, uno ti chiama, la
- Page 98 and 99:
80 Non è facile [il lavoro in Ital
- Page 100 and 101:
viare autonomamente piccole attivit
- Page 102 and 103:
84 Proseguendo oltre e incentrando
- Page 104 and 105:
immersa nei canoni della donna occi
- Page 106 and 107:
sua complessità mettendola in rela
- Page 108 and 109:
Tab. 3.4. Evoluzione percentuale de
- Page 110 and 111:
92 Rinunciato ben presto alla possi
- Page 112 and 113:
94 K: Capisco quello che intendi. P
- Page 114 and 115:
sembra costantemente rivolta al des
- Page 116 and 117:
timori e delle difficoltà relative
- Page 118 and 119:
femminile, hanno gioco forza fatto
- Page 120 and 121:
luce alcune dinamiche insite nella
- Page 122 and 123:
lità, contribuisce all’identific
- Page 124 and 125:
giungere a negare ai propri figli i
- Page 126 and 127:
108 cose in Italia. Loro ti ricevon
- Page 128 and 129:
110 C’è tanta solidarietà fra d
- Page 130 and 131:
snazionalista, intesa come un insie
- Page 132 and 133:
Parimenti, altri autori sono inclin
- Page 134 and 135:
Seppur in diminuzione rispetto all
- Page 136 and 137:
L’emigrazione costituisce in ogni
- Page 138 and 139:
familiari più o meno prossimi poss
- Page 140 and 141:
122 Altre fonti, considerando invec
- Page 142 and 143:
io. In particolare, le somme indiri
- Page 144 and 145:
nità sub-sahariane residenti nel B
- Page 146 and 147:
128 In un suo saggio, frutto di un
- Page 148 and 149:
urbano, dove il 76% dei nuclei fami
- Page 150 and 151:
internazionali risponda prevalentem
- Page 152 and 153:
tà agricole nonché nel settore im
- Page 154 and 155:
dimostrato anche dalla tab. 4.8. 52
- Page 156 and 157:
destinati per la maggior parte ad a
- Page 158 and 159:
ghi da poter ammortizzare il costo
- Page 160 and 161:
per il migrante senegalese maschio
- Page 162 and 163:
sposo deve dimostrare alla famiglia
- Page 164 and 165:
146 li… ma noi [donne senegalesi,
- Page 166 and 167:
meno lungo periodo trascorso in pat
- Page 168 and 169:
ne e risentimento: l’atteggiament
- Page 170 and 171:
Tutti! No no, non solo i familiari,
- Page 172 and 173:
154 problemi è forse perché c’
- Page 174 and 175:
nuano ad essere consistenti: così,
- Page 176 and 177:
che, per molti, il definitivo ritor
- Page 178 and 179:
mente rappresentato dal tentativo d
- Page 180 and 181:
quali optano, più o meno arbitrari
- Page 182 and 183:
ciascun percorso migratorio present
- Page 184 and 185:
crisi economica che dal 2007 attana
- Page 186 and 187:
gratorio temporaneo e transitorio c
- Page 188 and 189:
ad un più o meno lungo soggiorno n
- Page 190 and 191:
Conseguentemente all’entrata in v
- Page 192 and 193:
Italia e, nonostante la loro parzia
- Page 194 and 195:
la considerazione “dell’emigraz
- Page 196 and 197:
via, o perché voglio tornare o per
- Page 198 and 199:
vo ultimo il ritorno al focolare do
- Page 200 and 201:
za pensare ad investimenti produtti
- Page 202 and 203:
184 Sin da sùbito, Faty sottolinea
- Page 204 and 205:
sono ancora ben inseriti nelle magl
- Page 206 and 207:
188 culturali senegalesi tanti ital
- Page 208 and 209:
e in Senegal. Le similitudine tra l
- Page 210 and 211:
pagine, si tratta di un aspetto rip
- Page 212 and 213:
5. MIGRANTI D’INVESTIMENTO? I dat
- Page 214 and 215:
elemento tale da aver impedito all
- Page 216 and 217:
198 in Italia sono rimasto [ad aspe
- Page 218 and 219:
200 re 22. Quindi… con il 2 non s
- Page 220 and 221:
appare essere un elemento essenzial
- Page 222 and 223:
Io credo sempre a Dio e Dio mi ha a
- Page 224 and 225:
206 Sai, la parola investire non pi
- Page 226 and 227:
laterale. Conversando ulteriormente
- Page 228 and 229:
amate, il momento del ritorno in pa
- Page 230 and 231:
abbandonato l’aura religiosa dell
- Page 232 and 233:
mine viene cacciato di casa da ques
- Page 234 and 235:
216 almeno, un tetto almeno. Ma io
- Page 236 and 237:
Concordemente con quanto affermato
- Page 238 and 239:
scito ad accantonare dei risparmi,
- Page 240 and 241:
Tramite della agenzie di lavoro? Vo
- Page 242 and 243:
Accanto alle difficoltà nel ripren
- Page 244 and 245:
226 non è possibile dare i soldi a
- Page 246 and 247:
228 Parole nuovamente ribadite al t
- Page 248 and 249:
solo due mesi in Italia… e nel fr
- Page 250 and 251:
232 Qui tu lavori per la tua famigl
- Page 252 and 253:
234 La narrazione di Momar dunque,
- Page 254 and 255:
territorio italiano? E, tra quanti
- Page 257 and 258:
CONCLUSIONI Il Senegal odierno è u
- Page 259 and 260:
ienze raccolte, emergono infatti di
- Page 261:
tali aspetti. Per il futuro, allora
- Page 265 and 266:
APPENDICE A TRACCIA D’INTERVISTA
- Page 267 and 268:
Inserimento e percorso lavorativo i
- Page 269:
Come viene rappresentata l’Italia
- Page 272 and 273:
INTERVISTA N°2 Data: 7 Marzo 2010
- Page 274 and 275:
INTERVISTA N°4 Data: 8 Marzo 2010
- Page 276 and 277:
INTERVISTA N°6 Data: 9 Marzo 2010
- Page 278 and 279:
INTERVISTA N°8 Data: 11 Marzo 2010
- Page 280 and 281:
INTERVISTA N°10 Data: 12 Marzo 201
- Page 282 and 283:
INTERVISTA N°12 Data: 13 Marzo 201
- Page 284 and 285:
INTERVISTA N°14 Data: 13 Marzo 201
- Page 286 and 287:
INTERVISTA N°16 Data: 15 Marzo 201
- Page 288 and 289:
INTERVISTA N°18 Data: 19 Marzo 201
- Page 290 and 291:
INTERVISTA N°20 Data: 21 Marzo 201
- Page 293 and 294:
LIBRI & ALTRE PUBBLICAZIONI RIFERIM
- Page 295 and 296:
DONATO, L., CRISCUOLO, L., E MASCEL
- Page 297 and 298:
STOCCHIERO, A. (2009) Rimesse e mic