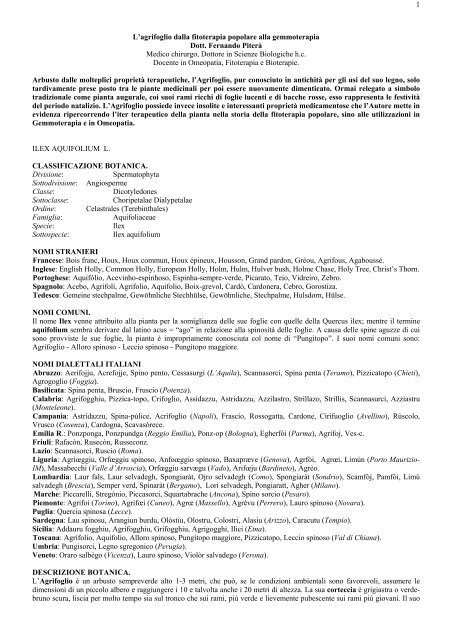1 L'agrifoglio dalla fitoterapia popolare alla gemmoterapia Dott ...
1 L'agrifoglio dalla fitoterapia popolare alla gemmoterapia Dott ...
1 L'agrifoglio dalla fitoterapia popolare alla gemmoterapia Dott ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’agrifoglio <strong>d<strong>alla</strong></strong> <strong>fitoterapia</strong> <strong>popolare</strong> <strong>alla</strong> <strong>gemmoterapia</strong><br />
<strong>Dott</strong>. Fernando Piterà<br />
Medico chirurgo, <strong>Dott</strong>ore in Scienze Biologiche h.c.<br />
Docente in Omeopatia, Fitoterapia e Bioterapie.<br />
Arbusto dalle molteplici proprietà terapeutiche, l’Agrifoglio, pur conosciuto in antichità per gli usi del suo legno, solo<br />
tardivamente prese posto tra le piante medicinali per poi essere nuovamente dimenticato. Ormai relegato a simbolo<br />
tradizionale come pianta augurale, coi suoi rami ricchi di foglie lucenti e di bacche rosse, esso rappresenta le festività<br />
del periodo natalizio. L’Agrifoglio possiede invece insolite e interessanti proprietà medicamentose che l’Autore mette in<br />
evidenza ripercorrendo l’iter terapeutico della pianta nella storia della <strong>fitoterapia</strong> <strong>popolare</strong>, sino alle utilizzazioni in<br />
Gemmoterapia e in Omeopatia.<br />
ILEX AQUIFOLIUM L.<br />
CLASSIFICAZIONE BOTANICA.<br />
Divisione: Spermatophyta<br />
Sottodivisione: Angiosperme<br />
Classe: Dicotyledones<br />
Sottoclasse: Choripetalae Dialypetalae<br />
Ordine: Celastrales (Terebinthales)<br />
Famiglia: Aquifoliaceae<br />
Specie: Ilex<br />
Sottospecie: Ilex aquifolium<br />
NOMI STRANIERI<br />
Francese: Bois franc, Houx, Houx commun, Houx épineux, Housson, Grand pardon, Gréou, Agrifous, Agaboussé.<br />
Inglese: English Holly, Common Holly, European Holly, Holm, Hulm, Hulver bush, Holme Chase, Holy Tree, Christ’s Thorn.<br />
Portoghese: Aquifólio, Acevinho-espinhoso, Espinha-sempre-verde, Picarato, Teio, Vidreiro, Zebro.<br />
Spagnolo: Acebo, Agrifoli, Agrifolio, Aquifolio, Boix-grevol, Cardò, Cardonera, Cebro, Gorostiza.<br />
Tedesco: Gemeine stechpalme, Gewöhnliche Stechhülse, Gewöhnliche, Stechpalme, Hulsdorn, Hülse.<br />
NOMI COMUNI.<br />
Il nome Ilex venne attribuito <strong>alla</strong> pianta per la somiglianza delle sue foglie con quelle della Quercus ilex; mentre il termine<br />
aquifolium sembra derivare dal latino acus = “ago” in relazione <strong>alla</strong> spinosità delle foglie. A causa delle spine aguzze di cui<br />
sono provviste le sue foglie, la pianta è impropriamente conosciuta col nome di “Pungitopo”. I suoi nomi comuni sono:<br />
Agrifoglio - Alloro spinoso - Leccio spinoso - Pungitopo maggiore.<br />
NOMI DIALETTALI ITALIANI<br />
Abruzzo: Aerifojju, Acrefojje, Spino pento, Cessasurgi (L’Aquila), Scannasorci, Spina penta (Teramo), Pizzicatopo (Chieti),<br />
Agrogoglio (Foggia).<br />
Basilicata: Spina penta, Bruscio, Fruscio (Potenza).<br />
Calabria: Agrifogghiu, Pizzica-topo, Crifoglio, Assidazzu, Astridazzu, Azzilastro, Strillazo, Strillis, Scannasurci, Azziastru<br />
(Monteleone).<br />
Campania: Astridazzu, Spina-pùlice, Acrifoglio (Napoli), Frascio, Rossogatta, Cardone, Cirifuoglio (Avellino), Rùscolo,<br />
Vrusco (Cosenza), Cardogna, Scavasòrece.<br />
Emilia R.: Ponzponga, Ponzpundga (Reggio Emilia), Ponz-op (Bologna), Egherfòi (Parma), Agrifoj, Ves-c.<br />
Friuli: Rafacòn, Rusecòn, Russeconz.<br />
Lazio: Scannasorci, Ruscio (Roma).<br />
Liguria: Agriœggiu, Orfœggiu spinoso, Anfoœggio spinoso, Baxapræve (Genova), Agrfòi, Agrœi, Limùn (Porto Maurizio-<br />
IM), Massabecchi (Valle d’Arroscia), Orfœggiu sarvægu (Vado), Arifœju (Bardineto), Agrèo.<br />
Lombardia: Laur fals, Laur selvadegh, Spongiaràt, Ojro selvadegh (Como), Spongiaràt (Sondrio), Scamfòj, Pamfòi, Limù<br />
salvadegh (Brescia), Semper verd, Spinaràt (Bergamo), Lori selvadegh, Pongiaratt, Agher (Milano).<br />
Marche: Piccarelli, Stregònio, Piccasorci, Squartabrache (Ancona), Spino sorcio (Pesaro).<br />
Piemonte: Agrifoi (Torino), Agrifœi (Cuneo), Agrœ (Massello), Agrèvu (Perrero), Lauro spinoso (Novara).<br />
Puglia: Quercia spinosa (Lecce).<br />
Sardegna: Lau spinosu, Arangiun burdu, Olòstiu, Olostru, Colostri, Alasiu (Arizzo), Caracutu (Tempio).<br />
Sicilia: Addauru fogghiu, Agrifogghiu, Grifogghiu, Agrigogghi, Ilici (Etna).<br />
Toscana: Agrifolio, Aquifolio, Alloro spinoso, Pungitopo maggiore, Pizzicatopo, Leccio spinoso (Val di Chiana).<br />
Umbria: Pungisorci, Legno sgregonico (Perugia).<br />
Veneto: Oraro salbègo (Vicenza), Lauro spinoso, Violòr salvadego (Verona).<br />
DESCRIZIONE BOTANICA.<br />
L’Agrifoglio è un arbusto sempreverde alto 1-3 metri, che può, se le condizioni ambientali sono favorevoli, assumere le<br />
dimensioni di un piccolo albero e raggiungere i 10 e talvolta anche i 20 metri di altezza. La sua corteccia è grigiastra o verdebruno<br />
scura, liscia per molto tempo sia sul tronco che sui rami, più verde e lievemente pubescente sui rami più giovani. Il suo<br />
1
legno è duro, pesante, molto resistente e dotato di grande flessibilità; di grana fine e omogenea non galleggia nemmeno<br />
quando è secco. Possiede un magnifico fogliame che in autunno è più esaltato dal contrasto con le bacche color corallo. Il<br />
tronco è diritto ed affusolato da cui dipartono dei rami patenti che danno origine a una chioma conica che in alcune varietà è<br />
densamente fogliata. La corteccia è omogenea e verde-grigiastra nelle piante giovani, mentre tende a solcarsi ed imbrunirsi<br />
con l’età. Le foglie sono sempreverdi, semplici e polimorfe; l’inserzione è alterna e avviene mediante un picciolo corto, tozzo<br />
e <strong>alla</strong>rgato (2 mm.) su rametti sottili e glabri di colore verdastro. La lamina fogliare è molto coriacea, cerosa e lucida, di colore<br />
verde scuro e <strong>d<strong>alla</strong></strong> forma ellittica, provvista di 12-16 pronunciamenti spinosi (6-8 spine per lato) che tendono ad arrotondarsi<br />
nelle piante giovani e nelle foglie poste all’apice delle chioma delle piante adulte. Il margine fogliare è intero, ma ondulato, più<br />
chiaro della lamina. Superiormente le foglie sono glabre di colore verde scuro lucente; inferiormente più chiare, quasi glauche;<br />
hanno una lamina a contorno ellittico con bordo sinuoso, ondulato e dentato <strong>d<strong>alla</strong></strong> consistenza cartilaginea e biancastra. La<br />
nervatura è penninervia con l’asse centrale ben visibile. Esistono delle varietà ornamentali di Agrifoglio con foglie verdi<br />
maculate e marginate di giallo, altre con foglie completamente gialle o sfumate di rosso (quelle dei germogli). I fiori sono<br />
unisessuali e brevemente peduncolati, inseriti singolarmente o, più frequentemente, riuniti in fascetti all’ascella delle foglie,<br />
verso la parte terminale del rametto e disposti in corimbi ascellari. Sono di piccole dimensioni (max 1 cm.) e poco visibili, con<br />
corolla di 6-8 mm. la quale è bianca nei fiori femminili, orlata di rosso nei maschili, provvista di 4 sepali, 4 petali saldati <strong>alla</strong><br />
base, e 4 stami, muniti di stilo anch’esso con 4 stimmi (raramente 5). I fiori maschili e quelli femminili si trovano su piante<br />
separate (piante dioiche). Quelli maschili hanno 4 stami ed i petali bianchi contornati di rosso, quelli femminili hanno l’ovario<br />
supero e la corolla completamente bianca. La fioritura avviene tra i mesi di Aprile e Maggio, talvolta a Giugno.<br />
Il frutto è una piccola drupa (diametro 1 cm.), ovvero una bacca scarlatta di un bel color rosso corallo lucente di forma<br />
globulosa, sub-sferica e carnosa di 8-12 mm. di diametro, contenente 4 piccoli noccioli. Le bacche compaiono solo sugli<br />
esemplari femminili da Settembre a Marzo, ma la drupa matura in inverno e persiste sulla pianta conferendole un notevole<br />
effetto molto decorativo (in alcune varietà le drupe possono essere gialle).<br />
MALATTIE DELL’AGRIFOGLIO<br />
L’Agrifoglio è parassitato <strong>d<strong>alla</strong></strong> minatrice delle foglie che provoca la formazione di pustole brune, con un foro centrale sulle<br />
foglie, le quali poi seccano e cadono.<br />
HABITAT e DISTRIBUZIONE<br />
Originario dell’Europa meridionale e delle regioni atlantiche, l’Agrifoglio è diffuso dall’Asia occidentale <strong>alla</strong> Cina,<br />
naturalizzato altrove, è raro in Africa e in Australia. Ilex è presente nell’Ovest e nel centro Europa con una sola specie che<br />
tuttavia è largamente diffusa nel nostro Continente. Pianta protetta, ricerca i terreni ricchi di humus e predilige luoghi molto<br />
umidi nelle macchie fresche e nelle selve, nei sottoboschi di bassa campagna e nei castagneti dei colli. Sopporta bene la<br />
mancanza di luce solare e le sue esigenze ecologiche e fitosociologiche sono simili a quelle del Faggio di cui è un abituale<br />
compagno. Vive nei boschi di latifoglie e predilige le fasce climatiche umide in luoghi ombreggiati; teme la luce intensa e le<br />
variazioni climatiche accompagnate da repentini sbalzi termici. In ogni caso può essere posizionato anche in ambienti<br />
soleggiati purché il suolo sia mantenuto umido. Talvolta abita la quasi totalità del piano arbustivo nella penombra delle fustaie<br />
e forma talvolta un fitto sottobosco che costituisce un ostacolo <strong>alla</strong> rigenerazione naturale. L’Agrifoglio riesce a prosperare<br />
all’ombra nei boschi perché ha minime esigenze di luce, ma avendo a disposizione una limitata quantità di energia, il suo<br />
accrescimento è assai lento; possiede però il vantaggio di non dover rifare ogni anno il proprio apparato fogliare. Vegeta<br />
ottimamente in terreni sabbiosi a reazioni acida, ricchi di sostanza organica ed elementi minerali e non tollera substrati molto<br />
calcarei. Evita pertanto le regioni calcaree e l’alta montagna perché i grandi freddi lo danneggiano, limitandone l’estensione in<br />
altitudine. In Italia è diffuso in tutto il territorio dal piano fino a 1.400 metri di quota, dove resiste a tutti gli inverni. Un tempo<br />
lo si incontrava facilmente nei cedui, nelle siepi e nei boschetti; ora è sempre più raro trovarlo allo stato spontaneo ed è più<br />
facile vederlo come arbusto di cinta dove viene spesso piantato a scopo ornamentale nelle diverse varietà. Nel nostro<br />
Meridione è più frequente un tipo a foglie maggiori (cm. 8-9 x 10-12) e meno ondulate (varietà Ilex australis Lacaita) che<br />
forse rappresenta una razza speciale. Per la buona resistenza all’inquinamento può essere impiegato nella formazione di siepi<br />
anche in città. Pianta longeva e di lento accrescimento, possiede un legno robusto ed omogeneo, chiaro appena tagliato, ma<br />
che con il tempo tende ad imbrunire. L’Agrifoglio non diventa un arbusto elevato se non dopo numerosi anni di vita. Può<br />
vivere anche sino a 300 anni.<br />
COLTIVAZIONE.<br />
L’Agrifoglio è uno tra gli arbusti a foglie persistenti più ornamentali nei nostri climi, sempre più apprezzato per la bellezza del<br />
fogliame e l’aspetto decorativo dei suoi frutti durante l’inverno. Esso richiede un terreno ricco e, preferibilmente, un tenore<br />
igroscopico piuttosto alto. La seminagione è il sistema più sicuro, poiché l’Agrifoglio, anche giovane, sopporta male il<br />
trapianto (da cui l’insuccesso dei piccoli arbusti trapiantati nei giardini, anche con la loro zolla). Poiché la crescita è assai<br />
lenta, è meglio rivolgersi ai vivaisti che lo allevano. Con l’Agrifoglio si possono edificare delle magnifiche siepi,<br />
impenetrabili, molto durature, almeno nel clima d’elezione dell’arbusto. Queste siepi si adattano particolarmente bene nei<br />
luoghi ombrosi , dove poche altre piante allignano. Verranno piantati di preferenza gli Agrifogli femminili, per i loro frutti che<br />
rallegrano l’occhio e, durante una buona parte dell’inverno, piacciono agli uccelli, senza però dimenticare qualche pianta<br />
maschile per l’impollinazione. Soltanto l’innesto precoce su fusto nato <strong>d<strong>alla</strong></strong> semina consente questa scelta. Sono state create<br />
numerosissime varietà con diverso portamento e caratteristiche fogliari; alcune varietà hanno infatti fogliame variegato di<br />
giallo con effetto molto decorativo (varietà “golden king”). Innestando su un soggetto maschile una marza di pianta femminile<br />
si possono ottenere i frutti con la coltivazione di un’unica essenza. Da ricordare inoltre la specie Ilex crenata, un arbusto di<br />
minori dimensioni, con foglie più piccole e lamina ovoidale-allungata con margine e apice spinosi. Si tratta sempre di una<br />
pianta dioica adatta a formare piccole barriere o siepi sempreverdi, i cui esemplari femminili portano dei frutti tondeggianti<br />
nerastri. Di questa specie esiste anche una varietà a fogliame giallo molto decorativo (“golden gem”). Gli agrifogli si piantano<br />
2
in marzo-aprile o in ottobre; nelle zone a clima mite possono essere piantati in qualsiasi momento dell’inverno, quando però il<br />
terreno non è eccessivamente umido. Le varietà a foglie variegate devono essere coltivate in posizioni più soleggiate perché<br />
all’ombra le differenze di colore delle foglie diventano meno nette. I cloni femminili e maschili si piantano insieme, per avere<br />
l’impollinazione e la produzione dei frutti. Per formare siepi, in marzo-aprile si mettono a dimora le piante giovani, alte circa<br />
40-50 cm., <strong>alla</strong> distanza di 60 cm. e si annaffiano abbondantemente se il tempo è asciutto. Non si potano fino <strong>alla</strong> primavera<br />
successiva; quindi si cimano, per favorire la formazione compatta di rami.<br />
Moltiplicazione. Le specie e le loro varietà si moltiplicano per mezzo di talee lunghe 5-8 cm., prelevate in agosto: si scelgono<br />
rametti dell’anno ben maturi, con una porzione del ramo portante, e si piantano in un miscuglio di torba e sabbia in parti<br />
uguali, in cassone freddo; in aprile-maggio dell’anno successivo si trapiantano le piante in vivaio, dove si coltivano per due<br />
anni, prima di metterle a dimora. Le varietà di Ilex aquifolium possono essere innestate sulla specie tipica, a marza in giugno o<br />
a gemma in agosto. Poiché le radici tendono comunque a produrre polloni, è consigliabile ricorrere <strong>alla</strong> moltiplicazione per<br />
mezzo di talee. Le diverse specie e le loro varietà si possono moltiplicare anche ricoprendo di terra i rami bassi in ottobre; si<br />
separano poi <strong>d<strong>alla</strong></strong> pianta madre due anni dopo e si piantano.<br />
Potatura. Non è necessario potare regolarmente, ma, se si desiderano forme particolari, si interviene in luglio-agosto. Le siepi<br />
si tosano ogni anno nel mese di aprile; se necessario, quelle vecchie si possono tagliare a fondo, a livello del legno vecchio.<br />
Gli agrifogli variegati a volte diventano verdi, se vengono trascurati o coltivati all’ombra: in questo caso si devono tagliare<br />
immediatamente <strong>alla</strong> base, con un coltello affilato, tutti i germogli verdi.<br />
MITI E LEGGENDE<br />
Riconducendoci ad antiche celebrazioni pagane, troviamo che l’Agrifoglio assume sempre il significato di buon augurio. Gli<br />
antichi Romani portavano ramoscelli di Agrifoglio durante i Saturnali, nei giorni precedenti al solstizio invernale, perché li<br />
consideravano dei talismani; sostenevano infatti che piantando l’albero nelle vicinanze della casa si tenevano lontani i<br />
malefici. Tali usanze e credenze si sono tramandate sino ai nostri giorni. La funzione di amuleto vegetale si ispira<br />
probabilmente al suo aspetto: le sue foglie persistenti, provviste di spine aguzze, evocano immagini di difesa, di durata e di<br />
sopravvivenza; mentre le sue bacche globose colore rosso vivo, sembrano celebrare la rinascita del sole al solstizio e augurare<br />
un anno felice. Per questi motivi i contadini inglesi, francesi, svizzeri e tedeschi, usavano appendere i ramoscelli di Agrifoglio<br />
nelle case e nelle stalle per allontanare i sortilegi e propiziare la fecondità degli animali. Quando in pieno inverno la<br />
vegetazione dorme spoglia e desolata, l’arbusto spicca col verde delle sue foglie ed il rosso delle sue bacche, a simboleggiare<br />
la persistenza della vita vegetale e la speranza della loro rinascita. Nelle credenze popolari, l’Agrifoglio benefico è sempre<br />
stato temuto da streghe e spiriti maligni. Insieme al Bosso, era ritenuto uno scaccia guai molto apprezzato. Possedere<br />
l’Agrifoglio, significava avere su se stessi e sulla propria casa parte delle forze benefiche di cui era fornita la pianta. Veniva<br />
infatti appeso nelle stalle e nelle case per tenere lontani sortilegi e malattie. Durante l’inverno gli antichi popoli Druidi<br />
decoravano le loro abitazioni con rami di Agrifoglio provvisti di bacche, per onorare gli spiriti della foresta. D’inverno nel<br />
periodo delle feste si ornavano le chiese con fronde di Agrifoglio, che poi i contadini portavano a casa, credendo che<br />
servissero contro i fulmini e gli incantesimi. Ancora oggi, <strong>alla</strong> vigilia di Natale, viene regalato e appeso alle porte (insieme al<br />
Vischio), come augurio di bene, per propiziarsi la sorte e attirare la fortuna. L’usanza di utilizzare l’Agrifoglio come<br />
decorazione natalizia nacque da una superstizione secondo la quale i folletti delle case amavano architettare scherzi durante le<br />
feste di Natale. Per difendersi da tali scherzi si appendevano ramoscelli di Edera e Agrifoglio sulle porte, sui camini e alle travi<br />
delle case. La pianta, nel linguaggio simbolico, rappresenta dunque la difesa, la precauzione, la previdenza e la resistenza.<br />
Secondo un’antica leggenda l’Agrifoglio sarebbe nato dalle orme di Cristo. Le sue foglie spinose e le bacche scarlatte come<br />
gocce di sangue furono considerate simbolo della passione del Salvatore. Per questa ragione la pianta di Agrifoglio è chiamata<br />
anche “Spina di Cristo” (Christ’s Thorn). Il Mattioli scriveva che le fronde spinose dell’Agrifoglio proteggevano la carne<br />
salata dai topi e da altri roditori: per questo motivo la pianta era anche detta Pungitopo maggiore. I grandi Agrifogli che<br />
crescono nei boschi sono provvisti di foglie irte di spine solo fino ad una certa altezza, più in alto le foglie cessano di essere<br />
una difesa e diventano più morbide e liscia come a significare che la pianta non ha più bisogno di difendersi dai nemici. Le sue<br />
bacche coralline, velenose per l’uomo, sono un ottimo nutrimento per gli uccelli che durante l’autunno e l’inverno rimangono<br />
nei nostri climi. Il suo fogliame perenne e sempreverde fornisce riparo ed asilo a piccoli animali durante i riposi invernali. E’<br />
l’amico che la natura riserva ai suoi figli nel tempo in cui tutto sembra averli abbandonati.<br />
SIMBOLISMO E MAGIA<br />
Considerata <strong>d<strong>alla</strong></strong> tradizione magica pianta di genere maschile perché collegata all’elemento fuoco e al pianeta Marte. Per<br />
questo motivo, se era portata addosso, la pianta avrebbe donato fortuna soprattutto agli uomini (il corrispondente femminile è<br />
l’Edera). Le si attribuivano protezione, sogni magici e il potere contro il fulmine. Era considerata la pianta protettiva per<br />
eccellenza, capace di difendere e proteggere dai fulmini, dai veleni, dagli spiriti cattivi e dagli stregoni malvagi se veniva<br />
piantato intorno <strong>alla</strong> casa. Se invece si lanciava l’Agrifoglio contro una bestia feroce, questo aveva la facoltà di calmarla<br />
immediatamente, anche se l’animale non veniva colpito. L’acqua di Agrifoglio (infuso o distillato) era spruzzata sui neonati in<br />
segno di protezione. Un antico rito magico per realizzare un desiderio, consisteva nel raccogliere, dopo la mezzanotte di un<br />
venerdì, nove foglie di Agrifoglio nel più completo silenzio, scegliendo una pianta non troppo spinosa. Si dovevano poi<br />
avvolgere le foglie in un panno bianco e annodare per nove volte le due estremità del panno. Infine, si riponeva questo<br />
sacchetto sotto il cuscino, e quello che si era pensato o desiderato si sarebbe avverato.<br />
CENNI STORICI<br />
Non è accertato se gli antichi conoscessero gli usi medicinali della pianta, benché crescesse sia in Italia che in Grecia. Nella<br />
Materia Medica di Dioscóride (Libro I, capitolo 102), il Mattioli afferma che nella storia delle piante tanti sono gli scritti e le<br />
diverse le opinioni degli antichi scrittori, da ingenerare molta confusione a tal punto da non saper più discernere in essi la<br />
verità. Tale è appunto il caso dell’Agrifoglio anticamente denominato Paliuro e descritto in un modo da Dioscóride e in un<br />
3
altro da Teofrasto; la descrizione di Teofrasto a sua volta è diversa da quella di Agatocle e quella di Agatocle diversa da quella<br />
di Plutarco; e infine quella di Plutarco differisce da tutte le altre. Ilex era per i Romani, ai tempi di Plinio e di Columella, ciò<br />
che oggi noi conosciamo sotto il nome di Quercus ilex, il nostro bellissimo Leccio. Nel Medio Evo la pianta era già<br />
conosciuta, come risulta <strong>d<strong>alla</strong></strong> descrizione di S. Alberto Magno. Il Mattioli la raffigura con molta esattezza sotto il nome di<br />
Aquifolio e ci narra “E’ adunque l’aquifolio una pianta grande come l’oxiacantha, le cui foglie che sempre verdeggiano, sono<br />
simili à quelle del lauro” e aggiunge che il decotto della sua radice serve contro le giunture indurite, le slogature e restaura la<br />
rottura delle ossa.<br />
MEDICINA POPOLARE<br />
La medicina <strong>popolare</strong> attribuisce <strong>alla</strong> pianta proprietà sudorifere e antireumatiche. Era utilizzata dalle popolazioni rurali per le<br />
malattie cutanee, come espettorante nella tosse, nel catarro cronico dei bronchi, nelle coliche, nelle gastralgie, nell’itterizia e<br />
nel vaiolo. Non sempre però l’uso dell’Agrifoglio era privo di effetti collaterali, perché anche le parti verdi della pianta<br />
possono presentare una certa tossicità. L’infuso di foglie venne usato nelle febbri intermittenti e nelle forme reumatiche per le<br />
sue proprietà febbrifughe e toniche. Per uso esterno l’Agrifoglio veniva utilizzato come risolvente applicando le foglie<br />
fresche contuse sui “tumori bianchi”, negli edemi, nella pleurite, negli ingorghi e nelle ostruzioni ghiandolari. Le popolazioni<br />
della Foresta Nera bevevano l’infusione delle foglie secche di Agrifoglio come succedaneo del tè; in modo analogo<br />
quest’ultima abitudine richiama quella dell’uso del maté, che è una specie di Agrifoglio sudamericano. In India le foglie sono<br />
considerate emollienti e diuretiche, le bacche purgative, emetiche e diuretiche. Presso le popolazioni indiane del Nord<br />
America una tisana ricavata <strong>d<strong>alla</strong></strong> cenere delle foglie era usata per curare la tosse convulsa.<br />
Le foglie fresche triturate erano impiegate come risolutivo: se ne facevano dei cataplasmi nei rigonfiamenti ghiandolari, negli<br />
edemi, negli ascessi.<br />
La seconda scorza dei rami, macinata a lungo e lasciata fermentare per due o tre settimane, serviva a fare un vischio per gli<br />
uccellatori senza dubbio superiore a quello ottenuto col Vischio.<br />
TOSSICITÀ<br />
Pianta medicinale controindicata in autoterapia e la cui prescrizione deve essere riservata solo al medico esperto in<br />
<strong>fitoterapia</strong>. L’ingestione delle bacche dell’Agrifoglio genera una violenta irritazione delle vie digestive con un quadro clinico<br />
simile <strong>alla</strong> gastroenterite coleriforme che può anche essere mortale. I sintomi consistono in dolori addominali, vomito,<br />
diarrea, sonnolenza, convulsioni e coma. Pertanto, a Natale, quando l’Agrifoglio è unito al Vischio nelle ghirlande, occorre<br />
ricordarsi che le sue bacche, vistose ed appetibili, si trovano a portata dei bambini. I tordi, i merli e altri uccelli invece, le<br />
mangiano senza alcun rischio. Le foglie, la corteccia e le radici, non presentano la tossicità delle bacche ma richiedono<br />
comunque cautela e non si devono mai superare i dosaggi terapeutici. I giovani getti, per la loro peculiare preparazione e<br />
diluizione, non presentano invece alcuna tossicità.<br />
PROPRIETÁ TERAPEUTICHE<br />
Nel passato l’Agrifoglio venne usato come antireumatico, antispasmodico, antigottoso e febbrifugo nelle febbri intermittenti.<br />
La corteccia era ritenuta anche epatoprotettiva e antisterica; la radice, invece, venne utilizzata per le sue proprietà diuretiche.<br />
La pania, ricavata <strong>d<strong>alla</strong></strong> corteccia e usata per il bracconaggio venne reclamizzata da J. Ruel (1479-1539) come cataplasma<br />
(associata a resina e cera in parti uguali) per risolvere ascessi, foruncoli, rigonfiamenti e tumori di diversa natura. Mattioli<br />
invece asserisce che il decotto di corteccia e radici possiede azione risolvente sugli indurimenti e guarisce le lussazioni: “Vale<br />
la decottione delle radici per mollificarre le giunture indurite per diflogagione: imperoché risolve e mollifica le durezze, e<br />
l’enfiagioni, e ristaura le rotture dell’ossa.” Il celebre Paracelso prescriveva il decotto di foglie per la cura dei reumatismi e<br />
delle forme artritiche. Alla fine del ’700 il Durante apprese da un empirico il loro valido uso contro le febbri intermittenti,<br />
proprietà questa che fu confermata più tardi da diversi Autori. Tra la fine del XVII e l’inizio del XIX secolo, le foglie ebbero<br />
reputazione tra i migliori febbrifughi, considerate efficaci quanto quelle della china nelle febbri intermittenti; vennero<br />
prescritte anche nel reumatismo e nella gotta. L’azione febbrifuga fu particolarmente studiata da Rousseau che riportò<br />
osservazioni di guarigioni dovute all’Agrifoglio (1822-1829-1831) preferendo utilizzare le foglie senza spine. In seguito il<br />
Magendie verificò il valore dei precedenti lavori osservando che la febbre non calava bruscamente come avviene con l’uso<br />
delle china, ma si abbassava lentamente e progressivamente in venti giorni al massimo. Reil e Werlhoff, riesumando le<br />
indicazioni di Paracelso, impiegarono le foglie per curare con successo forme reumatiche e gotta. Per il <strong>Dott</strong>. Hendricks<br />
(Hahnemannian Monthly) Ilex aquifolium è il rimedio del reumatismo oftalmico. In “The Medical Investigator” l’Autore<br />
così scriveva: . Il <strong>Dott</strong>. Hendricks guarì diversi casi di “infiammazione reumatica degli occhi con periostite dell’osso frontale che<br />
il più delle volte causavano la degenerazione stafilomatosa della cornea”. A tale proposito egli riporta il caso di una ragazza di<br />
17 anni che era stata curata dai migliori oculisti sin da quando aveva 5 anni. La ragazza soffriva di una grave forma di<br />
infiltrazione della cornea con stafiloma; i bulbi oculari sembravano come affetti da una protuberanza carnosa. Durante la notte<br />
la paziente soffriva di dolori brucianti alle orbite. Ilex aquifolium la guarì completamente in sei giorni! Heller raccomandava<br />
invece il succo di foglie nell’itterizia. Le bacche come purgativo ed emetiche. Il <strong>Dott</strong>. Cooper riporta la guarigione di un<br />
difficile caso di sordità cronica complicato da dolori <strong>alla</strong> milza che avevano la particolarità di migliorare in inverno. Egli<br />
raccomandava l’uso di Ilex aquifolium anche in casi di diarrea caratterizzata da scariche mucose e in casi di psilosi da sprue. Il<br />
<strong>Dott</strong>. Hale affermò di aver usato con successo il decotto ed il vino di Ilex per la tosse, le pleuriti, le coliche, la gotta ed i<br />
reumatismi. A titolo di completezza, riportiamo l’inusuale impiego terapeutico degli aculei di Ilex aquifolium consigliati dal<br />
Palma. Per Luigi Palma, infatti, la proprietà medicinale dell’Agrifoglio sarebbe essenzialmente contenuta nella foglia ed in<br />
4
particolare nelll’aculeo, nel quale sarebbe presente un’elevata concentrazione di “energia” capace di esplicare un’attività<br />
terapeutica tuttora ignorata. Come in alcune altre piante che producono aculei, l’efficacia terapeutica dell’Agrifoglio<br />
risiederebbe nel margine e negli aculei della foglia. Utilizzata in questo modo, la pianta può conferire all’organismo una<br />
maggiore capacità di resistenza ad attività che richiedono maggior sforzo fisico ed energia mentale e quindi a qualsiasi tipo di<br />
stress, migliorando le prestazioni ed il rendimento delle ghiandole surrenali. L’attività dell’Agrifoglio sarebbe particolarmente<br />
efficace in qualsiasi forma di astenia nervosa e nelle distonie legate ad alterazioni ormonali provocate da sforzi prolungati, da<br />
dosaggio eccessivo o effetti iatrogeni da farmaci, e talvolta, anche da un tipo di alimentazione inadeguata alle effettive<br />
necessità dell’organismo. Le proprietà terapeutiche dell’Agrifoglio si manifestano, per il Palma, anche a carico dell’emuntorio<br />
renale di cui aumenta la portata filtrante e l’intensità del ritmo della minzione, senza interferire nell’aumento quantitativo della<br />
secrezione urinaria. L’Agrifoglio risponderebbe in modo certo ed efficace nei casi indicati, ma si deve avvertire – ci ricorda<br />
questo Autore - che la sua azione terapeutica per manifestarsi necessita della fine polverizzazione degli aculei, perché in essi è<br />
concentrata la sostanza attiva elaborata <strong>d<strong>alla</strong></strong> pianta intera. “Sicché potendosi utilizzare soltanto gli aculei si otterrebbe una<br />
droga di una potenzialità terapeutica talmente elevata che per poterla sfruttare nei limiti di un’assimilazione fisiologica si<br />
dovrebbe usare una dose bassissima, non più di 0,50%. L’energia medicamentosa presente negli aculei dell’Agrifoglio non<br />
troverebbe corrispondenza in nessuna delle droghe note e non si riscontrerebbe neppure in una forma farmaceutica preparata<br />
con droghe ad alta concentrazione. Se si potesse stabilire una relazione di potenza terapeutica tra droga di Agrifoglio e droga<br />
di Cicuta, prescindendo <strong>d<strong>alla</strong></strong> differente natura medicinale, quella di Agrifoglio risulterebbe certamente la più potente. La<br />
possibilità di estendere l’uso dell’Agrifoglio ad alterazioni funzionali di qualsiasi meccanismo fisiologico, pure a beneficio di<br />
eventuali riflessi psicofisici, è di notevole interesse anche per l’utilità che può derivarne dall’uso di altre piante munite di<br />
aculeo. Tale possibilità è offerta da poche piante ma l’aculeo di Agrifoglio è il più attivo.” L’Autore ci ricorda inoltre di non<br />
fare confusione tra aculei e spine. E’ interessante notare come le indicazioni riportate dal Palma per l’impiego degli aculei e<br />
del margine fogliare, trovino una conferma e indicazioni simili in Pol Henry, il quale però utilizzava i giovani getti per il<br />
trattamento dell’insufficienza renale da nefroangiosclerosi.<br />
La corteccia avrebbe, secondo altri Autori, proprietà antiepilettiche (Valnet).<br />
Infine le bacche hanno proprietà purgative ed emetiche in dosi medicinali, ma essendo velenose se ne sconsiglia vivamente<br />
l’uso. I frutti, nel passato, venivano incautamente somministrati come purgativi ed emetici. La loro ingestione determina<br />
infatti disturbi gastrointestinali talvolta mortali. Non pochi sono i bambini che sedotti dal loro aspetto attraente hanno perso la<br />
vita; mentre esse rappresentano un alimento invernale per tordi e merli che sono insensibili <strong>alla</strong> loro tossicità.<br />
AZIONE FARMACODINAMICA di ILEX.<br />
Amara, antiepilettica (corteccia), antigottosa, antireumatica, antispasmodica, diaforetica, diuretica, emetica, febbrifuga,<br />
purgativa, stomachica, tonica, tossifuga.<br />
LE FOGLIE<br />
Principi attivi: Le foglie raccolte prima della fioritura contengono Ilicina, (un glucoside amorfo e amaro non ancora ben<br />
studiato), e Ilixantina (C17, H32,O11), una sostanza colorante che cristallizza in forma di piccoli aghi gialli che fonde a 198<br />
gradi ed è solubile in acqua e alcool. Sono inoltre presenti Acido caffetannico o caffeotannico (con proprietà simili <strong>alla</strong><br />
caffeina), acido ilicico, acido clorogenico, neoclorogenico, acido tannico, teobromina e rutina. E’ presente una sostanza<br />
molto amara, neutra, non cristallizzabile; tannino e sostanze tanniche, glucosio, un glucoside amorfo, gomma, clorofilla, una<br />
sostanza colorante gi<strong>alla</strong>, glucosio, potassa, tannini, peptina, acidi vegetali e minerali, idrocolloidi (gomma e mucillagini), cera<br />
e silice. L’Illicina ha proprietà febbrifughe (Rosseau e Magendie).<br />
Epoca di raccolta: si possono raccogliere durante l’intero anno, ma di preferenza in primavera.<br />
Tempo balsamico: è abbastanza ampio, tra Marzo e Maggio. Alcuni autori consigliano di raccogliere le foglie tra Maggio e<br />
Giugno. Queste differenze sono dovute ai diversi periodi di fioritura della pianta che varia a seconda del clima e dell’altezza<br />
dal piano.<br />
Istruzioni per la droga: raccogliere le foglie prima della fioritura e solo le foglie <strong>d<strong>alla</strong></strong> metà inferiore per non rovinare la<br />
pianta.<br />
Conservazione: le foglie si essiccano all’ombra e si conservano in sacchetti.<br />
Proprietà: antigottose, antitteriche, antireumatiche, antispasmodiche e sedative contro i dolori colici, calmanti pettorali,<br />
diaforetiche, diuretiche, febbrifughe, stomachiche, tossifughe.<br />
Indicazioni: atonia gastrica, diarrea, diarrea con febbre, diarrea spastica, disoressia, dispepsia, enterospasmi, febbre da<br />
pappataci, febbri reumatiche, febbri intermittenti e ricorrenti, gotta viscerale, reumatismo articolare cronico, reumatismo<br />
gottoso e turbe digestive.<br />
Preparazioni per uso interno: Infuso tradizionale al 2-3% (riposo di 20 minuti), da una a tre tazzine al giorno; oppure una<br />
tazza da somministrare a cucchiai nei dolori colici e nella bronchite cronica, contro il catarro bronchiale cronico, i reumatismi,<br />
la gotta, le digestioni difficoltose, le coliche; nelle tossi e nei raffreddori due o tre tazzine al dì. Altri ricettari consigliano un<br />
infuso più concentrato che si prepara con 30-60 foglie fresche o secche in un litro di acqua: la dose sarebbe di 2-3 tazze al<br />
giorno. Il Palma prescrive l’infuso della polvere impalpabile della foglia 2%, da due-tre tazzine pro die; l’estratto al 6% in<br />
preparazioni farmaceutiche; la polvere in 2 g. per dose e sino a 2-5 gr. al dì (sempre secondo Palma). Estratto 2 g. in pillole.<br />
Per quanto concerne i decotti, i modi di preparazione e le percentuali variano a seconda degli autori. Riportiamo qui di seguito<br />
quelli più frequentemente riscontrati nei vari libri di erboristeria. Un ottimo decotto contro la febbre si può ottenere con un<br />
cucchiaio da minestra di foglie per ogni tazza di acqua; lasciare in infusione per 10 minuti, quindi berne da 2 a 3 tazze al<br />
giorno fra i pasti. Decotto: un cucchiaio da minestra per tazza, bollire 2 minuti e tenere in infusione 10 minuti, somministrare<br />
2-3 tazze al giorno tra i pasti. Altro Decotto: bollire per pochi minuti 40-50 g. di foglie essiccate in un litro d’acqua e quindi<br />
colare. Se ne prendono 3-4 tazzine al giorno lontano dai pasti. Polvere: pestare in un mortaio le foglie essiccate sino a ridurle<br />
in polvere molto fine. Se ne prendono da mezzo a due cucchiaini da caffè nell’arco della giornata mescolati a vino bianco. Una<br />
5
tintura, anch’essa indicata contro la febbre e i reumatismi, si prepara mettendo 20 gr. di foglie per ogni tazza di alcool a 70°<br />
lasciando macerare per 10 giorni: assumere da 20 a 30 gocce 2 volte al giorno in poca acqua. Le foglie tritate, messe a<br />
macerare nell’alcool e poi allungate con vino bianco costituiscono il vino di Agrifoglio utilizzato per le febbri intermittenti. In<br />
un’altra preparazione di un vino medicato si consiglia di macerare 25 g. di foglie contuse in 200 cc di alcool per 8 giorni,<br />
aggiungendo a questo alcolato 800 cc di vino bianco e lasciando ancora macerare per 8 giorni. Vino (3% macerare per 8<br />
giorni) e somministrare 1 bicchierino prima dei pasti. Il succo fresco delle foglie venne impiegato vantaggiosamente nella cura<br />
dell’itterizia.<br />
Preparazioni per uso esterno: Infuso al 6-10% per impacchi sul torace all’inizio delle affezioni polmonari (bronchiti,<br />
pleuriti) e sull’addome nei dolori colici.<br />
Effetti collaterali e indesiderati: si consiglia non superare mai le dosi e le concentrazioni indicate. Anche le foglie a dosaggi<br />
maggiori, possono risultare tossiche.<br />
Varie: le foglie sottoposte a trattamento speciale furono utilizzate come succedanee del tè.<br />
GLI ACULEI<br />
Principi attivi: contengono una sostanza irritante simile <strong>alla</strong> caffeina.<br />
Epoca di raccolta: i margini della foglia con gli aculei si raccolgono prima della fioritura.<br />
Istruzioni per la droga: necessita della fine polverizzazione sia degli aculei che del loro margine fogliare a cui sono attaccati,<br />
previa essiccazione all’ombra.<br />
Conservazione: la polvere ottenuta si conserva in idonei sacchetti in luoghi ben asciutti.<br />
Proprietà: adattogene, antidistoniche, tonificanti, stimolanti surrenaliche, diuretiche.<br />
Indicazioni: diminuita resistenza fisica e mentale a situazioni di adattamento e a condizioni di stress psico-fisici. Astenia<br />
nervosa con diminuita resistenza ad attività che richiedono maggior sforzo fisico e mentale e quindi a qualsiasi tipo di stress.<br />
Migliorano la funzionalità e le prestazioni delle ghiandole surrenali. L’attività dell’Agrifoglio sarebbe particolarmente efficace<br />
in qualsiasi forma di astenia nervosa e nelle distonie dovute ad alterazioni ormonali del surrene provocate da sforzi prolungati,<br />
da eccessivo dosaggio o da effetti iatrogeni da farmaci, e da incongrua alimentazione. Le proprietà terapeutiche<br />
dell’Agrifoglio si manifestano, per il Palma, anche a carico dell’emuntorio renale di cui aumenterebbe la portata filtrante e<br />
l’intensità del ritmo della minzione, senza interferire nell’aumento quantitativo della secrezione urinaria.<br />
Preparazioni per uso interno: infuso della polvere impalpabile al 2%: due-tre tazzine pro die.<br />
LA CORTECCIA.<br />
Principi attivi: la corteccia è ricca di Ilicina, tannini e una sostanza amara.<br />
Epoca di raccolta: tutto l’anno; ma meglio in Novembre.<br />
Istruzioni per la droga: si stacca la seconda corteccia che deve essere sminuzzata ed essiccata al sole.<br />
Conservazione: si conserva in scatole in luoghi asciutti.<br />
Proprietà: antireumatica, antispasmodica, antiisterica, antiepilettica (Valnet), epatoprotettiva e sedativa contro i disturbi<br />
epatici, febbrifuga (febbri intermittenti), stomachica, tonica e tossifuga.<br />
Indicazioni: ha indicazioni simili a quelle delle foglie.<br />
Preparazioni per uso interno: Decotto al 3-5% da assumersi a cucchiai o tazzine in caso di febbre. Sempre contro la febbre si<br />
può utilizzare un decotto di corteccia preparato con 3 gr. per ogni tazza d’acqua, berne 2 o 3 tazze al giorno. Oppure: un pugno<br />
per litro d’acqua e tenere in infusione tutta la notte: 2-3 tazze al giorno, tra i pasti. Decotto: bollire per qualche minuto 30 g. di<br />
corteccia essiccata e sminuzzata in un litro d’acqua, colare e prenderne 4-5 bicchierini da liquore al giorno. Infuso: versare<br />
mezzo litro di acqua bollente su 3 cucchiaiate di corteccia finemente sminuzzata e lasciar riposare per una decina di minuti. Se<br />
ne bevono 2-3 tazze al giorno (isterismo, epilessia). Macerato: immergere 30 g. di corteccia ben sminuzzata in un litro (o<br />
anche tre quarti) di acqua fredda e lasciare macerare per almeno 12 ore; colare e prenderne 3-4 tazzine al giorno lontano dai<br />
pasti. Vino di corteccia al 4%: macerare per una settimana 40 g. di corteccia ben sminuzzata in un litro di vino bianco; se ne<br />
prendono 2-3 bicchierini al giorno, da utilizzare anche negli esiti di pleurite e polmonite. Una tintura vinosa si ottiene con 5<br />
gr. di corteccia per ogni tazza di vino rosso lasciata macerare per 10 giorni. Berne 2 bicchierini al giorno contro la febbre.<br />
Effetti collaterali e indesiderati: come per le foglie.<br />
Varie: il legno bianco, fine e compatto, è considerato pregiato per lavori di intarsio; colorato in nero imita bene l’ebano.<br />
Nell’alburno sono presenti pectine e viscina con cui si preparava il vischio per la cattura degli uccelletti.<br />
LE BACCHE.<br />
Principi attivi: i frutti contengono composti triterpenici ad azione digitaloide, acido clorogenico, destrosio, tannini e gomma.<br />
Epoca di raccolta: Ottobre-Dicembre, a completa maturazione.<br />
Istruzioni per la droga: da raccogliere a completa maturazione, mai verdi.<br />
Conservazione: si essiccano all’ombra o in locale ben riscaldato e si conservano in sacchetti.<br />
Proprietà: le bacche possiedono proprietà totalmente differenti dalle foglie essendo vomitive e purgative drastiche, ma<br />
sconsigliate perché possono provocare vomito sanguinolento anche a dosi modeste.<br />
Indicazioni: stitichezza.<br />
Preparazione per uso interno: le bacche usate fresche nell’adulto (mai più di 8 o 10 <strong>alla</strong> volta pro die) assunte al mattino al<br />
digiuno o <strong>alla</strong> sera coricandosi, dopo essere state lasciate 12 ore a bagno per ammorbidirle, sono un drastico purgante.<br />
Effetti collaterali e indesiderati: usate fresche nell’adulto e mai più di 10 <strong>alla</strong> volta sono fortemente purgative ed emetiche.<br />
Già in dose di 15 o 20 sono estremamente dannose e possono provocare vomito o conseguenze più gravi ed anche la morte,<br />
specialmente nei bambini. Se ne sconsiglia pertanto l’uso!<br />
Varie: le bacche essiccate, tostate e macinate, vennero un tempo usate come surrogati del caffè. Le bacche tostate sembrano<br />
infatti perdere il loro potere lassativo ed emetico, ma non conviene mai utilizzarle di frequente come bevanda.<br />
6
LE RADICI<br />
Principi attivi: tannini catechici, sali di potassio, pectine.<br />
Epoca di raccolta: Autunno.<br />
Istruzioni per la droga: sterrare, pulire accuratamente e sminuzzare.<br />
Conservazione: si essicca al sole e si conserva in scatole.<br />
Proprietà: diuretica, depurativa.<br />
Indicazioni: edemi, idropisia, oliguria, affezioni delle vie urinarie e reumatismo oftalmico.<br />
Prescrizioni per uso interno: Decotto al 2-5%, 2 o 3 tazzine al giorno. Decotto: bollire per dieci minuti 30 g. di radice<br />
essiccata in un litro d’acqua (3%). Se ne prendono 2-3 tazzine al giorno. Infuso al 4 - 5%; assumere 1-3 tazzine al giorno<br />
nell’idropisia e nelle affezioni delle vie urinarie. Per la cura del reumatismo oftalmico il <strong>Dott</strong>. Hendricks consiglia invece di<br />
raccogliere la pianta verde e la radice nel mese di giugno, tagliarla a piccoli pezzi e mettere una parte a macerare in alcool a<br />
95%, l’altra parte a macerare nell’acqua, e poi entrambe mescolate insieme.<br />
Effetti collaterali e indesiderati: come per le foglie.<br />
Varie: <strong>d<strong>alla</strong></strong> corteccia della radice si ottiene una pania glutinosa e appiccicaticcia, la quale pestata con acqua e quindi lavata<br />
con acqua corrente; da unire ad olio.<br />
In Veterinaria: decotto di radici al 10%: un litro al giorno come diuretico per bovini; da somministrare al mattino o <strong>alla</strong> sera<br />
due ore dopo il pasto.<br />
GEMMODERIVATO:<br />
Preparazione e materia prima.<br />
Il gemmoderivato, introdotto in terapia da Pol Henry, si ottiene mediante macerazione dei giovani getti in appropriata<br />
soluzione idrogliceroalcolica poi diluita <strong>alla</strong> prima decimale (1 DH). Per quanto riguarda il metodo estrattivo, esso non si<br />
discosta da quello comunemente usato per tutti i Macerati Glicerici (Gemmoderivati) ed è indicato come: Ilex aquifolium<br />
giovani getti, M.G. 1 DH.<br />
ORGANOTROPISMO E<br />
SINDROME BIOLOGICA SPERIMENTALE.<br />
I giovani getti di Ilex aquifolium possiedono un organotropismo per il rene e surrene, la mammella, l’occhio, l’orecchio e in<br />
misura minore anche per il sistema nervoso. Il gemmoderivato migliora il rendimento surrenalico e la funzionalità renale<br />
compromessa da processi flogistici cronici e aumenta la portata filtrante dell’emuntorio renale. Sul sistema nervoso Ilex<br />
aquifolium agisce come regolatore riducendo le forme di astenia nervosa e gli stati neurodistonici caratterizzati da alterazioni<br />
psicomotorie; è anche utile nel trattamento dell’epilessia. Rimedio ad azione complementare, è più efficace se prescritto in<br />
associazione con altri gemmoterapici. L’azione biologica e sperimentale di Ilex aquifolium, studiata da Pol Henry mediante<br />
elettroforesi, ha messo in evidenza che i germogli di Ilex aumentano le albumine e le gamma globuline, mentre hanno<br />
un’azione ambivalente sulle alfa globuline. Sulle euglobuline, Ilex riduce le frazioni alfa e le beta, mentre sulle gamma ha<br />
un’azione ambivalente.<br />
INDICAZIONI CLINICHE<br />
del GEMMODERIVATO.<br />
® Insufficienza renale da nefroangiosclerosi, (con Fagus sylvatica), (P. Henry).<br />
® Sindrome nefrosica (con Fagus sylvatica)<br />
® Lieve insufficienza surrenalica, (con Ribes nigrum).<br />
® Mastopatia fibroadenocistica (con Alnus incana, Betula verrucosa e Rubus idaeus),<br />
(P. Henry).<br />
® Displasia mammaria caratterizzata da nodosità benigne (con Alnus incana e Rubus idaeus)<br />
® Malattia di Réclus, mastosi (con Alnus incana).<br />
® Cisti sierose del seno (con Alnus incana)<br />
® Epilessia piccolo male, (con Tilia tomentosa), (P. Henry).<br />
® Psilosi e alopecia in casi di sprue.<br />
® Itterizia e postumi di febbri intermittenti (Haller).<br />
® Congiuntivite con dolori urenti alle orbite (che peggiorano di notte tra le ore 4 e le ore 6).<br />
® Stafiloma della cornea di origine reumatica, (Hendricks).<br />
® Cheratocono secondario a patologia reumatica con interessamento oftalmico.<br />
® Affezioni oculari in corso di patologia reumatica (Hendricks)<br />
® Infiammazione reumatica degli occhi, (con Salix alba linfa).<br />
® Dolori splenici che migliorano in inverno, (Cooper).<br />
® Irritazione dell’uretra con costante scolo di natura prostatica, (Cooper).<br />
® Acufeni e tinnitus (con Sorbus domestica).<br />
® Ipoacusia e sordità da timpanosclerosi, (con Alnus glutinosa, Sorbus domestica e Viburnum lantana).<br />
® Diatesi reumatica e gottosa.<br />
SINERGIE:<br />
con Alnus incana (mastopatia fibroadenosica)<br />
con Betula verrucosa (mastopatia fibroadenosica)<br />
con Fagus sylvatica (nefroangiosclerosi)<br />
7
con Fagus sylvatica (sindrome nefrosica)<br />
con Rubus idaeus (mastopatia fibrocistica)<br />
con Sorbus domestica (acufeni e ipoacusia)<br />
PRESCRIZIONE<br />
Prescrivere Ilex aquifolium, giovani getti, Macerato Glicerico 1 DH: 30–50 gocce diluite in poca acqua due-tre volte al<br />
giorno; oppure 50 gocce in unica somministrazione se associato ad altri gemmoterapici o fitoterapici.<br />
RIMEDI COMPLEMENTARI ANALOGICI.<br />
Alberi: Alnus incana, Betula pubescens, Betula verrucosa, Carpinus betulus, Castanea vesca, Fagus sylvatica, Quercus<br />
peduncolata, Sorbus domestica e Tilia tomentosa.<br />
Arbusti: Buxus sempervirens, Cornus sanguinea, Juniperus communis, Rosa canina,<br />
Rubus fructicosus, Rubus idaeus e Viburnum lantana.<br />
ILEX AQUIFOLIUM IN OMEOPATIA<br />
Non esiste una vera e propria sperimentazione sull’uomo sano. Le indicazioni, riportate da pochi Autori e in pochissime<br />
Materie Mediche, sono dovute a sintomi di guarigione osservate su pazienti ammalati. Ilex aquifolium è un “piccolo rimedio”<br />
utilizzato in Omeopatia nelle febbri intermittenti con marcati sintomi oculari e dolori splenici. Caratteristica di Ilex è che tutti i<br />
sintomi del paziente migliorano in inverno.<br />
Testa: Cefalea, emicrania, psilosi.<br />
Occhio – Congiuntivite con dolore urente alle orbite che peggiora di notte tra le ore 4 e le ore 6. Infiltrazione della cornea;<br />
stafiloma corneale; bruciore notturno nelle orbite, infiammazione reumatica dell’occhio.<br />
Apparato urinario: Colica renale, oliguria, irritazione dell’uretra con costante scolo di natura prostatica (Cooper).<br />
Relazioni: da confrontare con Ilex Paraguayensis – Yerba Mate – (Persistente dolore epigastrico; senso di acidità della bocca<br />
e della faringe, anoressia, pirosi, depressione nervosa, nevrastenia. Sonnolenza: incapacità per il lavoro, diminuzione della<br />
diuresi, colica renale, mal di testa, emicrania e prurito. Viene anche utilizzato come profilattico contro l’insolazione, essendo<br />
un sicuro stimolante della circolazione, della sudorazione e della diuresi). – Ilex vomitoria – Yaupon – (Proprietà emetiche –<br />
possiede anche qualità toniche e digestive, scevro da effetti di insonnia. Possiede un principio attivo che sembra agire come<br />
potente diuretico – impiegato nella nefrite e nella gotta). – Ilex Cassine – (Christmas berry tea) – eccellente diuretico e<br />
sostituto del tè.<br />
Dosaggi: Tintura Madre e basse diluizioni decimali (DH 1- DH 3).<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
1) - BAILLON, H.: Traité de Botanique Médicale - Phanérogamique. Hachette et C ie , Paris 1884.<br />
2) - BOERICKE, W.: Materia Medica Omeopatica. Ed. Homeopathic Book Publisher, London prima edizione italiana, 1998.<br />
3) - BRIGO, B.: L’Uomo, la Fitoterapia, la Gemmoterapia. Edizioni Tecniche Nuove, Milano 1997.<br />
4) - BULGARELLI, G., FLAMIGNI, S.: Piante tossiche e velenose. Ed. Demetra S.r.l., Bussolengo (VR) 1994.<br />
5) - CATTABIANI, A.: Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante. Ed. Mondadori, Milano 1997.<br />
6) - CUNNINGHAM, S.: Enciclopedia delle erbe magiche. Ed. Mursia S.p.A., Milano 1992.<br />
7) - DURANTE, C.: Herbario novo. Ed. G. Hertz, Venezia 1567.<br />
8) - FERRARI, M. - MEDICI, D.: Alberi e Arbusti in Italia. Ed. Edagricole, Bologna 1996.<br />
9) - FONT QUER, P.: Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado. Editorial Labor, S.A., Barcellona 1985.<br />
10) - GASTALDO, P.: Compendio della Flora officinale Italiana. Ed. Piccin, Padova 1987.<br />
11) - GRIEVE, M.: A Modern Herbal. Tiger Books International, London, 1992.<br />
12) - HENRY, P.: Gemmoterapia. Ricchiuto Editore, Verona 1989.<br />
13) - Da LEGNANO, L.P., POMINI, L.: Le Piante Medicinali del Canton Ticino e dell’Oltre<br />
Po’. Ed. Mediterranee, Roma 1978.<br />
14) - LIEUTAGHI, P.: Il libro dei frutti selvatici. Natura Amica, Rizzoli Editore, prima edizione, Milano Novembre 1974.<br />
15) – LUZZI, P.: Piante Selvatiche Velenose. Edagricole, Bologna 1995.<br />
16) - NADKARNI, K.M.: Indian Materia Medica. Popular Prakashan Private LTD. Bombay, India, 1976.<br />
17) - NEGRI, G.: Erbario figurato. Editore Ulrico Hoepli, Milano 1979.<br />
18) - PALMA, L.: Le piante medicinali d’Italia - Botanica, Chimica, Farmacodinamica, Terapia. Società Editrice<br />
Internazionale.<br />
19) - PALMA, L.: Fitoterapia essenziale. Vol. I, Palma Editore, Roma 1979.<br />
20) - PENZIG, O.: Flora Popolare Italiana. Orto Botanico della R. a Università. Vol. I, p. 242, Genova 1924. Ristampa<br />
Edizioni Edagricole, Bologna 1974.<br />
21) - PIGNATTI, S.: Flora d’Italia. Vol. II, p.73, Ed. Edagricole, Bologna 1982.<br />
22) - PITERA’, F.: Compendio di Gemmoterapia Clinica (Meristemoterapia), pp. 434-439, De Ferrari Editore, seconda<br />
edizione, Genova 1996.<br />
23) - POMINI, L.: Erboristeria Italiana. Edizioni Vitalità, seconda edizione, Torino 1981.<br />
24) - PROSERPIO, G.: Il Nuovo Codex Vegetabilis. Coedizione Sinerga e Studio Edizioni, Milano 1997.<br />
25) - REUTTER, L.: Traité de Matèrie Médicale. Drogues Végétales. Drougues Animales et de Chimie Végétale. Libraire J.B.<br />
Baillière et Fils, Paris 1923.<br />
26) - SCHAUENBERG, P., PARIS, F.: Le Piante Medicinali. Newton Compton Editori, Roma 1981.<br />
27) - VALNET, J.: Fitoterapia. Cura delle malattie con le piante. Aldo Martello-Giunti Editore S.p.A., Firenze 1981.<br />
8
28) - VIOLA, S.: Piante Medicinali e Velenose della Flora italiana. Edizioni Artistiche Maestretti, Milano 1965.<br />
29) - VOISIN, H: Matière Médicale du Praticin Homéopathe. Maloine S.A. Editeur & Les Laboratoires Homœpathique de<br />
France. Paris 1986.<br />
30) WESLAGER, A.C.: Erbe e medicine magiche degli Indiani del Nord America. Ed. Erre emme, Roma 1994.<br />
31) - WITT, R.: Cespugli e Arbusti selvatici. Franco Muzzio Editore, Padova 1987.<br />
9