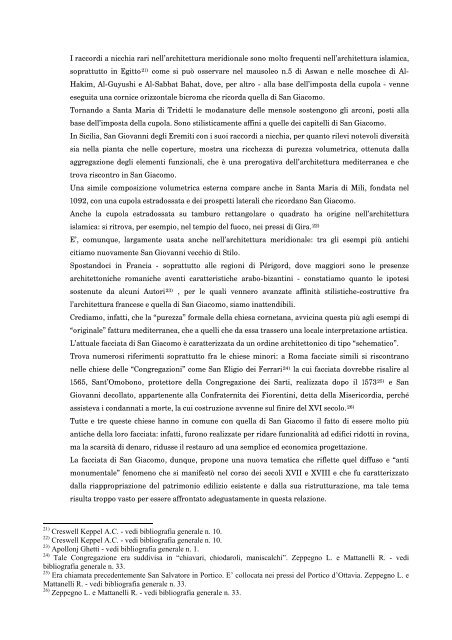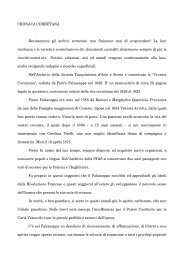Fabrizi F _ Traversi G.C. LA CHIESA DI - Società Tarquiniese Arte e ...
Fabrizi F _ Traversi G.C. LA CHIESA DI - Società Tarquiniese Arte e ...
Fabrizi F _ Traversi G.C. LA CHIESA DI - Società Tarquiniese Arte e ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I raccordi a nicchia rari nell’architettura meridionale sono molto frequenti nell’architettura islamica,<br />
soprattutto in Egitto21) come si può osservare nel mausoleo n.5 di Aswan e nelle moschee di Al-<br />
Hakim, Al-Guyushi e Al-Sabbat Bahat, dove, per altro - alla base dell’imposta della cupola - venne<br />
eseguita una cornice orizzontale bicroma che ricorda quella di San Giacomo.<br />
Tornando a Santa Maria di Tridetti le modanature delle mensole sostengono gli arconi, posti alla<br />
base dell’imposta della cupola. Sono stilisticamente affini a quelle dei capitelli di San Giacomo.<br />
In Sicilia, San Giovanni degli Eremiti con i suoi raccordi a nicchia, per quanto rilevi notevoli diversità<br />
sia nella pianta che nelle coperture, mostra una ricchezza di purezza volumetrica, ottenuta dalla<br />
aggregazione degli elementi funzionali, che è una prerogativa dell’architettura mediterranea e che<br />
trova riscontro in San Giacomo.<br />
Una simile composizione volumetrica esterna compare anche in Santa Maria di Mili, fondata nel<br />
1092, con una cupola estradossata e dei prospetti laterali che ricordano San Giacomo.<br />
Anche la cupola estradossata su tamburo rettangolare o quadrato ha origine nell’architettura<br />
islamica: si ritrova, per esempio, nel tempio del fuoco, nei pressi di Gira. 22)<br />
E’, comunque, largamente usata anche nell’architettura meridionale: tra gli esempi più antichi<br />
citiamo nuovamente San Giovanni vecchio di Stilo.<br />
Spostandoci in Francia - soprattutto alle regioni di Périgord, dove maggiori sono le presenze<br />
architettoniche romaniche aventi caratteristiche arabo-bizantini - constatiamo quanto le ipotesi<br />
sostenute da alcuni Autori23) , per le quali vennero avanzate affinità stilistiche-costruttive fra<br />
l’architettura francese e quella di San Giacomo, siamo inattendibili.<br />
Crediamo, infatti, che la “purezza” formale della chiesa cornetana, avvicina questa più agli esempi di<br />
“originale” fattura mediterranea, che a quelli che da essa trassero una locale interpretazione artistica.<br />
L’attuale facciata di San Giacomo è caratterizzata da un ordine architettonico di tipo “schematico”.<br />
Trova numerosi riferimenti soprattutto fra le chiese minori: a Roma facciate simili si riscontrano<br />
nelle chiese delle “Congregazioni” come San Eligio dei Ferrari24) la cui facciata dovrebbe risalire al<br />
1565, Sant’Omobono, protettore della Congregazione dei Sarti, realizzata dopo il 157325) e San<br />
Giovanni decollato, appartenente alla Confraternita dei Fiorentini, detta della Misericordia, perché<br />
assisteva i condannati a morte, la cui costruzione avvenne sul finire del XVI secolo. 26)<br />
Tutte e tre queste chiese hanno in comune con quella di San Giacomo il fatto di essere molto più<br />
antiche della loro facciata: infatti, furono realizzate per ridare funzionalità ad edifici ridotti in rovina,<br />
ma la scarsità di denaro, ridusse il restauro ad una semplice ed economica progettazione.<br />
La facciata di San Giacomo, dunque, propone una nuova tematica che riflette quel diffuso e “anti<br />
monumentale” fenomeno che si manifestò nel corso dei secoli XVII e XVIII e che fu caratterizzato<br />
dalla riappropriazione del patrimonio edilizio esistente e dalla sua ristrutturazione, ma tale tema<br />
risulta troppo vasto per essere affrontato adeguatamente in questa relazione.<br />
21)<br />
Creswell Keppel A.C. - vedi bibliografia generale n. 10.<br />
22)<br />
Creswell Keppel A.C. - vedi bibliografia generale n. 10.<br />
23)<br />
Apollonj Ghetti - vedi bibliografia generale n. 1.<br />
24)<br />
Tale Congregazione era suddivisa in “chiavari, chiodaroli, maniscalchi”. Zeppegno L. e Mattanelli R. - vedi<br />
bibliografia generale n. 33.<br />
25)<br />
Era chiamata precedentemente San Salvatore in Portico. E’ collocata nei pressi del Portico d’Ottavia. Zeppegno L. e<br />
Mattanelli R. - vedi bibliografia generale n. 33.<br />
26)<br />
Zeppegno L. e Mattanelli R. - vedi bibliografia generale n. 33.