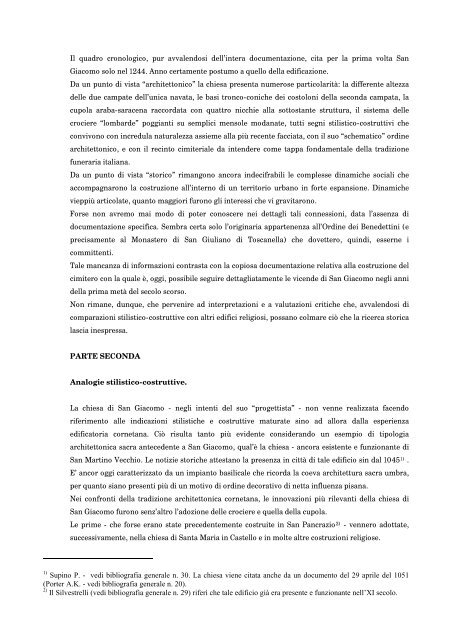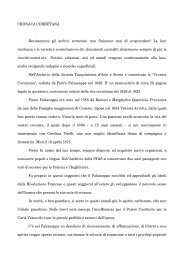Fabrizi F _ Traversi G.C. LA CHIESA DI - Società Tarquiniese Arte e ...
Fabrizi F _ Traversi G.C. LA CHIESA DI - Società Tarquiniese Arte e ...
Fabrizi F _ Traversi G.C. LA CHIESA DI - Società Tarquiniese Arte e ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il quadro cronologico, pur avvalendosi dell’intera documentazione, cita per la prima volta San<br />
Giacomo solo nel 1244. Anno certamente postumo a quello della edificazione.<br />
Da un punto di vista “architettonico” la chiesa presenta numerose particolarità: la differente altezza<br />
delle due campate dell’unica navata, le basi tronco-coniche dei costoloni della seconda campata, la<br />
cupola araba-saracena raccordata con quattro nicchie alla sottostante struttura, il sistema delle<br />
crociere “lombarde” poggianti su semplici mensole modanate, tutti segni stilistico-costruttivi che<br />
convivono con incredula naturalezza assieme alla più recente facciata, con il suo “schematico” ordine<br />
architettonico, e con il recinto cimiteriale da intendere come tappa fondamentale della tradizione<br />
funeraria italiana.<br />
Da un punto di vista “storico” rimangono ancora indecifrabili le complesse dinamiche sociali che<br />
accompagnarono la costruzione all’interno di un territorio urbano in forte espansione. Dinamiche<br />
vieppiù articolate, quanto maggiori furono gli interessi che vi gravitarono.<br />
Forse non avremo mai modo di poter conoscere nei dettagli tali connessioni, data l’assenza di<br />
documentazione specifica. Sembra certa solo l’originaria appartenenza all’Ordine dei Benedettini (e<br />
precisamente al Monastero di San Giuliano di Toscanella) che dovettero, quindi, esserne i<br />
committenti.<br />
Tale mancanza di informazioni contrasta con la copiosa documentazione relativa alla costruzione del<br />
cimitero con la quale è, oggi, possibile seguire dettagliatamente le vicende di San Giacomo negli anni<br />
della prima metà del secolo scorso.<br />
Non rimane, dunque, che pervenire ad interpretazioni e a valutazioni critiche che, avvalendosi di<br />
comparazioni stilistico-costruttive con altri edifici religiosi, possano colmare ciò che la ricerca storica<br />
lascia inespressa.<br />
PARTE SECONDA<br />
Analogie stilistico-costruttive.<br />
La chiesa di San Giacomo - negli intenti del suo “progettista” - non venne realizzata facendo<br />
riferimento alle indicazioni stilistiche e costruttive maturate sino ad allora dalla esperienza<br />
edificatoria cornetana. Ciò risulta tanto più evidente considerando un esempio di tipologia<br />
architettonica sacra antecedente a San Giacomo, qual’è la chiesa - ancora esistente e funzionante di<br />
San Martino Vecchio. Le notizie storiche attestano la presenza in città di tale edificio sin dal 10451) .<br />
E’ ancor oggi caratterizzato da un impianto basilicale che ricorda la coeva architettura sacra umbra,<br />
per quanto siano presenti più di un motivo di ordine decorativo di netta influenza pisana.<br />
Nei confronti della tradizione architettonica cornetana, le innovazioni più rilevanti della chiesa di<br />
San Giacomo furono senz’altro l’adozione delle crociere e quella della cupola.<br />
Le prime - che forse erano state precedentemente costruite in San Pancrazio2) - vennero adottate,<br />
successivamente, nella chiesa di Santa Maria in Castello e in molte altre costruzioni religiose.<br />
1)<br />
Supino P. - vedi bibliografia generale n. 30. La chiesa viene citata anche da un documento del 29 aprile del 1051<br />
(Porter A.K. - vedi bibliografia generale n. 20).<br />
2)<br />
Il Silvestrelli (vedi bibliografia generale n. 29) riferì che tale edificio già era presente e funzionante nell’XI secolo.