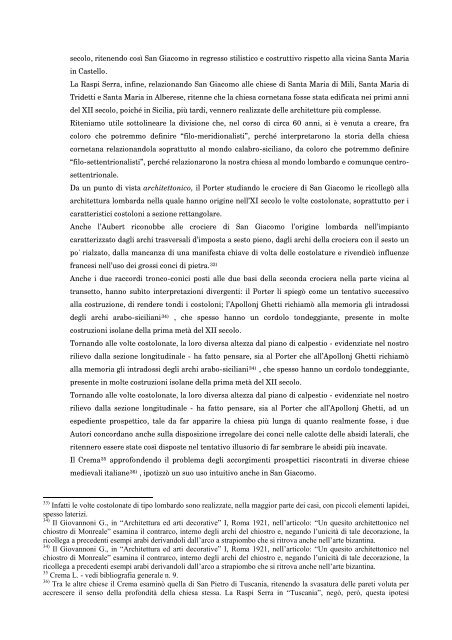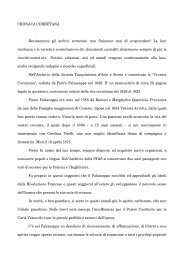Fabrizi F _ Traversi G.C. LA CHIESA DI - Società Tarquiniese Arte e ...
Fabrizi F _ Traversi G.C. LA CHIESA DI - Società Tarquiniese Arte e ...
Fabrizi F _ Traversi G.C. LA CHIESA DI - Società Tarquiniese Arte e ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
secolo, ritenendo così San Giacomo in regresso stilistico e costruttivo rispetto alla vicina Santa Maria<br />
in Castello.<br />
La Raspi Serra, infine, relazionando San Giacomo alle chiese di Santa Maria di Mili, Santa Maria di<br />
Tridetti e Santa Maria in Alberese, ritenne che la chiesa cornetana fosse stata edificata nei primi anni<br />
del XII secolo, poiché in Sicilia, più tardi, vennero realizzate delle architetture più complesse.<br />
Riteniamo utile sottolineare la divisione che, nel corso di circa 60 anni, si è venuta a creare, fra<br />
coloro che potremmo definire “filo-meridionalisti”, perché interpretarono la storia della chiesa<br />
cornetana relazionandola soprattutto al mondo calabro-siciliano, da coloro che potremmo definire<br />
“filo-settentrionalisti”, perché relazionarono la nostra chiesa al mondo lombardo e comunque centro-<br />
settentrionale.<br />
Da un punto di vista architettonico, il Porter studiando le crociere di San Giacomo le ricollegò alla<br />
architettura lombarda nella quale hanno origine nell’XI secolo le volte costolonate, soprattutto per i<br />
caratteristici costoloni a sezione rettangolare.<br />
Anche l’Aubert riconobbe alle crociere di San Giacomo l’origine lombarda nell’impianto<br />
caratterizzato dagli archi trasversali d’imposta a sesto pieno, dagli archi della crociera con il sesto un<br />
po' rialzato, dalla mancanza di una manifesta chiave di volta delle costolature e rivendicò influenze<br />
francesi nell’uso dei grossi conci di pietra. 33)<br />
Anche i due raccordi tronco-conici posti alle due basi della seconda crociera nella parte vicina al<br />
transetto, hanno subìto interpretazioni divergenti: il Porter li spiegò come un tentativo successivo<br />
alla costruzione, di rendere tondi i costoloni; l’Apollonj Ghetti richiamò alla memoria gli intradossi<br />
degli archi arabo-siciliani34) , che spesso hanno un cordolo tondeggiante, presente in molte<br />
costruzioni isolane della prima metà del XII secolo.<br />
Tornando alle volte costolonate, la loro diversa altezza dal piano di calpestio - evidenziate nel nostro<br />
rilievo dalla sezione longitudinale - ha fatto pensare, sia al Porter che all’Apollonj Ghetti richiamò<br />
alla memoria gli intradossi degli archi arabo-siciliani34) , che spesso hanno un cordolo tondeggiante,<br />
presente in molte costruzioni isolane della prima metà del XII secolo.<br />
Tornando alle volte costolonate, la loro diversa altezza dal piano di calpestio - evidenziate nel nostro<br />
rilievo dalla sezione longitudinale - ha fatto pensare, sia al Porter che all’Apollonj Ghetti, ad un<br />
espediente prospettico, tale da far apparire la chiesa più lunga di quanto realmente fosse, i due<br />
Autori concordano anche sulla disposizione irregolare dei conci nelle calotte delle absidi laterali, che<br />
ritennero essere state così disposte nel tentativo illusorio di far sembrare le absidi più incavate.<br />
Il Crema35 approfondendo il problema degli accorgimenti prospettici riscontrati in diverse chiese<br />
medievali italiane36) , ipotizzò un suo uso intuitivo anche in San Giacomo.<br />
33)<br />
Infatti le volte costolonate di tipo lombardo sono realizzate, nella maggior parte dei casi, con piccoli elementi lapidei,<br />
spesso laterizi.<br />
34)<br />
Il Giovannoni G., in “Architettura ed arti decorative” I, Roma 1921, nell’articolo: “Un quesito architettonico nel<br />
chiostro di Monreale” esamina il contrarco, interno degli archi del chiostro e, negando l’unicità di tale decorazione, la<br />
ricollega a precedenti esempi arabi derivandoli dall’arco a strapiombo che si ritrova anche nell’arte bizantina.<br />
34)<br />
Il Giovannoni G., in “Architettura ed arti decorative” I, Roma 1921, nell’articolo: “Un quesito architettonico nel<br />
chiostro di Monreale” esamina il contrarco, interno degli archi del chiostro e, negando l’unicità di tale decorazione, la<br />
ricollega a precedenti esempi arabi derivandoli dall’arco a strapiombo che si ritrova anche nell’arte bizantina.<br />
35<br />
Crema L. - vedi bibliografia generale n. 9.<br />
36)<br />
Tra le altre chiese il Crema esaminò quella di San Pietro di Tuscania, ritenendo la svasatura delle pareti voluta per<br />
accrescere il senso della profondità della chiesa stessa. La Raspi Serra in “Tuscania”, negò, però, questa ipotesi