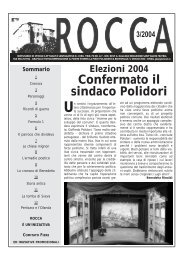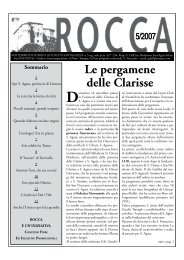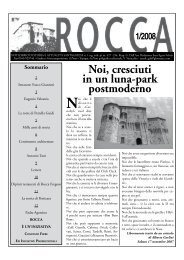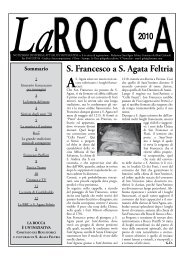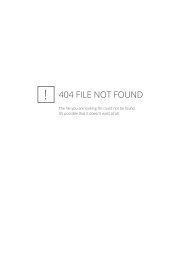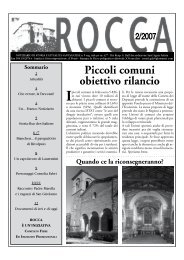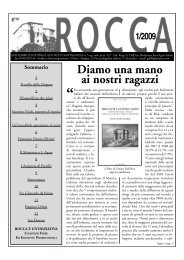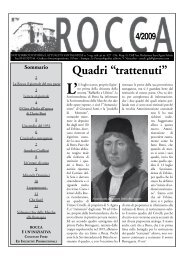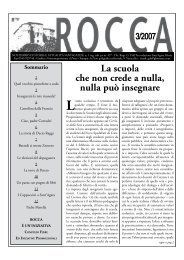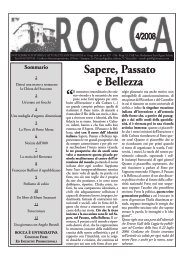ROCCA aprile 2004 - La Rocca - il giornale di Sant'Agata Feltria ...
ROCCA aprile 2004 - La Rocca - il giornale di Sant'Agata Feltria ...
ROCCA aprile 2004 - La Rocca - il giornale di Sant'Agata Feltria ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NOTIZIARIO DI STORIA E ATTUALITÀ SANTAGATESE N. 4 REG. TRIB. PS NR. 427 - DIR. RESP. G. DALL’ARA REDAZIONE SANT’AGATA FELTRIA<br />
FAX 0541/929744 - GRAFICA E FOTOCOMPOSIZIONE IL PONTE STAMPA LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORIALE, V. VERUCCHIO - EMAIL gda@glomanet.com<br />
Sommario<br />
2<br />
Sergio Zavoli e Ragazzini<br />
3<br />
Il santagatese rivoluzionario<br />
4<br />
Il paese contro <strong>il</strong> parroco<br />
5<br />
Att<strong>il</strong>io Ugolini, un amico<br />
6<br />
Lorenzo Maffei<br />
7<br />
Il Montefeltro ambito<br />
8<br />
Omaggio a Enzo Antinori<br />
9<br />
<strong>La</strong> campana <strong>di</strong> Carpegna<br />
10<br />
Campobin<strong>di</strong><br />
11<br />
Anni penuriosi<br />
12<br />
Le origini della Indel B<br />
<strong>ROCCA</strong><br />
È UN’INIZIATIVA<br />
COMITATO FIERE<br />
ED INIZIATIVE PROMOZIONALI<br />
Quei sig<strong>il</strong>li all’interno del<br />
Comune, posti su alcuni arma<strong>di</strong>,<br />
li avevano notati in parecchi<br />
citta<strong>di</strong>ni. A nessuno, però, era venuto<br />
in mente <strong>di</strong> indagare sulla loro reale<br />
portata. I primi ad accorgersi che qualcosa<br />
non quadrava sono stati i giornalisti<br />
del settimanale riminese <strong>il</strong> Ponte.<br />
Qualche visita, una telefonata alla<br />
Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, una serie <strong>di</strong> interviste<br />
e la storia è finita nera su bianco.<br />
Cosa è accaduto? Che la Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />
Finanza <strong>di</strong> Novafeltia ha posto sotto<br />
sequestro alcuni incartamenti del<br />
comune feretrano: nessuna ipotesi <strong>di</strong><br />
reato, si affrettano a spiegare dalla brigata<br />
<strong>di</strong> via Molari. Ma intanto da settimane<br />
è in atto una fase istruttoria e<br />
riguarda la regolarità <strong>di</strong> alcune procedure<br />
adottate per ban<strong>di</strong>re l’assegnazione<br />
<strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> ripristino <strong>di</strong> alcune aree<br />
del paese. Finanziate con la legge sui<br />
terremoti, circa 5 m<strong>il</strong>ioni <strong>di</strong> euro,<br />
riguardano in particolare la zona della<br />
grande frana <strong>di</strong> Montalcino, piazza<br />
mercato, e la zona Marecchiola.<br />
L’Autorità dei <strong>La</strong>vori Pubblici ha mosso<br />
alcuni r<strong>il</strong>ievi all’Amministrazione santagatese<br />
(“girati” per conoscenza alla<br />
Procura della Repubblica <strong>di</strong> Pesaro): la<br />
contestazione riguarda l’affidamento<br />
2/<strong>2004</strong><br />
Dieci m<strong>il</strong>iar<strong>di</strong><br />
sotto sig<strong>il</strong>lo<br />
degli incarichi per i lavori eseguiti<br />
Secondo i r<strong>il</strong>ievi dell’Autorità, i lavori<br />
andavano assegnati tramite bando <strong>di</strong><br />
evidenza europea.<br />
Il sindaco Goffredo Polidori è sereno.<br />
“Non abbiamo commesso alcun <strong>il</strong>lecito.<br />
- ha detto a <strong>il</strong> Ponte - Probab<strong>il</strong>mente<br />
si tratta <strong>di</strong> un <strong>di</strong>sguido: l’Autorità ha<br />
letto ‘lotti’ ma in realtà si tratta <strong>di</strong> progetti<br />
<strong>di</strong>versi che riguardano zone <strong>di</strong>fferenti<br />
e senza continuità. Per questo<br />
motivo sono stati affidati agli stessi<br />
progettisti del primo stralcio”. Il legale<br />
del Comune, l’avvocato bolognese<br />
Graziosi, dopo la valutazione degli<br />
incartamenti con <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e unico<br />
del proce<strong>di</strong>mento, l’ing. Giacobbi e i<br />
tecnici, è fiducioso: a suo giu<strong>di</strong>zio tutto<br />
si risolverà senza ripercussioni per<br />
l’amministrazione.<br />
Quei sig<strong>il</strong>li nel frattempo frenano la<br />
macchina comunale. E alcune pratiche<br />
restano sospese. Il primo citta<strong>di</strong>no si<br />
augura che gli accertamenti non<br />
“impantanino” la macchina comunale.<br />
<strong>La</strong> questione dei sig<strong>il</strong>li comunque interessa<br />
l’intera citta<strong>di</strong>nanza, è necessario<br />
fare chiarezza. Anche perché ci sono<br />
ancora tre “lotti” non finanziati, tre aree<br />
a rischio che attendono lavori <strong>di</strong> recupero.<br />
(M.C.)
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong> Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
Sergio Zavoli, Ciro<br />
Ragazzini e la Memoria<br />
In un lungo articolo pubblicato sul resto del Carlino l’8<br />
marzo <strong>2004</strong> dal titolo “Non processate la memoria” Sergio<br />
Zavoli cita un episo<strong>di</strong>o che riguarda <strong>il</strong> nostro concitta<strong>di</strong>no<br />
Ciro Ragazzini. Eccolo testualmente: “Perché quando<br />
Ragazzini l’impresario, portava a Teatro Novelli la stagione<br />
d’opera, nel coro ingaggiato sul posto c’era sempre un ex<br />
carrettiere con la voce da basso che non cantava più da<br />
trent’anni, afono e senza lavoro e lo sapevano tutti tranne <strong>il</strong><br />
<strong>di</strong>rettore d’orchestra e l’amministratore”.<br />
Va bene che l’articolo ha per titolo “Non processate la memoria”,<br />
ma va detto che non è la prima volta che <strong>il</strong> Senatore<br />
Zavoli cita questo episo<strong>di</strong>o. Nel suo libro “Socialista <strong>di</strong> Dio”,<br />
uscito molti anni fa, lo stesso Zavoli scrive “Quando<br />
Ragazzini portava al Teatro Novelli la stagione d’opera, nel<br />
coro ingaggiato sul posto c’era sempre un ex carrettiere che<br />
non cantava più da trent’anni, afono come un pesce, e lo<br />
sapevano tutti tranne l’impresario e <strong>il</strong> maestro”.<br />
In ogni caso, come già abbiamo scritto, l’episo<strong>di</strong>o, oltre che<br />
strano per chi conosceva Ragazzini, è anche sconosciuto ai<br />
santagatesi; ma se tra i nostri lettori c’è qualcuno che ha una<br />
buona Memoria e sa qualcosa <strong>di</strong> più, è pregato <strong>di</strong> farcelo<br />
sapere prima che Zavoli lo scriva un’altra volta.<br />
Casteldelci e Tonino<br />
Il 14 marzo <strong>di</strong> quest’anno <strong>il</strong> Resto del Carlino ha ospitato<br />
nella pagina della cultura un bell’articolo <strong>di</strong> Tonino Guerra<br />
de<strong>di</strong>cato a Casteldelci. Il titolo dell’articolo è “<strong>La</strong> prima luce<br />
del mondo”. Anche se <strong>il</strong> linguaggio <strong>di</strong> Guerra è sui generis<br />
(parla <strong>di</strong> spiritualità dei ruderi, <strong>di</strong> f<strong>il</strong>i d’erba, <strong>di</strong> case abban-<br />
Franco Vicini e Giuseppe Boldrini alla cena della<br />
<strong>Rocca</strong> 10 anni fa<br />
CRONACA<br />
2<br />
donate, <strong>di</strong> ombre granulose, <strong>di</strong> piccole trasparenze, <strong>di</strong> luoghi<br />
abbandonati), emerge una immagine <strong>di</strong> Casteldelci molto<br />
accattivante.<br />
Una e-ma<strong>il</strong> dalla<br />
Gran Bretagna<br />
Recentemente ho scoperto che <strong>il</strong> nome <strong>di</strong> Frampoli è anche<br />
<strong>il</strong> nome <strong>di</strong> un paesino in Ungheria.<br />
Un certo Ildo Frampuli emigrò negli Stati Uniti nel 1912. Era<br />
nato in un paesino che si chiama Durnholz/Valdurno,<br />
nell’Alto A<strong>di</strong>ge, e un v<strong>il</strong>laggio circondato dalle montagne.<br />
Ora chiedo ai lettori della <strong>Rocca</strong>: ci sono molti italiani che<br />
abitavano vicino all’Austria e che emigrarono a Sant’Agata?<br />
P.S. <strong>il</strong> Dottore Giuseppe Greci, figlio <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando, era nato<br />
nel 1821 a Sant’Agata, deceduto a 74 anni nel 1895. Abitava<br />
a Mercatino.<br />
Cor<strong>di</strong>ali saluti a tutti, Ciao, Evelina Cottingham<br />
<strong>La</strong> fiera <strong>di</strong> Pugliano<br />
<strong>La</strong> tesi <strong>di</strong> <strong>La</strong>urea <strong>di</strong> Enrico Bini è <strong>di</strong>ventata un libro accessib<strong>il</strong>e<br />
a tutti. Ha per titolo “<strong>La</strong> tra<strong>di</strong>zione delle fiere a Pugliano<br />
e nel Montefeltro”, ed è stato pubblicato dalla<br />
Confcommercio <strong>di</strong> Pesaro nel mese <strong>di</strong> febbraio <strong>2004</strong>. Il libro<br />
è decisamente interessante, si basa su <strong>di</strong> un importante apparato<br />
bibliografico, e contiene una prefazione <strong>di</strong> Girolamo<br />
Allegretti. <strong>La</strong> <strong>Rocca</strong> ha già pubblicato in anteprima una sintesi<br />
della tesi <strong>di</strong> Enrico Bini, relativa in particolare alle fiere<br />
<strong>di</strong> S. Agata <strong>Feltria</strong>. Felicitazioni all’autore e alla<br />
Confcommercio, per la sensib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong>mostrata con la pubblicazione<br />
del libro.<br />
Giorgio Capannelli (sost)<br />
Miramare <strong>di</strong> Rimini<br />
Angelo Valbruccioli (ben)<br />
Ravenna<br />
G<strong>il</strong>berto Mor<strong>di</strong>ni, S. Agata<br />
Guido Gui<strong>di</strong> (sost), S. Agata<br />
Italo Dolci, Casteldelci<br />
Rinal<strong>di</strong> Emi<strong>di</strong>o Bologna<br />
Rinal<strong>di</strong> Maria Talamello<br />
Renzo Paci (sost.), S. Agata<br />
Pierre Dominici (benemerito)<br />
Parigi<br />
Miranda Dominici (benemerita)<br />
SOTTOSCRIZIONI<br />
Rennes (F.)<br />
Gianfranca Sampaoli (sost)<br />
Peschiera Borromeo<br />
Eden Cedrini, Petrella Gui<strong>di</strong><br />
Istituto Suore <strong>di</strong> S. Dorotea, S.<br />
Agata<br />
Rita Agostini (sost) S. Agata<br />
Pierluigi Vicini, (sost) S. Agata<br />
Giancarlo Bonetti, Rimini<br />
Telesforo Tomei, Ponte M.<br />
Baffoni<br />
Marino Moretti (benemerito),<br />
Romagnano<br />
Come e quanto sottoscrivere?<br />
Or<strong>di</strong>nario 13 Euro - Sostenitore 15 Euro<br />
Benemerito 25 Euro<br />
Le sottoscrizioni possono essere inviate alla redazione della<br />
<strong>Rocca</strong>, Casella Postale 26, 61019 S. Agata <strong>Feltria</strong> (Pesaro),<br />
oppure possono essere consegnate ai vari collaboratori che<br />
<strong>di</strong>stribuiscono (volontariamente) <strong>il</strong> <strong>giornale</strong> a S. Agata,<br />
Novafeltria e nei paesi vicini.<br />
Se siete alla ricerca <strong>di</strong> un numero arretrato della <strong>Rocca</strong> potete<br />
rivolgervi ad Arrigo Bonci, o a Paola Boldrini, nei rispettivi<br />
negozi in piazza Garibal<strong>di</strong> a S. Agata.
Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
PERSONAGGI<br />
Santagatese rivoluzionario<br />
a Spoleto: ecco chi era<br />
Se avete letto l’ultimo numero<br />
della <strong>Rocca</strong> ricorderete certo la<br />
vicenda del santagatese rivoluzionario<br />
e sacr<strong>il</strong>ego, del quale scrisse<br />
<strong>il</strong> futuro Papa Pio IX, quando era<br />
ancora Vescovo <strong>di</strong> Spoleto. Ecco i fatti<br />
del due novembre 1830: “Nella piazza<br />
<strong>di</strong> San Domenico sta <strong>di</strong>pinto al muro<br />
un’immagine del Redentore che porta<br />
la Croce e nell’Atrio della Cattedrale<br />
avvi una Croce piantata dal lato sinistro.<br />
Alcuni sacr<strong>il</strong>eghi nella detta notte<br />
hanno imbrattato e graffiato <strong>il</strong> volto<br />
del Redentore, ed hanno spezzato la<br />
detta Croce. Non contenti <strong>di</strong> questo<br />
hanno tolti alcuni gra<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> pietra<br />
posti davanti a una piccola Chiesa<br />
sotto <strong>il</strong> titolo <strong>di</strong> SS. Giovanni e Paolo,<br />
collocandone i pezzi nel mezzo <strong>di</strong> una<br />
strada scoscesa”. Le indagini portarono<br />
in carcere “tre in<strong>di</strong>vidui, due<br />
Spoletini ed uno <strong>di</strong> S. Agata <strong>Feltria</strong>,<br />
figlio <strong>di</strong> un secon<strong>di</strong>no della Darsena,<br />
stato già m<strong>il</strong>itare nel Pontificio<br />
Governo, e domic<strong>il</strong>iato da qualche<br />
anno in Spoleto”.<br />
Per saperne <strong>di</strong> più abbiamo scritto<br />
all’autore del libro su Papa Pio IX,<br />
Andrea Tornielli, che ci ha gent<strong>il</strong>mente<br />
risposto fornendo ulteriori informazioni<br />
sui fatti e <strong>il</strong> nome del santagatese<br />
coinvolto. Dietro quell’episo<strong>di</strong>o, e<br />
gli altri che seguiranno vi sono alcuni<br />
rifugiati politici, alcuni agitatori, ecco<br />
le parole del Papa: “Difatti <strong>di</strong>etro<br />
nuove ricerche si conosce che l’estensione<br />
del sospetto e <strong>di</strong> sospetto fondato<br />
cade sui Rifugiati. Tutti però e<br />
carcerati e rifugiati sono dell’infima<br />
classe del popolo, calzolai, fabbri, e<br />
fra i rifugiati vi è un tal Buselli romagnolo<br />
<strong>di</strong> professione cocchiere presso<br />
un Mercante <strong>di</strong> Spoleto <strong>di</strong> nome<br />
Fagani. Uno solo dei carcerati, quello<br />
<strong>di</strong> S. Agata <strong>Feltria</strong>, per nome Giuseppe<br />
Biagiolini è stato assoggettato all’esame,<br />
e si mantiene nella negativa. Egli<br />
però è già caduto in contrad<strong>di</strong>zione<br />
asserendo <strong>di</strong> essersi trovato in casa<br />
senza più escirne circa un’ora <strong>di</strong> notte,<br />
mentre da più testimoni risulta <strong>di</strong><br />
essere stato incontrato alle tre ore”.<br />
Andrea Tornielli, famoso vaticanista,<br />
3<br />
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong><br />
ci segnala che chi desiderasse leggere<br />
la lettera del Papa integralmente può<br />
trovarla in ALBERTO SERAFINI, Pio<br />
IX, vol. I, Libreria E<strong>di</strong>trice Vaticana<br />
1958, pp. 463-464. E’ <strong>il</strong> volume che<br />
pubblica quasi integralmente la corrispondenza<br />
<strong>di</strong> Mastai Ferretti fino al<br />
momento dell’elezione papale.<br />
Monsignor Serafini a sua volta, ha<br />
preso la lettera dall’Elenchus<br />
Scriptorum, n. 257. <strong>La</strong> lettura della<br />
data è un po’ dubbia, ma sembra più<br />
probab<strong>il</strong>e <strong>il</strong> 5 anziché <strong>il</strong> 3 novembre<br />
1830.<br />
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong>, <strong>il</strong> <strong>giornale</strong> del tuo paese<br />
Le vostre foto nel nostro sito, prendete nota del nuovo in<strong>di</strong>rizzo<br />
Tutti i sottoscrittori che ci faranno avere la loro fotografia, potranno rivedersi<br />
nel sito web della <strong>Rocca</strong>. Se è da molto tempo che non lo visitate fatelo<br />
subito! Il sito web curato da Gino Sampaoli è ora pieno <strong>di</strong> informazioni e <strong>di</strong><br />
fotografie ine<strong>di</strong>te del nostro paese. Aiutateci a realizzare la sezione in <strong>di</strong>aletto<br />
e prendete nota del nuovo in<strong>di</strong>rizzo - http://santagata.altervista.org/<br />
A scuola <strong>di</strong> <strong>di</strong>aletto<br />
Il nostro Gino Sampaoli sta organizzando – da M<strong>il</strong>ano - una nuova sezione<br />
del sito web: "A scuola <strong>di</strong> <strong>di</strong>aletto". Per far questo avrebbe bisogno <strong>di</strong> qualcuno<br />
che lo potesse aiutare da S. Agata F.. Un'idea potrebbe essere quella <strong>di</strong><br />
coinvolgere gli insegnanti ed i bambini delle Scuole per aiutare <strong>il</strong> sito a documentare<br />
<strong>il</strong> nostro <strong>di</strong>aletto.<br />
Abbiamo bisogno del tuo contributo!<br />
Con questo numero comincia <strong>il</strong> nostro 11° anno. Grazie ai volontari che<br />
hanno provveduto a scrivere e <strong>di</strong>stribuire <strong>il</strong> <strong>giornale</strong>, grazie alle fotografie <strong>di</strong><br />
Enzo Liverani e Marco Zanchini, ad Arrigo Bonci che coor<strong>di</strong>na la <strong>di</strong>stribuzione,<br />
e grazie ai lettori e sostenitori, numerosi come sempre. Se <strong>il</strong> <strong>giornale</strong><br />
vi piace <strong>di</strong>telo ai vostri amici, e chiedete loro <strong>di</strong> sottoscrivere, per ricevere<br />
regolarmente la <strong>Rocca</strong>! Se volete aiutarci a fare più bello questo <strong>giornale</strong>,<br />
inviateci articoli, fotografie, ricor<strong>di</strong>, lettere e commenti. Se non siete d'accordo<br />
con <strong>il</strong> contenuto degli articoli pubblicati, o più semplicemente volete <strong>di</strong>re<br />
la vostra opinione, scriveteci.
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong> Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
STORIA<br />
Il paese contro <strong>il</strong> Parroco<br />
Nelle prime due puntate abbiamo<br />
visto come Don Bonaccorsi<br />
sia riuscito a fare <strong>il</strong> parroco <strong>di</strong><br />
S. Agata <strong>di</strong>videndo <strong>il</strong> paese e creando<br />
grossi problemi alla Giunta Comunale,<br />
alle organizzazioni politiche guidate<br />
dai repubblicani e al Vescovo, ma<br />
creando soprattutto grossi scandali. <strong>La</strong><br />
vicenda si trascinò per una decina <strong>di</strong><br />
ann. <strong>La</strong> <strong>Rocca</strong> la racconta per la prima<br />
volta. Ecco la terza puntata.<br />
Le accuse contro don Bonaccorsi continuano<br />
e finiscono tutte a Pennab<strong>il</strong>li,<br />
sulla scrivania del Vescovo. Nel luglio<br />
1910 <strong>il</strong> Bonaccorsi è accusato <strong>di</strong> frequentare<br />
una cantina, ma si <strong>di</strong>scolpa<br />
<strong>di</strong>cendo che era semplicemente entrato<br />
nella cantina del fu Severino Celli,<br />
non in una riven<strong>di</strong>ta, per assaggiare<br />
un vino nuovo, del quale peraltro ne<br />
aveva bevuto solo un bicchiere.<br />
I rapporti con molti paesani sono<br />
molto tesi al punto che <strong>il</strong> Presidente<br />
della Congregazione <strong>di</strong> Carità, nel<br />
mese <strong>di</strong> agosto del 1911, chiede<br />
espressamente al Vescovo che per la<br />
bene<strong>di</strong>zione degli arre<strong>di</strong> sacri della<br />
chiesina dell’Ospedale, nell’attuale via<br />
Benucci, sia inviato un altro sacerdote.<br />
Nel 1912 scoppia un nuovo scandalo.<br />
Qualche giorno prima della festa <strong>di</strong> S.<br />
Agata un gruppo <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni scrive al<br />
Vescovo per segnalare che l’Economo<br />
Spirituale sta per commettere un grave<br />
errore <strong>di</strong> Rito o Canone Ecclesiastico,<br />
alcune signorine infatti sotto la <strong>di</strong>rezione<br />
<strong>di</strong> una “d<strong>il</strong>ettante in musica” si<br />
stanno preparando per cantare la<br />
messa del 5 febbraio. Il gruppo si riunisce<br />
tutti i giorni in Chiesa. I firmatari<br />
della lettera sostengono anche che<br />
un gruppo <strong>di</strong> giovani cantori non è<br />
stato accettato da Bonaccorsi.<br />
Lo “scandalo” è nel fatto che <strong>di</strong>rettrice,<br />
signorine che cantano e organo, si<br />
configurano come un’orchestra più<br />
adatta a situazioni profane.<br />
Sulla stessa questione un’altra lettera<br />
firmata da Saveria Liverani, Italia<br />
Bonci, Em<strong>il</strong>ia Giorgi, Gemma Macori,<br />
Can<strong>di</strong>da Ermeti, Armida Marianni,<br />
Giustina Vicini, Cesira Ragazzini,<br />
Edvige Ragazzini, Leda Ragazzini,<br />
in<strong>di</strong>rizzata a Don Carlo Bonaccorsi,<br />
contesta la rappresentazione in programma<br />
perché‚ contraria ai decreti <strong>di</strong><br />
Papa Pio X (“E ‘rigorosamente proibito<br />
alle cosiddette banche musicali <strong>di</strong><br />
suonare in Chiesa”), ed invita ad<br />
impe<strong>di</strong>re “tale esecuzione”.<br />
<strong>La</strong> Curia <strong>di</strong> Pennab<strong>il</strong>li verifica che<br />
l’informazione ricevuta risponda al<br />
vero e imme<strong>di</strong>atamente dopo, con<br />
telegramma del 3 febbraio, comunica:<br />
“vietato donne cantare Chiesa”.<br />
Il 4 febbraio, vig<strong>il</strong>ia <strong>di</strong> S. Agata, parte<br />
una lettera a firma della <strong>di</strong>rettrice del<br />
coro Maria Bellocchi e della pianista<br />
Carmen Para. “Siamo rimaste sorprese<br />
e addolorate” <strong>di</strong>cono “nel sapere che<br />
ha proibito che cantiamo nella nostra<br />
Chiesa la messa sacra ad onore della<br />
nostra protettrice”. Le signorine chiariscono<br />
che l’intento era solo <strong>di</strong> tipo<br />
religioso, e che <strong>il</strong> gruppo era sorto<br />
solo per onorare adeguatamente<br />
Sant’Agata, ed ora si trova deluso dal<br />
Parroco che impe<strong>di</strong>sce loro la rappresentazione.<br />
Chiariscono che <strong>il</strong> coro ha<br />
intenzione <strong>di</strong> cantare <strong>di</strong>etro ad una<br />
tenda, proprio per non trasformare la<br />
cerimonia da sacra a profana, e concludono<br />
riaffermando la loro volontà<br />
<strong>di</strong> cantare in Chiesa.<br />
Il 5 febbraio alle 9 del mattino<br />
Monsignor Riccar<strong>di</strong>, Vicario Generale,<br />
risponde con un telegramma in<strong>di</strong>rizzato<br />
all’Arciprete: “Compreso circostanze<br />
tollero esecuzione musicale vietando<br />
ripetersi inconvenienti”.<br />
L’episo<strong>di</strong>o finisce sulla stampa sotto <strong>il</strong><br />
titolo “Discor<strong>di</strong>e”: "Alla vig<strong>il</strong>ia della<br />
festa la nostra Curia proibì secondo la<br />
liturgia che le signorine cantassero in<br />
Chiesa. Dal popolo - prosegue l’articolo<br />
- questa proibizione fu accettata<br />
con entusiasmo perché <strong>il</strong> cantare la<br />
messa da parte <strong>di</strong> dette signorine veniva<br />
a dare una sod<strong>di</strong>sfazione al prete,<br />
che è mal tollerato da 10 anni dal<br />
paese. Alle signorine <strong>di</strong>spiaceva non<br />
far sentire le melo<strong>di</strong>ose loro voci in<br />
Chiesa, benché nei giorni precedenti<br />
detta Messa venisse da esse cantata<br />
nei caffè, nelle bettole e nelle vie stesse<br />
del paese, come se si trattasse <strong>di</strong><br />
canzoni popolari. Così si sono riunite<br />
ed hanno scritto una lettera che ha<br />
commosso <strong>il</strong> debol cuore del Vicario<br />
del Vescovo che, calpestando la liturgia,<br />
con or<strong>di</strong>ne telegrafico sopprimeva<br />
la prima proibizione. L’articolo termina<br />
con un chiaro riferimento al<br />
Bonaccorsi, “sarebbe meglio che la<br />
Curia pensasse <strong>di</strong> togliere la causa <strong>di</strong><br />
tante <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>e in questo paese”.<br />
Nel frattempo però la Curia <strong>di</strong><br />
Pennab<strong>il</strong>li ha inviato come Cappellano<br />
(ed anche come informatore) a S.<br />
Agata, Don Baldassini, anche se ufficialmente<br />
ancora non è stato riferito<br />
nulla al Bonaccorsi, che così nei rap-<br />
4<br />
porti interpersonali mostra <strong>di</strong> ignorarlo.<br />
Come da incarico avuto, però, Don<br />
Baldassini scrive ripetutamente a<br />
Pennab<strong>il</strong>li per far sapere cosa sta accadendo<br />
in paese:<br />
- <strong>il</strong> 7 febbraio comunica che <strong>il</strong> permesso<br />
del Vicario è stato raccolto con<br />
sdegno da "molti onesti citta<strong>di</strong>ni", tra i<br />
quali <strong>il</strong> Sindaco e <strong>il</strong> <strong>di</strong>rettore scolastico,<br />
e descrive scandalizzato come la<br />
Messa fosse “intramezzata da suoni<br />
ballab<strong>il</strong>i”. A suo parere i santagatesi<br />
vogliono sapere se nel Montefeltro ci<br />
sia ancora una Curia;<br />
- <strong>il</strong> 12 febbraio racconta che la messa<br />
musicata ha avuto come risultato un<br />
manifesto affisso da mano ignota che<br />
contiene oltraggi contro Baldassini,<br />
Vittorio Buffoni (definito nel manifesto<br />
"figlio <strong>di</strong> un negoziante celebre per i<br />
fallimenti, vagabondo e girovago"),<br />
Donini “frate sfratato”, <strong>La</strong>ura Giorgi<br />
“che ha regalato al marito una corona<br />
<strong>di</strong> figli non suoi”, Clarice Giorgi “maestra<br />
<strong>di</strong> mal<strong>di</strong>cenze”. Don Baldassini<br />
pensa che <strong>di</strong>etro quel manifesto ci<br />
possa essere “un prete”.<br />
- Don Bonaccorsi sta per assentarsi<br />
dalla Parrocchia per qualche giorno e<br />
la lascerà, anziché affidata al<br />
Baldassini, in mano al Padre<br />
Guar<strong>di</strong>ano.<br />
Don Baldassini chiede infine che la<br />
Curia si interessi urgentemente <strong>di</strong> S.<br />
Agata, paese nel quale tutti protestano<br />
contro la Curia.<br />
Come si vede la situazione in paese è<br />
precipitata.<br />
Il 14 febbraio 1912 <strong>il</strong> Vicario Generale<br />
della Diocesi Feretrana, Monsignor<br />
Riccar<strong>di</strong>, considerata l’assenza non<br />
giustificata del Parroco-eletto Don<br />
Bonaccorsi, e visto che la parrocchia<br />
non può rimanere senza pastore, incarica<br />
<strong>il</strong> cappellano Don F<strong>il</strong>ippo<br />
Baldassini <strong>di</strong> prendere cura e regime<br />
della Parrocchia <strong>di</strong> S. Agata.<br />
Il 29 febbraio Don Baldassini scrive<br />
alla Curia: “Ieri sera, dopo 16 giorni, è<br />
arrivato Bonaccorsi, subito ha ripreso<br />
<strong>il</strong> regime della Parrocchia non tenendo<br />
conto del decreto da Lei fatto... non<br />
tiene conto delle facoltà date a me... e<br />
non ne vuol sapere. Io non so fino a<br />
qual punto si estende <strong>il</strong> decreto da Lei<br />
firmato, Lei stesso giu<strong>di</strong>chi e decida<br />
della condotta del Bonaccorsi”.<br />
(Fine terza puntata.<br />
Appuntamento per la quarta<br />
ed ultima puntata sul prossimo<br />
numero della <strong>Rocca</strong>)
Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
Il nostro amico<br />
Att<strong>il</strong>io<br />
Èparticolarmente <strong>di</strong>ffic<strong>il</strong>e trovare le parole per dare<br />
notizia della scomparsa del caro amico Att<strong>il</strong>io Ugolini<br />
(25 luglio 1912 - 13 febbraio <strong>2004</strong>). Chi ha partecipato<br />
alla cerimonia <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>o che si è svolta a Torricella, ha<br />
potuto toccare con mano quanto Att<strong>il</strong>io fosse amato da<br />
tutti, in primo luogo, certo, dai suoi fam<strong>il</strong>iari, e poi dall'intera<br />
comunità, dalla Parrocchia e dalle Associazioni alle<br />
quali ha de<strong>di</strong>cato tempo e passione. Senza nulla chiedere<br />
in cambio. Come tutti, anche io lo ricordo come una persona<br />
sempre <strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>e, con <strong>il</strong> sorriso scolpito sulle labbra,<br />
um<strong>il</strong>e e generoso. Mi piaceva parlare con lui delle cose<br />
che, nonostante la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> età, ci univano, ed erano<br />
tante. In ogni caso <strong>di</strong>versi lettori <strong>di</strong> questo <strong>giornale</strong> ricorderanno<br />
i suoi articoli, e le sue fotografie, dai quali traspariva<br />
<strong>il</strong> suo amore per i nostri monti, e per Torricella in particolare.<br />
Att<strong>il</strong>io nel sistemare l'archivio parrocchiale, un<br />
compito che lo ha impegnato qualche anno, ogni tanto<br />
riportava alla luce qualche scoperta. <strong>La</strong> più bella è quella<br />
relativa ad una antico pizzo imprestato dal parroco <strong>di</strong><br />
Torricella (nel 1882), ad un ebreo <strong>di</strong> nome Giacomo Levi.<br />
Molti anni dopo <strong>il</strong> prestito, Guido Mattei Gent<strong>il</strong>i, nella sua<br />
storia della parrocchia <strong>di</strong> Torricella, aveva commentato <strong>il</strong><br />
fatto facendo capire che <strong>il</strong> pizzo non era stato più restituito.<br />
Ma nel 1995 durante alcuni lavori <strong>di</strong> restauro, invece,<br />
l'antico pizzo era stato trovato, dunque Levi lo aveva regolarmente<br />
restituito, e Att<strong>il</strong>io aveva scritto per la <strong>Rocca</strong> un<br />
articolo corredato da una bella foto, con <strong>il</strong> titolo “Accusato<br />
ingiustamente un ebreo”. Un altro bell'intervento <strong>di</strong> Ugolini<br />
è relativo al ritrovamento da lui fatto dei resti dell'antichissimo<br />
ponte descritto in passato dalle storico Pier Antonio<br />
Guerrieri. Quei resti si trovano attualmente a circa 200<br />
metri dal Ponte Molino Baffoni.<br />
Dall’ottobre ’94 abbiamo ospitato molti suoi interventi, sul<br />
tema della viab<strong>il</strong>ità e delle strade, su <strong>di</strong>versi personaggi storici<br />
del nostro territorio e sui monumenti da salvare, ma<br />
abbiamo anche potuto contare sulla sua collaborazione<br />
nella <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> questo <strong>giornale</strong>, e sulla sua amicizia.<br />
Ciao Att<strong>il</strong>io e “Rimanga nel cuore <strong>di</strong> chi ti ha conosciuto <strong>il</strong><br />
ricordo della tua vita onesta e laboriosa”.<br />
G.D.<br />
PERSONAGGI<br />
5<br />
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong><br />
Att<strong>il</strong>io Ugolini<br />
A91 anni, in Novafeltria, si spegneva serenamente la<br />
nob<strong>il</strong>e esistenza <strong>di</strong> Ugolini Att<strong>il</strong>io: socio benemerito<br />
e sostenitore della <strong>Rocca</strong>. Egli contribuì con scritti e<br />
pubblicazioni <strong>di</strong> notizie storiche, relativi a Torricella, frazione<br />
<strong>di</strong> Novafeltria, quando ancora era appo<strong>di</strong>ato del Comune<br />
<strong>di</strong> S. Agata <strong>Feltria</strong>; Ugolini era cultore e ricercatore attento<br />
della storia <strong>di</strong> Torricella ed amava ritrarre e pubblicare, tramite<br />
la <strong>Rocca</strong>, le bellezze, le caratteristiche naturali e monumentali<br />
rievocando le figure <strong>di</strong> personaggi che <strong>il</strong>lustrarono<br />
nei tempi <strong>il</strong> suo paese, che amava d’amore f<strong>il</strong>iale. <strong>La</strong> <strong>Rocca</strong>,<br />
per mezzo suo, ebbe modo <strong>di</strong> portare a conoscenza dei suoi<br />
lettori dell’esistenza in Torricella <strong>di</strong> un’Ara votiva, ara sacrificale<br />
d’età romana; promosse e finanziò la ristampa della<br />
vita del beato popolare Padre Valentini Francesco, nato e<br />
vissuto in Torricella, morto a Pesaro. Le spoglie mortali sono<br />
conservate a Montecerignone. L’immagine del beato<br />
Francesco detto “Buono”, <strong>di</strong>pinta da Antonio Conti <strong>di</strong><br />
Acqualagna è attualmente conservata, insieme a quelle <strong>di</strong><br />
altri sette “beati popolari” del Montefeltro, nella cappella<br />
gent<strong>il</strong>izia dei Mattei Gent<strong>il</strong>ini <strong>di</strong> Torricella.<br />
L’Ugolini si rese benemerito per l’apporto finanziario elargito<br />
a favore della ristrutturazione dell’antica e monumentale<br />
chiesa <strong>di</strong> Torricella, della cappella del cimitero e del<br />
Monumento ai Caduti <strong>di</strong> guerra.<br />
Un merito particolare ebbe anche per la sistemazione e<br />
restauro, a sua cura e spese, dell’archivio della parrocchia<br />
vecchio <strong>di</strong> circa tre secoli. Tale lavoro lo impegnò per alcuni<br />
anni;<br />
A suor Chiara Giovanna delle suore Clarisse <strong>di</strong> S. Agata<br />
<strong>Feltria</strong>, alle figlie ed ai parenti, la <strong>Rocca</strong> porta sentite condoglianze<br />
per la per<strong>di</strong>ta del carissimo Att<strong>il</strong>io, la cui memoria<br />
sarà sempre mantenuta negli annali della nostra <strong>Rocca</strong>,<br />
per i meriti acquisiti e riconosciutigli con l’onorificenza<br />
elargitagli dal Presidente della Repubblica, anni ad<strong>di</strong>etro, <strong>di</strong><br />
Cavaliere della Repubblica.<br />
Il Presidente della Sezioni Mut<strong>il</strong>ati <strong>di</strong> Guerra <strong>di</strong> Novafeltria,<br />
Comm. Amedeo Varotti, con pubblico manifesto ha ricordato<br />
<strong>il</strong> Cav. Att<strong>il</strong>io Ugolini qualificandolo “citta<strong>di</strong>no laborioso<br />
ed onesto”, “<strong>di</strong>rigente attivo e fattivo”, per l’apporto umanitario<br />
che l’Ugolini aveva profuso nella Sezione Mut<strong>il</strong>ati <strong>di</strong><br />
Guerra, alla quale era iscritto per infermità contratte quale<br />
combattente nei Balcani, durante la guerra 1940-45.<br />
Il mistero della Massa Mariana<br />
<strong>La</strong> tesi <strong>di</strong> <strong>La</strong>urea <strong>di</strong> Andrea Onofri,<br />
recentemente presentata a<br />
Perticara, ha come argomento la<br />
nostra realtà, quella per intenderci<br />
dell'Alta Val Marecchia nel Me<strong>di</strong>o Evo,<br />
<strong>il</strong> periodo <strong>di</strong> Carlo Magno, <strong>di</strong> Pipino <strong>il</strong><br />
Breve e Berengario II; quando <strong>il</strong><br />
Montefeltro era terra <strong>di</strong> confine.<br />
Un periodo <strong>di</strong>ffic<strong>il</strong>e, da stu<strong>di</strong>are e da<br />
vivere, un'epoca <strong>di</strong> invasioni, con l'ultimo<br />
lembo <strong>di</strong> terra romana che resisteva.<br />
Un'epoca che nera non fu se<br />
non nelle parole delle persone superficiali.<br />
Onofri leggendo le pergamene<br />
conservate a Ravenna e <strong>di</strong> recente<br />
pubblicate, ha fatto delle scoperte<br />
interessanti. Adottando le tecniche <strong>di</strong><br />
Sherlock Holmes, ha messo in f<strong>il</strong>a<br />
in<strong>di</strong>ci, tracce, parole e ha visto nascere<br />
un tessuto <strong>di</strong> significati.<br />
Da noi prima dell’anno m<strong>il</strong>le, in un<br />
panorama <strong>di</strong> case sparse, più che <strong>di</strong><br />
v<strong>il</strong>laggi, vivevano famiglie mononucleari<br />
sim<strong>il</strong>i a quelle <strong>di</strong> oggi, e non<br />
patriarcali come forse avremmo pensa-<br />
to. Ma soprattutto ha scoperto la collocazione<br />
esatta della Massa mariana,<br />
confermando le coraggiose tesi sostenuta<br />
qualche anno fa da Manlio<br />
Flenghi. <strong>La</strong> tesi <strong>di</strong> Onofri, anche se ha<br />
un nome poco accattivante<br />
“Organizzazione del territorio e aree <strong>di</strong><br />
confine: <strong>il</strong> Montefeltro (secoli VIII-X)”<br />
per <strong>il</strong> lettore contemporaneo, meriterebbe<br />
una pubblicazione adeguata, e<br />
che qualcun altro riprenda in mano la<br />
fatica.
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong> Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
<strong>La</strong> rocca si è già occupata <strong>di</strong><br />
Lorenzo Maffei. In questo articolo<br />
riportiamo alcuni documenti<br />
storici, in gran parte ine<strong>di</strong>ti, che lo<br />
riguardano.<br />
Don Nicolò Lorenzo Maffei, storico<br />
santagatese del '700, collaborò a lungo<br />
con Ludovico Antonio Muratori, che <strong>di</strong><br />
lui scrisse in una lettera in<strong>di</strong>rizzata a<br />
Luc’Antonio Gent<strong>il</strong>i <strong>di</strong> Torricella, nel<br />
1732: “Quell’iscrizione mandatami dal<br />
signor Lorenzo Maffei la qual farò porre<br />
nella classe dè Magistrati e Dignità<br />
Maggiori, non poteami esser più cara,<br />
e al più proposito. Io godo che V.S.<br />
abbia contratta amicizia con questo<br />
uomo, degno veramente <strong>di</strong> rispetto,<br />
ed amore; e prego a non voler lasciar<br />
occasione <strong>di</strong> avanzargli i miei più um<strong>il</strong>i<br />
ossequj”.<br />
<strong>La</strong> sua vita fu sinteticamente descritta<br />
dall’Arciprete Casanovi in occasione<br />
dell'orazione funebre, eccola nella trascrizione<br />
dell'eru<strong>di</strong>to Francesco<br />
Gaudenzi. "Di 22 anni fu fatto Dottore<br />
<strong>di</strong> Legge in Urbino. Dieci anni dopo<br />
Professore <strong>di</strong> Eloquenza a Modena, in<br />
quello Stab<strong>il</strong>imento <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> ove erano<br />
allora professori un Zaccaria, un<br />
Muratori, un Torti. Poscia professore<br />
in Padova <strong>di</strong> lingua ebraica e membro<br />
<strong>di</strong> molte Accademie. Protetto dal<br />
Principe Eugenio che gli esebì a vantaggio<br />
<strong>di</strong> qualche congiunto <strong>di</strong> lui,<br />
cariche onorevoli fra le proprie m<strong>il</strong>izie.<br />
Caro al generale Daon<br />
Governatore <strong>di</strong> M<strong>il</strong>ano notissimo per<br />
le sue campagne contro <strong>il</strong> Re <strong>di</strong><br />
Prussia. Carissimo al Principe<br />
Lodovico Archinti che lo volle proprio<br />
Bibliotecario ed al nepote del Re <strong>di</strong><br />
Danimarca che accompagnò a Roma e<br />
pe’ quali sarebbe ad<strong>di</strong>venuto letterato<br />
della corte Danese, essendo cattolico,<br />
non ripugnava <strong>di</strong> essere ad una Corte<br />
non cattolica. A Roma invaghì de’ suoi<br />
STORIA<br />
Lorenzo Maffei<br />
meriti Benedetto XIII che gli comandò<br />
<strong>di</strong> spesso visitarlo, gli esebì <strong>il</strong><br />
Vescovado <strong>di</strong> Assisi, e poscia <strong>il</strong><br />
Feretrano, i quali Egli ricusò; e<br />
Clemente XII trovatolo versatissimo<br />
nella Storia Sacra e profana e nella lingua<br />
greca ed ebraica, gli <strong>di</strong>ede incarico<br />
<strong>di</strong> scrivere l’apologia de’ tre primi<br />
secoli della Chiesa e le annotazioni<br />
intorno ad Anastasio Bibliotecario nelle<br />
vite de’ Romani pontefici in benemerenza<br />
<strong>di</strong> che gli conferì poi una<br />
Commenda Abbaziale. Fu anche autore<br />
delle note della Repubblica<br />
Sigoniana degli Ebrei stampata nel<br />
Tomo 4 della Collezione M<strong>il</strong>anese, nello<br />
scrivere la quale a M<strong>il</strong>ano nella<br />
Biblioteca Archinti fu a lui un Rabbino<br />
<strong>di</strong> Modena presentandogli un preziosissimo<br />
anello, che Egli non volle ricevere,<br />
perché era proprio del dono <strong>il</strong><br />
persuadergli moderazione verso gli<br />
Ebrei, se non <strong>di</strong>ssuaderlo dall’opera.<br />
In Roma fu poi sommamente tenuto in<br />
stima dai Car<strong>di</strong>nali e Prelati più accre<strong>di</strong>tati,<br />
e dotti e da molti letterati, precisamente<br />
dal chiarissimo Marchese<br />
Scipione Maffei. Passato <strong>il</strong> magggior<br />
tempo della sua vita a Ravenna (ove<br />
giovanetto fu per causa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o presso<br />
i Monaci Classensi) a Modena, a<br />
Padova, a M<strong>il</strong>ano, a Venezia, a Roma,<br />
rimpatriando <strong>di</strong>ede <strong>il</strong> suo nome al<br />
Colegio patrio dei Canonici, ai quali<br />
impetrò i beni enfiteutici della Ba<strong>di</strong>a<br />
<strong>di</strong> Monte Ercole, insegnò pubblicamente<br />
le leggi e <strong>di</strong> anni 76 morì".<br />
Negli Atti <strong>di</strong> morte conservati in quel<br />
poco che resta dell'archivio storico<br />
della Collegiata, nella data 21 <strong>di</strong>cembre<br />
1770, si legge: L’eccellentissimo<br />
signor abate, dottore in ambo le leggi<br />
Niccolò Lorenzo Maffei, canonico <strong>di</strong><br />
questa Insigne Collegiata <strong>di</strong> Sant’Agata<br />
<strong>Feltria</strong>, della sua età <strong>di</strong> circa 76 anni,<br />
per <strong>il</strong> suo ragguardevole ed egregio<br />
Pensieri e parole dell’Assessore Cangini<br />
Cangini, Assessore pelato e tracagnotto, ha un pensiero<br />
e un programma chiari. Eccoli:<br />
“Sono dell’assessorato alle attività varie ed eventuali”.<br />
“Vi ringrazio che vi avete cosato <strong>di</strong> venire anche se, premetto<br />
non sono proprio esperto per quanto riguarda”.<br />
“Le problematiche sono svariegate e bisogna fare basta <strong>di</strong><br />
dare una botta alla botte e una botta alla moglie ubriaca”.<br />
“Difatti, ne abbiamo deliberato anche in giunta. Viceversa. E<br />
abbiamo sv<strong>il</strong>uppato un ampio coso che ne abbiamo parlato"<br />
Domanda: “anche un comune come <strong>il</strong> Suo ha <strong>il</strong> problema<br />
dello smog?”.<br />
Palmiro Cangini: “...No... Che ci siamo riuniti nel nel nel che<br />
abbiamo fatto arrivare la autobotti <strong>di</strong> smog”.<br />
Domanda: Ma come?<br />
“STAI ZITTO TE CHE SEI ... politicamente .... battuto... che...<br />
6<br />
carattere e a nessuno secondo per eru<strong>di</strong>zione<br />
i tutte le <strong>di</strong>scipline e a tutti<br />
assai caro, dopo avere ricevuti i santissimi<br />
sacramenti della Chiesa con venerazione<br />
<strong>di</strong> tutti, e cioè la Confessione,<br />
la Sacra Comunione e l’estrema<br />
Unzione e anche con la raccomandazione<br />
dell’anima e condonato per<br />
assoluzione pontificia, l’anima placidamente<br />
restituì al suo Creatore nell’ora<br />
20 <strong>di</strong> questo giorno e imme<strong>di</strong>atamente<br />
con grande pianto del popolo e della<br />
Congregazione del Capitolo e del<br />
Clero fu trasportato dal luogo del<br />
decesso alla Chiesa della Beata<br />
Vergine della Misericor<strong>di</strong>a e per giusta<br />
supplicazione, al mattino seguente <strong>il</strong><br />
suo corpo fu portato in questa insigne<br />
Chiesa Collegiata e dopo aver terminato<br />
i funerali secondo <strong>il</strong> rito, fu tumulato<br />
nella tomba <strong>di</strong> famiglia e lì aspetterà<br />
la resurrezione dei morti. In fede<br />
dei quali Pietro Casanovi Arciprete <strong>di</strong><br />
proprio pugno". Per inciso la tomba <strong>di</strong><br />
famiglia <strong>di</strong> cui si parla si trova, assieme<br />
ad altre, sotto l'attuale pavimento<br />
della Chiesa, e in futuro si spera <strong>di</strong><br />
poter riaprire l'accesso, incautamente<br />
chiuso negli anni passati.<br />
A San Donato si conserva una lapide<br />
latina, trovata a Sorbanello, che fece<br />
incidere lui stesso, e dalla quale si<br />
ricava la genealogia della sua famiglia,<br />
<strong>di</strong> origine longobarda, giunta a S.<br />
Agata nel 1300. Ecco l'epigrafe nella<br />
traduzione proposta da Tonino<br />
Marani: “Lorenzo Maffei figlio <strong>di</strong><br />
Francesco ricomprò e restaurò la casa<br />
<strong>di</strong> Sorbanello comprata dall’avo<br />
Giovanni Battista, figlio <strong>di</strong> Cristoforo e<br />
pronipote del Beato F<strong>il</strong>ippo della<br />
Congregazione Pisana tramite <strong>il</strong> nonno<br />
Maffeo, venduta dal padre Francesco<br />
figlio <strong>di</strong> Lorenzo. 1738, 100 anni dall’acquisto,<br />
240 dalla morte del Beato<br />
F<strong>il</strong>ippo, figlio <strong>di</strong> Maffeo”.<br />
Mi fai perdere <strong>il</strong> f<strong>il</strong>o del <strong>di</strong>sc...... che poi <strong>il</strong> tubo ....che non<br />
mi si collega <strong>il</strong> cervello alla bocca.... e comunque. Fatti non<br />
pugnette e i fatti mi .... cosano.<br />
Con questo cosa volevo <strong>di</strong>re? non lo so!!!! però c’ho ragione”.<br />
Non perdete <strong>il</strong> libro sull’Assessore che ha questa trama:<br />
Cangini, fa gli onori <strong>di</strong> casa mostrando le “meraviglie” del<br />
comune: la <strong>di</strong>scarica, <strong>il</strong> depuratore delle acque sporche, la<br />
Maria delle piade, antica fiamma <strong>di</strong> Cangini. Ma a volte la<br />
fiamma si rinnova.<br />
Quando <strong>il</strong> paese è pieno <strong>di</strong> turisti, mamme con bambini,<br />
vecchi, ragazzotti, arriva una comitiva <strong>di</strong> russi capitanata<br />
dal sindaco <strong>di</strong> Novoriminskigrad e composta da politici,<br />
mafiosi, ma sul più bello arriva un nubifragio <strong>di</strong> quelli cattivi.<br />
Finale a sorpresa.<br />
(tratto da “Cent’anni <strong>di</strong> Roncofritto”, <strong>di</strong> Paolo Cevoli)
Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
Si legge nell’Archivio Vescov<strong>il</strong>e <strong>di</strong><br />
S. Marino - Montefeltro che <strong>il</strong><br />
Vescovo Mons. Crispino<br />
Agostinucci, sceso a Torricella per la<br />
celebrazione della Festa della Vergine<br />
del Buon Consiglio, insieme con altri<br />
15 sacerdoti, <strong>il</strong> 25 Apr<strong>il</strong>e 1856, colpito<br />
da misteriosi improvvisi dolori, moriva<br />
alle ore 10.40 in casa del dott. Ubaldo<br />
Mattei Gent<strong>il</strong>i. Una morte esemplare,<br />
accompagnata da tutti i conforti della<br />
religione; una morte, però, che aveva<br />
suscitato dei sospetti nella<br />
Magistrature <strong>di</strong> S. Agata <strong>Feltria</strong>, che l’avrebbe<br />
voluta chiarire con l’autopsia,<br />
rifiutata dai presenti. <strong>La</strong> lettera del parroco<br />
don Francesco Mariani, che<br />
comunicava al Vicario, la triste notizia,<br />
è accompagnata da altri<br />
scritti interessanti.<br />
L’improvvisa scomparsa<br />
del Presule Feretrano<br />
aveva risvegliato l’appetito<br />
dei Sarsinati, che,<br />
sostenuti dalla<br />
Legazione <strong>di</strong> Forlì, tentarono<br />
<strong>di</strong> accorpare 15<br />
parrocchie del versante<br />
del Savio e dell’Uso per<br />
accrescere la loro piccolezza.<br />
<strong>La</strong> più importante<br />
<strong>di</strong> queste Comunità era<br />
S. Agata, che da sempre<br />
coltivava nell’animo <strong>il</strong><br />
sogno <strong>di</strong> unirsi alla<br />
Romagna.<br />
I Sarsinati promettevano<br />
<strong>di</strong> promuovere a<br />
Concattedra la sua<br />
Collegiata e garantivano<br />
buoni appoggi presso le<br />
Legazione. S. Agata era<br />
<strong>il</strong> centro principale: una<br />
volta capitolata fac<strong>il</strong>mente<br />
le altre parrocchie<br />
avrebbero, forse,<br />
seguito la stessa sorte.<br />
<strong>La</strong> sconvenienza e i<br />
danni <strong>di</strong> tale smembramento<br />
sono elencati in<br />
<strong>di</strong>eci punti, che inviarono<br />
al nuovo eletto<br />
Mons. Elia Alberani,<br />
unitamente ai gioiosi<br />
sentimenti <strong>di</strong> esultanza<br />
STORIA<br />
e altri auguri <strong>di</strong> ben venuto, perché se<br />
ne servisse per impe<strong>di</strong>re la rovina<br />
della sua Sposa. Eccoli in breve:<br />
1) Il Vescovo del Montefeltro, non è<br />
vescovo <strong>di</strong> una città, ma <strong>di</strong> una<br />
Provincia un Vescovo campagnolo;<br />
2) Le 15 parrocchie sono quasi tutte<br />
“f<strong>il</strong>iali dell’antica Pieve <strong>di</strong> S. Pietro <strong>di</strong><br />
Penna, che riconoscono come<br />
Cattedrale Matrice”;<br />
3) e 4) Il vent<strong>il</strong>ato smembramento<br />
apporterebbe danno alla Mensa<br />
Capitolare e vescov<strong>il</strong>e, private del<br />
miglior cattedratico e del maggior<br />
numero <strong>di</strong> chierici per <strong>il</strong> Seminario;<br />
5) e 6) S. Agata con tale operazione<br />
non farebbe un gran guadagno, perché<br />
attualmente impiega due ore per<br />
7<br />
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong><br />
Il Montefeltro fu sempre un bocconcino<br />
ambito per le <strong>di</strong>ocesi confinanti<br />
raggiungere la sede vescov<strong>il</strong>e, attraversando<br />
<strong>il</strong> solo fiume Marecchia; per<br />
scendere a Sarsina impiegherebbe<br />
sempre due ore con lo svantaggio <strong>di</strong><br />
dover attraversare <strong>il</strong> Savio e <strong>il</strong> Fanante<br />
che sono senza ponte;<br />
7) Se da 22 anni non avvengono le<br />
visite pastorali non è per motivo <strong>di</strong> trascuratezza,<br />
ma per causa della malferma<br />
salute <strong>di</strong> mons. Begni;<br />
8) <strong>La</strong> privazione <strong>di</strong> S. Agata renderebbe<br />
molto più <strong>di</strong>fficoltosa la visita delle<br />
altre parrocchie, che sono sprovviste<br />
<strong>di</strong> un decoroso alloggio e la sede<br />
vescov<strong>il</strong>e non sarebbe più centrale;<br />
9) e 10) L’iniziativa creerebbe infiniti<br />
<strong>di</strong>sturbi alla Diocesi, senza migliorare<br />
la situazione <strong>di</strong> S. Agata e risolleverebbe<br />
le vecchie ruggini,<br />
create dai decreti<br />
pontifici.<br />
<strong>La</strong> temuta ipotesi non si<br />
è avverata e la Diocesi<br />
riprende <strong>il</strong> suo consueto<br />
cammino.<br />
Nel corso dei secoli,<br />
però, tagli dolorosi ne<br />
ha dovuti subire tanti la<br />
nostra Diocesi come<br />
quelli <strong>di</strong> Sestino,<br />
Cicognaia e Santa Sofia<br />
Marecchia, quelli <strong>di</strong> S.<br />
Damiano e <strong>di</strong> Paderno e<br />
ultimamente la per<strong>di</strong>ta<br />
delle parrocchie poste<br />
in Provincia <strong>di</strong> Forlì,<br />
compensate dall’acquisto<br />
<strong>di</strong> alcune parrocchie<br />
della Repubblica <strong>di</strong> San<br />
Marino e della sofferta<br />
Romagnano e Sapigno.<br />
Finalmente i nostri<br />
Patroni Marino e Leone<br />
sono scesi dalla loro<br />
nicchia e hanno allontanato<br />
da noi la paura<br />
della totale scomparsa<br />
della Diocesi con <strong>il</strong> confronto<br />
e la gioia <strong>di</strong> rivedere<br />
sui nostri colli la<br />
paterna autorevole e<br />
prestigiosa figura <strong>di</strong> un<br />
vescovo tutto nostro.<br />
Don Pietro Cappella
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong> Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
Il giorno <strong>di</strong> Pasqua all'età <strong>di</strong> 79 anni <strong>il</strong> carissimo Enzo<br />
Antinori ci ha lasciato. Scompare con lui un artista<br />
poliedrico, un uomo sensib<strong>il</strong>e come pochi, un amico<br />
<strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>e e caro. Enzo, come ha detto don Giuseppe <strong>il</strong> giorno<br />
dei suoi funerali, "ha voluto passare la Pasqua con la<br />
sua adorata Adriana". I suoi greppi, i suoi calanchi, la sua<br />
Buga, la sua Miniera sembrano adesso <strong>di</strong>versi agli occhi <strong>di</strong><br />
chi lo conosceva, <strong>di</strong> chi aveva ascoltato le sue canzoni, o <strong>di</strong><br />
chi aveva letto i suoi ricor<strong>di</strong>. Mentre scriviamo sono trascor-<br />
PERSONAGGI<br />
Enzo Antinori<br />
8<br />
se ancora troppe poche ore dalla sua scomparsa, e così ci<br />
sembra che qualsiasi cosa si possa scrivere non sia adeguata,<br />
non sia pari al desiderio <strong>di</strong> ricordarlo come meriterebbe.<br />
Efrem Satanassi, nel breve ricordo che ha fatto <strong>di</strong> Enzo, ha<br />
detto che presto ci saranno delle occasioni per ricordarlo;<br />
anche questo <strong>giornale</strong>, che deve tantissimo a Enzo, ci sarà.<br />
Per ora pubblichiamo <strong>il</strong> ricordo letto da Don Pietro in occasione<br />
della cerimonia funebre.<br />
<strong>La</strong> scomparsa del carissimo Enzo ha vivamente colpito<br />
i suoi cari e tutti quelli che hanno avuto la fortuna <strong>di</strong><br />
conoscere <strong>il</strong> suo carattere, le sue belle preziose qualità.<br />
Davvero un modello <strong>di</strong> uomo e <strong>di</strong> cristiano, una persona<br />
<strong>di</strong> rara intelligenza e bontà, sensib<strong>il</strong>e alle cose belle,<br />
sempre <strong>di</strong>screto, prudente e rispettoso. Sapeva <strong>di</strong> arte e <strong>di</strong><br />
musica, <strong>di</strong> lettere e <strong>di</strong> storia. Riusciva bene in tutto quello<br />
che si metteva a fare. I capitoli importanti della sua vita<br />
sono soprattutto due: la Famiglia e “i Su Grepp”.<br />
Ha vissuto anni felici con la sua Adriana, strappata così presto<br />
dalla morte. L’ha tanto pianta in versi e in musica. Ora<br />
l’ha ritrovata per continuare insieme l’avventura meravigliosa<br />
della Casa del Padre.<br />
<strong>La</strong> Buga, che ha scritto <strong>di</strong>etro le tante nostre insistenze, è<br />
un po’ <strong>il</strong> <strong>di</strong>ario della sua vita, la fotografia del mondo dei<br />
minatori, la storia del gran bene che ha voluto alla sua terra<br />
e agli amici.<br />
Davvero un vuoto profondo scava la sua morte nel cuore<br />
<strong>di</strong> chi l’ha conosciuto e amato. <strong>La</strong> nostra comunità perde<br />
un amico vero, un operatore valido e insostituib<strong>il</strong>e.<br />
Ci conforta solo la fede, che l’ha visto lasciare una valle <strong>di</strong><br />
lacrime e salire alla casa del Padre a occupare quel posto<br />
<strong>di</strong> vita, <strong>di</strong> pace e <strong>di</strong> gioia, che <strong>il</strong> Salvatore Gesù gli ha preparato<br />
accanto alla sua Adriana e ai suoi Cari.<br />
Don Pietro<br />
Miniera ha ricordato Marcinelle<br />
Dall’inferno della miniera <strong>di</strong><br />
Marcinelle, al Museo storico<br />
minerario <strong>di</strong> Perticara, 48 anni<br />
dopo. Per ricordare e celebrare <strong>il</strong> sacrificio<br />
dei do<strong>di</strong>ci marchigiani - <strong>il</strong> più<br />
anziano aveva 49 anni e <strong>il</strong> più giovane<br />
26 - morti nella trage<strong>di</strong>a dell’8 agosto<br />
1956 in Belgio, la Regione Marche ha<br />
organizzato per sabato, 27 marzo, una<br />
cerimonia <strong>di</strong> commemorazione, nella<br />
quale Sono state consegnate dal<br />
Presidente Vito D’Ambrosio ai fam<strong>il</strong>iari<br />
dei minatori morti le medaglie alla<br />
memoria <strong>di</strong> Maestri del <strong>La</strong>voro.<br />
Le medaglie, realizzate dal maestro<br />
argentiere Marco Paoletti, sono state<br />
appositamente coniate dalla Regione<br />
Marche e raffigurano la Campana <strong>di</strong><br />
Marcinelle “Maria Mater Orphanorum”,<br />
realizzata con <strong>il</strong> contributo <strong>di</strong> tutte le<br />
regioni italiane e <strong>di</strong>ventata <strong>il</strong> simbolo<br />
della memoria. <strong>La</strong> Campana, voluta<br />
dai Maestri del <strong>La</strong>voro, è collocata dal<br />
2002 proprio nel sito <strong>di</strong> Bois du Cazier,<br />
ad ammonire che non accadano più<br />
sim<strong>il</strong>i trage<strong>di</strong>e. Le Marche hanno pagato<br />
un tributo elevato in questa trage<strong>di</strong>a:<br />
sono state la terza regione ( dopo<br />
l’Abruzzo con 60 vittime e la Puglia<br />
con 22) con <strong>il</strong> più alto numero <strong>di</strong><br />
morti, due dei quali, come ben sanno<br />
i lettori della <strong>Rocca</strong>, delle nostre terre.<br />
<strong>La</strong> giornata ha visto, nella sede del<br />
Museo storico minerario <strong>di</strong> Perticara,<br />
la celebrazione della Santa Messa da<br />
parte <strong>di</strong> Monsignor Angelo Comastri,<br />
Arcivescovo <strong>di</strong> Loreto e Presidente<br />
della Conferenza Episcopale delle<br />
Marche. Di seguito, dopo <strong>il</strong> benvenuto<br />
del sindaco <strong>di</strong> Novafeltria, Gabriele<br />
Berar<strong>di</strong>, è stato proiettato un documentario<br />
sulla trage<strong>di</strong>a e sono state<br />
raccolte le testimonianze <strong>di</strong> ex minatori<br />
marchigiani e <strong>di</strong> alcuni scampati alla<br />
morte in quel crudele 8 agosto <strong>di</strong> 48<br />
anni fa, in cui morirono 262 uomini <strong>di</strong><br />
do<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>verse nazionalità, tra cui 136<br />
italiani. Questa giornata <strong>di</strong> celebrazioni<br />
vuole rappresentare un momento <strong>di</strong><br />
riflessione de<strong>di</strong>cato alla memoria <strong>di</strong> un<br />
evento doloroso, che sconvolse <strong>il</strong><br />
mondo per molte settimane e che<br />
portò all’attenzione dell’opinione pubblica<br />
anche le <strong>di</strong>sumane con<strong>di</strong>zioni in<br />
cui lavoravano e vivevano i minatori<br />
emigrati all’estero: quasi schiavi,<br />
deportati in carri bestiame, considerati<br />
alla stregua dei cavalli impiegati per<br />
trasportare <strong>il</strong> carbone, che in 262<br />
lasciarono anche 406 orfani.
Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
STORIA<br />
Chi suonò le campane<br />
<strong>di</strong> Carpegna?<br />
Antico <strong>il</strong> monte, antica la famiglia,<br />
antiche le braccia che e<strong>di</strong>ficarono<br />
circa 800 anni fa la<br />
vetusta pieve romanica. Risalendo la<br />
china della Carpegna attraverso la piccola<br />
valle del torrente Mutino, ci avviciniamo<br />
sui 750 metri d’altezza, al<br />
paese che dal monte prende nome.<br />
Ripercorriamo in un affascinante viaggio<br />
i sentieri percorsi da santi e da<br />
cavalieri, da artisti e car<strong>di</strong>nali, dalla<br />
gente del popolo. Salendo si apre<br />
innanzi a noi un paesaggio degno <strong>di</strong><br />
un pittore, una natura degna <strong>di</strong> un<br />
mistico. Uomo e natura si sono alleati,<br />
cesellando nel tempo un vasto gioiello<br />
<strong>di</strong> meravigliosa bellezza, capace <strong>di</strong><br />
rapirti lo sguardo ed <strong>il</strong> cuore. Non<br />
siamo forse nella magica terra del<br />
Montefeltro?!<br />
Un territorio in grado <strong>di</strong> suscitare le<br />
invi<strong>di</strong>e d’ognuno che non gli appartenga...<br />
se solo noi ci rendessimo<br />
conto del priv<strong>il</strong>egio <strong>di</strong> poterlo chiamare:<br />
Montefeltro nostra patria ed in questa<br />
terra poter affondare le ra<strong>di</strong>ci sino<br />
ad arrivare alla fonti vitali dei due fondatori<br />
e patroni san Leo e san Marino!<br />
E nel misterioso Montefeltro, misteriosa,<br />
ma reale al contempo, é la storia<br />
che ci accingiamo a narrare. Un<br />
fatto che estese la fama del tranqu<strong>il</strong>lo<br />
paese carpegnolo oltre frontiera, tanto<br />
che agli alberghi giunsero richieste<br />
d’informazioni da <strong>di</strong>versi paesi europei<br />
e perfino dall’America. Il motivo?<br />
Uno strano fenomeno che catalizzò<br />
l’attenzione <strong>di</strong> tutti su questo paese:<br />
l’oscuro suono delle “campane fantasma”.<br />
Fino al momento dei fenomeni<br />
la situazione era tranqu<strong>il</strong>la; poi “la citta<strong>di</strong>na”,<br />
venne asse<strong>di</strong>ata da molti<br />
curiosi che si spingevano fin lassù per<br />
rendersi conto <strong>di</strong> persona dello strano<br />
effetto acustico <strong>di</strong> cui tanto si parlava.<br />
Ebbene, tutto cominciò <strong>il</strong> 1° novembre<br />
1970. Quella sera, esattamente alle<br />
20.15, all’interno della chiesa parrocchiale<br />
<strong>di</strong> San Nicolò, situata nel centro<br />
del paese, fra’ Giuseppe era intento a<br />
conversare con frate Mario nella pro-<br />
pria cella quando una campana<br />
cominciò a suonare a <strong>di</strong>stesa. <strong>La</strong> conversazione<br />
si interruppe, poiché in<br />
quel timbro i due frati riconobbero la<br />
più piccola delle quattro campane del<br />
loro campan<strong>il</strong>e, <strong>il</strong> cosiddetto<br />
“Cendìno”, usato per richiamare i parrocchiani<br />
alla messa, e stupefatti per<br />
quel suono assolutamente fuori orario,<br />
i due, temendo qualche avvenimento<br />
drammatico, si precipitarono nel refettorio<br />
dove altri due frati erano intenti<br />
a guardare la TV, chiedendo spiegazioni.<br />
Ma quelli, ancor più stupiti, <strong>di</strong>ssero<br />
<strong>di</strong> non aver u<strong>di</strong>to nulla.<br />
E nulla aveva u<strong>di</strong>to padre Doriano,<br />
<strong>il</strong> parroco, che si trovava nell’ufficio<br />
parrocchiale, né Gino, <strong>il</strong> campanaro.<br />
Tutti si recarono allora al campan<strong>il</strong>e<br />
ma constatarono che la cella campanaria<br />
era chiusa a chiave e le campane<br />
completamente immob<strong>il</strong>i.<br />
Si pensò all’eco della vicina chiesa<br />
<strong>di</strong> San Pietro, e credendo che qualcuno<br />
avesse bisogno d’aiuto, i frati si<br />
recarono sul posto, ma anche lì nessuno<br />
aveva suonato le campane.<br />
Quando ormai i due frati si erano rassegnati<br />
all’idea <strong>di</strong> aver avuto un’allucinazione,<br />
erano le 22, la campana<br />
riprese a suonare all’interno della chiesa,<br />
questa volta u<strong>di</strong>ta da tutti. E tutti<br />
riconobbero l’inconfon<strong>di</strong>b<strong>il</strong>e suono<br />
della campana piccola del loro campan<strong>il</strong>e.<br />
Ma ciò che più sconcertava era<br />
notare che mentre <strong>il</strong> suono si u<strong>di</strong>va<br />
chiaramente nelle stanze dei frati,<br />
negli altri ambienti del convento,<br />
non si avvertiva nessun rumore.<br />
A mezzanotte, poi ancora alle due,<br />
mentre le altre stanze rimasero s<strong>il</strong>enziose,<br />
lo scampanio echeggiò nel dormitorio,<br />
spaventando i frati.<br />
Fu l’indomani, <strong>il</strong> 2 novembre, giorno<br />
dei morti, che la campana si fece<br />
u<strong>di</strong>re all’esterno, lasciando allibiti i<br />
presenti che si apprestavano ad assistere<br />
alla messa: tutti poterono chiaramente<br />
constatare che le campane<br />
erano perfettamente immob<strong>il</strong>i, eppure<br />
suonavano.<br />
Ma anche questa volta <strong>il</strong> suono si<br />
9<br />
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong><br />
u<strong>di</strong>va esclusivamente nel sagrato della<br />
chiesa, mentre nulla si percepiva né<br />
all’interno del convento, né all’esterno<br />
del sagrato, qualche metro più in là.<br />
Il fatto si ripeté per tutto <strong>il</strong> giorno<br />
e nei giorni successivi, attirando gli<br />
abitanti del paese al completo.<br />
Secondo i testimoni, <strong>il</strong> suono sembrava<br />
provenire ora dall’alto, ora dal<br />
basso, senza un punto preciso nello<br />
spazio.<br />
Quello che è certo è che le persone<br />
<strong>di</strong>slocate a guar<strong>di</strong>a nella cella campanaria,<br />
a pochi centimetri dalle campane,<br />
non u<strong>di</strong>vano assolutamente nulla.<br />
Il 13 novembre accadde un fatto<br />
nuovo. Il timbro del suono mutò palesemente:<br />
non fu più <strong>il</strong> piccolo<br />
“Cendìno” a farsi u<strong>di</strong>re, ma la grande<br />
Campana <strong>di</strong> Mezzogiorno che iniziò a<br />
<strong>di</strong>ffondere nell’aria la sua voce possente,<br />
pur rimanendo anch’essa assolutamente<br />
immob<strong>il</strong>e.<br />
Nel frattempo la notizia si spargeva,<br />
e curiosi arrivavano in massa per rendersi<br />
conto del fatto.<br />
Nel gennaio del 1971 si ebbe un’altra<br />
variazione: la Campana a Morto,<br />
terza delle quattro campane ospitate<br />
nella cella campanaria del convento,<br />
iniziò a far sentire i suoi lugubri rintocchi<br />
al posto delle prime due. E nel<br />
giro <strong>di</strong> pochi giorni ci si accorse <strong>di</strong> un<br />
fatto impressionante: ad ogni serie <strong>di</strong><br />
rintocchi <strong>di</strong> questa campana corrispondeva<br />
puntualmente <strong>il</strong> decesso <strong>di</strong><br />
un abitante del paese.<br />
Il fatto cominciato <strong>il</strong> 1° novembre<br />
andò avanti quaranta giorni, per<br />
quasi tutto <strong>il</strong> 1971, con le campane<br />
che ormai si alternavano nel loro<br />
gioco sotto gli occhi sbalor<strong>di</strong>ti <strong>di</strong><br />
quanti le vedevano perfettamente<br />
immob<strong>il</strong>i, ma potevano u<strong>di</strong>rne chiaramente<br />
la voce. Poi, con <strong>il</strong> finire dell’anno,<br />
la manifestazione andò scemando<br />
fino al completo esaurimento<br />
nel periodo pasquale del 1972.<br />
(segue a pag.10)
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong><br />
(segue da pag.9)<br />
Chi suonò le campane<br />
<strong>di</strong> Carpegna?<br />
<strong>La</strong> chiesa fu teatro, in quello stesso spazio <strong>di</strong> tempo,<br />
<strong>di</strong> numerosi altri fenomeni inspiegab<strong>il</strong>i e avvenimenti arcani.<br />
Uno fra tutti: L’altare ad un primo controllo risultava<br />
essere sparecchiato come sempre quando non si celebra la<br />
messa, ma dopo qualche tempo le guar<strong>di</strong>e che picchettavano<br />
la chiesa asseriscono che rientrate in un secondo<br />
momento nella chiesa vi trovarono sopra <strong>il</strong> calice e i paramenti<br />
neri da morto. Una mano ignota era intervenuta, ma<br />
asseriscono le guar<strong>di</strong>e che assolutamente nessuno in quel<br />
momento era entrato nell’e<strong>di</strong>ficio.<br />
Il suddetto caso delle campane venne stu<strong>di</strong>ato ed analizzato<br />
da <strong>di</strong>versi ricercatori, italiani e stranieri. Ad<strong>di</strong>rittura <strong>il</strong><br />
misterioso suono venne anche registrato, e si ebbe la<br />
prova certa che <strong>il</strong> suono era reale, quin<strong>di</strong> era da escludere<br />
la suggestione collettiva.<br />
Ad aumentare l’enigma, ci si mise <strong>il</strong> fatto <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>oso<br />
<strong>il</strong> quale avendo registrato i suoni, affermò <strong>di</strong> averne<br />
u<strong>di</strong>ti soltanto due, mentre <strong>il</strong> registratore ne aveva registrati<br />
ben quattro. Un’èquipe <strong>di</strong> tecnici del suono <strong>di</strong> Bologna,<br />
che venne ad eseguire un sopralluogo con apposite, idonee<br />
e sofisticate apparecchiature, giunse alla conclusione<br />
che <strong>il</strong> suono che si u<strong>di</strong>va aveva effettivamente gli stessi<br />
<strong>di</strong>agrammi <strong>di</strong> struttura sonora <strong>di</strong> quello delle campane.<br />
E la quarta campana? <strong>La</strong> Campana d’Ovest, muta spettatrice<br />
degli eventi che riguardarono le sue tre sorelle, fortunatamente<br />
ha fino ad oggi taciuto.<br />
Narra, infatti, un’antica leggenda del luogo che “quando<br />
tutt’e quattro le campane <strong>di</strong> Carpegna avranno suonato,<br />
la montagna si spaccherà”.<br />
Al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> tutte le possib<strong>il</strong>i spiegazioni, quale può essere <strong>il</strong><br />
significato <strong>di</strong> un tale avvenimento? Se accettiamo la testimonianza<br />
<strong>di</strong> un frate mio conoscente, <strong>di</strong> alta spiritualità,<br />
morto anni or sono, egli ebbe a parlarmi <strong>di</strong> un suo confratello,<br />
deceduto dopo la guerra a causa dello scoppio <strong>di</strong><br />
una mina. Questo, apparso ad una donna del paese, le<br />
avrebbe rivelato <strong>di</strong> trovarsi ancora nel dolente Purgatorio.<br />
e che fu lui a richiamare l’attenzione, affinché i frati memori<br />
tornassero a pregare per la sua anima e così suffragata<br />
essa potesse volare alla gioia del Para<strong>di</strong>so. A questo ricondurrebbero<br />
anche i tempi del fenomeno (2 novembre), gli<br />
eventi connessi al suono della campana funebre (annunzio<br />
anticipato della morte <strong>di</strong> qualche paesano) ed infine<br />
l’altare preparato per la messa esequiale.<br />
Chiunque tu sia Feretrano o straniero che ti accingi a<br />
salire <strong>il</strong> monte o ad inoltrarti in qualche posto dell’antica<br />
<strong>di</strong>ocesi leontina, sappi e ricorda che sulle sue strade, ai<br />
crocicchi, nelle chiese, o nei campi, o tra le mura <strong>di</strong> un<br />
castello ormai tramontato, <strong>il</strong> mondo dei mortali e degli<br />
immortali si sono dati appuntamento e ad ogni passo porte<br />
segrete si potrebbero spalancare sull’eternità. Allora tu da<br />
quel posto eleva la tua bella preghiera e sali assieme agli<br />
angeli la scala <strong>di</strong> Giacobbe che s’innalza sino al trono del<br />
Dio uno e trino e della Madre sua la regina del<br />
Montefeltro.<br />
Ivan Fattori<br />
STORIA<br />
10<br />
Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
Miniere a Campobin<strong>di</strong><br />
<strong>La</strong> località Campobin<strong>di</strong> è sita circa 800 m a N/NO <strong>di</strong> S.<br />
Agata <strong>Feltria</strong> presso la borgata S. Giovanni, dove si ha<br />
la continuazione degli affioramenti coltivati nelle concessioni<br />
Perticara e Marazzana.<br />
Il ricercatore G. Celli, nel 1886, con modesti lavori ritenne<br />
<strong>di</strong> aver scoperto un giacimento <strong>di</strong> zolfo, ma si trattava <strong>di</strong><br />
una lente molto limitata della Formazione gessososolfifera,<br />
corrispondente alla parte analoga delle miniera Perticara e<br />
Marazzana.<br />
Questa scoperta, indusse <strong>il</strong> Celli a proseguire le ricerche<br />
che si protrassero quasi ininterrottamente sino al 1905,<br />
cono risultati negativi, anche se vi fu qualche produzione;<br />
35 t <strong>di</strong> zolfo grezzo nel 1886 e 3 t, nel 1893.<br />
Da 1886 al 1905, si scavarono complessivamente 472 m <strong>di</strong><br />
gallerie, 4 pozzi per complessivi 87 m. e 146 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>scenderie.<br />
Dopo una sospensione dei lavori, nel 1907, presso San<br />
Giovanni, <strong>il</strong> titolare scavò una galleria in una zona più a<br />
nord, presso le case d’Onofrio ad ovest dell’abitato <strong>di</strong> S.<br />
Donato.<br />
Tale galleria, aperta alla base della formazione, in un banco<br />
<strong>di</strong> 5 m <strong>di</strong> marne, proseguì in quelle interposte fra i gessi,<br />
attraversando dopo 105 m, lo strato <strong>di</strong> calcare solfifero che<br />
risultò ster<strong>il</strong>e. Dopo quest’ultimo tentativo, i lavori vennero<br />
sospesi nel 1908.<br />
Il permesso <strong>di</strong> ricerca venne prorogato allo stesso Celli e<br />
passò nel 1914 al Sig. G. Rossi che, a sua volta, lo trasferì<br />
nel 1920 alla Soc. Montecatini la quale, dopo avervi praticato<br />
trascurab<strong>il</strong>i lavori negli anni del 1924 al 1927, abbandonò<br />
definitivamente la ricerca.<br />
M. Battistelli<br />
In mostra<br />
anche<br />
due<br />
quadri<br />
della<br />
Chiesa<br />
dei<br />
Cappucci<br />
ni <strong>di</strong><br />
S. Agata
Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
Nel 1799, anno in cui la comunità<br />
<strong>di</strong> S. Agata <strong>Feltria</strong> abbisogna<br />
urgentemente <strong>di</strong> una risorsa<br />
finanziaria per saldare i debiti contratti<br />
nei due anni precedenti per<br />
provvedere allo sfamo della popolazione,<br />
“che ridotta a luttuosa circostanza<br />
minaccia una sempre abbominevole<br />
sommossa”, i dottori Lucchesi<br />
e Meschini, l’u<strong>di</strong>tore Roberto Fabri e<br />
Antonio Fabri (in altro documento<br />
Roberto Fabri, <strong>il</strong> dottor Enea<br />
Nastasini, <strong>il</strong> notaio Antonio Buffoni e<br />
Marcantonio Baldassarri, i primi <strong>di</strong> S.<br />
Agata, l’ultimo della Toscana Tomba),<br />
definiti quattro dei migliori possidenti<br />
del luogo, si obbligano privatamente,<br />
stante che l’impegno che vorrebbe<br />
assumersi <strong>il</strong> Consiglio generale della<br />
Comunità non viene accettato, <strong>di</strong><br />
fronteggiare detto bisogno creando<br />
censi passivi per un “cambio” in sorte<br />
<strong>di</strong> scu<strong>di</strong> 1.000 sopra alcuni loro fon<strong>di</strong><br />
situati nello Stato fiorentino a favore<br />
dei signori Salvetti, Malvisi e<br />
Glendarini, che ora (1805), patrocinati<br />
dall’avvocato Guido Fabbri <strong>di</strong><br />
Ravenna, vogliono subito essere saldati<br />
almeno dei frutti mai riscossi e<br />
minacciano esecuzioni sopra i fon<strong>di</strong><br />
del territorio toscano e osano avanzare<br />
riven<strong>di</strong>cazioni dello stesso tenore<br />
su quelli pontifici senza tenere in<br />
alcun conto la legge <strong>di</strong> questo stato.<br />
In vista <strong>di</strong> ciò i quattro, per evitare le<br />
molestie e trovare un garante per i<br />
propri interessi, implorano dalla Sagra<br />
Congregazione del Buon Governo un<br />
provve<strong>di</strong>mento a loro favore per essere<br />
esentati dal pagamento ed evitare<br />
così le esecuzioni sui loro beni.<br />
I m<strong>il</strong>le scu<strong>di</strong> erano stati erogati interamente<br />
nell’acquisto <strong>di</strong> grano, <strong>il</strong> quale<br />
fu tutto panizzato (non dai fornai,<br />
anche se era stato garantito ad essi<br />
l’appalto esclusivo) a conto pubblico<br />
e <strong>di</strong>stribuito alla popolazione; ma perché<br />
<strong>il</strong> prezzo era stato eccessivo e<br />
molte furono le spese della condotta<br />
(<strong>il</strong> grano proveniva dalla Marca e da<br />
altre province dello stato) e dei cambi<br />
<strong>di</strong> monete allora circolanti (i toscani<br />
avevano preteso <strong>il</strong> pagamento in piastre<br />
fiorentine d’argento), si era verificata<br />
nella panificazione una per<strong>di</strong>ta<br />
vistosa, “quale an<strong>di</strong>ede maggiormente<br />
ad aumentare per essersi <strong>il</strong> denaro<br />
girato più volte in <strong>di</strong>verse compre <strong>di</strong><br />
grano e rispettive panizzazioni”.<br />
Nel penurioso 1805 <strong>il</strong> podestà <strong>di</strong> S.<br />
STORIA<br />
Anni penuriosi<br />
Agata riceve un <strong>di</strong>spaccio del delegato<br />
apostolico <strong>di</strong> Urbino con l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
interessarsi riguardo alla sod<strong>di</strong>sfazione<br />
<strong>di</strong> un debito <strong>di</strong> scu<strong>di</strong> 305 e baiocchi<br />
84 che grava dal 1978 la cassa<br />
annonaria per acquisto <strong>di</strong> grano dal<br />
Capitolo e da Alessandro Ripa <strong>di</strong><br />
Verucchio, <strong>di</strong> cui la Comunità <strong>di</strong> S.<br />
Agata deve addossarsi <strong>il</strong> peso. Il caso<br />
è portato in Consiglio generale dove,<br />
“considerandosi dai congregati non<br />
essere possib<strong>il</strong>e <strong>di</strong> aggravare i popoli<br />
in quest’anno penurioso con nuove<br />
imposizioni, per la ragione anche <strong>di</strong><br />
un altro riparto prescritto dalla Sacra<br />
Congregazione del Buon Governo”,<br />
per pagare <strong>il</strong> debito dei m<strong>il</strong>le scu<strong>di</strong>,<br />
più 77 <strong>di</strong> frutti maturati annualmente<br />
all’avvocato Guido Fabbri <strong>di</strong> Ravenna,<br />
fu risoluto <strong>di</strong> riconsiderare le revisioni<br />
comunitative che non furono riscosse<br />
negli anni dei passati sconvolgimenti,<br />
“onde liquidare vari cre<strong>di</strong>ti che questa<br />
Comunità tiene con <strong>di</strong>versi particolari,<br />
che ebbero allora a che fare nei pubblici<br />
interessi, e pagare con l’esigenza<br />
dei medesimi <strong>il</strong> mentovato Ripa e<br />
Capitolo <strong>di</strong> Verucchio”.<br />
Fu imme<strong>di</strong>atamente intrapresa tale<br />
operazione <strong>di</strong> recupero, ma per le<br />
molte <strong>di</strong>fficoltà insorte non la si potè<br />
portare a perfezionamento, “ma tuttavia<br />
si ha in oggi in capitale una<br />
11<br />
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong><br />
somma liquida <strong>di</strong> scu<strong>di</strong> trecento settanta<br />
tre e baiocchi ottanta, oltre scu<strong>di</strong><br />
quattrocento venti due, che questa<br />
Comunità va cre<strong>di</strong>trice alle <strong>di</strong>ecisette<br />
del Rettorato”, che sono Maiano,<br />
Saudoleto, <strong>Rocca</strong>, Ugrigno, Libiano,<br />
Pereto, Scavolo, Monte Benedetto,<br />
Caioletto, Rosciano e Raggio,<br />
Fragheto, V<strong>il</strong>la <strong>di</strong> Fragheto, Palazzo,<br />
Vacaldola, Rivolpaio, Sartiano e<br />
Torricella.<br />
Riguardo ai quattro capi delle citate<br />
famiglie agiate <strong>di</strong> S. Agata <strong>il</strong> tribunale<br />
<strong>di</strong> Ravenna nel frattempo ha or<strong>di</strong>nato<br />
l’esecuzione ipotecaria dei beni da<br />
essi posseduti nella ex Em<strong>il</strong>ia e <strong>il</strong> loro<br />
arresto se fossero entrati in detto<br />
stato.<br />
Il 27 ottobre 1807 Roberto Fabri, Enea<br />
Nastasini ed altri implorano <strong>il</strong> delegato<br />
apostolico affinchè <strong>il</strong> pagamento<br />
dei frutti non onorati sui censi del<br />
1799 ai prestatori <strong>di</strong> Bagno siano<br />
liquidati con la cassa dell’amministrazione<br />
generale dei beni. Essi vengono<br />
accontentati dalla Sagra<br />
Congregazione del Buon Governo e<br />
l’adesione del pontefice, i quali hanno<br />
<strong>di</strong>sposto si paghino tutti i frutti decorsi<br />
non sod<strong>di</strong>sfatti e alla convenuta<br />
ragione.<br />
Marco Battistelli<br />
Anni ’60<br />
quando si<br />
andava a<br />
teatro per<br />
vedere <strong>il</strong><br />
“cinema”
<strong>La</strong> <strong>Rocca</strong><br />
In molti a S. Agata sanno che l’antenata<br />
<strong>di</strong> Indel B, l’azienda che dal<br />
1988 da impiego a circa 160 persone,<br />
per la maggior parte citta<strong>di</strong>ni<br />
santagatesi, era l’azienda MIVIS; tuttavia<br />
sono in pochi a conoscerne le origini.<br />
MIVIS era <strong>il</strong> nome che i fratelli Giorgio<br />
e Bruno Minguzzi e Bruno ed Ezio<br />
Turci, questi ultimi figli <strong>di</strong> Alberto<br />
Visini <strong>di</strong> Ravenna, <strong>di</strong>edero a questa<br />
azienda manifatturiera fondata nel lontano<br />
1970 e operante già da allora nel<br />
settore della refrigerazione.<br />
I soci Minguzzi e Visini <strong>di</strong>rigevano a<br />
Ravenna, già dal 1968, un’azienda <strong>di</strong><br />
frigoriferi dall’omonimo nome, derivante<br />
dalle iniziali dei due cognomi.<br />
Guardando ancora più ad<strong>di</strong>etro,<br />
occorre ricordare che in origine<br />
l‚azienda era denominata FRIGOVIS,<br />
poiché i fratelli Minguzzi <strong>di</strong>vennero<br />
solo successivamente soci del fondatore<br />
Alberto Visini.<br />
<strong>La</strong> sede amministrativa della MIVIS <strong>di</strong><br />
Ravenna era in Via Renato Serra, mentre<br />
i vari reparti (schiumatura,<br />
montaggio compressori, imbal-<br />
lo, spe<strong>di</strong>zioni..) erano <strong>di</strong>slocati<br />
in <strong>di</strong>verse zone della città. Le<br />
<strong>di</strong>fficoltà che sorsero per gestire<br />
i reparti non furono poche:<br />
innanzitutto la gestione dei<br />
vari locali costituiva un costo<br />
assai elevato a causa degli affitti<br />
da corrispondere e inoltre<br />
era fisicamente impossib<strong>il</strong>e o<br />
quantomeno insostenib<strong>il</strong>e<br />
coor<strong>di</strong>nare gli stessi, se non<br />
con enormi per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> tempo.<br />
Questi problemi indussero i<br />
soci a ricercare una soluzione<br />
alla <strong>di</strong>spersione che comprometteva<br />
la gestione dell’azienda.<br />
<strong>La</strong> risposta arrivò quasi per<br />
caso.<br />
Alberto Visini, conobbe negli<br />
anni ‘60 Libera Succi <strong>di</strong><br />
Bacciolino (FO), sorella <strong>di</strong><br />
S<strong>il</strong>vio che ormai da <strong>di</strong>verso<br />
tempo viveva a Sant’Agata<br />
<strong>Feltria</strong> con la moglie santagatese,<br />
Velia Librari. Alberto confidò<br />
a Libera e a S<strong>il</strong>vio la<br />
volontà <strong>di</strong> riunire i vari locali,<br />
risolvendo così i problemi che<br />
CRONACA<br />
Le origini della Indel B<br />
ass<strong>il</strong>lavano l’azienda ravennate; l’idea<br />
<strong>di</strong> Visini era quella <strong>di</strong> cercare una zona<br />
in cui costruire un nuovo stab<strong>il</strong>imento,<br />
usufruendo delle leggi regionali che<br />
stab<strong>il</strong>ivano agevolazioni a sostegno<br />
degli investimenti in zone depresse.<br />
Succi consigliò prontamente <strong>di</strong> considerare<br />
S. Agata <strong>Feltria</strong> come possib<strong>il</strong>e<br />
ubicazione viste le caratteristiche della<br />
zona: in loco infatti, non vi erano altre<br />
aziende, per cui era alta la richiesta <strong>di</strong><br />
lavoro e inoltre <strong>il</strong> territorio si prestava<br />
ottimamente ad un inse<strong>di</strong>amento produttivo.<br />
Succi non perse tempo e parlò con<br />
l’allora sindaco Alfredo Polidori e <strong>il</strong><br />
Segretario Comunale Giuseppe De<br />
Marco, per esporre la proposta; l’idea<br />
fu accolta favorevolmente entusiasmo,<br />
proprio perché allora si presentavano<br />
poche opportunità <strong>di</strong> sv<strong>il</strong>uppo industriale<br />
del territorio santagatese.<br />
Non rimase che interpellare Bruno,<br />
Ezio e i fratelli Minguzzi, i quali si<br />
mostrarono interessati: <strong>il</strong> progetto<br />
poteva partire!<br />
Come primo passo, la MIVIS <strong>di</strong><br />
<strong>La</strong> miniera <strong>di</strong><br />
zolfo <strong>di</strong> Perticara<br />
(cantiere Certino,<br />
pozzo Vittoria)<br />
12<br />
Marzo/Apr<strong>il</strong>e <strong>2004</strong><br />
Ravenna assunse una cinquantina <strong>di</strong><br />
operai <strong>di</strong> S. Agata per insegnare loro <strong>il</strong><br />
mestiere da svolgere, in attesa che iniziasse<br />
la costruzione della nuova fabbrica<br />
a S. Agata.<br />
Per circa due anni questi operai dovettero<br />
rimanere a Ravenna, dal lunedì al<br />
venerdì, pagandosi l’affitto e le varie<br />
spese <strong>di</strong> sostentamento; ogni fine settimana,<br />
in ritorno da Ravenna, erano<br />
impazienti <strong>di</strong> passare davanti al luogo<br />
stab<strong>il</strong>ito per la costruzione, speranzosi<br />
che i lavori fossero iniziati.<br />
I lavori infatti cominciarono e finalmente<br />
nel 1971 la MIVIS aprì le porte<br />
a circa sessanta <strong>di</strong>pendenti, alcuni dei<br />
quali ancora oggi lavorano presso<br />
Indel B.<br />
E’ forse d’obbligo per noi santagatesi<br />
ringraziare i fautori <strong>di</strong> questo progetto,<br />
poiché S. Agata avrebbe potuto subire<br />
la stessa sorte <strong>di</strong> quegli ormai numerosi<br />
piccoli comuni che vengono<br />
abbandonati dai propri abitanti a<br />
causa della mancanza <strong>di</strong> lavoro.<br />
Ecco i nomi dei "pionieri" (ci auguriamo<br />
<strong>di</strong> non aver tralasciato nessuno!):<br />
Agostini Ezio, Agostini<br />
Gianfranco, Alessi Antonio,<br />
Alessi Pietro, Astorri<br />
Giancarlo, Bagnoli Ezio,<br />
Bagnoli Patrizia, Balchesini<br />
Gino, Bartolini Fernando,<br />
Berar<strong>di</strong> Marta, Borghesi<br />
Pasquale, Bossari Flora,<br />
Bossari Pia, Botticelli <strong>La</strong>zzaro,<br />
Brunori Maurizio, Bucci<br />
Giancarlo, Cangini Mario,<br />
Capannelli Giorgio, Ciccioni<br />
Andrea, Ciccioni Marcello,<br />
Ciccioni Tino, D’Orazi<br />
Arnaldo, D’Orazi Roberto,<br />
D’Orazio Wally, Giovanetti<br />
Ezio, Giovanetti Fermino,<br />
Giuliani Em<strong>il</strong>iano, Liverani<br />
Enzo, Magnani Angelo, Manzi<br />
Angelo, Manzi Arturo, Paci<br />
Bruno, Paci Gino, Paolucci<br />
Edgardo, Rinal<strong>di</strong> Enzo, Rinal<strong>di</strong><br />
Vallino, Sartini Luigi, Sartini<br />
Marzia, Urbini Luciano, Valli<br />
Leonardo, Valli Pierangelo,<br />
Valli Valentina, Vicini<br />
Leonardo, Vicini S<strong>il</strong>vana, Vitali<br />
Leo, Zanchini Pierluigi,<br />
Emanuela Liverani
Minieran. 52<br />
<strong>La</strong> voce della Buga