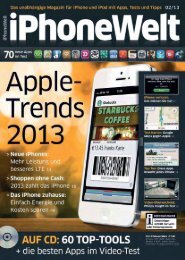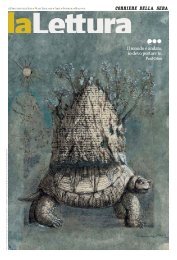Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013<br />
RRR<br />
Sommario<br />
corriere.it/lalettura<br />
L’inserto continua online<br />
con il «Club della Lettura»:<br />
una community esclusiva<br />
per condividere idee e opinioni<br />
4 Il dibattito delle idee<br />
«Il nucleare aiuta la natura»<br />
di STEFANO GATTEI<br />
5 Mettiamo una tassa<br />
sulle citazioni facili<br />
di GUIDO VITIELLO<br />
Orizzonti<br />
6 Società<br />
Il ritorno dei barbari<br />
di GIUSEPPE SARCINA<br />
e ALESSANDRO ZIRONI<br />
8 Società<br />
La cucina della pace<br />
e la riscossa dei carnivori<br />
di ANGELA FRENDA<br />
e VIVIANA MAZZA<br />
11 Visual data<br />
Perché Lisbona<br />
assomiglia a Honolulu<br />
di GIORGIA LUPI<br />
e SIMONE QUADRI<br />
Caratteri<br />
12 L’intervista<br />
Il canone inverso<br />
di Jonathan Lethem<br />
di ALESSANDRA FARKAS<br />
14 Narrativa italiana<br />
Una naturalista<br />
in casa Manzoni<br />
di ERMANNO PACCAGNINI<br />
17 Personaggi<br />
Il mondo della Dc<br />
raccontato da una figlia<br />
di ALDO GRASSO<br />
18 Le classifiche dei libri<br />
La pagella<br />
di ANTONIO D’ORRICO<br />
Sguardi<br />
20 Tendenze<br />
Fede nell’arte:<br />
il Vaticano alla Biennale<br />
di STEFANO BUCCI<br />
e VINCENZO TRIONE<br />
22 Riscoperte<br />
L’infanzia di Cindy Sherman<br />
di ARTURO CARLO QUINTAVALLE<br />
24 Il protagonista<br />
Timothy Greenfield-Sanders<br />
il fotografo d’America<br />
di GIANLUIGI COLIN<br />
Percorsi<br />
26 Graphic novel<br />
L’ultimo gladiatore<br />
di MICHELE PETRUCCI<br />
28 La biografia/1<br />
L’uomo che scoprì Timbuctù<br />
di ELISABETTA ROSASPINA<br />
29 La biografia/2<br />
La donna che insegna<br />
Beethoven ai sordi<br />
di PAOLA D’AMICO<br />
30 Controcopertina<br />
I malati all’ergastolo<br />
di FULVIO BUFI<br />
e LUIGI FERRARELLA<br />
Il dibattito delle idee<br />
In Europa le regole variano. Nel nostro Paese<br />
occorre aggiornare le leggi alla nuova società<br />
Ius<br />
scholae<br />
Oltre il diritto di sangue<br />
oltre il diritto del suolo<br />
Diamo la cittadinanza<br />
agli stranieri che vanno a scuola<br />
di MAURIZIO FERRERA<br />
Forse non sarà all’ordine del giorno nella prima<br />
riunione del nuovo governo (come promette<br />
il programma del Pd), ma è certo che<br />
la questione della cittadinanza agli immigrati<br />
dovrà essere seriamente affrontata nella<br />
prossima legislatura. In Italia risiedono stabilmente<br />
quasi tre milioni e mezzo di persone<br />
che provengono da Paesi non appartenenti all’Ue. Il<br />
nostro «tasso di naturalizzazione» si situa però al di sotto<br />
della media Ue ed è pari alla metà di quello francese<br />
o britannico. Siamo in altre parole fra i Paesi più avari<br />
nel concedere la cittadinanza agli immigrati, e in particolare<br />
ai loro figli, anche se nati in ospedali italiani. Si<br />
tratta di 650 mila minori in tutto, 75 mila nuove registrazioni<br />
all’anno. Questi ragazzi parlano la nostra lingua,<br />
guardano la televisione, vanno a scuola, dove studiano<br />
storia, geografia e letteratura italiana. Ma sono considerati<br />
«extracomunitari» o semplicemente «stranieri».<br />
L’acquisizione della nazionalità è attualmente disciplinata<br />
dalla legge 91 del 1992. È automaticamente cittadino<br />
chi nasce da genitori italiani o possa vantare una discendenza<br />
diretta da cittadini italiani, anche senza essere<br />
nato nel nostro Paese. Per chi non possiede questi<br />
requisiti la naturalizzazione è un percorso a ostacoli. Bisogna<br />
prima ottenere un permesso e poi una carta di<br />
soggiorno. Le norme che disciplinano queste tappe dovrebbero<br />
essere allineate a una direttiva del 2004, ma<br />
purtroppo non è così. Le procedure sono più lunghe,<br />
macchinose e restrittive di quanto previsto dalla direttiva.<br />
Dopo dieci anni di residenza legale, si può chiedere<br />
la cittadinanza. La media degli altri Paesi è di cinque<br />
anni e, paradossalmente, era così anche in Italia prima<br />
della legge del 1992. La nazionalità si può successivamente<br />
trasmettere ai figli, come un’eredità. Se ciò non<br />
avviene, questi ultimi restano stranieri residenti. Dopo i<br />
18 anni, possono, sì, chiedere la cittadinanza, ma solo se<br />
risultano nati sul suolo italiano, sono stati immediatamente<br />
registrati all’anagrafe (cosa che non avviene se i<br />
genitori sono o erano irregolari) e hanno soggiornato<br />
senza interruzioni in Italia per diciotto anni (molti figli<br />
di immigrati trascorrono lunghi periodi con i parenti<br />
nel Paese di origine). Un sistema anacronistico, che stride<br />
con le migliori pratiche internazionali, ingiustamente<br />
punitivo oltre che irragionevole sul piano economico,<br />
politico e sociale. Il nostro Paese deve urgentemente<br />
modernizzare la propria «politica della cittadinanza»:<br />
senza massimalismi, ma con coraggio e nel rispetto della<br />
cornice europea. Quali direzioni seguire?<br />
Nel corso del XX secolo, la naturalizzazione degli stranieri<br />
è stata collegata al cosiddetto ius sanguinis (presenza<br />
di genitori o antenati già «nazionali»: caso tipico<br />
RRR<br />
La naturalizzazione va vista<br />
come un processo graduale,<br />
accompagnato da incentivi<br />
e da corsie preferenziali,<br />
soprattutto per i minori<br />
i<br />
In Italia vige lo ius sanguinis:<br />
italiani i figli di italiani. La<br />
cittadinanza si può acquisire<br />
per matrimonio o dopo 10<br />
anni di residenza (5 i rifugiati,<br />
4 i cittadini Ue). I nati in Italia<br />
hanno una finestra tra i 18 e i<br />
19 anni per richiederla<br />
In Francia oltre al «diritto di<br />
sangue» è previsto un «diritto<br />
di suolo differito»: i figli di<br />
genitori stranieri diventano<br />
francesi al compimento della<br />
maggiore età. Per la<br />
naturalizzazione bastano 5<br />
anni di residenza, 2 per chi ha<br />
frequentato una Grande École<br />
Chi nasce in Germania da<br />
genitori stranieri riceve la<br />
cittadinanza se almeno uno<br />
dei genitori risiede<br />
regolarmente da 8 anni e da<br />
3 possiede un permesso di<br />
soggiorno illimitato. Ha poi<br />
tempo fino ai 23 anni per<br />
scegliere un solo passaporto<br />
Può chiedere la cittadinanza<br />
britannica lo straniero che<br />
vive nel Regno Unito da 5<br />
anni. I figli di stranieri<br />
legalmente residenti (con<br />
permesso illimitato) nati su<br />
suolo britannico hanno<br />
diritto alla cittadinanza<br />
la Germania) oppure allo<br />
ius soli (nascita nel territorio<br />
nazionale: casi tipici<br />
gli Stati Uniti e la Francia).<br />
I due criteri riflettevano<br />
concezioni filosofiche profondamente<br />
diverse di ciò<br />
che deve fondare l’appartenenza<br />
a una comunità politica:<br />
una concezione «oggettiva»,<br />
basata su sangue<br />
e stirpe, contrapposta a una «soggettiva», basata sulla<br />
condivisione di valori, diritti e doveri. Fichte contro Renan,<br />
in altre parole: nazione-popolo versus nazione-repubblica.<br />
Sulla scia degli imponenti flussi migratori degli<br />
ultimi due decenni, questi criteri non tengono più<br />
nella loro forma pura. Che senso ha concedere la cittadinanza<br />
per «legami di sangue» a chi è nato e risiede all’estero<br />
e non ha magari nessun rapporto con la madrepatria?<br />
Perché negare la nazionalità (o farla sospirare<br />
per un tempo quasi infinito) a uno straniero che non è<br />
nato in loco ma si è bene integrato nel Paese di immigrazione?<br />
Oppure concederla per «legami di suolo» a chi è<br />
nato in un dato Paese solo per caso, senza poi vivervi<br />
stabilmente?<br />
Una seria politica della cittadinanza va oggi imperniata<br />
su nuovi criteri: essenzialmente la residenza (ius domicilii),<br />
accompagnata da «filtri» che attestino la disponibilità<br />
e la misura dell’integrazione (frequenza scolastica,<br />
lavoro regolare, conoscenza della lingua e così via).<br />
La naturalizzazione non deve essere più vista come un<br />
passaggio «puntuale», un salto di status irreversibile disciplinato<br />
da criteri molto generali e automatici. Va piuttosto<br />
vista come un processo graduale, accompagnato<br />
da incentivi premiali e corsie preferenziali. Ciò vale soprattutto<br />
per i minori, ai quali dovrebbe applicarsi una<br />
combinazione di ius domicilii e ius scholae (il ministro<br />
Riccardi ha recentemente usato l’espressione di ius culturae).<br />
Nel linguaggio degli esperti, questo canale è definito<br />
socialization-based acquisition: la naturalizzazione<br />
è condizionata alla frequenza scolastica e/o ad altre<br />
esperienze formative. La giustificazione di questa posizione<br />
è quasi intuitiva. Chi è stato socializzato alla cultura<br />
e alla lingua di un dato Paese ha più alte probabilità<br />
di condividerne i valori o quanto meno di rispettare il<br />
pacchetto di diritti e doveri vigente in quel Paese. Come<br />
sosteneva Ernest Renan, dopo tutto la cittadinanza è un<br />
«plebiscito quotidiano»: ogni giorno i membri della comunità<br />
politica «scelgono» di ubbidire alla legge. D’altra<br />
parte, chi diventa cittadino ha un incentivo ulteriore<br />
a seguire le norme del proprio Paese: si origina in altre<br />
parole un vero e proprio circolo virtuoso. In Francia (dove<br />
è stato ormai abbandonato lo ius soli) un minore che<br />
abbia seguito un percorso d’istruzione per almeno cinque<br />
anni ha automaticamente diritto alla cittadinanza.<br />
In Danimarca e Finlandia il diritto scatta anch’esso automaticamente<br />
con la frequenza scolastica, a partire dai<br />
15 anni (purché non ci siano state condanne penali che<br />
prevedano il carcere).<br />
A partire dal 2009 si è finalmente aperto anche in Ita-