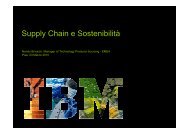Partecipazione riflessiva: il possibile contributo dell≈etica della ...
Partecipazione riflessiva: il possibile contributo dell≈etica della ...
Partecipazione riflessiva: il possibile contributo dell≈etica della ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
144<br />
Roberto Franzini Tibaldeo<br />
alternative”. 15 La ricerca è dunque ciò che occorre effettuare per risolvere<br />
detta situazione, mentre <strong>il</strong> pensiero (riflessivo) è ciò che “trasforma l’azione<br />
meramente appetitiva, cieca e impulsiva in azione intelligente”, 16 attribuisce<br />
significati e valori, e inoltre espleta i seguenti compiti: “giudicare dell’evidenza<br />
e agire in conformità”. 17<br />
A partire da Dewey e con la mediazione di Matthew Lipman, Cosentino<br />
rielabora come segue la definizione di “pensiero riflessivo”:<br />
lo scavo riflessivo non consiste in un semplice cammino a ritroso che risale dalla<br />
pratica alla corrispondente teoria che la giustifica, ma deve configurarsi come<br />
un’apertura alla complessità: un cammino che da lineare diventa circolare (pratica-teoria-pratica...),<br />
da predefinito diventa costruito su se stesso (ricorsività), da<br />
selettivo diventa inclusivo e trasversale rispetto ai contenuti, da programmab<strong>il</strong>e<br />
incerto e aperto all’imprevedib<strong>il</strong>ità. 18<br />
La riflessività del f<strong>il</strong>osofare ha pertanto assunto nuove sfumature che ne<br />
fanno un interessante e promettente paradigma di ricerca. 19 Contestualmente<br />
all’ampliamento teorico del “riflessivo” mi sembra che anche per l’idea di responsab<strong>il</strong>ità,<br />
tradizionalmente confinata entro i limiti <strong>della</strong> sola ponderazione<br />
delle conseguenze delle azioni umane, si prof<strong>il</strong>ino novità di r<strong>il</strong>ievo. Viviamo<br />
infatti entro scenari contraddistinti da incertezza e imprevedib<strong>il</strong>ità, scenari<br />
in cui, dopo secoli di riduzione <strong>della</strong> realtà a un’astrazione in cui l’elemento<br />
quantitativo la faceva da padrone, ciò che costituisce l’antropologico ha<br />
finalmente la possib<strong>il</strong>ità di venire liberato e “lasciato essere” in tutta la sua<br />
dinamica complessità. Viviamo inoltre in scenari plasmati da un agire individuale<br />
e collettivo che, anche in virtù delle possib<strong>il</strong>ità offerte dalla tecnologia,<br />
sperimenta <strong>il</strong> dramma <strong>della</strong> propria costitutiva ambivalenza e dell’assenza di<br />
punti di riferimento assolutamente certi. Come aveva ben compreso già tre<br />
decenni fa Hans Jonas, sim<strong>il</strong>i scenari finiscono inevitab<strong>il</strong>mente per porre l’uomo<br />
dinanzi a inedite sfide etiche concernenti questioni di senso, sfide che<br />
15 Ivi, p. 74; cfr. anche ivi, pp. 72 e sgg. In un altro passo <strong>della</strong> medesima opera Dewey aggiunge:<br />
“La funzione del pensiero riflessivo è quindi quella di trasformare una situazione in cui si<br />
è fatta esperienza di un’oscurità, un dubbio, un conflitto, o un disturbo di qualche sorta, in una<br />
situazione chiara, coerente, risolta, armoniosa” (ivi, p. 172). Conseguentemente, l’autore procede<br />
a enunciare le fasi in cui si articola <strong>il</strong> pensiero riflessivo: suggestione, intellettualizzazione, ipotesi,<br />
ragionamento, controllo (ivi, pp. 180 e sgg.).<br />
16 J. DEWEY, Come pensiamo (1933), La Nuova Italia, Firenze 1961, p. 79.<br />
17 Ivi, p. 83.<br />
18 A. COSENTINO, F<strong>il</strong>osofia come pratica sociale, cit., p. 93.<br />
19 Sovrapposte all’originaria impronta pragmatista, si notano stratificazioni di matrice costruttivista,<br />
nonché riflessioni provenienti dal modello ecologico e dall’epistemologia <strong>della</strong> complessità<br />
[cfr. ad esempio G. BATESON, Verso un’ecologia <strong>della</strong> mente (1972), Adelphi, M<strong>il</strong>ano 2004; E. MORIN,<br />
Il paradigma perduto: che cos’è la natura umana? (1973), Bompiani, M<strong>il</strong>ano 1974; poi, Feltrinelli,<br />
M<strong>il</strong>ano 1994, 1999; ID., Le vie <strong>della</strong> complessità (1985), in AA.VV., La sfida <strong>della</strong> complessità,<br />
Feltrinelli, M<strong>il</strong>ano 1985; ID., Le idee: habitat, vita, organizzazione, usi e costumi (1991), Feltrinelli,<br />
M<strong>il</strong>ano 1993; ID., Introduzione al pensiero complesso (1991), cit.,; U. BRONFENBRENNER, Ecologia dello<br />
sv<strong>il</strong>uppo umano (1979), Mulino, Bologna 1986; J. BRUNER, La cultura dell’educazione: nuovi orizzonti<br />
per la scuola, Feltrinelli, M<strong>il</strong>ano 1996; M. LIPMAN, Educare al pensiero, cit.; cfr. anche A. COSENTINO,<br />
Costruttivismo e formazione, Liguori, Napoli 2002].