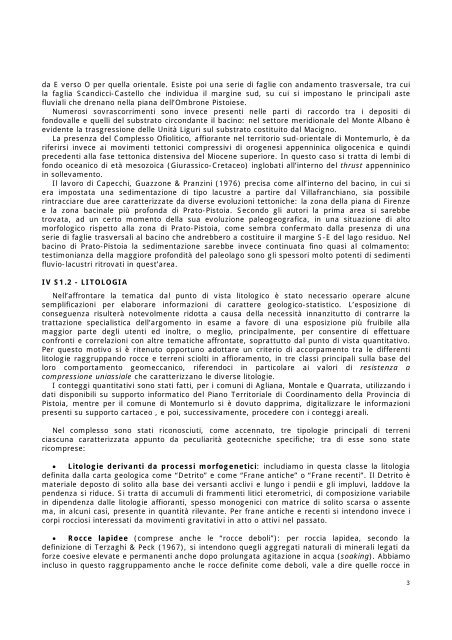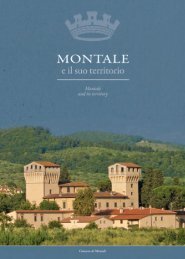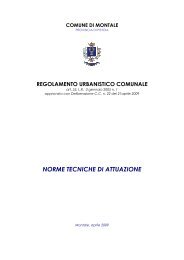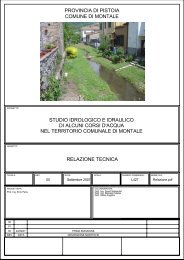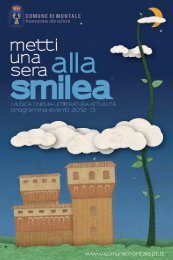IV - SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO - Comune di Montale
IV - SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO - Comune di Montale
IV - SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO - Comune di Montale
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
da E verso O per quella orientale. Esiste poi una serie <strong>di</strong> faglie con andamento trasversale, tra cuila faglia Scan<strong>di</strong>cci-Castello che in<strong>di</strong>vidua il margine sud, su cui si impostano le principali astefluviali che drenano nella piana dell’Ombrone Pistoiese.Numerosi sovrascorrimenti sono invece presenti nelle parti <strong>di</strong> raccordo tra i depositi <strong>di</strong>fondovalle e quelli del substrato circondante il bacino: nel settore meri<strong>di</strong>onale del Monte Albano èevidente la trasgressione delle Unità Liguri sul substrato costituito dal Macigno.La presenza del Complesso Ofiolitico, affiorante nel territorio sud-orientale <strong>di</strong> Montemurlo, è dariferirsi invece ai movimenti tettonici compressivi <strong>di</strong> orogenesi appenninica oligocenica e quin<strong>di</strong>precedenti alla fase tettonica <strong>di</strong>stensiva del Miocene superiore. In questo caso si tratta <strong>di</strong> lembi <strong>di</strong>fondo oceanico <strong>di</strong> età mesozoica (Giurassico-Cretaceo) inglobati all’interno del thrust appenninicoin sollevamento.Il lavoro <strong>di</strong> Capecchi, Guazzone & Pranzini (1976) precisa come all’interno del bacino, in cui siera impostata una se<strong>di</strong>mentazione <strong>di</strong> tipo lacustre a partire dal Villafranchiano, sia possibilerintracciare due aree caratterizzate da <strong>di</strong>verse evoluzioni tettoniche: la zona della piana <strong>di</strong> Firenzee la zona bacinale più profonda <strong>di</strong> Prato-Pistoia. Secondo gli autori la prima area si sarebbetrovata, ad un certo momento della sua evoluzione paleogeografica, in una situazione <strong>di</strong> altomorfologico rispetto alla zona <strong>di</strong> Prato-Pistoia, come sembra confermato dalla presenza <strong>di</strong> unaserie <strong>di</strong> faglie trasversali al bacino che andrebbero a costituire il margine S-E del lago residuo. Nelbacino <strong>di</strong> Prato-Pistoia la se<strong>di</strong>mentazione sarebbe invece continuata fino quasi al colmamento:testimonianza della maggiore profon<strong>di</strong>tà del paleolago sono gli spessori molto potenti <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentifluvio-lacustri ritrovati in quest’area.<strong>IV</strong> S1.2 - LITOLOGIANell’affrontare la tematica dal punto <strong>di</strong> vista litologico è stato necessario operare alcunesemplificazioni per elaborare informazioni <strong>di</strong> carattere geologico-statistico. L’esposizione <strong>di</strong>conseguenza risulterà notevolmente ridotta a causa della necessità innanzitutto <strong>di</strong> contrarre latrattazione specialistica dell’argomento in esame a favore <strong>di</strong> una esposizione più fruibile allamaggior parte degli utenti ed inoltre, o meglio, principalmente, per consentire <strong>di</strong> effettuareconfronti e correlazioni con altre tematiche affrontate, soprattutto dal punto <strong>di</strong> vista quantitativo.Per questo motivo si è ritenuto opportuno adottare un criterio <strong>di</strong> accorpamento tra le <strong>di</strong>fferentilitologie raggruppando rocce e terreni sciolti in affioramento, in tre classi principali sulla base delloro comportamento geomeccanico, riferendoci in particolare ai valori <strong>di</strong> resistenza acompressione uniassiale che caratterizzano le <strong>di</strong>verse litologie.I conteggi quantitativi sono stati fatti, per i comuni <strong>di</strong> Agliana, <strong>Montale</strong> e Quarrata, utilizzando idati <strong>di</strong>sponibili su supporto informatico del Piano Territoriale <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento della Provincia <strong>di</strong>Pistoia, mentre per il comune <strong>di</strong> Montemurlo si è dovuto dapprima, <strong>di</strong>gitalizzare le informazionipresenti su supporto cartaceo , e poi, successivamente, procedere con i conteggi areali.Nel complesso sono stati riconosciuti, come accennato, tre tipologie principali <strong>di</strong> terreniciascuna caratterizzata appunto da peculiarità geotecniche specifiche; tra <strong>di</strong> esse sono statericomprese:• Litologie derivanti da processi morfogenetici: inclu<strong>di</strong>amo in questa classe la litologiadefinita dalla carta geologica come “Detrito” e come “Frane antiche” o “Frane recenti”. Il Detrito èmateriale deposto <strong>di</strong> solito alla base dei versanti acclivi e lungo i pen<strong>di</strong>i e gli impluvi, laddove lapendenza si riduce. Si tratta <strong>di</strong> accumuli <strong>di</strong> frammenti litici eterometrici, <strong>di</strong> composizione variabilein <strong>di</strong>pendenza dalle litologie affioranti, spesso monogenici con matrice <strong>di</strong> solito scarsa o assentema, in alcuni casi, presente in quantità rilevante. Per frane antiche e recenti si intendono invece icorpi rocciosi interessati da movimenti gravitativi in atto o attivi nel passato.• Rocce lapidee (comprese anche le “rocce deboli”): per roccia lapidea, secondo ladefinizione <strong>di</strong> Terzaghi & Peck (1967), si intendono quegli aggregati naturali <strong>di</strong> minerali legati daforze coesive elevate e permanenti anche dopo prolungata agitazione in acqua (soaking). Abbiamoincluso in questo raggruppamento anche le rocce definite come deboli, vale a <strong>di</strong>re quelle rocce in3