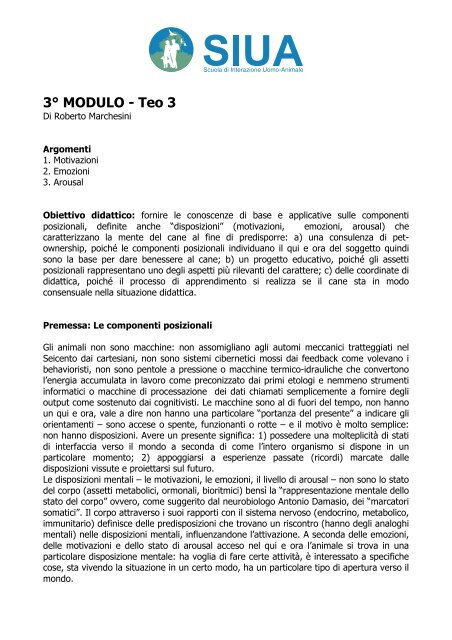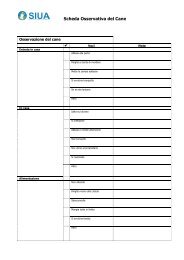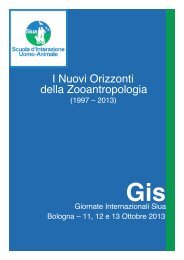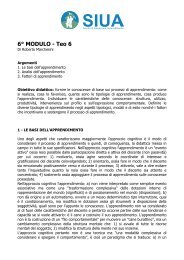3° MODULO - Teo 3 - Siua
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>3°</strong> <strong>MODULO</strong> - <strong>Teo</strong> 3<br />
Di Roberto Marchesini<br />
Argomenti<br />
1. Motivazioni<br />
2. Emozioni<br />
3. Arousal<br />
Obiettivo didattico: fornire le conoscenze di base e applicative sulle componenti<br />
posizionali, definite anche “disposizioni” (motivazioni, emozioni, arousal) che<br />
caratterizzano la mente del cane al fine di predisporre: a) una consulenza di petownership,<br />
poiché le componenti posizionali individuano il qui e ora del soggetto quindi<br />
sono la base per dare benessere al cane; b) un progetto educativo, poiché gli assetti<br />
posizionali rappresentano uno degli aspetti più rilevanti del carattere; c) delle coordinate di<br />
didattica, poiché il processo di apprendimento si realizza se il cane sta in modo<br />
consensuale nella situazione didattica.<br />
Premessa: Le componenti posizionali<br />
Gli animali non sono macchine: non assomigliano agli automi meccanici tratteggiati nel<br />
Seicento dai cartesiani, non sono sistemi cibernetici mossi dai feedback come volevano i<br />
behavioristi, non sono pentole a pressione o macchine termico-idrauliche che convertono<br />
l’energia accumulata in lavoro come preconizzato dai primi etologi e nemmeno strumenti<br />
informatici o macchine di processazione dei dati chiamati semplicemente a fornire degli<br />
output come sostenuto dai cognitivisti. Le macchine sono al di fuori del tempo, non hanno<br />
un qui e ora, vale a dire non hanno una particolare “portanza del presente” a indicare gli<br />
orientamenti – sono accese o spente, funzionanti o rotte – e il motivo è molto semplice:<br />
non hanno disposizioni. Avere un presente significa: 1) possedere una molteplicità di stati<br />
di interfaccia verso il mondo a seconda di come l’intero organismo si dispone in un<br />
particolare momento; 2) appoggiarsi a esperienze passate (ricordi) marcate dalle<br />
disposizioni vissute e proiettarsi sul futuro.<br />
Le disposizioni mentali – le motivazioni, le emozioni, il livello di arousal – non sono lo stato<br />
del corpo (assetti metabolici, ormonali, bioritmici) bensì la “rappresentazione mentale dello<br />
stato del corpo” ovvero, come suggerito dal neurobiologo Antonio Damasio, dei “marcatori<br />
somatici”. Il corpo attraverso i suoi rapporti con il sistema nervoso (endocrino, metabolico,<br />
immunitario) definisce delle predisposizioni che trovano un riscontro (hanno degli analoghi<br />
mentali) nelle disposizioni mentali, influenzandone l’attivazione. A seconda delle emozioni,<br />
delle motivazioni e dello stato di arousal acceso nel qui e ora l’animale si trova in una<br />
particolare disposizione mentale: ha voglia di fare certe attività, è interessato a specifiche<br />
cose, sta vivendo la situazione in un certo modo, ha un particolare tipo di apertura verso il<br />
mondo.
Sono le componenti posizionali – definite anche “disposizioni mentali” o “marcatori<br />
somatici” – a dare un qui e ora al soggetto, a differenziare cioè il suo presente ovvero a<br />
situare il cane in un particolare presente (ora ha voglia di questo) mentre le macchine<br />
sono in uno stato di “isocronia”, per loro il qui e ora non esiste. Occorre pertanto<br />
conoscere le diverse componenti posizionali per creare coerenza tra quanto viene proposto<br />
al cane e quanto è nelle sue corde. In altre parole mentre una macchina, esattamente<br />
come uno strumento, viene utilizzata ovvero “si usa”, un animale può darmi una<br />
prestazione solo con il consenso altrimenti la farà controvoglia e ne riceverà un riscontro<br />
negativo o ricordo spiacevole della situazione. I cani pertanto proprio in virtù del fatto che<br />
hanno emozioni, motivazioni ed arousal vanno coinvolti e non usati.<br />
1 - MOTIVAZIONI<br />
Per comprendere cosa desiderano i cani, vale a dire quali attività sono portati a compiere<br />
e quali oggetti spiccano nel loro orizzonte è necessario parlare di motivazioni. Le<br />
motivazioni sono disposizioni mentali: 1) di orientamento al mondo, ossia cosa interessa,<br />
cosa si ricerca, cosa spicca, cosa diviene un target (elezione di particolari enti); 2) di<br />
espressioni comportamentali ossia di particolari proposte di attività (proattive); 3) di aree<br />
dove si cerca gratificazione e che danno autoefficacia (piacere). Le motivazioni sostengono<br />
le attività del cane dandogli interesse per ciò che lo circonda e gratificazione nel<br />
comportamento, facendo emergere certi oggetti e ritagliando specifiche situazioni<br />
appaganti. Questo significa che il soggetto ha non solo un’immersione sensoriale nella<br />
realtà, ma anche orientativa: cerca nel mondo, è interessato del mondo, è gratificato nel<br />
fare al mondo, è stimolato dal mondo solo sulla base di precise disposizioni.<br />
Il mondo visto dal cane è assai differente dal nostro non solo perché diverse sono le<br />
finestre sensoriali di accesso alla realtà, ma anche perché la diversità di motivazioni fa<br />
emergere cose differenti. La motivazione predatoria, per esempio, fa spiccare gli oggetti<br />
piccoli in movimento e predispone l’animale a ricorrerli e a catturarli. La motivazione<br />
territoriale porta il cane a considerare il suo ambiente sulla base della presenza di barriere<br />
e dell’ampiezza spaziale e a difenderlo dall’invasione di estranei. La collezione di<br />
motivazioni e il diverso peso di queste nell’orientamento di un soggetto specificano in<br />
modo profondo il carattere di un individuo perché indicano quali attività egli sarà portato a<br />
compiere, cosa andrà a scegliere nel mondo, quali comportamenti esprimerà di<br />
preferenza. Nel cane possiamo discriminare le diverse razze rispetto al differente peso che<br />
assumono le motivazioni di specie: in una razza è maggiormente presente la m. predatoria<br />
(border collie) in un’altra la m. epimeletica (labrador), in un’altra ancora la m. difensiva<br />
(rottweiler). Il valore delle diverse motivazioni, ossia la prevalenza ad accendersi di una<br />
motivazione piuttosto che di un’altra, dà un “profilo vocazionale” al soggetto, vale a dire<br />
indica le disposizioni ad agire in un modo piuttosto che in un altro.<br />
Le motivazioni presentano i seguenti aspetti: 1) fase appetitiva, che si verifica quando: a)<br />
il soggetto da tempo non esprime quella motivazione, b) il soggetto è inserito in un<br />
ambiente che presenta degli stimoli o dei target correlati con quella motivazione, c) il<br />
soggetto è stimolato in aree motivazionali correlate o sinergiche oppure è inserito in un<br />
contesto ludico che ha a che fare con quella motivazione; 2) fase espressiva (un tempo<br />
definita consumatoria) che si caratterizza perché il soggetto mette in atto una sequenza
comportamentale o una collezione di comportamenti molto specifici e finalizzati a colmare<br />
la distanza con il target motivazionale; 3) fase di riposo che si caratterizza per due aspetti:<br />
a) gratificazione, ossia di piacere acquisito attraverso l’espressione stessa del<br />
comportamento, la gratifica per il raggiungimento del target, l’autoefficacia.<br />
L’attività ludica è la cornice prioritaria per aprire le motivazioni e possiamo dire che non vi<br />
sia alcun gioco che non si basi su una o più motivazioni, pertanto è necessario conoscere<br />
le motivazioni per poter giocare con il proprio cane. Il gioco è un’espressione<br />
motivazionale perché “proattiva”, vale a dire che è il soggetto che propone delle attività al<br />
mondo – il contrario è l’espressione “reattiva” tipica delle emozioni – e lo fa sulla base di<br />
tendenze che lo gratificano: rincorrere, afferrare e scuotere, tirare, prendere un oggetto e<br />
farsi rincorrere. Il gioco è perciò una cornice motivazionale o “metamotivazione”, vale a<br />
dire che può essere considerata una motivazione che si riferisce ad altre motivazioni.<br />
Giocare è una proposta che il cucciolo fa sulla base delle sue tendenze motivazionali, è<br />
cioè un comportamento proattivo che si basa sull’espressione elettiva delle motivazioni del<br />
soggetto. Questo significa che a seconda dei giochi che il soggetto presenta con più<br />
facilità è possibile capire quali siano le sue motivazioni più forti. Non a casa un cucciolo di<br />
border sarà portato a fare giochi predatori (correre dietro una pallina, uno di rottweiler a<br />
giochi competitivi (tira-molla), uno di labrador giochi epimeletici e collaborativi (come il<br />
riporto). Il gioco è il volano che consente al soggetto di esercitarsi nelle aree di maggiore<br />
propensione.<br />
Nel gioco è possibile individuare obiettivi e linee evolutive delle motivazioni: a) esercitare<br />
delle tendenze, farle evolvere attraverso gratificazione, perché il soggetto è soddisfatto<br />
solo nel poterle compiere; b) dare autoefficacia, perché prevedono il raggiungimento di<br />
target ovvero di risultati che il soggetto ottiene sul mondo; c) correlare le tendenze interne<br />
del soggetto con le opportunità che il mondo dispone e quindi creare un legame o<br />
correlazione tra mondo interno e mondo esterno; d) dare alla tendenza motivazionale una<br />
competenza espressiva attraverso delle conoscenze o rappresentazioni degli elementi utili<br />
o correlati a essa, per esempio una definizione rappresentazionale dei target, dei modi<br />
espressivi, dei contesti riferiti, degli enti che la suscitano.<br />
Ma l’aspetto più importante riguarda il rapporto tra motivazioni e piacere – nelle due<br />
scansioni più frequenti: 1) demotivazione, 2) frustrazione – con il rischio di compromettere<br />
gravemente il benessere del cane. Uno scarso livello di attivazione motivazionale provoca<br />
“demotivazione” (1) ovvero poca coerenza tra ambiente di vita del cane da una parte e<br />
stimolazione e target motivazionale richiesti dalla specie-razza dall’altra – situazione che si<br />
può riscontrare non di rado nella vita oziosa delle nostre case. In questi casi l’utilizzo di<br />
giocattoli non è affatto un antropomorfismo ma un modo per alleviare la scarsa<br />
stimolazione delle motivazioni, sempre che sappiamo completare questa presenza con<br />
attività di interazione e momenti all’aperto. La demotivazione infatti non riguarda solo<br />
l’assenza di attività quanto piuttosto il vivere una situazione quotidiana poco coerente<br />
rispetto alle tendenze interne del soggetto, con insorgenza di noia e di depressione, e più<br />
in generale di distacco dal mondo. Anche una continua “frustrazione” (2) delle motivazioni<br />
accese – ossia stimolare ma non dare possibilità di espressione – è uno dei più importanti<br />
fattori di stress, che spesso esita in comportamenti alterati, come il leccarsi o mordicchiarsi<br />
una parte del corpo o mettere in atto comportamenti ripetuti. Conoscere le motivazioni di<br />
una specie e le vocazioni di una razza è pertanto indispensabile prima di tutto nella scelta
dell’animale da adottare – in riferimento alle disponibilità ad assolverle – e in seconda<br />
battuta nella gestione quotidiana del cane per assicurargli benessere.<br />
Compito dell’educatore è di realizzare una “consulenza sulle motivazioni” attraverso: a)<br />
una consulenza preadottiva, vale a dire orientando la scelta del pet-owner sulla base delle<br />
disponibilità e delle aspettative in riferimento alle vocazioni di razza, che non indicano solo<br />
attitudini bensì specifici bisogni gratificatori e tendenze da disciplinare; b) una consulenza<br />
postadottiva, vale a dire indicando al pet-owner quali attività di gratificazione è necessario<br />
implementare con quel soggetto sulla base delle vocazioni; c) un progetto pedagogico<br />
disciplinativo per evitare che le vocazioni diano luogo a maniacalità, enfatizzazioni e<br />
generalizzazioni su un solo ambito motivazionale con conseguenti problemi di gestioneconduzione<br />
ma altresì con rischi-vulnerabilità nell’ambito della frustrazione e<br />
demotivazione; d) un progetto pedagogico compensativo per arricchire l’orizzonte<br />
motivazionale del soggetto sollecitando lo sviluppo delle motivazioni ipotoniche al fine di<br />
ampliare le capacità collaborative del soggetto, evitando il rischio conativo; e) un progetto<br />
pedagogico prosociale favorendo lo sviluppo delle motivazioni centripetative, per esempio<br />
la m. epimeletica (fare qualcosa per te), la m. collaborativa (fare qualcosa con te), la m.<br />
et-epimeletica (chiedere di fare qualcosa per me), la m. sociale (stare insieme agli altri).<br />
1.1 – Caratteristiche delle motivazioni<br />
Le motivazioni rappresentano le disposizioni proattive del soggetto (proposte): 1)<br />
tendenze a compiere particolari comportamenti; 2) elezione di particolari target; 3)<br />
orientamenti e interessi; 4) aree dove si cerca gratificazione; 5) fattori determinanti le<br />
vocazioni. Le motivazioni si sono sedimentate così come le osserviamo in una specie<br />
perché hanno dato una fitness (vantaggio riproduttivo) riferita al contesto e allo stile di<br />
vita della specie: rappresentano quindi un capitolo importante dell’etogramma. Per<br />
esempio: la motivazione predatoria nel gatto garantisce un maggior successo di<br />
sopravvivenza e capacità riproduttiva. Le motivazioni sono il frutto della storia della specie<br />
(filogenesi) e in tal senso sono innate: a) ogni specie ha un catalogo specifico di<br />
motivazioni; b) ogni razza presenta un particolare volume delle motivazioni di specie. Le<br />
motivazioni sono set neurobiologici e come tali sono suscettibili di evoluzione, vale a dire<br />
vengono organizzate nel processo ontogenetico attraverso l’esercizio, l’esperienza diretta,<br />
il gioco sociale, l’imitazione, la stimolazione. In tal senso la struttura motivazionale si<br />
modifica: a) sotto il profilo del volume, vale a dire quanta rilevanza ha quella motivazione<br />
per quel soggetto; b) per quanto concerne le relazioni con altre componenti cognitive<br />
ovvero se generalizzata ed espressa in modo generico o se disciplinata attraverso regole<br />
espressive.<br />
Quando un’attività viene fatta con il consenso della motivazione rientra nella coordinata<br />
del “voler fare” (gratificazione). Nel momento in cui un’attività viene fatta senza il<br />
consenso della motivazione rientra nella coordinata del “dover fare”(conazione). Se<br />
l’attività è motivazionale ossia per gratificazione viene marcata con emozioni positive = il<br />
soggetto ne ha un ricordo piacevole e vorrà rifarla. Quando l’attività è imposta-richiesta,<br />
non ha cioè la spinta motivazionale del soggetto che la deve compiere e di conseguenza<br />
rientra nel dover fare, ossia per conazione, viene marcata con emozioni negative = il<br />
soggetto ne ha un ricordo spiacevole e si sottrarrà. La coerenza tra la motivazione del
soggetto e l’attività che si trova a compiere è pertanto un requisito di base perché il<br />
soggetto ne abbia poi un ricordo piacevole. Questo aspetto ha rilevanza: 1) nella gestioneconduzione<br />
ordinaria del cane, poiché se impostiamo delle attività che vogliamo che il<br />
cane ripeta o comunque non vi si sottragga è necessario impostarle secondo una<br />
coordinata motivazionale ovvero cercando la motivazione che la sostiene; 2) nella<br />
didattica, perché ogni processo esperienziale e più in generale di apprendimento è un<br />
evento proattivo che pertanto richiede il sostegno e il consenso della motivazione e non un<br />
evento passivo subito dal cane.<br />
Pochi si rendono conto dell’importanza della marcatura emozionale delle situazioni: essa di<br />
fatto trasforma le diverse circostanze vissute dal cane in magneti capaci di attrarre<br />
successivamente il soggetto nella medesima situazione qualora sia stata marcata con<br />
emozioni positive o, viceversa, di respingerlo se marcata con emozioni negative. Se il cane<br />
è chiamato a fare continuamente un’attività per conazione – per esempio lo porto sul<br />
campo e lo costringo a fare un’attività che a lui non interessa – in breve quella situazione<br />
(ambiente, attività, struttura di relazione, persone presenti) verrà ricordata con una<br />
marcatura emozionale negativa e in seguito il cane tenderà a sottrarsi da tale situazione.<br />
Se voglio che il cane si orienti verso la situazione-attività che desidero devo costruire<br />
l’attività stessa secondo le coordinate motivazionali ossia: a) individuare la motivazione<br />
che regge quell’attività e costruire il set in modo tale da suscitare in lui la corretta<br />
motivazione; b) trasformare l’attività in una cornice ludica (metamotivazionale) e<br />
organizzare la prestazione richiesta come espressione della motivazione; c) far sì che la<br />
prestazione preveda il raggiungimento di un target coerente con il profilo della<br />
motivazione e che si chiuda con un evento di autoefficacia, che prevede gratificazione e<br />
autostima; d) chiudere l’attività quando il soggetto è ancora in fase proattiva in modo tale<br />
da non stancare la declinazione specifica della motivazione.<br />
Quanto detto ha a che fare sia con la realizzazione del benessere quotidiano del cane,<br />
giacché per star bene il cane si deve sentire motivato ovvero attivo nella sua struttura<br />
motivazionale, sia con la didattica poiché apprendere è un evento attivo e costruttivo,<br />
basato cioè su proposte del discente, e quindi richiede il coinvolgimento motivazionale.<br />
Nella didattica behaviorista tutto si basa sull’incentivo alimentare, ma questo porta a una<br />
stanchezza dell’attività perché non organizzata in senso gratificatorio ma solo sul baratto:<br />
tu cane fai questa attività (che non ti piace e non ha alcun senso per te) e io ti do un<br />
bocconcino. L’attività inevitabilmente viene marcata con emozioni negative e col passare<br />
del tempo occorrerà una sempre maggiore ricompensa per attivarla.<br />
La motivazione è la tendenza di base, per esempio la m. sillegica è la tendenza a<br />
“raccogliere”.<br />
La declinazione della motivazione è l’ambito di espressione della motivazione, per esempio<br />
“raccogliere palline”. Se troppo espressa può andare in saturazione, quindi occorre<br />
mantenere alto il valore evitando di stancare e mantenendo un certo languore. La<br />
motivazione è il sale della vita, ciò che dà sapore alle attività. Se motivato non senti la<br />
fatica, se demotivato anche il più piccolo sforzo è insopportabile. Rispetto all’interesse<br />
motivazionale abbiamo i seguenti stati: 1) appetitivo = il soggetto è inquieto perché<br />
desidera esprimere una certa motivazione, ne è stimolato dalla situazione o dalla presenza<br />
del target; 2) frustrativo = il soggetto è a disagio perché pur essendo stimolato non gli si<br />
permette di esprimere una motivazione; 3) gratificato = il soggetto è sereno perché ha
potuto esprimere la motivazione; 4) demotivato = il soggetto è depresso perché non ha<br />
motivazioni aperte.<br />
Quando al soggetto viene richiesta un’attività senza il consenso della motivazione è in uno<br />
stato di “conazione”: a) petizione = ti chiedo di fare qualcosa che non vuoi fare; b)<br />
imperativo = ti ordino o utilizzo la mia autorità per farti fare quello che non vuoi fare; c)<br />
coercizione = ti costringo con la forza o con strumenti di contenzione a fare quello che<br />
non vuoi fare; d) ricompensa o baratto = ti faccio fare quello che non vuoi fare attraverso<br />
una ricompensa. A lungo andare uno stato conativo continuo provoca effetti quali stress<br />
e/o ansia nel cane. La conazione fa parte della “triade impositiva”: inibizione, conazione,<br />
vessazione. Per questo è necessario limitare per quanto possibile l’effetto conativo, anche<br />
nella tradizionale forma del baratto (se fai questo ti do un bocconcino), cercando di<br />
inserire l’attività su una coordinata motivazionale (coinvolgimento).<br />
Anche un continuo stato di frustrazione comporta una situazione di inquietudine e<br />
inappagamento che può evolvere in un comportamento derivale: FRUSTRAZIONE (sono<br />
inquieto perché non posso esprimere quello che voglio) è SOSTITUZIONE (limito la mia<br />
inquietudine attraverso l’espressione di una motivazione simile o gemella) è<br />
REITERAZIONE (quell’attività mi dà piacere ma non gratificazione perciò la ripeto) è<br />
COMPULSIONE (faccio quell’attività in modo ritualizzato per anticipare uno stato di<br />
inquietudine) èSTEREOTIPIA (non mi accorgo di fare quell’attività). Bisogna pertanto<br />
evitare di mettere il soggetto in un continuo stato di frustrazione. Tuttavia nella vita<br />
sociale il cucciolo deve imparare a gestire gli effetti contrastativi allo stato motivazionale:<br />
1) gestione della frustrazione = imparare che non sempre si può fare quello che si<br />
desidera; 2) gestione della conazione = imparare che talvolta si deve fare anche ciò che<br />
non si desidera. La ridirezione è un altro effetto frequente dell’impossibilità di dirigere sul<br />
target competente l’espressione motivazionale: in questo caso abbiamo a differenza della<br />
sostituzione l’espressione piena della coordinata motivazionale ma su un “target<br />
surrogato” che non dà piena gratificazione.<br />
Ovviamente per promuovere il benessere motivazionale e impostare una didattica<br />
coerente con la struttura motivazionale, vale a dire consensuale, è necessario conoscere<br />
molto bene le motivazioni dei cani come specie e le tendenze vocazionali delle diverse<br />
razze. Per quanto concerne le motivazioni alcuni orientamenti di base facilmente rinvenibili<br />
nel cane sono i seguenti: 1) m. predatoria = volgersi verso gli oggetti piccoli in movimento<br />
e raggiungerli; 2) m. sillegica = raccogliere degli oggetti e portarli nella tana o in un<br />
nascondiglio; 3) m. territoriale = difendere un territorio o un ambiente circoscritto; 4) m.<br />
protettiva = difendere un affiliato o un cucciolo; 5) m. perlustrativa = esplorare un<br />
ambiente e mapparlo; 6) m. esplorativa = analizzare un oggetto nei dettagli; 7) m.<br />
epimeletica = aiutare e accudire un compagno; 8) m. competitiva = confrontarsi o<br />
gareggiare con un compagno; 9) m. di ricerca = cercare degli oggetti nascosti; 10) m. di<br />
corteggiamento = attirare un partner sessuale; 11) m. cinestesica = fare movimento,<br />
correre, saltare; 12) m. somestesica = esplorare il proprio corpo; 13) m. collaborativa =<br />
fare un’attività con un partner, concertarsi in un’attività di gruppo; 14) m. possessiva =<br />
mantenere il possesso di un oggetto; 15) m. comunicativa = esprimere uno stato o<br />
indicare qualcosa; 16) m. et-epimeletica = chiedere l’aiuto o lasciarsi curare da un altro<br />
soggetto; 17) m. affiliativa = far parte di un gruppo ristretto; 18) m. sociale = raggiungere<br />
un posizionamento all’interno del gruppo.
Le diverse razze si differenziano anche per il volume differente o prevalenza delle varie<br />
motivazioni: a) Labrador e in generale i retriever = prevalenza della motivazione<br />
epimeletica; b) Border collie e in generale i conduttori di gregge = prevalenza della<br />
motivazione predatoria; c) Rottweiler e in generale i molossoidi = prevalenza della<br />
motivazione competitiva; d) Maremmano e in generale i custodi del gregge = prevalenza<br />
della motivazione protettiva. A seconda della motivazione prevalente il cucciolo farà<br />
proposte ludiche conseguenti per esempio nel labrador avremo il riporto di oggetti, nel<br />
border il gioco della pallina, nel rottweiler il tira molla. Il gioco per il cane è una palestra<br />
per strutturare la motivazione. Il progetto pedagogico sarà pertanto specifico nelle<br />
diverse razze: 1) la didattica terrà conto delle diverse strutture motivazionali del cucciolo<br />
evitando di forzare le motivazioni deboli (ponendo delle regole troppo strette, dei tempi<br />
lunghi di attività, dei costi troppo alti di espressione) e viceversa gratificando molto il<br />
soggetto e mantenendo alta la motivazione (interrompo l’attività quando il cane ne ha<br />
ancora voglia) e parallelamente strutturando l’attività nelle motivazioni prevalenti in modo<br />
disciplinativo (ovvero impostando regole e chiedendo al soggetto attività supplementari; 2)<br />
l’educazione dovrà tener conto della struttura motivazionale evitando di enfatizzare le<br />
motivazioni già alte e parimenti sviluppando le aree deboli e parimenti incentivando le<br />
motivazioni pro sociali; 3) l’istruzione andrà a dare conoscenze specifiche di espressione<br />
sulle motivazioni prevalenti (quale target, quale modo, quale contesto) e autocontrolli e<br />
regole su quelle che possono divenire problematiche nella gestione e conduzione ordinaria<br />
del cane.<br />
L’espressione delle motivazioni presenta delle variabili che vanno conosciute: a) effetto di<br />
autoefficacia = una motivazione è più facilmente attivabile quanto maggiori sono i riscontri<br />
di autoefficacia che il soggetto ha ottenuto in quell’ambito ovvero quanto maggiore è nel<br />
cane la percezione di competenza che possiede in quell’espressione; b) effetto interattivo<br />
= le motivazioni instaurano rapporti reciproci ovvero ogni motivazione ha motivazioni<br />
sinergiche che ne facilitano l’attivazione e motivazioni contro laterali che ne ostacolano<br />
l’espressione; c) effetto onerativo = una motivazione si attiva e si esprime in modo<br />
inversamente proporzionale ai costi che il soggetto deve sostenere per esprimerla o alle<br />
regole di espressione a cui il soggetto deve sottostare per esprimerla; d) effetto di<br />
prevalenza = una motivazione è tanto più attivabile quanto maggiori sono i target che la<br />
gratificano, gli stimoli che la suscitano e la molteplicità di espressione a cui è correlata.<br />
A) Effetto di autoefficacia. Nell’espressione della motivazione il cane raggiunge particolari<br />
risultati, ne riceve cioè un riscontro di autoefficacia (sono capace) e in genere il soggetto è<br />
più portato a svolgere le attività di cui si sente capace. Il ritorno di autoefficacia è<br />
un’ulteriore gratifica e anche questo catalizza l’attenzione del cane su quel particolare<br />
comportamento. In quell’ambito cioè il cane si sente a proprio agio ed è portato a<br />
ricercare gratificazione agendo su quella coordinata motivazionale piuttosto che su altre.<br />
B) Effetto interattivo. Le diverse motivazioni tra di loro possono avere un effetto di<br />
potenziamento (m. sinergiche) o di antagonismo (m. controlaterali). Sono sinergiche<br />
quando insistono su una medesima direttrice comportamentale, per esempio di<br />
centrifugazione o di aggressione. Sono controlaterali quando prevedono comportamenti<br />
opposti, per esempio rincorrere o mantenere il possesso. Si possono utilizzare le<br />
sinergiche per potenziare una particolare motivazione e le controlaterali per abbassare una<br />
particolare motivazione.
C) Effetto onerativo. L’espressione di una motivazione richiede uno sforzo<br />
comportamentale che può essere valutabile come la lacuna che il soggetto deve riempire<br />
per poter raggiungere il target motivazionale. Questa lacuna non è propriamente uno<br />
spazio fisico quanto piuttosto un contesto di scacco ovvero un insieme di impedimenti, di<br />
distanze, di azioni poste al cane come problemi da risolvere, da cui la natura proattiva<br />
delle motivazioni. Ora è possibile accrescere il contesto di scacco ovvero il costo che il<br />
cane deve pagare per raggiungere il target (effetto onerativo) e in questo caso<br />
diminuiremo l’espressività della motivazione oppure si può diminuirlo (effetto esonerativo)<br />
aumentando l’espressività.<br />
D) Effetto di prevalenza. Il mondo è una collezione di enti alcuni dei quali immediatamente<br />
correlabili con una motivazione (per esempio un piccolo animale che corre davanti al cane<br />
per la motivazione predatoria) altri richiamabili per affinità (una pallina). Quanto più il<br />
soggetto si esercita su un gran numero di target tanto più si allarga l’effetto di richiamo<br />
ovvero la sua tendenza a trovare nei diversi oggetti dei richiami rispetto a quella<br />
motivazione. Allo stesso modo quanto più si giocherà su quella coordinata motivazionale<br />
tanto più il cane valuterà l’interazione con noi secondo quella precisa coordinata<br />
ampliando l’orizzonte degli stimoli che la suscitano e delle espressioni che la<br />
caratterizzano.<br />
1.2 – Motivazioni e progetto pedagogico<br />
La motivazione come tendenza espressiva è altresì una “coordinata evolutiva” e in tal<br />
senso può risentire di diversi sviluppi: 1) generalizzazione = non si danno regole e la<br />
motivazione viene espressa in modo libero; 2) enfatizzazione = si lavora sempre su quella<br />
motivazione e la motivazione diviene ipertrofica; 3) disciplina = si lega la motivazione a un<br />
target specifico, a un modo espressivo e a un contesto; 4) depressione = non si stimola e<br />
non si esercita il soggetto su quella coordinata motivazione e questa diviene sempre meno<br />
importante per il soggetto. Se pensiamo agli obiettivi pedagogici avremo: a) bisogni di<br />
equilibrio: il soggetto non dev’essere maniacale ed eccessivo in un solo ambito<br />
motivazionale ma deve poter godere di un ampio orizzonte di motivazioni; b) bisogni di<br />
gratificazione: il benessere del soggetto si basa sull’espressione delle sue tendenze<br />
pertanto occorre dargli competenze in modo tale da fargliele esprimere in modo non<br />
problematico rispetto al suo inserimento nell’ecumene; c) bisogni prosociali: il soggetto<br />
deve potersi inserire in modo positivo nella comunità e per questo è adattativo per lui,<br />
oltre che favorevole nella gestione, la prevalenza di tendenze pro sociali, come la<br />
collaborazione, l’affiliazione, l’epimelesi, rispetto alla predatorietà e alla territorialità, per<br />
cui è necessario favorire le prime rispetto alle seconde.<br />
I quattro ambiti di lavoro evolutivo sulle motivazioni sono importanti nella costruzione del<br />
carattere del cane: 1) Generalizzazione e disciplina lavorano sul “modo composizionale”<br />
della motivazione, ovvero a cosa è legata la motivazione, mentre enfatizzazione e<br />
depressione lavorano sul “volume” della motivazione ossia sulla forza-prevalenza di quella<br />
motivazione sul soggetto. Attraverso la generalizzazione si amplia il catalogo espressivo ed<br />
elicitativo della motivazione, vale a dire si lavora sull’effetto di prevalenza e sull’esonero<br />
mentre nella disciplina, al contrario, si limita l’effetto di prevalenza e si danno delle regole<br />
espressive e quindi si onera ma al contempo si dà autoefficacia se l’espressione viene
ealizzata nel modo disciplinato. L’enfatizzazione lavora sull’esonero, sulla prevalenza, sulle<br />
sinergiche e sull’autoefficacia mentre la depressione lavora limitando la prevalenza,<br />
ponendo oneri all’espressione e soprattutto cercando di attivare le controlaterali.<br />
La generalizzazione è molto spesso l’effetto indesiderato di una carenza pedagogica ed è<br />
la fonte di molti problemi comportamentali del cane. Si verifica quando si accondiscende<br />
alle proposte ludiche generaliste del cucciolo senza dargli alcuna regola: a) rincorri<br />
qualunque cosa, in qualunque modo, in qualunque contesto; b) prendi e tira qualunque<br />
cosa, in qualunque modo, in qualunque contesto. La generalizzazione crea maniacalità,<br />
non indirizza la motivazione, lasciandola libera la enfatizza, non la struttura e di<br />
conseguenza darà problemi di gestione del cane, di integrazione nell’ecumene, di<br />
inserimento sociale e parimenti rischi di frustrazione e vessazione perché il pet-owner sarà<br />
costretto a controllare il cane. La generalizzazione può essere utile per le motivazioni che<br />
hanno una forte credenziale di integrazione e inserimento sociale: in questo caso si cerca<br />
di effettuare l’effetto di prevalenza e si dà molta autoefficacia. Le motivazioni enfatiche e<br />
problematiche, al contrario, non vanno generalizzate bensì disciplinate.<br />
Nella disciplina, che non significa imposizione o inibizione bensì definizione di regole<br />
espressive, si usa la forza vocazionale (per es. la predatorietà del border) per definire un<br />
alveo espressivo e trasformare la vocazione in attitudine: a) definizione di un target<br />
specifico; b) definizione di un modo espressivo; c) definizione di un contesto particolare.<br />
Disciplina significa pertanto assunzione di regole precise ossia limitazione dell’effetto di<br />
prevalenza. La definizione di regole ha peraltro un effetto onerativo quindi rischia di<br />
abbassare il volume della motivazione: per questo va applicata alle motivazioni prevalenti<br />
nel soggetto e va affiancata a riscontri di autoefficacia allorché viene espressa in modo<br />
disciplinato. In genere si lavora sulla disciplina in quelle motivazioni che possono<br />
presentare problematicità.<br />
Nell’enfatizzazione: si cerca di aumentare il volume di una motivazione perché troppo<br />
ipotonica attraverso: 1) stimolazione = presentazione di target e contesti coerenti con<br />
quella motivazione 2) esonero = si diminuisce il costo di espressione della motivazione; 3)<br />
esercizio = si propongono attività (un premio) su quella coordinata motivazionale; 4)<br />
autoefficacia = si consente di raggiungere al cane il successo e il target motivazionale, 5)<br />
sinergici = si lavora sulle motivazioni sinergiche e si deprimono le antagoniste. Si<br />
enfatizzano quelle motivazioni che, ipotoniche in quella razza o in quel particolare<br />
soggetto, sono al contrario importanti per l’inserimento prosociale e per le attività<br />
collaborative che si vogliono intraprendere.<br />
Nella depressione si cerca di diminuire il volume di una motivazione perché troppo<br />
sviluppata attraverso: 1) deprivazione = si tolgono gli stimoli o si allontana da un contesto<br />
che suscita quella motivazione; 2) effetto onerativo = si aumenta il costo di espressione di<br />
una particolare motivazione; 3) disgiunzione = si evita di gratificare il soggetto in quella<br />
particolare area motivazionale; 4) attivazione controlaterale = si vanno a suscitare,<br />
esercitare e gratificare le motivazioni che si oppongono a quella particolare motivazione.<br />
La depressione non ha l’obiettivo di azzerare una motivazione, anche perché non sarebbe<br />
possibile, né inibire l’espressione di una particolare motivazione, ma semplicemente di<br />
diminuirne fortemente il volume. Associata a un’azione disciplinativa (senza autoefficacia)<br />
consente di evitare il conflitto con il pet-owner e la frustrazione nel cane.<br />
Rispetto alla pet-ownership le motivazioni possono favorire o contrastare la<br />
centripetazione; in tal senso abbiamo: a) motivazioni centrifugative: quelle che
allontanano il cane dal rapporto (esplorativa, predatoria); b) motivazioni autocentrative:<br />
quelle che chiudono il cane su se stesso (possessiva, territoriale); c) motivazioni<br />
centripetative: quelle che portano il cane verso la persona (epimeletica, collaborativa). Se<br />
il cane si presenta troppo centrifugato rispetto al pet-owner è necessario incentivare le<br />
motivazioni centripetative, in modo tale da favorire la gratificazione nello stare accanto al<br />
pet-owner. Se il cane si presenta troppo centrifugato rispetto al suo ambiente di vita (per<br />
esempio i cani che tendono ad allontanarsi da casa) occorre, insieme ovviamente ad altri<br />
interventi, incentivare le motivazioni centripetative e autocentrative. Se il cane si presenta<br />
troppo centripetato occorre al contrario favorire alcune motivazioni centrifugative, come<br />
l’esplorativa. Se il cane è autocentrato bisogna lavorare sia sulle centripetative che sulle<br />
centrifugative.<br />
Per disciplinare una motivazione occorre scegliere dei target molto specifici che non si<br />
prestino a processi di generalizzazione. Per questo occorre fare molta attenzione ai<br />
giocattoli usati nelle attività ludiche: i giocattoli divengono dei target e la loro struttura può<br />
favorire l’effetto di prevalenza come, al contrario, deprimerlo. Se per esempio utilizzo<br />
giocattoli a forma di animale in giochi predatori è facile che poi il cane generalizzi su dei<br />
target viventi.<br />
Quando un’espressione motivazionale è strutturata in una “cornice motivazionale appresa”<br />
parliamo di “comportamento motivazionale”. Se al contario un’espressione motivazionale è<br />
destrutturata, generalista, ridiretta o secondo coordinate innate parliamo di<br />
“comportamento motivo”, che fa parte del comportamento impulsivo.<br />
Per quanto concerne gli ambiti di lavoro sulle motivazioni ovvero i contesti ove è possibile<br />
mettere in atto una pedagogia motivazionale abbiamo: 1) le attività ludiche, giacché il<br />
gioco è metamotivazionale, apre cioè le motivazioni rendendo facile l’elicitazione (suscitare<br />
una motivazione), la scelta della coordinata motivazionale (elezione della motivazione), la<br />
definizione di uno stile espressivo; 2) le attività di relazione con il pet-owner, vale a dire il<br />
tipo di interscambio e il ruolo assunto dal cane, poiché le dimensioni di relazione<br />
prevedono l’attivazione di certe coordinate motivazionali; 3) il tipo di ambiente in cui il<br />
cane vive la sua quotidianità attraverso le situazioni e gli elementi che stimolano o<br />
suscitano particolari coordinate motivazionali e la disponibilità di target che vanno a<br />
gratificare e danno autoefficacia a certe espressioni motivazionali; 4) le attività sociali<br />
ossia come il cane è inserito all’interno delle dinamiche sociali all’interno del gruppo e al di<br />
fuori del gruppo.<br />
Gli obiettivi pedagogici di base sulle motivazioni possono essere così riassunti: a)<br />
disciplinare le motivazioni enfatiche; b) sviluppare le motivazioni neglette; c) favorire le<br />
motivazioni centripetative; d) dare un quadro composizionale all’assetto. Ovviamente ogni<br />
progetto pedagogico specifico risente delle altre variabili sopra descritte e comunque va<br />
ricostruito sul soggetto perché variano le m. enfatiche, le m. neglette, le esigenze<br />
centripetative e la struttura complessiva dell’identità comportamentale del cane.<br />
A) Disciplinare le motivazioni enfatiche = affinché le vocazioni possano diventare<br />
doti/attitudini è necessario dotarle di una cornice rappresentazionale di target, modo e<br />
contesto: 1) evita la maniacalità e quindi la deriva frustrativa; 2) facilita la gestione del<br />
cane.<br />
B) Sviluppare le motivazioni neglette = affinché il cane possa trovare in qualunque<br />
situazione o attività un “gancio motivazionale” è importante sviluppare un orizzonte ampio<br />
di motivazioni: 1) consente di evitare la facilità conativa ovvero che molte attività siano
vissute come imposte; 2) consente di evitare gli stati di demotivazione ovvero le derive<br />
depressive.<br />
C) Favorire le motivazioni centripetative = attraverso un buon tono delle motivazioni<br />
centripetative avrò un soggetto portato alla relazione con l’uomo e non sfuggente a tale<br />
relazione. Le motivazioni centripetative sono un importante fattore di socievolezza.<br />
D) Dare un quadro composizionale = bisogna evitare il comportamento motivo (impulsività<br />
motivazionale) che quasi sempre è disadattativo rispetto alla complessità di proposte che il<br />
cane deve saper fare nell’ambito ecumenico. Laddove prevale il comportamento motivo ci<br />
sarà una maggiore tendenza inibitiva e una maggiore richiesta di autocontrollo. Per<br />
favorire il comportamento motivazionale bisogna legare alla struttura motivazionale delle<br />
rappresentazioni e delle emozioni adeguate.<br />
2 - EMOZIONI<br />
Le emozioni rappresentano una delle componenti più importanti della vita mentale del<br />
cane. Attraverso le emozioni il cane dà un’interpretazione immediata di quello che gli sta<br />
accadendo e si mette nelle migliori condizioni fisiologiche e comportamentali per affrontare<br />
quella particolare situazione. Alcune emozioni come la paura aumentano il battito cardiaco<br />
altre come il disgusto lo rallentano, certe emozioni come la rabbia rendono insofferenti a<br />
ogni interazione altre come la festosità accrescono il desiderio di interazione. Sotto questo<br />
aspetto esistono emozioni positive che danno piacere e aumentano l’apertura del soggetto<br />
verso il mondo ed emozioni negative che diminuiscono il piacere e chiudono la sua<br />
interazione. Esistono stimoli che suscitano in modo innato certe emozioni: per esempio è<br />
facile che un rumore improvviso o l’apertura di un ombrello suscitino la paura così come<br />
un invito al gioco da parte di un conosciuto induce gioia e festosità.<br />
D’altro canto quando il cane viene a contatto con oggetti o situazioni nuove a seconda di<br />
quello che gli procurano – piacere o sofferenza - verranno marcati con emozioni positive o<br />
negative e come tali verranno ricordati. Le emozioni sono pertanto centrali nel ricordo e<br />
funzionano come delle bussole che orientano il cane verso qualcosa o lo allontanano da<br />
essa. Per questo è importante marcare con emozioni positive tutti quegli oggetti e<br />
situazioni con cui il cane deve confrontarsi quotidianamente: l’automobile e i mezzi di<br />
trasporto, i locali aperti al pubblico, la presenza di bambini, l’incontro di persone o cani<br />
sconosciuti, gli oggetti di vestizione come la pettorina o la museruola, le biciclette e le<br />
carrozzine, la mano dell’uomo, l’ascensore, i rumori, il trasportino, etc. Per marcare<br />
positivamente si possono utilizzare stimoli piacevoli come il bocconcino o, in certi casi, la<br />
carezza. Se il cane sta vivendo emozioni positive è più predisposto all’esplorazione,<br />
all’interazione, all’esperienza e quindi all’apprendimento: per questo se vogliamo insegnare<br />
qualcosa al nostro cane dobbiamo preoccuparci che stia provando emozioni positive.<br />
Le emozioni hanno anche un’importante funzione comunicativa, servono cioè nella loro<br />
espressione a portare fuori ciò che il soggetto sta vivendo. Abbiamo funzioni di confronto<br />
o collative che mettono gli interlocutori nella situazione di dichiarare reciprocamente il<br />
proprio stato. Attraverso l’espressione delle emozioni il cane mostra agli interlocutori come<br />
è predisposto ovvero quello che sta vivendo in un particolare momento, compreso le sue<br />
disposizioni verso gli interlocutori stessi. Esistono poi funzioni concertative ovvero<br />
espressioni di emozioni, come la paura o la festosità, che hanno la funzione di sintonizzare<br />
tutti i membri del gruppo su un particolare stato. In genere le emozioni si trasmettono per
contagio all’interno del gruppo, come una sorta di onda concertativa, soprattutto se<br />
espresse ad alta soglia ovvero se il comportamento ad esse legato è declamato. Ma nel<br />
rapporto reciproco le emozioni si trasmettono anche a bassa soglia, per osmosi: per<br />
indurre nel nostro cane emozioni positive è importante che noi stessi ci poniamo in modo<br />
positivo.<br />
La differenza tra contagio e osmosi ci permette di definire due stati emozionali differenti:<br />
a) soprasoglia, dove una particolare emozione prende il sopravvento su tutte le altre e si<br />
caratterizza in modo chiaro, con risposte fisiologiche e comportamentali molto evidenti; b)<br />
sottosoglia, allorché l’emozione è sì attivata ma non prende il sopravvento e si inserisce<br />
all’interno di un assetto emozionale più complesso e prolungato nel tempo che prende il<br />
nome di “umore”. A lungo andare la prevalenza di una disposizione emozionale o di un<br />
assetto emozionale specifico ha effetti ontogenetici, in altre parole va a definire la<br />
“tendenza emozionale del soggetto”, altrimenti detto “carattere emozionale”. Il carattere<br />
emozionale indica il modo prevalente con cui il soggetto interpreta le situazioni ossia come<br />
il cane prende la vita, generalizzando gli enti in modo positivo o negativo.<br />
Il carattere emozionale è un aspetto che qualifica il modo ordinario con cui il cane si<br />
rapporta al mondo: 1) se prevalgono in lui le emozioni positive avremo un carattere<br />
fiducioso, aperto al mondo, giocoso, esplorativo, desideroso di entrare in relazione; 2) se<br />
prevalgono le emozioni negative avremo un carattere diffidente, chiuso e non interattivo.<br />
Il carattere emozionale è in parte innato: già alla nascita, valutando la cucciolata,<br />
troveremo soggetti più sicuri, più diffidenti, più apatici, più festosi. Tuttavia sono le<br />
esperienze che maggiormente influenzano la struttura del carattere emozionale. Per<br />
favorire lo sviluppo di un carattere fiducioso è necessario mettere il cucciolo in condizioni<br />
piacevoli evitando di sottoporlo a stimoli che producono sofferenza, disagio, costrizione,<br />
vessazione e frustrazione.<br />
Alcune emozioni come la paura possono essere indotte non solo da situazioni spiacevoli<br />
vissute ma altresì da mancanza di conoscenza di un particolare ente o più in generale da<br />
uno sviluppo caratterizzato o da una estrema povertà di stimolazione (un ambiente non<br />
arricchito) o da un’alterazione del processo di attaccamento (profilo insicuro). Sia la<br />
povertà di occasioni esperienziali sia la mancanza di una buona base sicura possono<br />
determinare un’alterazione del processo di socializzazione ambientale nota come sindrome<br />
da privazione sensoriale. Per questo è molto importante che il cucciolo cresca con la<br />
madre nei primi due mesi e lo faccia in un ambiente arricchito. Dopo è indispensabile che<br />
il proprietario completi il processo di attaccamento dandogli sostegno e sicurezza e<br />
cercando di renderlo sempre più autonomo e parallelamente mettendolo in interazione con<br />
più stimoli possibili, soprattutto con quegli oggetti-situazioni con cui si dovrà confrontare<br />
nella sua vita quotidiana. Occorre ricordare che il primo anno di vita è centrale nello<br />
sviluppo emotivo del cane e che adottare un cucciolo richiede delle attenzioni anche per<br />
dare un equilibrio emotivo alla vita adulta.<br />
La struttura emozionale ha una rilevanza nel profilo comportamentale perché si sviluppa in<br />
modo inconscio e fa partire immediatamente il treno di risposte fisio-comportamentali, per<br />
cui ciò che il soggetto avverte non è l’emozione come disposizione mentale ma le risposte<br />
del corpo. Quando prendiamo in carico (ci rendiamo conto) le risposte proviamo un<br />
sentimento.
2.1 – Caratteristiche delle emozioni<br />
<br />
<br />
Le emozioni rappresentano le disposizioni reattive del soggetto (risposte) ovvero come si<br />
dispone il cane (viraggio fisiologico-comportamentale) in relazione a quello che presenta la<br />
realtà esterna in un particolare momento. Mentre le motivazioni sono disposizioni proattive<br />
(tendenza a fare e a proporre una certa attività), le emozioni sono disposizioni reattive<br />
(modi di rispondere agli eventi del mondo esterno). In tal senso le emozioni<br />
rappresentano delle: 1) strutture interpretative = tendenze a valutare in un certo modo un<br />
ente ossia una situazione-evento oppure un target-stimolo; 2) strutture responsive = treni<br />
di espressioni fisiologico-comportamentali in risposta alla sollecitazione ricevuta dalla<br />
realtà esterna in un momento specifico; 3) strutture comunicative = modalità espressive<br />
atte a concertare o a confrontare le disposizioni vissute dal soggetto nel qui e ora; 4)<br />
strutture mnestiche = modi per marcare un particolare ente e quindi di ricordarlo.<br />
Le emozioni come le motivazioni sono disposizioni mentali ossia componenti posizionali<br />
della mente, modalità discrete (un po’ come i diversi colori) in cui la mente si presenta e si<br />
pone sia sotto il profilo proattivo (cosa ha voglia di fare = motivazioni) sia sotto quello<br />
reattivo (come risponde agli eventi = emozioni). Le emozioni non sono semplicemente<br />
sollecitate dal mondo, ma rappresentano “modalità preconcette di valutare gli eventi del<br />
mondo” attraverso una collezione di risposte strutturate, per esempio: a) la paura si<br />
manifesta attraverso l’immobilità, il diminuire l’esposizione del corpo, la midriasi; b) la<br />
festosità dà luogo a un’ipercinesi, a una tendenza interattiva, a una propensione alla<br />
vocalizzazione. Esistono correlazioni innate tra tipologie di eventi e tipologia emozionale –<br />
un rumore improvviso sollecita la paura – e tuttavia nel corso dell’ontogenesi l’individuo<br />
costruisce nuove correlazioni (ricordi di eventi) sulla base di ciò che un evento ha<br />
provocato nel soggetto, per cui una situazione o un target vanno a sollecitare una<br />
particolare emozione.<br />
Le emozioni perciò donano all’individuo una sorta di competenza di risposta innata e<br />
diretta, organizzata su conoscenze sedimentate dalla filogenesi ma altresì in grado di<br />
estendersi alle esperienze vissute dal soggetto nel corso della vita. Si tratta di una<br />
reattività condivisa dalla specie – tutti i soggetti presentano quel viraggio fisiologicocomportamentale<br />
quando vivono quella particolare emozione – per cui facilmente<br />
riconoscibile e dai forti connotati comunicativi. Da questa prima analisi risaltano le tre<br />
funzioni adattative delle emozioni: a) mettere il corpo nelle migliori condizioni per<br />
affrontare un ente nelle sue problematicità (rischi/opportunità) potendo avere a<br />
disposizione degli “stati reattivi” ben precisi e differenziati sotto il profilo della condizioni<br />
del corpo e dei comportamenti messi in atto; b) esprimere in modo chiaro e inequivocabile<br />
le proprie disposizioni a un interlocutore sulla base di eventi fisiologici, per esempio la<br />
miosi/midriasi oppure l’emissione di particolari feromoni, e comportamentali, per esempio<br />
il mettersi in allerta piuttosto che il rilassarsi; c) ricordare l’ente attraverso il valore che<br />
questo ha avuto per il soggetto in modo tale da avere un primo livello interpretativo<br />
appreso di tipo orientativo.<br />
Rispetto al punto “a” diremo che le emozioni, in qualità di treni di risposte fisiologichecomportamentali,<br />
contribuiscono a mettere il corpo nelle migliori disposizioni per<br />
affrontare una certa situazione. Vale a dire che sono pacchetti di risposte che, lungo la<br />
storia della specie, si sono rivelati utili ad affrontare delle situazioni tipo. Questo non<br />
significa che siano sempre adattative, soprattutto allorché presentano situazioni nuove
ispetto alla selezione filogenetica. La paura per esempio può dar luogo alla risposta di<br />
immobilità (frezing) riconducibile al fatto che a muoverla è stata in natura un predatore e,<br />
come sappiamo, è più facile sfuggire alla vista di un predatore rimanendo immobile. Ma se<br />
oggi a spaventarci è un tir il frezing non ci è di aiuto anzi, rischia di metterci nei guai.<br />
Rispetto al punto “b” diremo che le emozioni sono importanti per facilitare la<br />
comunicazione all’interno di un gruppo perché le risposte sono standardizzate e<br />
significanti, ovvero portatrici di un valore ben preciso e condiviso: 1) funzione<br />
CONCERTATIVA = le emozioni si contagiano per osmosi all’interno del gruppo mettendo<br />
tutto il gruppo in una certa situazione; 2) funzione COLLATIVA = le emozioni facilitano il<br />
confronto tra il proprio stato e quello dell’altro contribuendo a dichiarare lo stato<br />
disposizionale dei due interlocutori. L’espressione delle emozioni ha un importanza<br />
fondamentale nella comunicazione di presentazione e di incontro sociale perché<br />
testimoniano in modo fedele lo stato degli interlocutori.<br />
Rispetto al punto “c” diremo che l’atto di ricordare un evento implica sempre due processi:<br />
1) la significazione = cosa vuol dire quell’evento ovvero la rappresentazione concettuale<br />
dell’ente; 2) l’attribuzione di valore = come quell’ente interferisce con il mio stato di<br />
piacere ossia il valore emozionale. Se uscendo di casa vediamo che sta piovendo<br />
quell’evento sollecita in noi un ricordo che ha una valenza concettuale (bisogna prendere<br />
l’ombrello) e una valenza emozionale (storciamo il naso). Ogni esperienza e<br />
apprendimento subisce una “marcatura emozionale” per cui il ricordo non è mai un evento<br />
unicamente rappresentazionale (quali immagini sollecita, come dobbiamo interpretarlo,<br />
cosa dobbiamo fare) ma anche emozionale (quali emozioni ci suscita). La marcatura<br />
emozionale orienta il nostro comportamento verso quelle situazioni e quei target che sono<br />
ricordati attraverso emozioni positive.<br />
Le emozioni sono strutture filogenetiche, hanno cioè un significato di fitness (hanno<br />
aumentato le possibilità di sopravvivenza e di riproduzione) nelle funzioni sopracitate e<br />
quindi hanno una rilevanza profonda nel soggetto. Le emozioni come componenti innate si<br />
sono sedimentate nella specie perché consentono al soggetto una prima valutazione non<br />
concettuale della situazione rispetto all’orientamento e al tipo di risposta che richiede.<br />
Tuttavia le emozioni, proprio come le motivazioni, vengono disciplinate dall’esperienza, in<br />
modo tale da evitare la sequenza in default: target – emozione – risposta innata. Il<br />
soggetto nel corso dell’ontogenesi acquisisce autocontrollo, conoscenze interpretative,<br />
nuove modalità di risposta. L’espressione diretta dell’emozione, ovvero non mediata dalla<br />
valutazione rappresentazionale e priva di autocontrollo, dà luogo al “comportamento<br />
emotivo” che rappresenta l’altro capitolo (insieme a quello motivo) dell’impulsività, un<br />
aspetto di alta problematicità gestionale. Se l’emozione è illuminata dalla valutazione<br />
rappresentazionale e se il soggetto mantiene l’autocontrollo abbiamo un comportamento<br />
emozionale.<br />
Ogni specie si caratterizza per assetti emozionali specifici ma altresì ogni razza: più o<br />
meno paurosa, festosa, sicura, ecc. La natura filogenetica delle emozioni non deve farcele<br />
ritenere delle strutture fisse ovvero immodificabili. Le emozioni sono set neurobiologici e<br />
come tali sono suscettibili di evoluzione nel corso dell’ontogenesi: 1) sotto il profilo del<br />
volume/evocabilità = con quale facilità il soggetto presenta quella particolare emozione; 2)<br />
per quanto concerne la relazione evocativa = cosa suscita quella particolare emozione<br />
oppure come un ricordo è stato marcato; 3) per quanto concerne la relazione espressiva<br />
= in che modo esprimo l’emozione e controllo l’impulsività.
Le emozioni si dividono rispetto alla situazione-evento a cui devono dare risposta in due<br />
tipologie: 1) emozioni di base, ovvero risposte dirette agli eventi del mondo, come la<br />
paura, il disgusto, lo stupore; 2) emozioni sociali, ovvero risposte verso altri membri del<br />
gruppo, come l’irritazione, la gelosia, la vanità. Rispetto alle emozioni di base non vi è<br />
dubbio che, quantunque differente sia l’evocabilità, l’evocazione e l’espressione nelle<br />
diverse specie, è innegabile la presenza di questi stati della mente animale. Più complessa<br />
è la valutazione delle emozioni sociali, alcune delle quali indubbiamente presenti e<br />
dimostrabili, come l’irritazione, altre sono materia di discussione, per esempio se il cane<br />
provi gelosia.<br />
Le emozioni possono essere valutate anche rispetto alla valenza edonica e in questo caso<br />
avremo: 1) emozioni positive, se aumentano lo stato di piacere del soggetto; 2) emozioni<br />
negative, se diminuiscono lo stato di piacere del soggetto. Prendiamo come esempio di<br />
emozioni negative: a) paura ovvero tendenza a considerare la situazione come portatrice<br />
di pericolo; b) tristezza ossia tendenza a considerare la situazione come priva di eventi<br />
piacevoli; c) allerta ossia tendenza a cercare di capire se la situazione riserba sorprese<br />
spiacevoli. Prendiamo come esempio di emozioni positive: a) sicurezza ovvero sensazione<br />
di poter controllare una particolare situazione; b) festosità ossia tendenza a considerare la<br />
situazione come portatrice di buoni eventi; c) stupore ossia tendenza ad ammirare la<br />
situazione come carica di suggerimenti. Le sei emozioni sopracitate possono essere situate<br />
a due a due secondo “coordinate polari” – a) paura-sicurezza; b) tristezza-festosità; c)<br />
allerta-stupore – a tal punto che alcuni autori le considerano la stessa emozione.<br />
La costruzione delle coordinate polari ci consente di realizzare i cosiddetti circomplessi<br />
emozionali facendo incrociare due coordinate polari (per esempio le coordinate paurasicurezza<br />
e tristezza-festosità) e ottenendo così quattro quadranti a rappresentare stati<br />
emozionali compositi: 1) ambivalente tra paura e festosità; 2) propositivo tra sicurezza e<br />
festosità; 3) depresso tra paura e tristezza; 4) irritato tra sicurezza e tristezza. Numerosi<br />
sono i circomplessi che si possono costruire incrociando coordinate polari non solo a<br />
indicare stati emozionali o umorali ma altresì tendenze caratteriali. Se prendiamo le<br />
coordinate paura-sicurezza e conflittuale-coesivo avremo i seguenti quadranti: 1)<br />
pacificante tra paura e coesione; 2) invitante tra coesione e sicurezza; 3) assertivo tra<br />
sicurezza e conflittualità; 4) avversativo tra paura e conflittualità.<br />
Come nelle motivazioni riconosciamo tre livelli – stato di attivazione, tendenza<br />
situazionale, assetto caratteriale: a indicare 1) quale motivazione è accesa in un<br />
particolare momento, 2) quali tendenze motivazionali una particolare situazione suscita, 3)<br />
quali sono le motivazioni più forti in quel particolare soggetto – allo stesso modo per<br />
quanto concerne le emozioni abbiamo tre livelli: 1) l’emozione vera e propria ossia lo stato<br />
emozionale attivato soprasoglia ed espresso con un comportamento emozionale o un<br />
comportamento emotivo; 2) lo stato umorale ossia l’insieme di emozioni attivate ma<br />
sottosoglia a indicare una tendenza complessiva del soggetto; 3) il carattere emozionale<br />
del soggetto ovvero quali tendenze emozionali sono più forti in quel soggetto.<br />
L’assetto emozionale del soggetto può avere una tendenza/prevalenza di emozioni positive<br />
(CARATTERE FIDUCIOSO) o di emozioni negative (CARATTERE DIFFIDENTE). Entrambi<br />
gli assetti sono teoricamente adattativi: 1) in un mondo pieno di opportunità è adattativo<br />
essere “fiduciosi”; 2) in un mondo pieno di rischi è adattativo essere “diffidenti”. Il<br />
carattere fiducioso o diffidente si evincono dai seguenti parametri: a) livello di interattività;<br />
b) tendenza al gioco; c) grado di socievolezza; d) capacità di integrare le novità; e)
esploratività-apprendimento; f) flessibilità cognitiva. Per la vita con l’uomo è adattativo<br />
avere un carattere fiducioso. I circomplessi sono molto utili per inquadrare le tendenze<br />
reattive del soggetto per esempio rispetto le situazioni nuove o alle interazioni sociali.<br />
2.2 – Emozioni e progetto pedagogico<br />
Le emozioni hanno un importante valore sia per il benessere del cane nella sua<br />
quotidianità sia come orientatori per: 1) induzione = favorire la realizzazione di una<br />
particolare attività o il posizionamento del soggetto in una certa situazione; 2) marcatura<br />
positiva = per favorire il mantenimento o il riposizionamento in una certa attività e<br />
situazione. Al fine di realizzare l’induzione è necessario suscitare o trasmettere emozioni<br />
positive nell’attività e nella situazione che si vuole promuovere, perché aprono il soggetto<br />
al mondo e gli consentono l’interattività. Al fine di realizzare la marcatura positiva è<br />
necessario collegare la situazione e l’attività da mantenere con emozioni positive in modo<br />
tale da marcarne in modo positivo il ricordo, giacché saranno queste ultime ad assegnare<br />
il primo valore (piacevole vs spiacevole) all’attività o situazione. Il lavoro sulle emozioni in<br />
senso orientativo (1 e 2) è molto importante nella didattica perché: a) per attivare il cane<br />
e coinvolgerlo nel processo di apprendimento è indispensabile l’induzione; b) per<br />
mantenere successivamente l’interesse del cane per l’attività didattica è indispensabile la<br />
marcatura positiva.<br />
Per suscitare le emozioni positive, necessarie sia per l’induzione che per la marcatura, è<br />
indispensabile: 1) favorire l’agio mentale; 2) lavorare sulla somatopsichica; 3)<br />
somministrare gli stimoli appetitivi; 4) realizzare l’osmosi emozionale; 5) promuovere uno<br />
stato di piacere. Queste cinque leve consentono di attivare maggiormente le emozioni<br />
positive, anche se ovviamente non è possibile evitare completamente l’attivazione di<br />
emozioni negative – a volte è sufficiente un rumore improvviso o un evento imprevedibile.<br />
Anche l’attivazione emozionale positiva ha a che fare con il coinvolgimento perché solo se<br />
il cane sta vivendo delle emozioni positive è veramente coinvolto in quello che sta<br />
facendo.<br />
Per favorire l’agio mentale (1) occorre: a) evitare la triade impositiva, ossia essere<br />
vessatori verso il cane, inibirlo continuamente, forzare le attività facendogliele fare per<br />
conazione; b) promuovere la gratificazione, impostando le attività secondo le coordinate<br />
motivazionali e dando autoefficacia, evitando demotivazione e frustrazione; c) mantenere<br />
il soggetto in una modica attivazione cognitiva, rendendolo interessato e curioso, evitando<br />
la noia ma altresì l’eccessiva problematicità delle situazioni, attivando la memoria e le<br />
funzioni logiche; d) dare conoscenze/competenze al soggetto in modo tale da accrescere il<br />
senso di sicurezza, renderlo adattativo alle situazioni, dargli autoefficacia; e) abbassare lo<br />
stress diminuendo la sovra stimolazione e il carico di richieste e consentendo al cane di<br />
vivere dei momenti di recupero; f) diminuire ansia e stati conflittuali migliorando la<br />
comunicazione tra pet-owner e cane e in particolare lavorando sul posizionamento sociale<br />
del cane; g) evitare gli sbalzi di arousal ovvero l’induzione di eccitazione e di apatia,<br />
cercando di mantenere lo stato di arousal del cane a livello intermedio, evitando le<br />
fluttuazioni di arousal e promuovendo stabilità.<br />
Attraverso il benessere del corpo è possibile promuovere il benessere della mente, un<br />
intervento che prende il nome di somatopsichica (2) che si realizza lavorando: a) sul
soddisfacimento dei parametri fisiologici di base come l’omeotermia, la corretta<br />
alimentazione, la ginnastica funzionale, il riparo dalle intemperie; b) sul riposo, evitando la<br />
stanchezza, le situazioni di disagio, le alterazioni del bioritmo; c) sull’attività fisica e in<br />
particolare promuovendo una corretta forma atletica che consente un buon metabolismo<br />
delle attività e la produzione di endorfine; d) sul massaggio specifico, soprattutto per<br />
sgravare le tensioni nelle aree cervicali e lombari, allentando le tensioni negli arti,<br />
stimolando le aree della testa soprattutto nelle zone frontali.<br />
Le emozioni positive vengono stimolate dagli stimoli appetitivi (3), vale a dire da quegli<br />
enti che sono correlati ai bisogni fisiologici o alle disposizioni motivazionali del soggetto<br />
ovvero quelli che: a) danno gratificazione orale, sapendo che per il cane il bocconcino<br />
rappresenta una gratifica importante, ovviamente con differenze di rilevanza da soggetto a<br />
soggetto; b) rappresentano dei target motivazionali, come la pallina o il riportello, ovvero<br />
degli enti che suscitano un forte interesse e un orientamento ma altresì che costituiscano<br />
una gratifica nell’espressione motivazionale; c) danno luogo a contesti piacevoli ovvero<br />
capaci di mettere il soggetto in una condizione di perfetto equilibrio o corrispondenza tra<br />
lo stato interno e le opportunità offerte per soddisfarlo; d) sono tipici delle interazioni dolci<br />
come la relazione basata sulla calma e sul rilassamento, l’espressione epimeletica,<br />
l’affettività, il ritorno del pet-owner dopo un allontanamento; e) rappresentano stimoli<br />
prototipici ovvero elettivi rispetto alla sensorialità oppure innescanti condizioni di<br />
benessere come l’apaisina.<br />
Anche l’osmosi emozionale (4) ossia il passaggio di emozioni dal pet-owner al cane è un<br />
modo per suscitare emozioni positive avendo cura di: a) mantenere uno stato emozionale<br />
positivo quando si interagisce con il cane; b) creare un contesto rilassante nella vita<br />
ordinaria (non troppi stimoli, non completa assenza); c) avere delle sistemiche positive in<br />
casa, evitare i continui litigi che danno luogo sia osmosi negativa nel rapporto diretto che<br />
un contagio negativo attraverso l’intera sistemica; d) non caricare d’ansia le attività e non<br />
essere troppo presi dalle prestazioni; e) non focalizzarsi sui problemi, per esempio temere<br />
che il cane sia preso da una fobia; f) non esagerare con le richieste affettive , non essere<br />
troppo oppressivi.<br />
Abbiamo infine le cornici di piacere (5) ovvero quelle situazioni che più di ogni altre danno<br />
soddisfazione al cane mettendolo in una situazione di forte coinvolgimento emozionale: a)<br />
le attività di gioco, poiché la cornice ludica indica che “va tutto bene” giacché non si gioca<br />
se c’è un pericolo e se prima non si sono assolti i bisogni di base; b) le attività di<br />
regressione caratterizzate da esplicitazioni et-epimeletiche, ovviamente se non vengono<br />
utilizzate in senso pacificatorio, anche perché queste attività vengono espresse o come<br />
auto-tranquillizzazione o come ricerca di piacere; c) le attività di ricerca olfattiva perché<br />
sono perfettamente in linea con le caratteristiche percettive del cane; d) la passeggiata,<br />
un evento che costituisce sempre per il cane un evento salutato da emozioni positive,<br />
soprattutto se il pet-owner ha il buon senso di considerare questo evento come attività<br />
perlustrativa e non come condotta; e) le attività epimeletiche, i rituali affettivi, le attività di<br />
grooming rappresentano cornici sociali coesive sempre accompagnate da emozioni<br />
positive.<br />
Un progetto pedagogico per le emozioni contempla i seguenti aspetti: 1) sviluppare un<br />
carattere fiducioso ovvero un assetto emozionale complessivo e tendenziale più portato<br />
all’estremità positiva della coordinata polare; 2) marcare positivamente le situazioni, le<br />
attività, i target che ci interessano in modo tale da favorire sia l’ingresso nelle situazioni-
attività che ci interessano che il mantenimento e altresì per favorire l’inserimento pro<br />
sociale e l’integrazione con gli elementi dell’ecumene; 3) legare l’emozione ad adeguate<br />
cornici espressive al fine di contenere il comportamento emotivo, dando delle alternative al<br />
comportamento in default, rafforzando le capacità di autocontrollo; 4) diminuire le aree di<br />
insicurezza che compromettono la resilienza del soggetto e facilitano l’insorgenza di ansia,<br />
fobie, compulsioni, depressioni.<br />
Il carattere fiducioso (1) è adattativo per favorire l’integrazione del cane nell’ecumene e<br />
rappresenta un fattore importante per sviluppare la socievolezza nel cane ossia il piacere<br />
che il cane prova nello stare in situazioni sociali. Per favorirlo bisogna lavorare sulle<br />
emozioni positive suscitandole ed esercitandole nel cucciolo, evitando per quanto è<br />
possibile, soprattutto nel periodo che va dalla nascita all’adolescenza, le emozioni<br />
negative.<br />
Essendo le emozioni i primi decifratori del valore (2) di una situazione/attività è<br />
indispensabile associare la rappresentazione di quella situazione/attività con emozioni<br />
positive. Per esempio è importante marcare positivamente le situazioni sociali con<br />
emozioni positive: questo è un altro fattore predisponente la socievolezza.<br />
Per quanto riguarda le cornici espressive (3), le emozioni richiamano treni di risposte fisiocomportamentali<br />
innate: comportamento emotivo. Se da un punto di vista evoluzionistico<br />
il comportamento emotivo è stato adattativo, nella vita con l’uomo molto spesso tale<br />
comportamento rappresenta un problema, anche per il cane. Quindi si può insegnare al<br />
cane a manifestare l’emozione in modo più adeguato e adattativo. Si deve cioè disciplinare<br />
l’emozione per dare luogo al “comportamento emozionale”, il quale è regolato dai seguenti<br />
fattori: a) capacità di autocontrollo, b) modica fluttuazione di arousal, c) numerose<br />
conoscenze sulle situazioni, d) modica stimolazione dell’emozione. Se questi fattori<br />
decadono si può passare dal comportamento emozionale al comportamento emotivo.<br />
Abbiamo infine il fattore insicurezza (4) che può originare da diverse cause come<br />
un’alterazione del processo di attaccamento, un deficit di autoefficacia, una carenza nel<br />
processo di socializzazione, una prevalenza di stimoli avversivi, una rilevanza della triade<br />
impositiva. L’insicurezza provoca una prevalenza dell’attenzione centripeta (stato di<br />
allarme) sull’attenzione centrifuga (stato di interesse). Nell’attenzione centrifuga<br />
prevalgono le emozioni positive mentre nell’attenzione centripeta prevalgono le emozioni<br />
negative. Attraverso il lavoro sulle emozioni è possibile diminuire l’insicurezza del soggetto.<br />
3 - AROUSAL<br />
L’arousal indica il livello di attivazione posizionale del soggetto nella scala che va da<br />
“eccitazione” o alto arousal ad “apatia” o basso arousal. Il livello di attivazione è molto<br />
importante perché definisce: a) la soglia di reattività del soggetto ovvero il livello dello<br />
stimolo capace di suscitare una reazione nel soggetto; b) il grado di equilibrio o di<br />
benessere del soggetto, massimo quando l’arousal è intermedio e minimo nelle due<br />
situazioni polari; c) il tipo di ricerca messa in atto dal soggetto che è specifica quando<br />
l’arousal è alto (inquietudine) mentre è diversiva quando l’arousal è basso (noia); d) il tipo<br />
di cognitività presente nel soggetto, deficitaria di concentrazione quando l’arousal è alto,<br />
deficitaria di attenzione quando è basso, ottima se intermedio; e) il rischio di impulsività
ovvero che il soggetto mette in atto un comportamento emotivo o motivo, massimo se<br />
l’arousal è alto.<br />
Le aree di valutazione dell’arousal sono: 1) il livello di arousal ordinario ossia come si<br />
posiziona il cane nelle situazioni normali, quando cioè non accade nulla di speciale e non vi<br />
è totale assenza di stimoli = dev’essere quanto più intermedio; 2) la stabilità di arousal<br />
ovvero come si snoda lo stato di arousal nel corso della giornata se non accade nulla di<br />
speciale e quanto è sensibile al cambiamento = deve evitare le fluttuazioni e mantenersi<br />
quanto più stabile possibile; 3) lo scostamento di arousal straordinario, vale a dire quanto<br />
muta il suo valore al variare delle condizioni stimolative = deve avere scostamenti piccoli.<br />
L’arousal è una componente importante del posizionamento del cane nelle tre scansioni –<br />
1) livello ordinario intermedio o stato di calma; 2) stabilità nel corso della giornata; 3)<br />
scostamento minimo nelle situazioni straordinarie – poiché come abbiamo visto interviene<br />
su 5 fattori centrali nell’espressione comportamentale: la reattività, l’impulsività, la<br />
cognitività, il benessere, la ricerca. Se l’autocontrollo rappresenta il freno della macchina<br />
comportamentale l’arousal può essere rappresentato come la velocità. Molti dei problemi<br />
di gestione del cane derivano proprio da un’alterazione dell’arousal nelle tre scansioni: 1)<br />
ci sono cani con arousal ordinario troppo polare con alterazioni complessive nei 5 fattori<br />
del comportamento; 2) ci sono cani con continue fluttuazioni di arousal con problemi<br />
bipolari (per esempio deficit ora di attenzione ora di concentrazione) e instabilità<br />
complessiva; 3)ci sono cani che presentano scostamenti ampi dello stato di arousal<br />
provocando difficoltà di gestione e tempi lunghi per raggiungere nuovamente uno stato di<br />
calma. A fronte di queste considerazione è evidente che occorre approntare un lavoro<br />
pedagogico anche riferito all’arousal sia sotto forma di attenzioni nella didattica sia come<br />
obiettivi educativi, tenendo conto che l’arousal è una variabile che muta da soggetto a<br />
soggetto e nel corso della vita del soggetto.<br />
1) Arousal ordinario = indica come normalmente è posizionato il soggetto, valutando<br />
alcune variabili : a) la razza di appartenenza del cane; b) l’età del cane ossia il momento<br />
evolutivo in cui lo prendo in considerazione; c) le caratteristiche del contesto ordinario di<br />
vita; d) la correttezza evolutiva e in particolare il processo di attaccamento. Ci sono razze<br />
che in situazioni ordinarie presentano un maggiore o minore livello di eccitazione. Per<br />
esempio c’è una differenza notevole tra un terrier e un terranova. Occorre pertanto nel<br />
primo caso indirizzare verso una mitigazione mentre nel secondo caso alzare un po’<br />
l’attivazione I soggetti giovani presentano un arousal ordinario molto più alto che non va<br />
assecondato ma che richiede esercizi di contenimento. Alcuni soggetti più apatici vanno<br />
viceversa sostenuti perché con l’avanzare dell’età possono assumere profili depressivi. Il<br />
contesto di vita ordinaria può essere improntato sull’eccitazione (molti stimoli, interazioni<br />
vivaci, cornici ludiche) oppure sull’apatia (sempre solo in casa, luogo silenzioso, persone<br />
anziane). E’ necessario agire sul contesto per evitare che ordinariamente il cane stia in una<br />
situazione di arousal non intermedio. Il cucciolo inoltre può aver subito dei processi<br />
involutivi (per es: deprivazione materna) che hanno dato un carattere di alta o bassa<br />
eccitabilità cosicché il profilo ordinario si presenta lontano dal livello intermedio. Occorre<br />
lavorare per assicurare di nuovo un corretto livello di arousal ordinario.<br />
2. Stabilità di arousal = indica la sensibilità del soggetto rispetto allo scostamento<br />
dall’arousal ordinario rispetto alla minima variazione ambientale. Anche in questo caso<br />
abbiamo dei fattori di influenza: a) la razza di appartenenza del cane; b) l’età del cane<br />
ossia il momento evolutivo in cui lo prendo in considerazione; c) la presenza di
autocontrolli; d) la correttezza evolutiva e in particolare il processo di attaccamento. Anche<br />
in fatto di stabilità la razza è una variabile importante. Ci sono razze come il Dobermann<br />
estremamente sensibili che mutano lo stato di arousal al minimo scostamento ambientale,<br />
altre molto più stabili. Per questo alcuni soggetti richiedono di più esercizi di stabilità. Gli<br />
adulti sono molto più stabili dei soggetti giovani: questa loro fluttuazione è funzionale alla<br />
risposta evolutiva. Occorre tuttavia evitare di assecondare la tendenza fluttuante non<br />
premiando gli accessi instabili e viceversa cercando di dare stabilità. L’instabilità di arousal<br />
trova nella mancanza di autocontrolli una fonte di potenziamento per esercizio. Occorre<br />
pertanto lavorare oltre che sulla calma e sulla stabilità anche sugli autocontrolli che<br />
evitano l’esercizio della fluttuazione. La deprivazione materna e in genere le alterazioni del<br />
processo di attaccamento facilitano lo sviluppo di uno stato di arousal fluttuante. Occorre<br />
intervenire attraverso esercizi di calma, autocontrolli e disciplina comportamentale.<br />
3. Scostamento di arousal = indica il livello di variazione che il soggetto presenta tra lo<br />
stato ordinario e quello straordinario. Lo scostamento dev’essere contenuto e quanto è più<br />
vasto tanto più: a) metterà in difficoltà i sistemi regolativi; b)tempo sarà necessario per<br />
ritornare allo stato ordinario. I sistemi regolativi più importanti sono: 1) Le cornici<br />
posizionali; 2) Gli autocontrolli; 3) La lucidità cognitiva. Per quanto concerne le cornici<br />
posizionali va detto che l’espressione posizionale per poter essere adeguata deve<br />
coniugarsi a specifiche rappresentazioni di target, contesto e modo. Lo scostamento<br />
facilita il comportamento impulsivo, creando problemi adattativi e integrativi. Se esiste un<br />
forte scostamento occorre sedimentare molto bene le cornici posizionali. Anche<br />
l’autocontrollo, ovvero la capacità di fermarsi e non dar luogo a un comportamento<br />
emozionale e motivazionale, viene messo sotto pressione dallo scostamento di arousal. In<br />
caso di altri scostamenti occorre lavorare oltre che sull’arousal anche sul parametro di<br />
autocontrollo. Infine dobbiamo ricordare che il soggetto presenta lucidità cognitiva se in<br />
grado di valutare con freddezza il contesto e mettere in atto comportamenti utili ( operanti<br />
ed euristiche ) nonché avere flessibilità cognitiva. Lo scostamento contrasta la lucidità<br />
cognitiva per cui occorre lavorare molto sulle conoscenze del cane. Lo scostamento nei<br />
suoi valori indica anche quanto tempo è necessario per riportare il soggetto in uno stato di<br />
arousal ordinario. Questo ci fa capire come sia necessario lavorare per rendere più lieve<br />
possibile lo scostamento tra situazione ordinaria e straordinaria.<br />
3.1 Arousal e pedagogia<br />
Lo stato di arousal ha un importanza sia come obiettivo educativo (problema di<br />
pedagogia) sia come attenzione per favorire i processi di apprendimento (problema di<br />
didattica). Da un punto di vista strettamente pedagogico si devono individuare quali<br />
obiettivi ci si pone rispetto alle tre variabili di arousal: a) livello di arousal ordinario; b)<br />
stabilità di arousal durante la giornata; c) scostamento del livello di arousal nelle situazioni<br />
straordinarie. Sotto questo profilo è indispensabile tener conto dei fattori che influenzano<br />
lo stato di arousal, sapendo che tanto più il cucciolo si troverà nelle condizioni ottimali<br />
tanto più eserciterà quello stato e si andrà a posizionare da adulto in quello stato. Da un<br />
punto di vista strettamente didattico ci si deve preoccupare di portare il cane nella<br />
situazione di arousal migliore per poter avere attenzione (capacità acquisitiva) e<br />
concentrazione (capacità elaborativa) indispensabili per il processo di apprendimento.
In una situazione di alta arousal l’animale si presenta vigile, eccitato, poco concentrato,<br />
molto reattivo agli stimoli esterni, irrequieto, in cerca frenetica, instabile sotto il profilo<br />
posizionale, fa fatica a controllarsi, è eccessivo nel tono comportamentale e impreciso<br />
nella realizzazione, alcune espressioni (predatorio) sono rinvigorite, altre (ricerca olfattiva)<br />
sono depresse. In generale uno stato di alta arousal mette a dura prova gli autocontrolli e<br />
facilita il comportamento impulsivo. L’alta arousal crea una situazione fastidiosa o<br />
comunque in contrasto con il principio edonico, vi è una forte tendenza proattiva, una<br />
scarsa tendenza inibitoria, una scarsa o nulla capacità di apprendimento, la collaborazione<br />
e la gestione dell’animale è resa più difficoltosa, con più facilità emergono i default innati.<br />
Se il soggetto rischia la deriva ansiosa e irritativa l’alto arousal la facilita.<br />
L’alto arousal è negativo sotto il profilo pedagogico poiché rafforza nel cucciolo questo<br />
stato e lo posiziona da adulto in uno stato eccitatorio – è un po’ come abituarsi ad andare<br />
in auto a tutta velocità. Ci ritroveremo un cane irrequieto, molto reattivo, portato a<br />
mettere in atto comportamenti impulsivi, di difficile gestione e facile ai rischi ansiogeni,<br />
quindi distruttività ed eccesso somestesico. L’educazione alla calma (stato di arousal<br />
intermedio) ha pertanto non solo un obiettivo gestionale ma anche e direi soprattutto<br />
educativo: sviluppare un carattere posizionato lontano dalle polarità eccitatorie e apatiche.<br />
L’alto arousal è negativo anche sotto il profilo della didattica perché compromette la<br />
concentrazione e quindi la capacità di soffermarsi sull’attività didattica e di elaborare i<br />
concetti acquisiti. Ovviamente se ci troviamo di fronte a un cucciolo che presenta un basso<br />
arousal occorrerà innalzarglielo modicamente per raggiungere lo stato intermedio; allo<br />
stesso modo se durante la didattica il cucciolo si trova in uno stato di basso arousal sarà<br />
indispensabile alzarglielo modicamente per aumentare il suo interesse esplorativo, la sua<br />
proattività e la capacità attentiva.<br />
A questo punto è indispensabile sapere cosa innalza l’arousal: a) gli stimoli forti, avendo<br />
presente che la stimolazione tende in generale a innalzare l’arousal ma soprattutto gli<br />
stimoli: nuovi, proto tipici, visivi, cinetici, modicamente complessi vale a dire portati a<br />
suscitare curiosità; b) il gioco, sapendo che la cornice ludica tende a innalzare l’arousal e<br />
soprattutto: i giochi con oggetti in movimenti, i giochi performativi, i giochi che utilizzano<br />
la bocca, i giochi eccitatori, i giochi di competizione; c) le attività reattive che richiedono<br />
forte attenzione e scarso discernimento come: la perlustrazione visiva, il rincorrere<br />
qualcosa, l’avere prontezza di risposta, il difendere qualcosa.<br />
Anche lo stato di basso arousal è negativo sotto il profilo pedagogico poiché posiziona il<br />
cucciolo in uno stato apatico e depressivo, con scarsa capacità di rispondere alle situazioni<br />
in cui si viene a trovare e soprattutto di correlazione ai mutamenti ambientali e<br />
situazionali. Ci ritroveremo un cane annoiato, poco adattabile, facile a comportamenti<br />
sostitutivi e quindi anche a eccessi somestesici o comportamenti distruttivi. Il cane in uno<br />
stato di basso arousal si presenta apatico, con uno scarsa interesse per quello che gli<br />
accade intorno, facile alla depressione, alla riduzione del comportamento reattivo e<br />
proattivo, alla sonnolenza e all’inattività, con una riduzione complessiva della vigilanza, con<br />
uno stato di abbattimento generale e di prostrazione, con scarsa attenzione agli stimoli<br />
esterni, con un basso profilo del sistema emozionale e motivazionale, con uno scarso<br />
dettaglio nella percezione del tempo. Ma anche sotto il profilo didattico è da evitare questo<br />
stato perché se l’arousal è basso l’animale fa fatica ad apprendere perché è poco attento,<br />
ha uno scarso profilo proattivo (che come sappiamo è centrale nell’esperienza e<br />
nell’apprendimento), un più consistente profilo inibitorio e quindi una diminuzione drastica
dei comportamenti centrifughi. Anche l’interattività verso il pet-owner può risultare<br />
diminuita e il cane manifesta attività autoriferite, come l’eccesso somestesico. Talvolta si<br />
evidenziano comportamenti diversivi, riferibili a depressione e frustrazione, o<br />
semplicemente sostitutivi. Ovviamente se ci troviamo di fronte a un cucciolo che presenta<br />
un alto arousal occorrerà abbassarglielo modicamente per raggiungere lo stato intermedio;<br />
allo stesso modo se durante la didattica il cucciolo si trova in uno stato di alto arousal sarà<br />
indispensabile abbassarglielo modicamente per aumentare la sua concentrazione e la sua<br />
capacità elaborativa.<br />
A questo punto occorre sapere cosa abbassa l’arousal: a) le attività epimeletiche come le<br />
carezze di rilassamento, l’alimentazione, il grooming, il contatto prolungato acinetico, i<br />
comportamenti regressivi; b) le attività defaticanti ossia le attività che portano a una<br />
stanchezza fisica come le attività muscolari, esocrine, digestive ma altresì i cambi di<br />
stagione; c) le attività esplorative e solutive, quelle che richiedono forte concentrazione e<br />
discernimento come il monitoraggio olfattivo, il problem solving, le attività controintuitive.