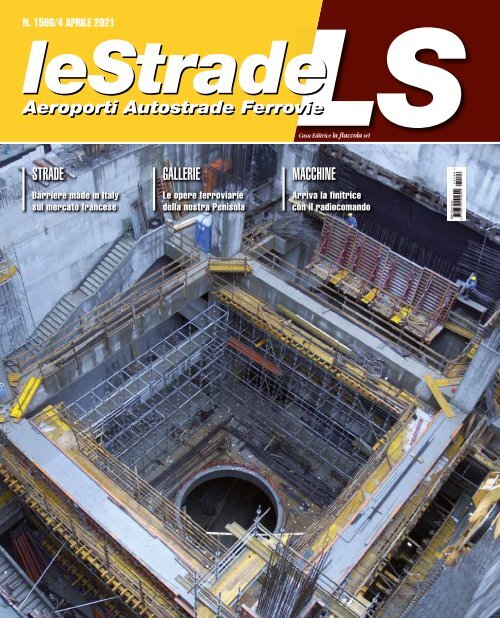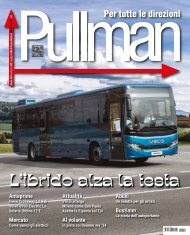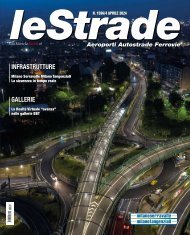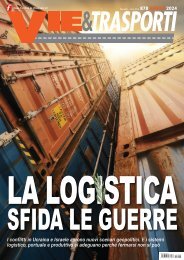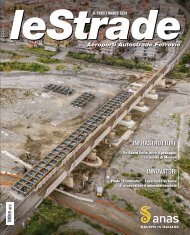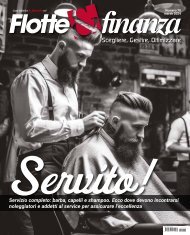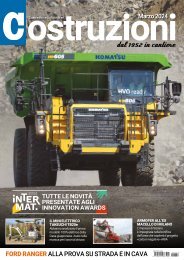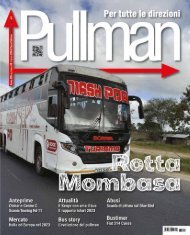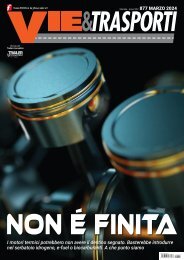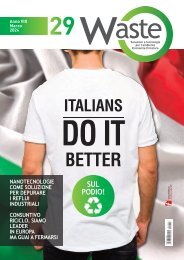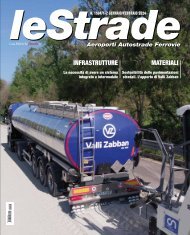LeStrade n.1566 aprile 2021
Strade Barriere made in Italy sul mercato francese Gallerie Le opere ferroviarie della nostra Penisola Macchine Arriva la finitrice con il radiocomando
Strade
Barriere made in Italy sul mercato francese
Gallerie
Le opere ferroviarie della nostra Penisola
Macchine
Arriva la finitrice con il radiocomando
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
leStrade<br />
LS<br />
Aeroporti Autostrade Ferrovie<br />
N. 1566/ 4 APRILE <strong>2021</strong><br />
Aeroporti Autostrade Ferrovie<br />
Casa Editrice la fiaccola srl<br />
STRADE GALLERIE MACCHINE<br />
Barriere made in Italy<br />
sul mercato francese<br />
Le opere ferroviarie<br />
della nostra Penisola<br />
Arriva la finitrice<br />
con il radiocomando
Mapeshield<br />
®
2<br />
Sommario<br />
ISSN: 0373-2916<br />
N. 1566 Aprile <strong>2021</strong> anno CXXIII<br />
3 LS<br />
IN COLLABORAZIONE CON<br />
Casa Editrice<br />
la fiaccola srl<br />
20123 Milano<br />
Via Conca del Naviglio, 37<br />
Tel. 02/89421350<br />
Fax 02/89421484<br />
casaeditricelafiaccola@legalmail.it<br />
Mensile - LO-NO/00516/02.<strong>2021</strong>CONV<br />
ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE STAMPA<br />
N. 01740 / Vol.18 foglio 313 del 21/11/1985 -<br />
ROC 32150<br />
Ufficio Traffico e Pubblicità<br />
Laura Croci<br />
marketing @ fiaccola.it<br />
Marketing e pubblicità<br />
Sabrina Levada Responsabile estero<br />
slevada @ fiaccola.it<br />
Agenti<br />
Giorgio Casotto<br />
Tel. 0425/34045<br />
Cell. 348 5121572 - info@ ottoadv .it<br />
Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige<br />
Veneto - Emilia Romagna<br />
(escluse Parma e Piacenza)<br />
Amministrazione<br />
Francesca Lotti<br />
flotti @ fiaccola.it<br />
Margherita Russo<br />
amministrazione @ fiaccola.it<br />
Ufficio Abbonamenti<br />
Mariana Serci<br />
abbonamenti @ fiaccola.it<br />
Abbonamento annuo<br />
Italia E 100,00<br />
Estero E 200,00<br />
una copia E 10,00<br />
una copia estero E 20,00<br />
Impaginazione<br />
Studio Grafico Page - Novate Milanese (Mi)<br />
Stampa<br />
Tep Srl<br />
Strada di Cortemaggiore 50 - 29100 Piacenza<br />
È vietata e perseguibile per legge la riproduzione<br />
totale o parziale di testi, articoli, pubblicità ed<br />
immagini pubblicate su questa rivista sia in forma<br />
scritta sia su supporti magnetici, digitali, etc.<br />
La responsabilità di quanto espresso negli articoli<br />
firmati rimane esclusivamente agli Autori.<br />
Il suo nominativo è inserito nella nostra mailing<br />
list esclusivamente per l’invio delle nostre<br />
comunicazioni e non sarà ceduto ad altri,<br />
in virtù del nuovo regolamento UE sulla Privacy<br />
N.2016/679. Qualora non desideri ricevere in<br />
futuro altre informazioni, può far richiesta alla Casa<br />
Editrice la fiaccola srl scrivendo a: info@fiaccola.it<br />
Questo periodico è associato<br />
all’Unio ne stampa periodica italiana.<br />
Numero di iscrizione 14744<br />
L’OPINIONE<br />
7 La strada del futuro green, digitale e resiliente<br />
di Domenico Crocco<br />
L’OPINIONE LEGALE<br />
8 Il perimetro operativo del soccorso istruttorio<br />
di Claudio Guccione, Camilla Triboldi<br />
SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE<br />
10 L’esempio del Traforo del Frejus nel 150° anno<br />
dall’inaugurazione (Seconda Parte)<br />
di Pasquale Cialdini<br />
OSSERVATORIO ANAS<br />
14 Rientro strade, via libera<br />
alla seconda tranche del piano<br />
NEWS<br />
16 Attualità<br />
20 Prodotti<br />
22 Convegni<br />
24 Agenda <strong>2021</strong>. Convegni, Corsi, Eventi<br />
In Copertina<br />
Il grande cantiere della stazione Chiaia, Linea 6 della Metropolitana di<br />
Napoli. Struttura definitiva in risalita (cubo) con vista sull’asola della cupola<br />
inferiore (sfera). Concessionaria Hitachi Rail STS; progettazione Metropolitana<br />
di Napoli; realizzazione gruppo ICM.<br />
© Metropolitana di Napoli SpA<br />
Redazione<br />
Direttore responsabile<br />
Lucia Edvige Saronni<br />
Direttore editoriale<br />
Fabrizio Apostolo<br />
fapostolo@fiaccola.it<br />
Redazione<br />
Mauro Armelloni, Stefano Chiara<br />
Giovanni Di Michele, Edvige Fornara<br />
Emilia Longoni<br />
Segreteria di redazione<br />
Jole Campolucci<br />
jcampolucci@fiaccola.it<br />
Consulenti tecnici e legali<br />
Terotecnologia<br />
Gabriele Camomilla<br />
Normativa<br />
Biagio Cartillone<br />
Gallerie<br />
Alessandro Focaracci<br />
Infrastrutture e Cantieri<br />
Federico Gervaso<br />
Appalti Pubblici<br />
Claudio Guccione<br />
Ponti e Viadotti<br />
Enzo Siviero<br />
con<br />
INFRASTRUTTURE&MOBILITÀ<br />
Infrastrutture<br />
28 La sfida possibile dei Servizi Ecosistemici<br />
di Mauro Di Prete, Antonella Santilli, Daniela Silvestre<br />
Strade<br />
36 Concentrato di buona tecnica<br />
a cura della redazione<br />
40 Green technology italo-francese<br />
di Fabrizio Apostolo<br />
Ferrovie<br />
44 La ferrovia vista dal cielo<br />
a cura della redazione<br />
46 Link epocale tra due stazioni<br />
a cura della redazione<br />
Mobilità&Traffico<br />
50 Veicoli autonomi e responsabilità<br />
di Leonardo Annese<br />
MATERIALI&TECNOLOGIE<br />
Materiali<br />
88 La strada maestra di ricerca e formazione<br />
a cura di leStrade in collaborazione con l’Istituto Italiano<br />
per il Calcestruzzo<br />
Focus: Da Genova a Treviglio, storie di ponti, controlli,<br />
grande ingegneria e alta qualità<br />
92 Tecniche di misura dello stato tensionale<br />
di Settimo Martinello<br />
Tecnologie&Sistemi<br />
100 Il Piave mormorò… La ciclabile è super-protetta<br />
di Emilia Longoni<br />
Comitato di redazione<br />
Leonardo Annese - ANAS/CNI AIPCR ITALIA<br />
Roberto Arditi - Gruppo SINA<br />
Mario Avagliano - ANAS<br />
Fabio Borghetti - Politecnico di Milano<br />
Michele Culatti - Gruppo Siviero<br />
Paola Di Mascio - AIPSS<br />
Concetta Durso - ERF<br />
Laura Franchi - TTS Italia<br />
Giancarlo Guado - SIGEA<br />
Salvatore Leonardi - DISS<br />
Pietro Marturano - MIT<br />
Andrea Mascolini - OICE<br />
Francesco Morabito - FINCO<br />
Michela Pola - FEDERBETON<br />
Maurizio Roscigno - ANAS<br />
Emanuela Stocchi - AISCAT<br />
Monica Tessi - ANIE/ASSIFER<br />
Susanna Zammataro - IRF<br />
Hanno collaborato<br />
Leonardo Annese, Mauro Armelloni,<br />
Alfio Bonaventura, Eleonora Cesolini,<br />
Pasquale Cialdini, Domenico Crocco, Grazia Crocco,<br />
Maria Luisa De Guglielmo, Antonello De Risi,<br />
Mauro Di Prete, Laura Franchi, Gabriella Gherardi,<br />
Claudio Guccione, Emilia Longoni, David Marini,<br />
Settimo Martinello, Antonella Santilli,<br />
Sara Settembrino, Daniela Silvestre,<br />
Camilla Triboldi, Giuseppe Venditti,<br />
Edvige Viazzoli, Susanna Zammataro.<br />
Comitato Tecnico-Editoriale<br />
PRESIDENTE<br />
LANFRANCO SENN<br />
Professore Ordinario di Economia Regionale<br />
Responsabile Scientifico CERTeT,<br />
Centro di Economia Regionale, Trasporti<br />
e Turismo dell’Università Bocconi di Milano<br />
MEMBRI<br />
54 Rinascimento ferroviario<br />
di Edvige Viazzoli<br />
60 La grande sfida della Periadriatica<br />
di David Marini, Giuseppe Venditti<br />
66 Laboratorio europeo di gestione green<br />
di Eleonora Cesolini, Sara Settembrino<br />
72 Chiaia, la stazione che fa viaggiare la luce agli inferi<br />
di Maria Luisa De Guglielmo, Antonello De Risi<br />
79 Dalla geometria alla bellezza<br />
di Fabrizio Apostolo<br />
82 Risolvere i problemi grazie al know-how<br />
di Stefano Chiara<br />
104 Primato olandese nelle strade digitali<br />
di Grazia Crocco<br />
106 Dalla road safety alle gallerie paramassi<br />
di Stefano Chiara<br />
MACCHINE&ATTREZZATURE<br />
Macchine<br />
112 Versatile, precisa e con radiocomando<br />
di Fabrizio Apostolo<br />
116 Protezioni e prestazioni<br />
di Mauro Armelloni<br />
Attrezzature<br />
118 Qualità al servizio della gestione viaria<br />
di Mauro Armelloni<br />
GIANNI VITTORIO ARMANI<br />
Già Amministratore delegato ANAS<br />
ELEONORA CESOLINI<br />
TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin)<br />
PASQUALE CIALDINI<br />
Già Direttore Generale per la Vigilanza<br />
e la Sicurezza delle Infrastrutture MIT<br />
DOMENICO CROCCO<br />
Dirigente ANAS,<br />
Segretario Generale PIARC Italia<br />
CARLO GIAVARINI<br />
Università La Sapienza di Roma,<br />
Presidente onorario SITEB<br />
LUCIANA IORIO<br />
MIT, Presidente WP1 UNECE<br />
AMEDEO FUMERO<br />
Dirigente MIT, Capo Dipartimento per i Trasporti,<br />
la Navigazione e i Sistemi informativi e statistici<br />
LUCIANO MARASCO<br />
Dirigente MIT, Responsabile IV Divisione<br />
DG Sicurezza Stradale<br />
FRANCESCO MAZZIOTTA<br />
Già Dirigente MIT, Responsabile II Divisione<br />
DG Sicurezza Stradale<br />
VINCENZO POZZI<br />
Già Presidente CAL<br />
MASSIMO SCHINTU<br />
Direttore Generale AISCAT<br />
& GALLERIE<br />
GALLERIE<br />
OPERE IN SOTTERRANEO<br />
PAGINE ASSOCIATIVE<br />
122 AIIT Modifiche al Codice della Strada<br />
a cura della Segreteria AIIT<br />
123 AISES La forza della gestione<br />
di Gabriella Gherardi<br />
124 ANIE ASSIFER Elettrificazione per la transizione ecologica<br />
Ufficio Comunicazione ANIE ASSIFER<br />
125 FINCO Canone unico<br />
di Alfio Bonaventura<br />
126 IRF Conoscenza per la ripresa<br />
di Susanna Zammataro<br />
127 TTS Italia Tre mosse per digitalizzare la logistica<br />
di Laura Franchi<br />
ORNELLA SEGNALINI<br />
Dirigente MIT, Direttore Generale<br />
Dighe e Infrasrutture Idriche ed Elettriche<br />
MARIO VIRANO<br />
Direttore Generale TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin)<br />
GILBERTO CARDOLA<br />
Amministratore BBT SE<br />
(Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel)<br />
IN RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI<br />
ANGELO ARTALE<br />
Direttore Generale FINCO<br />
FEDERICO CEMPELLA<br />
Associazione del Genio Civile<br />
MARIA PIA CERCIELLO<br />
PIARC ITALIA<br />
GABRIELLA GHERARDI<br />
Presidente AISES<br />
OLGA LANDOLFI<br />
Segretario Generale TTS Italia<br />
GIOVANNI MANTOVANI<br />
Già Presidente AIIT<br />
MARCO PERAZZI<br />
Relazioni Istituzionali UNICMI<br />
DONATELLA PINGITORE<br />
Presidente ALIG<br />
CARLO POLIDORI<br />
Presidente AIPSS<br />
DANIELA PRADELLA<br />
ANIE/ASSIFER<br />
ADNAM RAHMAN<br />
Vice Presidente IRF<br />
STEFANO RAVAIOLI<br />
Direttore SITEB<br />
GIUSEPPE SCHLITZER<br />
Direttore Generale Federbeton<br />
GABRIELE SCICOLONE<br />
Presidente OICE<br />
SERGIO STORONI RIDOLFI<br />
SIGEA<br />
Anas SpA<br />
Ente nazionale<br />
per le strade<br />
Associazione Italiana<br />
Società Concessione<br />
Autostrade e Trafori<br />
Associazione<br />
del Genio Civile<br />
Associazione Italiana<br />
per l’Ingegneria Traffico<br />
e dei Trasporti<br />
Associazione Mondiale<br />
della Strada<br />
Associazione Italiana<br />
dei Professionisti<br />
per la Sicurezza Stradale<br />
Associazione Italiana<br />
Segnaletica e Sicurezza<br />
Associazione Laboratori<br />
di Ingegneria e Geotecnica<br />
Associazione<br />
Industrie<br />
Ferroviarie<br />
Associazione Italiana<br />
Segnaletica Stradale<br />
European Union<br />
Road Federation<br />
Formazione Addestramento<br />
Scienza Tecnologia Ingegneria<br />
Gallerie e Infrastrutture<br />
Federazione delle Associazioni<br />
della filiera del cemento,<br />
del calcestruzzo e dei materiali<br />
di base per le costruzioni nonché<br />
delle applicazioni e delle<br />
tecnologie ad esse connesse<br />
Federazione Industrie<br />
Prodotti Impianti Servizi<br />
ed Opere Specialistiche<br />
per le Costruzioni<br />
International Road<br />
Federation<br />
Associazione delle<br />
organizzazioni di ingegneria,<br />
di architettura e di consulenza<br />
tecnico-economica<br />
Società Italiana Geologia<br />
Ambientale<br />
Società Italiana Infrastrutture<br />
Viarie<br />
SITEB<br />
Strade Italiane e Bitumi<br />
Associazione Italiana<br />
della Telematica per<br />
i Trasporti e la Sicurezza<br />
Unione Nazionale delle<br />
Industrie delle Costruzioni<br />
Metalliche dell’Involucro e dei<br />
Serramenti<br />
Sommario<br />
lestrade @ fiaccola.it<br />
www.fiaccola.com<br />
www.lestradeweb.com<br />
On line nella<br />
sezione Archivio,<br />
tutti i numeri sfogliabili
4<br />
Inserzionisti<br />
Ammann Italy Srl<br />
ammann.com 103<br />
Bitem Srl<br />
bitemsrl.com 86<br />
Cancellotti Srl<br />
cancellotti.it 25<br />
Canginibenne Srl<br />
canginibenne.com 99<br />
Car Segnaletica Stradale Srl<br />
carsrl.com 1<br />
Codevintec Italiana Srl<br />
codevintec.it 49<br />
Dynapac Italia Srl<br />
dynapac.com 85<br />
7° E&E Congress<br />
eecongress<strong>2021</strong>.org 110<br />
Elia Peroni & C. Sas<br />
eliaperoni.it 17<br />
Istituto I.R.I.D.E. Srl<br />
istituto-iride.com 23<br />
Iterchimica Srl<br />
iterchimica.it 35<br />
Mapei SpA<br />
mapei.com<br />
Merlo SpA<br />
merlo.com<br />
II Cop.<br />
III Cop.<br />
Prealux Srl<br />
prealux.it 19<br />
Raet Srl<br />
raetsrl.it 65<br />
Roxtec Italia Srl<br />
roxtec.com/it 21<br />
Simex Srl<br />
simex.it 26<br />
Tekna Chem SpA<br />
teknachem.it 6<br />
Aziende citate<br />
4 EMME 92<br />
Anas 7, 14, 36, 88<br />
BBT 60<br />
Cangini 118<br />
Cometto 46<br />
Consorzio Integra 17<br />
Cortensafe 100<br />
CSP Fea 22<br />
Dynapac 112<br />
Epiroc 116<br />
Fagioli 21<br />
Gruppo FS Italiane 36<br />
Infrarail Firenze 54<br />
Iren 20<br />
Istituto Iride 31<br />
Istituto Italiano per il Calcestruzzo 88<br />
Mapei 20<br />
Montecristo 112<br />
Metropolitana di Napoli 72<br />
RFI Rete Ferroviaria Italiana 44<br />
SMA Road Safety 106<br />
Solosar 40<br />
Stevanato 82<br />
Telt 66<br />
Vita International 40<br />
Webuild 19<br />
Vermeer Italia Srl<br />
vermeeritalia.it 109<br />
RICICLA<br />
FINO AL 60%<br />
DI FRESATO<br />
AUMENTA<br />
LA VITA UTILE<br />
DELLA PAVIMENTAZIONE<br />
Valli Zabban amplia la propria gamma RIGENERVAL con i nuovi<br />
leganti modificati RIGENERVAL HARD e RIGENERVAL HARD PLUS<br />
per applicazioni stradali ad alte prestazioni e basso impatto<br />
ambientale. Con i prodotti della linea RIGENERVAL è possibile<br />
riciclare a caldo, nel conglomerato bituminoso, fino al 60% di<br />
fresato senza fumi e molestie olfattive, garantendo comunque una<br />
pavimentazione stradale flessibile e durabile, con un forte risparmio<br />
economico ed energetico.<br />
RIGENERVAL by Valli Zabban, un generatore di vantaggi<br />
che fa la differenza.<br />
ELIMINA<br />
FUMI E MOLESTIE<br />
OLFATTIVE<br />
I.ME.VA SpA<br />
imeva.it 43<br />
Valli Zabban SpA<br />
vallizabban.it 5<br />
Vita International Srl<br />
vitainternational.it<br />
IV Cop.<br />
100 C<br />
25 M<br />
0 Y<br />
0 K<br />
PANT.<br />
3005 C<br />
RAL<br />
5015<br />
In questo numero<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade
7<br />
LS<br />
La commissaria UE ai trasporti Adina Valean ha paragonato il sistema dei trasporti alla spina dorsale che collega cittadini e imprese<br />
europee. I trasporti in Europa danno lavoro a oltre 10 milioni di persone e valgono circa il 5 % del PIL Europeo. Allo stesso<br />
tempo il trasporto non è privo di costi sociali: oggi le emissioni inquinanti provenienti dai trasporti corrispondono a circa un<br />
quarto delle emissioni totali di gas serra d’Europa. E ogni anno muoiono sulle strade europee oltre 25mila persone.<br />
La ricerca scientifica sostiene inoltre che le emissioni provenienti dai trasporti contribuiscono, insieme alle altre, ad alterare<br />
il clima provocando fenomeni estremi. I cambiamenti climatici influenzeranno le infrastrutture di trasporto attraverso<br />
quattro tipi di fenomeni:<br />
1. Aumento delle temperature, che comporta una maggiore vulnerabilità delle infrastrutture stradali (asfalto) e ferroviarie (binari)<br />
dovuta alla crescente frequenza di giorni caldi;<br />
2. Variazione nelle precipitazioni, che influenza negativamente la stabilità dei terreni e di conseguenza delle infrastrutture localizzate<br />
in contesti instabili e che porta al rischio di allagamento dei network sotterranei;<br />
3. Variazione nel livello del mare, che pone dei rischi per le infrastrutture stradali e ferroviarie localizzate sui litorali, nonché per le infrastrutture<br />
portuali;<br />
4. Le alluvioni, che hanno impatti sulle infrastrutture di trasporto che si trovano in prossimità dei corsi d’acqua.<br />
In tutto il mondo ci si sta interrogando su come rafforzare le nostre infrastrutture rendendole più resilienti ai fenomeni climatici estremi e sempre<br />
più frequenti. Ma per prevenire questi danni, occorre rendere “green” le nostre strade, perché quanto meno inquinamento sarà prodotto dai<br />
trasporti, tanto minori saranno i fenomeni di alterazioni climatiche e i danni alle infrastrutture. Ecco perché nella sua Strategia di mobilità sostenibile<br />
e intelligente, la Commissione Europea dichiara di puntare a un futuro della strada green, con almeno 30 milioni di auto a emissioni zero<br />
entro il 2030 e quasi tutte le auto entro il 2050. Per conseguire il traguardo della strada resiliente, occorre dunque investire sulla strada green,<br />
la strada ambientalmente sostenibile.<br />
L’Opinione<br />
La strada del futuro<br />
green, digitale e resiliente<br />
opera di Geremia Renzi - Accademia di Brera<br />
Ma la strada del futuro potrà essere green solo perché sarà anche digitale. Le tecnologie digitali - dice sempre la Commissione - hanno il potenziale<br />
per rivoluzionare il nostro modo di muoverci rendendo la mobilità più intelligente, efficiente e verde.<br />
La prima smart road italiana, la Smart Road Anas inaugurata a Cortina, sarà green. Ogni smart road comprenderà infatti una Green Island, un<br />
sito multi-tecnologico per la generazione e la trasformazione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, mini eolico), che consentirà a ogni segmento<br />
di essere alimentato in maniera sostenibile, grazie anche a un sistema di distribuzione elettrica che aumenta l’efficienza energetica garantendo<br />
minori costi operativi. E green e totalmente elettrica sarà l’automobile connessa e automatizzata come quella realizzata da VisLab che,<br />
a guida autonoma e senza l’intervento del conducente, ha percorso 3mila km sulla tratta Anas della Sassari-Olbia, lo scorso autunno.<br />
In Europa si lavora a una strada sempre più digitale. Le strade vengono oggi classificate sulla base dei livelli di supporto che le infrastrutture possono<br />
dare alla guida autonoma. Si va dal gradino più basso, l’infrastruttura convenzionale senza informazioni digitali, fino al livello medio in cui<br />
tutte le informazioni dinamiche e statiche sono disponibili in formato digitale, fino al livello massimo, definito guida cooperativa, cooperative driving,<br />
in cui l’infrastruttura stessa è in grado di guidare sia il singolo veicolo, sia gruppi di veicoli in modo da ottimizzare i flussi di traffico. Questa<br />
guida fa pensare alla strada futura come al binario di un treno dove il sistema di gestione e controllo del traffico (European<br />
Rail Traffic Management System) è totalmente automatizzato. La strada del futuro sarà dunque green, smart,<br />
digitale e sempre più simile al binario di un treno. Già oggi nei test di platooning vediamo un camion con un conducente<br />
in testa e altri senza conducente che lo seguono collegati solo in modo digitale al camion guida. È lo stesso<br />
concetto della locomotiva che guida, seguita dai vagoni. Domani potremo vedere sulle nostre autostrade una serie<br />
di veicoli che si spostano tutti alla stessa velocità attivati da remoto da una centralina collegata che regola tutti<br />
i movimenti delle auto come su una pista telecomandata.<br />
Duemila anni fa, al tempo dell’antica Roma, i solchi scolpiti nel lastricato delle strade di pietra per favorire<br />
la marcia dei carri, trasformarono le antiche strade dell’Impero nei primi binari ferroviari della storia.<br />
La strada del futuro, che assomiglierà sempre di più a un binario, non fa che seguire dunque il suo<br />
antico destino.<br />
Domenico Crocco<br />
Dirigente Direzione Affari Istituzionali e Media<br />
Responsabile Rapporti Internazionali Anas SpA<br />
Primo Delegato e Segretario Generale<br />
Comitato Italiano Associazione Mondiale<br />
della Strada PIARC<br />
PRODOTTO<br />
ITALIANO<br />
TEKNA CHEM S.p.A. - via Sirtori, 20838 Renate (MB) tel. 0362 918311 - www.teknachem.it - info@teknachemgroup.com<br />
4/<strong>2021</strong>
8<br />
Normativa e Infrastrutture<br />
Il perimetro operativo<br />
del soccorso istruttorio<br />
Per il Consiglio di Stato può trovare applicazione anche in sede di comprova dei requisiti<br />
Claudio Guccione<br />
Avvocato<br />
Fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />
& Associati<br />
Camilla Triboldi<br />
Avvocato<br />
P&I Studio Legale Guccione & Associati<br />
L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />
& Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche<br />
all’Università La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />
L’Opinione legale<br />
1. Palazzo Spada a Roma, sede del Consiglio di Stato<br />
Con la recente sentenza n. 1540 del 22/2/<strong>2021</strong>,<br />
il Consiglio di Stato è tornato ad esprimersi sul<br />
perimetro operativo del soccorso istruttorio per<br />
precisare che esso può trovare applicazione anche nella<br />
fase di verifica del possesso dei titoli, successivamente<br />
all’avvenuta aggiudicazione. Si tratta, in particolare,<br />
del caso in cui, dichiarati determinati requisiti di capacità<br />
economico-finanziaria e tecnico-professionale, in<br />
sede di comprova il concorrente produca documentazione<br />
insufficiente, incompleta, errata o comunque inidonea<br />
a dimostrare il requisito posseduto e dichiarato<br />
all’atto di presentazione della domanda di partecipazione.<br />
Affermato il principio di diritto, è proprio sulla base<br />
di quest’ultima precisazione che, nel caso di specie, il<br />
Collegio ha invero escluso l’applicabilità dell’istituto in<br />
parola, che in nessun modo può essere strumentalizzato<br />
per consentire la rettifica della dichiarazione originaria<br />
nella sua integralità. La pronuncia è stata, infatti,<br />
anche l’occasione per rimarcare il principio generale di<br />
auto-responsabilità del concorrente, in forza del quale<br />
ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori<br />
commessi nella presentazione della propria documentazione,<br />
specialmente ove le disposizioni della lex specialis<br />
siano chiare e precise.<br />
Soccorso istruttorio<br />
e comprova dei requisiti<br />
Come noto, il soccorso istruttorio è un istituto tipico<br />
dell’azione amministrativa, previsto in termini generali<br />
dall’art. 6 della Legge sul procedimento amministrativo<br />
n. 241/1990, ove si assegna al Responsabile<br />
Unico del procedimento il compito e la facoltà di ricorrere<br />
a questo strumento per colmare eventuali lacune<br />
formali dell’istruttoria procedimentale. L’istituto è stato<br />
poi inserito all’interno del primo Codice dei contratti<br />
pubblici (D.Lgs. 163/2006) e specificamente declinato<br />
per la materia della procedure di gara, in termini<br />
parzialmente differenti rispetto al paradigma fissato<br />
dalla legge generale. Si tratta, infatti, non di una mera<br />
facoltà ma di un doveroso modus procedendi, volto a<br />
superare inutili formalismi in nome del favor partecipationis<br />
e del principio di semplificazione (ex multis,<br />
C.d.S., Sez. V, sent. 17/12/2018). In questo senso, il<br />
riferimento cardine è certamente l’Adunanza Plenaria<br />
n. 9 del 25 febbraio 2014, che ha interpretato il “potere<br />
di soccorso” come un dovere della stazione appaltante<br />
di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni<br />
già esistenti ovvero di completarli - ma solo in<br />
relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione -, di<br />
chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi,<br />
fornire interpretazioni di clausole ambigue, nel rispetto<br />
della par condicio dei concorrenti. Il perimetro<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
OSSERVATORIO NORMATIVO<br />
Autorità di Regolazione dei Trasporti<br />
n Delibera 22 dicembre 2020, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità<br />
di regolazione dei trasporti per l’anno <strong>2021</strong>. (Delibera n. 225/2020)”, pubblicata in GU- Serie Generale<br />
n. 49 del 27 febbraio <strong>2021</strong>;<br />
n Delibera 22 dicembre 2020, recante “Approvazione del bilancio di previsione <strong>2021</strong> e pluriennale <strong>2021</strong>-<br />
2023. (Delibera n. 224/2020)”, pubblicata in GU- Supplemento Ordinario alla Serie Generale n. 45 del 24<br />
febbraio <strong>2021</strong>.<br />
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)<br />
n Delibera 26 novembre 2020, recante “Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001).<br />
Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Verona-Padova. 2° lotto funzionale ‘attraversamento<br />
di Vicenza’ approvazione del progetto preliminare (CUP J41E91000000009). (Delibera n. 64/2020)”, pubblicata<br />
in GU- Serie Generale n. 55 del 5 marzo <strong>2021</strong>.<br />
di applicazione e i limiti dell’istituto sono stati mano a<br />
mano definiti dalla giurisprudenza, nella differenziazione<br />
tra irregolarità essenziali e non, fino all’avvento del<br />
nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)<br />
che all’art. 83, comma 9, prevede che la stazione appaltante<br />
assegni al concorrente un termine, non superiore<br />
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o<br />
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In un’ottica<br />
sostanzialistica, si consente la sanatoria di irregolarità<br />
che, pur presenti nella documentazione prodotta<br />
dal concorrente per la partecipazione alla procedura,<br />
non inficino l’idoneità dell’operatore economico a<br />
rendere la prestazione né alterino la bontà dell’offerta<br />
presentata. L’unico limite è quello dell’intrinseca<br />
inalterabilità dell’offerta tecnica ed economica, sancito<br />
dalla lettera della norma e confermato dalla giurisprudenza<br />
di riferimento. Tale limite è evidentemente<br />
correlato al principio generale dell’auto-responsabilità,<br />
in forza del quale il concorrente deve sottostare<br />
alle conseguenze di eventuali errori commessi nella<br />
presentazione della documentazione che, se sanati<br />
ex post, si tradurrebbero in modificazioni dell’offerta<br />
o nella produzione di documenti nuovi - formatisi<br />
in data successiva a quella di scadenza del termine di<br />
presentazione delle offerte - in violazione del principio<br />
della par condicio partecipationis (cfr. TAR Lazio,<br />
Sez. III, 22.09.2020, n. 9661). Tuttavia, fuori dai casi<br />
in cui l’esclusione dell’operatore si palesa come doverosa,<br />
anche in relazione al principio di tassatività delle<br />
cause di esclusione, l’approccio deve essere quello<br />
di declassare al rango di irregolarità sanabili tutte<br />
le mere omissioni o gli errori formali. Nel caso in esame,<br />
il tema del soccorso istruttorio si intreccia poi con<br />
quello della verifica del concreto possesso dei requisiti.<br />
Le disposizioni di riferimento per questo specifico<br />
momento della procedura di gara sono significativamente<br />
mutate tra vecchio e nuovo Codice: dall’imposizione<br />
del termine di 10 giorni essenziale e perentorio<br />
per la produzione della documentazione, dettato<br />
dall’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006 per esigenze<br />
di celerità e certezza nella fase di conclusione del<br />
procedimento della scelta del contraente (cfr. Ad. Plenaria<br />
n. 10 del 25.2.2014), si è passati all’indicazione<br />
meno stringente dell’art. 85, comma 5, D.Lgs. n.<br />
50/2016 che non prevede alcun riferimento temporale.<br />
È proprio sulla base di tale rilevo che il Consiglio di<br />
Stato, nella sentenza qui in commento, ha ritenuto di<br />
spingersi sino ad estendere l’applicazione dell’istituto<br />
del soccorso istruttorio anche alla fase di comprova<br />
dei requisiti, come meglio si preciserà nel prosieguo.<br />
Origine della controversia<br />
e giudizio di primo grado<br />
Il caso concreto da cui nasce la vicenda riguarda una<br />
procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico<br />
avente ad oggetto il servizio di gestione delle violazioni<br />
amministrative intestate a soggetti residenti<br />
all’estero e il servizio di recupero crediti internazionale<br />
per conto di alcuni Comuni della Liguria. L’amministrazione<br />
procedente annullava in autotutela l’atto dirigenziale<br />
di aggiudicazione all’operatore economico, a seguito<br />
di una segnalazione della controinteressata circa<br />
la carenza di uno dei requisiti richiesti dal disciplinare<br />
di gara. In particolare, l’aggiudicataria aveva prodotto<br />
un’attestazione a comprova dello svolgimento di “servizi<br />
uguali” a quello posto a base di gara, che si era poi<br />
rivelata oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione<br />
rilasciante, non risultando più sufficiente per la prova<br />
richiesta. L’operatore economico impugnava dunque<br />
il provvedimento, denunciando, in via preliminare, (i)<br />
l’incompetenza del Segretario comunale ad adottare<br />
l’atto dirigenziale summenzionato e contestando, nel<br />
merito, (ii) la scelta dell’Amministrazione di ricorrere<br />
all’annullamento d’ufficio in autotutela piuttosto che al<br />
potere di revoca e (iii) la mancata attivazione del soccorso<br />
istruttorio per rimediare alla sopravvenuta inidoneità<br />
del certificato di buona esecuzione in discussione.<br />
Dopo aver analizzato ogni censura promossa, il TAR Liguria<br />
adito in primo grado rigettava in toto il ricorso con<br />
la sentenza n. 677, pubblicata il 1° ottobre 2020. Per<br />
quanto di maggiore interesse in questa sede, il Giudice<br />
di prime cure, superata l’eccezione di incompetenza e<br />
respinto il primo motivo di merito, ha affrontato il tema<br />
della mancata attivazione nel caso di specie del soccorso<br />
istruttorio. Invero, nulla di nuovo è stato dichiarato<br />
sull’argomento, atteso che il soccorso istruttorio processuale<br />
invocato dalla ricorrente, mediante la produzione<br />
in giudizio di un nuovo certificato di regolare esecuzione,<br />
diverso da quello originariamente prodotto e<br />
rilasciato da una amministrazione diversa, non risultava<br />
comunque sufficiente ed idoneo per la comprova del<br />
requisito mancante. È, tuttavia, in sede di impugnazio-<br />
9<br />
LS<br />
ne di tale capo della decisione che si è registrato l’innovativo<br />
orientamento che ha aperto le porte al soccorso<br />
istruttorio anche nella fase di verifica del possesso dei<br />
requisiti conseguente all’aggiudicazione.<br />
La sentenza n. 1540/<strong>2021</strong><br />
del Consiglio di Stato<br />
Il ricorrente in primo grado proponeva appello avverso<br />
la sentenza di rigetto emessa dal TAR Liguria, lamentando<br />
l’erroneità delle statuizioni espresse, soprattutto<br />
in punto di soccorso istruttorio. In particolare, l’operatore<br />
economico rappresentava come il nuovo certificato<br />
fosse del tutto idoneo a dimostrare lo svolgimento di<br />
un servizio identico a quello oggetto della procedura di<br />
gara e come il Giudice di primo grado ne avesse invece<br />
travisato il contenuto e il significato. Secondo la tesi<br />
dell’appellante, infatti, a fronte della sopravvenuta inidoneità<br />
del certificato prodotto in sede di comprova dei<br />
requisiti post aggiudicazione, ben avrebbe potuto essere<br />
considerato, in sostituzione, il nuovo documento attestante<br />
lo svolgimento di un precedente servizio identico<br />
a quello oggetto di gara, pur se rilasciato da una<br />
Amministrazione differente. I Giudici di Palazzo Spada<br />
non hanno tuttavia ritenuto di accogliere tale prospettazione,<br />
confermando la decisione di primo grado, meglio<br />
specificandone la motivazione. Difatti, è stato rilevato<br />
come, nel caso di specie, l’invocato soccorso istruttorio<br />
non avrebbe ad oggetto tanto la documentazione di<br />
gara a comprova della dichiarazione originaria quanto<br />
piuttosto la dichiarazione medesima nella sua integralità.<br />
In particolare, ciò che il ricorrente vorrebbe non è<br />
la semplice integrazione o rettifica della documentazione<br />
dimostrativa bensì la sostituzione della dichiarazione<br />
prodotta con una afferente un diverso servizio, mai<br />
dichiarato in sede di gara.<br />
Ad ogni modo, la pronuncia è stata l’occasione per<br />
enunciare un principio di diritto che, seppur non applicabile<br />
allo specifico caso di specie, si rivela dalla portata<br />
particolarmente significativa. Dopo aver rilevato<br />
la differenza tra l’art. 48, comma 2 del previgente<br />
codice dei contratti pubblici del 2006 e la nuova disciplina<br />
di riferimento per la fase della verifica del possesso<br />
dei requisiti dichiarati (artt. 85, comma 5 e 32,<br />
commi 5 e 7, D.Lgs. n. 50/2016), il Collegio ha infatti<br />
concluso che “non può escludersi il soccorso istruttorio<br />
nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti<br />
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,<br />
il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione<br />
insufficiente o incompleta o errata, comunque<br />
inidonea a dimostrare il requisito così come<br />
posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della<br />
domanda di partecipazione”. In applicazione dell’art.<br />
83, comma 9 del Codice, dunque, ben potrebbe la stazione<br />
appaltante assegnare un termine all’aggiudicatario<br />
per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la<br />
documentazione carente anche in questa fase conclusiva<br />
della procedura di gara. In definitiva, la sentenza<br />
in commento costituisce un interessante approfondimento<br />
sulla materia del soccorso istruttorio, aderendo<br />
a quel filone sostanzialistico che propende per l’estensione<br />
dell’applicabilità dell’istituto in un’ottica di favor<br />
partecipationis, pur sempre nel rispetto dei principi di<br />
auto-responsabilità dei concorrenti e di immodificabilità<br />
delle offerte presentate in gara. nn<br />
4/<strong>2021</strong><br />
L’Opinione legale
10<br />
2<br />
11<br />
LS<br />
Sicurezza delle Infrastrutture<br />
L’esempio del Traforo del Frejus<br />
nel 150° anno dall’inaugurazione<br />
Nel numero di febbraio abbiamo richiamato alla memoria il “sogno” di Medail (un traforo sotto<br />
le Alpi) e il primo progetto di Henri Maus. In questa puntata della nostra serie sull’opera grande<br />
del Fejus ci occuperemo degli studi sulle nuove tecniche funzionali alla realizzazione<br />
di un traforo molto più lungo di quelli costruiti nel mondo, a quel tempo, e ripercorreremo<br />
le varie tappe della progettazione.<br />
Pasquale Cialdini<br />
Dirigente Generale a r.<br />
Ministero Infrastrutture<br />
e Trasporti<br />
In soli dieci anni (1849-1859) il piccolo Regno di Sardegna<br />
non solo riuscì risanare i bilanci, (dopo la pesante<br />
sconfitta della Prima Guerra d’Indipendenza),<br />
ma compì una notevolissima opera di ammodernamento<br />
nei settori dell’agricoltura e dei trasporti dove fu migliorata<br />
la rete stradale e, partendo da zero, fu costruita una<br />
rete ferroviaria di quasi 900 km (fig. 1) 1 . Nelle tre regioni<br />
(Piemonte, Liguria e Savoia), alla fine del 1859 la rete<br />
di strade ferrate era di gran lunga superiore a quella degli<br />
altri Stati di cui era divisa la penisola italiana. La linea<br />
ferroviaria Torino-Genova è il simbolo più importante delle<br />
opere di quegli anni. In soli 4 anni di lavoro (1849-53)<br />
L’ing. Pasquale Cialdini è stato a capo dell’Ispettorato Generale per la<br />
Circolazione e la Sicurezza Stradale e Direttore Generale della Direzione<br />
per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture presso il Ministero<br />
delle Infrastrutture e dei Trasporti. È socio onorario AIIT e Segretario<br />
dell’Associazione del Genio Civile.<br />
(Seconda Parte)<br />
1. Strade ferrate nel Regno di Sardegna nel 1957<br />
nella tratta di 157 km tra Moncalierie<br />
Genova furono costruiti 42<br />
ponti e dieci gallerie che consentirono<br />
di superare le grandi<br />
difficoltà morfologiche del<br />
montagnoso territorio ligure 2 .<br />
In tale contesto, il grande progetto<br />
dell’attraversamento delle<br />
Alpi non fu certo tenuto in disparte<br />
da chi reggeva con tanto<br />
senno lo stato cisalpino. L’avvicinarsi<br />
alla Francia, accorciando<br />
i tempi di trasporto delle merci<br />
e dei passeggeri era di fondamentale<br />
importanza per sviluppare<br />
quella solidarietà di interessi in tutti i<br />
settori che formava parte integrante e imprescindibile<br />
dei vasti piani politici di Cavour. E, pertanto,<br />
con legge del 14 giugno 1852 veniva decretava<br />
la ferrovia da Torino a Susa (poi aperta il 21 maggio<br />
1854) e nel 1853 si stipulava con la Società Lafitte il<br />
contratto per la costruzione della ferrovia in Savoia<br />
da Chambery a San Jean de Maurienne e nel capitolato<br />
si includevano anche gli studi preliminari per<br />
il passaggio attraverso le Alpi. Per l’esecuzione del<br />
contratto, fu costituita la Società Vittorio Emanuele<br />
che presentò un progetto di attraversamento redatto<br />
dall’ing. Le Haitre. Questo progetto riduceva la lunghezza<br />
del traforo a soli 5.500 m, innalzandolo però a 1.700 m<br />
s.l.m. Il progetto fu scartato perché non avrebbe garantito<br />
l’accesso nei mesi invernali per le frequenti tormente<br />
di vento e di neve che affliggevano la zona di accesso<br />
a quella quota; ai minori costi di costruzione dovuti alla<br />
minore lunghezza del traforo, infatti, si sarebbero dovuti<br />
anche aggiungere dei maggiori costi di manutenzione<br />
ed esercizio per rendere il più possibile fruibile l’accesso.<br />
In quegli anni furono presentati anche altri progetti da parte<br />
di ingegneri italiani e stranieri: Cauchaux, Bourdaloue,<br />
De Lorenzi e Ranco 3 . I progetti dei primi tre ingegneri furono<br />
scartati in quanto presentavano profonde modifiche<br />
di tracciato senza peraltro apportare miglioramenti 4 , mentre<br />
il progetto proposto da Ranco era pressoché coincidente<br />
con quello, di Maus che è stato già illustrato (leStrade<br />
1-2 <strong>2021</strong>) e confermava la necessità di costruire un traforo<br />
lungo circa 12.700 m con imbocchi a Bardonecchia<br />
e a Modane, senza pozzi intermedi, data la loro notevole<br />
lunghezza e l’impraticabilità dei luoghi posti a quota superiore<br />
ai 2.000 m dove sarebbero dovuti essere ubicati.<br />
Come conclusione di tutti questi studi, il tracciato proposto<br />
da Maus, e confermato da Ranco (fig. 2) appariva<br />
senza dubbio il migliore, ma per l’esecuzione si opponevano<br />
notevoli difficoltà apparentemente insormontabili.<br />
Non si avevano precedenti esperienze di tunnel così<br />
1<br />
lunghi, inoltre l’impossibilità di utilizzare pozzi intermedi<br />
creava due ordini di problemi:<br />
• Il primo riguardava i tempi di costruzione. L’avanzamento<br />
medio giornaliero con i mezzi ordinari era di 46 cm al giorno,<br />
il che significava che ci sarebbero voluti oltre 35 anni,<br />
senza alcuna interruzione e lavorando 365 giorni all’anno;<br />
• Il secondo riguardava le condizioni di lavoro all’interno<br />
di un tunnel così lungo e con solo due imbocchi, il che significava<br />
lavorare in ciascuno dei due fori a diversi chilometri<br />
dall’imbocco. I mezzi ordinari di ventilazione erano<br />
del tutto insufficienti a garantire condizioni minime<br />
di sopravvivenza per gli operai. Autorevoli esperti erano<br />
certi che, pur se si fosse riusciti a comprimere l’aria<br />
a parecchie atmosfere, la resistenza delle pareti dei tubi<br />
di condotta e la dispersione dell’aria nelle giunture ne<br />
avrebbero estinta la velocità dopo il primo o al massimo<br />
il secondo chilometro di distanza del fronte dello scavo<br />
dall’imbocco; e di chilometri bisognava farne più di sei<br />
da ognuno dei due imbocchi. Infine si nutrivano preoccupazioni<br />
anche per la temperatura all’interno del traforo<br />
che si prevedeva molto alta in quanto si scavava all’interno<br />
di una montagna la cui cima era molto elevata e,<br />
tenuto conto del gradiente termico (un grado ogni 30 m<br />
di profondità) e del calore prodotto dalle lampade, dalla<br />
respirazione degli operai e dallo sparo delle mine, il cantiere<br />
doveva divenire ben presto invivibile.<br />
Dal punto di vista geologico gli studi dell’esimio prof. Sismonda,<br />
che aveva accompagnato il progetto di Maus,<br />
furono confermati dalle relazioni e dai sondaggi effettuati<br />
da altri illustri geologi francesi: il prof. Mortillet, Elia<br />
di Baumont, Dufrenoy, Combes e Regnault. Tutti confermavano<br />
anche la possibilità di incontrare, durante lo<br />
scavo, ammassi d’acqua anche di rilevanti dimensioni e<br />
quantità, ma tutti erano certi che, se fossero stati seguiti<br />
i suggerimenti da loro forniti, si sarebbe potuto rimediare<br />
senza soverchi intralci nell’avanzamento dei lavori.<br />
Furono condotti anche approfonditi rilievi dei terreni per<br />
definirne la loro stratificazione 5 . In sostanza dal punto<br />
3<br />
2. Tracciato proposto da Maus e confermato<br />
da Ranco<br />
3. Compressore a colonna<br />
di vista geologico non parevano esserci difficoltà insormontabili.<br />
Bisognava vincere gli altri gravi ostacoli di cui<br />
si è già fatto cenno. Il nodo della questione era di verificare<br />
se e fino a che punto ci si poteva avvalere dell’aria<br />
compressa per superare tali ostacoli.<br />
Il ruolo determinante degli studi<br />
di Sommeiller, Grandis e Grattoni<br />
Alla risoluzione dei problemi sopraindicati lavorarono alacremente<br />
tre ingegneri del Genio Civile Germano Sommeiller,<br />
Sebastiano Grandis e Severino Grattoni. I primi<br />
due avevano già avuto modo di specializzarsi in Belgio e<br />
in Inghilterra 6 e tutti e tre avevano seguito i lavori di costruzione<br />
della galleria dei Giovi, dove avevano potuto<br />
sperimentare non solo l’utilizzazione della caduta dell’acqua<br />
per la produzione di energia, ma anche il trasporto<br />
a grande distanza dell’energia prodotta. I tre ingegneri<br />
stipularono una convenzione il 28 marzo 1854 che fu<br />
approvata con legge 20 luglio 1854 secondo la quale si<br />
impegnavano a provvedere alle necessarie sperimentazioni<br />
al cui costo avrebbe provveduto lo Stato con un<br />
somma di 120.000 lire. Gli studi e le prove eseguite, li<br />
convinsero sulla possibilità di poter comprimere l’aria,<br />
di trasportarla nel luogo desiderato e lì utilizzare il lavoro<br />
assorbito. Uno dei risultati più importanti degli studi<br />
e delle sperimentazioni condotte è stato il “compressore<br />
a colonna” 7 (fig. 3).<br />
1. In realtà nel 1849 la rete ferroviaria piemontese non partiva proprio da<br />
“zero”, perché l’anno precedente era stata inaugurata la prima tratta da Torino<br />
(Porta Nuova) a Moncalieri di 8 km. La linea Torino-Genova era stata<br />
prevista a totale carico dello Stato dalle “Regie Patenti” n. 443 del 13 febbraio<br />
1845 a firma del re Carlo Alberto.<br />
2. Tra le gallerie, una citazione particolare merita quella dei Giovi lunga<br />
3.265 km, tra Busalla e Pontedecimo. Il progettista era l’ingegnere inglese<br />
Isambard Brunel, al cui fianco lavoravano gli ingegneri del Genio Civile,<br />
Luigi Ranco e Germano Sommeiller che poi utilizzarono le esperienze ivi<br />
maturate per la progettazione e la direzione dei lavori del Frejus.<br />
3. Luigi Ranco (Asti 1813-Torino 1887) era un ingegnere del Genio Civile,<br />
ha lavorato alla costruzione della tratta Torino – Genova con Maus. Fu nominato<br />
commissario governativo della Società Vittorio Emanuele, che gestiva<br />
la tratta ferroviaria nella Savoia e nella valle di Susa. In seguito, dopo l’Unità<br />
d’Italia, gli fu affidata anche la direzione della ferrovia Salerno-Potenza<br />
4. In particolare il progetto di Cauchaux prevedeva lo spostamento del tracciato<br />
verso il Monginevro valicando il Monte Tabor a circa 2.000 m s.l.m.<br />
ed allungando il tracciato di oltre 80 km e presentava le stesse difficoltà di<br />
accesso nei mesi invernali di quello di Le Haitre.<br />
5. La stratificazione dei terreni da Nord verso Sud, con le rispettive lunghezze<br />
e la % rispetto alla lunghezza del traforo:<br />
• terreno antracifero all’imbocco lato Fournaux per una lunghezza di circa<br />
1.800 m, pari al 14,4%;<br />
• quarziti subito dopo il terreno antracifero per circa 500 m, pari allo 4%;<br />
• calcari massicci per i successivi 2.500 m, pari 20%;<br />
• scisti calcari su tutto il versante italiano per i restanti 8.000 m, pari al 61%.<br />
6. Nel 1846 il governo piemontese decise di inviare in Belgio ed Inghilterra<br />
i giovani ingegneri più promettenti ed un gruppo di operai per seguire i<br />
lavori nei Paesi più avanzati nel campo ferroviario. Tra i giovani ingegneri<br />
scelti dal prof. Carlo Ignazio Giulio c’erano Germano Sommeiller e Sebastiano<br />
Grandis. Il prof. Giulio sarà poi il membro relatore della Commissione<br />
che giudicò il progetto del traforo fatto dai suoi due allievi nel 1857.<br />
7. Per le caratteristiche del “compressore a colonna” progettato dai tre<br />
ingegneri, si rimanda al Saggio storico descrittivo di Michele Treves<br />
“Sulla perforazione meccanica delle gallerie ferroviarie”, Venezia 1864<br />
(pagg. 40-45).<br />
Sicurezza delle Infrastrutture<br />
Sicurezza delle Infrastrutture<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
12<br />
7<br />
13<br />
LS<br />
4. La perforatrice di Sommellier<br />
5. Perforatrice custodita nel compartimento ferroviario a Torino Porta Nuova<br />
La convenzione prevedeva anche che le valutazioni<br />
delle sperimentazioni dovevano essere affidate a una<br />
Commissione governativa formata da insigni ed eminenti<br />
tecnici 8 . La Commissione individuò anche quale<br />
doveva essere la quantità d’aria occorrente per garantire<br />
la vivibilità degli operai impegnati nelle operazioni di<br />
scavo di almeno 100 m 3 di roccia al giorno. Dai calcoli<br />
della Commissione si ricavò la necessità di poter disporre<br />
di poco più di 74.000 m 3 di aria nelle 24 ore e quindi<br />
di 3.084 m 3 ogni ora 9 . Dai calcoli di Sommeiller si ricavava<br />
che il volume d’aria che si poteva ottenere con la<br />
forza motrice, disponibile a Bardonecchia, era di 4.086<br />
m 3 . Con tale valore si poteva scavare più dei 100 m 3<br />
al giorno e arrivare addirittura a 120 m 3 che equivalevano<br />
a un avanzamento giornaliero di 3 m. Dopo i primi<br />
esperimenti sui compressori e sulle perforatrici condotti<br />
a Collegno, presso Torino, si utilizzò un’antica cava<br />
di calcare in località La Coscia, vicino a Genova, dove<br />
furono riprodotte le stesse condizioni che si sarebbero<br />
trovate nel traforo con risultati entusiasmanti. Le conclusioni<br />
della Commissione possono così sintetizzarsi:<br />
1. “Il compressore di Grandis, Grattoni e Sommeiller opera<br />
in modo regolare e sicuro e fornisce il miglior mezzo<br />
conosciuto per applicare la forza dell’acqua cadente a<br />
comprimere grandi volumi di aria e consente di somministrare<br />
ai lavori sotterranei aria respirabile e forza motrice”.<br />
2. “Gli sperimenti sul movimento dell’aria compressa entro<br />
lunghe condotte, quantunque fatti sopra un tubo della<br />
lunghezza di 389 m, danno sicuro argomento di credere<br />
che l’aria compressa si potrà mandare fino alla metà della<br />
distanza che separa i due imbocchi, conservando una forza<br />
motrice sufficiente al suo impiego per le perforazioni”.<br />
3. “Le quantità d’acqua e la caduta di cui si può disporre<br />
nelle due valli (di Bardonecchia e dell’Arc) sono sufficienti<br />
a dar moto a quel numero di compressori che è<br />
necessario alla ventilazione dei lavori”.<br />
4. “I perforatori meccanici possono essere mossi dall’aria<br />
compressa ed essi consentono una velocità circa dieci<br />
volte maggiore per la predisposizione dei fori per la collocazione<br />
delle mine, rispetto al lavoro manuale. L’uso dei<br />
perforatori abbrevia considerevolmente la durata del lavoro<br />
della galleria e lo abbrevierà tanto più rispetto al lavoro<br />
manuale, quanto più sarà ribelle la natura dei terreni”.<br />
Da ultimo, la Commissione conclude affermando di “non<br />
essere in grado di indicare basi ragionate per contratti<br />
relativi all’esecuzione di un’opera di natura straordinaria,<br />
da condursi con mezzi straordinari e che l’opera<br />
deve quindi cominciarsi di necessità in economia”. La<br />
4<br />
5<br />
relazione termina con l’invito a “metter mano sollecitamente<br />
alle operazioni ed esplorazioni” propedeutiche<br />
all’esecuzione dell’opera. Suggerisce, infine, di “cominciare<br />
lo scavo della galleria coi mezzi consueti”, mentre<br />
si reperiscono tutti materiali necessari “per proseguirla<br />
con il più celere procedimento” (meccanico).<br />
Il progetto: approvazione<br />
e finanziamento<br />
Terminati tutti gli studi e le sperimentazioni che sinteticamente<br />
sono stati descritti, i tre ingegneri Sommeiller,<br />
Grandis e Grattoni, cui si aggiunse anche l’ingegner<br />
Luigi Ranco predisposero il progetto definitivo del traforo<br />
ferroviario. Il Ministero dei lavori pubblici stipulò<br />
con la Società Vittorio Emanuele una nuova convenzione<br />
10 con un capitolato aggiornato. Il Governo presentò<br />
nell’<strong>aprile</strong> del 1857 al Parlamento per l’approvazione la<br />
convenzione ed il progetto di legge che decretava l’esecuzione<br />
della galleria e prevedeva che lo Stato si assumesse<br />
a tutto suo rischio l’esecuzione del traforo tra<br />
Bardonecchia e Fourneaux (art. 16 del d.d.l.) e la costruzione<br />
dei due tronchi di ferrovia dai due imbocchi<br />
rispettivamente a Susa e a Modane per un costo complessivo<br />
di 41,6 milioni di lire, così ripartiti:<br />
• Tronchi da Susa a Bardonecchia 14,40 milioni<br />
e da Fourneaux a Modane:<br />
• Traforo:<br />
20,60 milioni<br />
• Armamento:<br />
3,67 milioni<br />
• Imprevisti (8%):<br />
2,93 milioni<br />
In un articolo successivo seguiremo l’iter del disegno<br />
di legge nel Parlamento e gli interventi di Cavour, poi<br />
descriveremo le varie fasi della costruzione del traforo.<br />
Quale insegnamento trarre<br />
dall’iter progettuale?<br />
Questa domanda viene spontanea, dopo aver esaminato<br />
nel dettaglio tutte le complesse fasi della progettazione,<br />
dal sogno di Medail del 1839 e dal primo progetto di Hen-<br />
6<br />
6. Gli ingegneri Grandis, Sommellier e Grattoni<br />
ri Maus, tra il 1845 e il 1849 (leStrade 1-2/<strong>2021</strong>) e poi<br />
tutti gli studi e le sperimentazioni che sono stati condotti<br />
da Sommeiller, Grandis e Grattoni negli anni successivi<br />
e che si conclusero nel 1857. In questi giorni, quasi<br />
tutte le forze politiche hanno individuato nella realizzazione<br />
delle “grandi opere” uno degli strumenti principali<br />
per uscire dalla crisi economica, tuttavia molto acceso<br />
è stato il dibattito sull’opportunità di utilizzare il “Codice<br />
degli appalti” o seguire il “modello Genova”. Su questo argomento<br />
si sono espressi anche i rappresentanti dei costruttori<br />
ed è intervenuta recentemente anche l’Antitrust<br />
e l’Agenzia Anticorruzione con pareri tra di loro opposti. I<br />
giornali hanno riportato le diverse posizioni che in modo<br />
molto sintetico si possono così riassumere:<br />
a) Coloro che propongono il “modello Genova” considerano<br />
che il Codice degli appalti ha subito tali e tante modifiche<br />
che lo hanno ridotto ad un “pot-pourri” di diverse<br />
e contrastanti disposizioni ed indicano “la sua sospensione<br />
come l’unica strada da seguire per sboccare i cantieri<br />
fermi, superando le ferraginosità degli iter e la moltiplicazione<br />
dei passaggi burocratici che costituiscono il terreno<br />
fertile in cui prosperano i fenomeni illeciti”;<br />
b) Coloro che ritengono necessario seguire le procedure<br />
ordinarie, motivano la loro scelta, in quanto: “il modello<br />
Genova non può diventare il sistema per gli appalti in Italia,<br />
il codice degli appalti non può essere cancellato perché<br />
in larga parte recepisce le direttive europee in materia”.<br />
Alcuni hanno anche aggiunto che “bisogna, però,<br />
lavorare per semplificare le procedure, per ridurre il numero<br />
delle stazioni appaltanti ed apportare alcune modifiche”<br />
ed inoltre che “non si deve consentire alle imprese<br />
cui è stato affidato l’appalto di poterlo poi subappaltare in<br />
modo indiscriminato”.<br />
Entrambe le posizioni, sembra che non abbiano compreso<br />
che la causa del fallimento della gestione delle opere pubbliche,<br />
e in particolare delle grandi opere, negli ultimi decenni<br />
è da ricercare soprattutto nella mancanza di un’adeguata<br />
programmazione e di una corretta progettazione.<br />
Questi difetti hanno comportato che le opere sono rimaste<br />
in gran parte incompiute o sono costate molto più del<br />
preventivato a causa di varianti, di sospensioni dei lavori<br />
e di riserve dell’imprese appaltatrici. Tutto ciò ha spesso<br />
favorito una dilagante corruzione con infiltrazioni anche<br />
di natura mafiosa. È bene, quindi ricordare, che prima di<br />
attivare qualsivoglia procedura di appalto, le stazioni appaltanti<br />
devono accertarsi che il progetto sia stato realizzato<br />
correttamente.<br />
Anche se sono passati molti anni, ricordo che l’ultima raccomandazione<br />
che noi studenti abbiamo ricevuto dai nostri<br />
professori della facoltà di ingegneria è stata proprio sull’estrema<br />
cura e attenzione che avremo dovuto dedicare nella<br />
nostra vita professionale alla progettazione; e ricordo anche<br />
bene che questa stessa raccomandazione è stata la prima<br />
che ho ricevuto dai miei superiori quando, pochi mesi<br />
dopo, sono stato assunto al Ministero dei Lavori Pubblici.<br />
Dopo qualche tempo, frequentando la biblioteca del Ministero,<br />
ho scoperto che la raccomandazione sulla “corretta<br />
progettazione” che avevo ricevuto aveva origini antichissime.<br />
Sfogliando uno dei primi numeri del “Giornale del<br />
Genio Civile” (n. 6 del 1863) 11 ho rintracciato una delle<br />
primissime disposizioni del Ministero, in materia di opere<br />
pubbliche, la circolare n. 29 del 1° settembre 1863 con la<br />
quale il ministro Luigi Federico Menabrea 12 , invitava gli Ingegneri<br />
Capi degli uffici del Genio Civile a “portare la mas-<br />
7. Legge fondamentale sulle opere pubbliche<br />
sima cura ed attenzione nello studio e nell’accertamento<br />
delle condizioni particolari di ciascuna opera per scegliere<br />
ed applicare i migliori ed i più economici sistemi consacrati<br />
dall’esperienza”. La circolare poi proseguiva invitando<br />
i progettisti a “usare ogni diligenza nella valutazione<br />
delle opere, nella determinazione dei prezzi relativi e nelle<br />
operazioni di calcolo che sieno fatte con quella più rigorosa<br />
esattezza che l’arte rende possibile”. La circolare ricordava<br />
anche che “nell’eseguimento dei lavori non dev’essere<br />
permessa variazione alcuna dei limiti stabiliti dal progetto.<br />
Qualunque modificazione, che alteri le forme o le dimensioni<br />
prescritte, o che porti aumento di opere, quantunque<br />
reso necessario da circostanze imprevedute, non sarà mai<br />
consentita se non sia espressamente approvata da questo<br />
Ministero”. Menabrea concludeva con “un comando” che<br />
era al tempo stesso un auspicio: “Quando i signori Ingegneri<br />
prendano a cuore le premesse avvertenze, le opere<br />
potranno essere portate a termine nel rispetto dei tempi e<br />
dei costi preventivati”. È proprio da quest’ultimo “comando”<br />
che bisogna partire per evitare il ripetersi dei fenomeni<br />
che hanno caratterizzato in questi ultimi decenni l’esecuzione<br />
delle opere pubbliche e specialmente delle “grandi<br />
opere”. Se si esaminano le numerose opere incompiute e<br />
anche quelle che in corso d’opera hanno subito numerose<br />
varianti con aumenti considerevoli dei costi, si vedrà che<br />
erano prive di un’adeguata programmazione e il loro progetto<br />
era, fin dall’origine, carente.<br />
I governi che si sono succeduti non sono andati alla ricerca<br />
della causa principale, hanno solo pensato di risolvere<br />
i problemi modificando di continuo le leggi sugli appalti,<br />
come se queste fossero in grado di cambiare i comportamenti<br />
delle persone, ovvero dei progettisti, dei responsabili<br />
delle stazioni appaltanti e dei titolari delle imprese. Tutti<br />
sappiamo che la “Legge fondamentale sulle opere pubbliche”<br />
del 1865 (L. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato f) è rimasta<br />
in vigore per 130 anni ed insieme al “Regolamento<br />
per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello<br />
Stato” (R.D. 25 maggio 1985, n. 350), ha consentito la costruzione<br />
dell’Italia nell’Ottocento e nei primi quarant’anni<br />
del Novecento e poi la ricostruzione nel Secondo Dopoguerra.<br />
La legge che l’ha abrogata nel 1994 (n.109/1994,<br />
cosiddetta Legge Merloni), in meno di 25 anni, è stata più<br />
volte modificata e poi abrogata e sostituita da altre leggi<br />
che sono state a loro volta abrogate e sostituite 13 .<br />
Una conclusione<br />
Per intervenire sui comportamenti non si devono cambiare<br />
di continuo le leggi perché questo comporta anche difficoltà<br />
di interpretazione sugli ambiti di applicazione delle<br />
modifiche e questo aumenta a dismisura il contenzioso<br />
tra le stazioni appaltanti e le imprese che, molto spesso,<br />
hanno ottenuto attraverso le “riserve” corrispettivi molto<br />
più elevati di quelli pattuiti. Per intervenire sui comportamenti<br />
si devono, invece, aumentare i controlli a partire dal<br />
progetto e poi durante l’esecuzione delle opere sul rispetto<br />
della legge vigente. A tal proposito, si auspica che il Ministero<br />
delle Infrastrutture ponga mano immediatamente a<br />
una nuova legge sui lavori pubblici, prendendo a modello<br />
la legge del 1865, la componga di pochi e chiari articoli che<br />
non diano luogo a interpretazioni contrastanti. Contemporaneamente<br />
dovrebbero essere emanati anche i Regolamenti<br />
attuativi, aggiornando quelli del 1895. Al tempo<br />
stesso, è necessaria una profonda riduzione e specializzazione<br />
delle stazioni appaltanti, organizzate sul modello<br />
dei compianti Uffici del Genio Civile, affidando al Consiglio<br />
Superiore dei Lavori pubblici, oltre al compito dell’approvazione<br />
dei progetti delle opere pubbliche dello Stato anche<br />
quello delle ispezioni sui lavori. nn<br />
8. La Commissione era composta da: Luigi Des Ambrois di Navache,<br />
presidente; Luigi Federico Menabrea, Dionigi Ruva, Quintino Sella e<br />
Carlo Ignazio Giulio, membri.<br />
9. Chi vuole approfondire l’argomento, può leggere il Saggio storico<br />
descrittivo (già citato) di Michele Treves, pagg.75-76.<br />
10. I punti salienti della convenzione, come prevista nel disegno di<br />
legge, saranno descritti in un articolo successivo.<br />
11. Fin dalla costituzione del Ministero dei Lavori pubblici nel 1859 è<br />
stato pubblicato il Giornale del Genio Civile che mensilmente raccoglieva<br />
le disposizioni normative e la descrizione delle numerose opere pubbliche<br />
realizzate dagli uffici centrali e periferici del Ministero. Tutti i numeri<br />
del Giornale del Genio Civile sono consultabili nella Biblioteca del Ministero<br />
dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità<br />
Sostenibili) in via Nomentana, 2.<br />
12. Luigi Federico Menabrea era ingegnere, professore al Politecnico di<br />
Torino e generale del Genio militare. E’ stato anche Presidente del Consiglio<br />
Superiore dei Lavori Pubblici e dal dicembre 1862 al settembre<br />
1864 Ministro del Lavori Pubblici ed infine da ottobre 1867 a dicembre<br />
1869 Presidente del Consiglio dei Ministri.<br />
13. La legge sulle opere pubbliche (Legge n.2248, allegato f), del 1865<br />
è durata 130 anni durante i quali l’Italia è stata dotata di numerosissime<br />
opere pubbliche, in particolare ferrovie e strade. Nel 1895 è stato<br />
pubblicato il RD n. 350 del 25/5/1895 “Regolamento per la direzione,<br />
contabilità e collaudo dei lavori dello Stato”, cui ha fatto seguito il DM<br />
del 29/5/1895 “Regolamento per la compilazione dei progetti di opere<br />
pubbliche dello Stato”. Intere generazioni di ingegneri hanno utilizzato<br />
questi tre importanti strumenti che hanno consentito la “costruzione e,<br />
nel secondo dopoguerra, anche la ricostruzione dell’Italia”. Nel 1994 la<br />
“legge sulle OO. PP.” è stata abrogata dalla cosiddetta Legge “Merloni”<br />
n. 109/1994 che è stata poi abrogata dal D.Lgs n.50 del 18/4/2006.<br />
Il Regolamento n.350/1895 è rimasto in vigore fino al 2010, quando è<br />
stato abrogato dal Regolamento emanato con DPR n.207/2010. Il D.Lgs<br />
n.163/2006 è stato poi abrogato dal D.Lgs n.50 del 18/4/2016 che ha<br />
anche abrogato il DPR n.207/2010 di cui però ha lasciato in vigore alcuni<br />
punti in attesa della pubblicazione dei provvedimenti normativi necessari<br />
(ovvero di un nuovo regolamento). Il 15/7/2016 viene pubblicata<br />
sulla G.U. l’Avviso di rettifica che modifica 100 articoli su 220 del D.Lgs<br />
n.50/2016. Il 5/7/2017 viene pubblicato il D.Lgs n.56 del 19/7/2017<br />
recante “disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50/2016” con il<br />
quale vengono apportate grosse correzioni per risolvere le criticità rilevate<br />
nel primo anno di applicazione del Codice degli appalti. Le modifiche<br />
ed integrazioni al D.Lgs. n.50/2016 sono continuate anche negli<br />
anni successivi e ad oggi siamo arrivati alla versione 7.8.<br />
Sicurezza delle Infrastrutture<br />
Sicurezza delle Infrastrutture<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
14<br />
15<br />
LS<br />
Rientro strade, via libera<br />
alla seconda tranche del piano<br />
Ritornano sotto la gestione di Anas (Gruppo FS Italiane) 3mila km di rete provinciale<br />
Al via la seconda tranche 1<br />
di rientro strade ad Anas<br />
da parte delle amministrazioni<br />
locali per circa 3.000<br />
km, che unita ai trasferimenti<br />
della prima tranche avviata alla<br />
fine del 2018, incrementa la rete<br />
in gestione ad Anas a un totale<br />
di oltre 32.000 km. Nel dettaglio,<br />
in esecuzione dei DPCM<br />
del 21 novembre 2019, il 7 <strong>aprile</strong><br />
è stata effettuata la consegna<br />
di 872 km da parte delle regione<br />
Emilia-Romagna. A seguire il<br />
Piemonte con 1.000 km, la Lombardia<br />
con 1.075 km e la Toscana<br />
con 39 km (che si aggiungono<br />
ai 573 km trasferiti dalla<br />
Toscana nel 2018). Le operazioni<br />
di passaggio si concluderan-<br />
2<br />
no entro la fine del mese di <strong>aprile</strong>.<br />
Con questa seconda tranche,<br />
entrano nella gestione di Anas<br />
altri circa 1.300 ponti, che saranno<br />
immediatamente inseriti<br />
nel programma Bridge Management<br />
System che prevede cicli<br />
cadenzati di monitoraggi e ispezioni.<br />
Anas, sulla base delle prescrizioni<br />
contenute nel parere<br />
del Consiglio Superiore dei Lavori<br />
Pubblici del 18 <strong>aprile</strong> 2019,<br />
ha svolto in via preventiva sulla<br />
rete della seconda tranche in<br />
corso di trasferimento una due<br />
diligence infrastrutturale con lo<br />
scopo di controllare la presenza di eventuali<br />
criticità per la sicurezza degli utenti e verificare<br />
lo stato di conservazione e funzionalità<br />
delle strutture, comprensive di ponti, viadotti<br />
e gallerie. Questa attività ispettiva, interamente<br />
a carico di Anas, è stata propedeutica<br />
alla conoscenza degli asset stradali per programmare<br />
i necessari interventi di manutenzione<br />
e messa in sicurezza delle tratte oggetto<br />
di rientro in gestione ad Anas. Le attività<br />
sono state completate a marzo <strong>2021</strong> per con-<br />
© Anas SpA<br />
© Anas SpA<br />
1. Strade già rientrate e attività Anas: SS 148 nel Lazio<br />
2. SS 452 “della Contessa” in Umbria<br />
sentire l’effettivo trasferimento delle strade.<br />
“Il Piano Rientro Strade ad Anas - ha dichiarato<br />
l’Amministratore delegato Massimo Simonini<br />
- ha diversi obiettivi che riguardano<br />
l’ambito della sostenibilità nell’ottica di migliorare<br />
la qualità del servizio complessivo<br />
offerto agli utenti. Aumenta l’efficienza della<br />
gestione dell’intera rete, con interventi di<br />
manutenzione programmata più omogenei,<br />
potenzia gli standard di sicurezza con benefici<br />
in termini di accessibilità a tutti i territori<br />
e alle aree interne. Inoltre, concentrare le<br />
competenze in un unico gestore, che ha un<br />
unico core business, evita la frammentazione<br />
delle competenze nella gestione delle strade<br />
e dei trasporti e rappresenta una garanzia<br />
per la destinazione degli investimenti, mantenendo<br />
e sviluppando al contempo il know<br />
how di Anas”. nn<br />
Consolidamento strutturale e conservativo del ponte monumentale di Ariccia<br />
■ Sicilia, in adeguamento<br />
l’itinerario Catania-Gela<br />
Sono stati avviati il 29 marzo i primi cantieri<br />
nell’ambito dei lavori per l’adeguamento e la<br />
messa in sicurezza dell’itinerario Catania-Gela. I<br />
primi tratti interessati dalle lavorazioni riguardano<br />
la strada statale 117bis “Centrale Sicula”, dal<br />
km 76 al km 82, incluso il completamento della<br />
rotatoria presente al km 80,650 della statale.<br />
Nella settimana precedente erano stati inoltre<br />
consegnati all’impresa aggiudicataria, e sono<br />
quindi di prossimo avvio, i lavori dal km 12 al<br />
km 43 della strada statale 417 “Di Caltagirone”.<br />
I lavori consegnati - avviati o di imminente avvio<br />
- hanno un importo di investimento pari a<br />
circa 25 milioni di euro. Sono inoltre in corso le<br />
progettazioni di altri interventi, per un investimento<br />
ulteriore di circa 74 milioni di euro. I lavori<br />
sono stati aggiudicati mediante una gara<br />
di accordo quadro suddivisa in tre lotti. Anas ha<br />
Anas (Gruppo FS Italiane) il 29 marzo ha avviato<br />
gli interventi di consolidamento strutturale<br />
e conservativo del ponte monumentale Pio IX<br />
di Ariccia (Roma). Le attività hanno avuto inizio<br />
con la fase di cantierizzazione che al momento<br />
non interesserà la sede stradale, in quanto<br />
i primi interventi riguarderanno le facciate<br />
esterne e l’area sottostante il ponte, senza limitazioni<br />
al transito. Successivamente si procederà<br />
con le lavorazioni nella parte superiore<br />
e scatterà il provvedimento di chiusura al transito<br />
in entrambe le direzioni. Tale intervento è<br />
il risultato di un atto di transazione tra Comune<br />
e Anas attraverso il quale Anas ha preso in carico<br />
gli interventi dell’opera del Comune. L’investimento<br />
complessivo dell’intera opera è pari<br />
a 5,5 milioni di euro.<br />
“Avviamo lavori importanti per un ponte storico<br />
- ha dichiarato l’ing. Marco Moladori, Responsabile<br />
Struttura Territoriale Lazio -, un’attività<br />
resa possibile grazie alla sinergia e collaborazione<br />
con il Comune di Ariccia, che ha garantito<br />
una grande attenzione per il territorio.<br />
Gli interventi previsti sono necessari per tutelare<br />
un’infrastruttura di grande valore e importante<br />
collegamento tra la zona dei Castelli Romani<br />
e la capitale. Naturalmente l’impegno di<br />
Anas è quello di ridurre al minimo il disagio e<br />
3 4<br />
© Anas SpA<br />
aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture<br />
della Regione Sicilia del 14 novembre 2016, per<br />
garantire il rispetto della legalità nei cantieri.<br />
■ Sardegna, riqualificazione<br />
dei ponti della SS 131<br />
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha avviato<br />
un piano di interventi finalizzati alla riqualificazione<br />
delle opere d’arte nel tratto sassarese<br />
della strada statale 131 “Carlo Felice”, del valore<br />
complessivo di oltre 15 milioni di euro. A partire<br />
dall’8 <strong>aprile</strong> sono stati avviati gli interventi di<br />
demolizione e ricostruzione del sottovia situato<br />
all’altezza dello svincolo di Saccargia sulla statale<br />
597 (km 197,800) per un valore di oltre 2<br />
milioni di euro. Gli interventi prevedono la chiusura<br />
di un tratto di 600 metri di statale 131 con<br />
deviazioni segnalate in loco. La stessa tipologia<br />
di interventi interesserà nel breve periodo i sottovia<br />
situati agli svincoli di Thiesi (km173,300),<br />
a tal proposito abbiamo migliorato la viabilità<br />
comunale che sarà interessata dai percorsi alternativi<br />
in occasione della chiusura del ponte”.<br />
Grazie a questo intervento Anas potrà conservare<br />
e preservare lo storico ponte monumentale<br />
di Ariccia che vide la sua prima realizzazione<br />
nel 1847 su progetto dell’architetto Giuseppe<br />
Bartolini. L’opera commissionata da Papa Pio<br />
IX, da cui prende il nome, svolge un ruolo di primaria<br />
importanza per il collegamento della comune<br />
di Ariccia con la città di Roma.<br />
3, 4. Via al “restauro” del ponte Pio IX<br />
© Anas SpA<br />
Bonnanaro (179,200) e Siligo (186,800) del valore<br />
di un 1 milione di euro ciascuno, e del sottovia<br />
situato allo svincolo di Florinas/Codrongianus<br />
(km 194,300) i cui lavori hanno un valore<br />
di 2,4 milioni di euro. Il piano prevede inoltre<br />
il risanamento conservativo e l’adeguamento<br />
strutturale del viadotto Badde Olia (205,500)<br />
per un investimento di 4,8 milioni di euro e i cui<br />
lavori saranno avviati entro la fine di <strong>aprile</strong>. Un<br />
intervento analogo è in corso di progettazione<br />
sul viadotto situato al km 145,500 per ulteriori<br />
2,8 milioni di euro. I lavori fanno parte di un<br />
ampio programma di riqualificazione del tratto<br />
nord della statale 131 finalizzato ad incrementare<br />
gli standard di sicurezza della principale arteria<br />
Sarda che riguarda, oltre alle opere d’arte,<br />
la manutenzione delle pavimentazioni, la realizzazione<br />
della segnaletica orizzontale e verticale,<br />
la sostituzione dei guardrail e l’ammodernamento<br />
delle gallerie Chighizzu I e II.<br />
Strutture Territoriali<br />
Osservatorio ANAS<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
con
16<br />
LS<br />
News<br />
Notiziario chiuso il 12 Aprile <strong>2021</strong><br />
Attualità<br />
Così si formerà<br />
la classe dirigente<br />
La professoressa Antonietta<br />
Polimeni, Magnifica Rettrice<br />
dell’Università La Sapienza di<br />
Roma, il 13 <strong>aprile</strong> scorso ha<br />
ricevuto Federico Cempella,<br />
Presidente dell’Associazione del<br />
Genio Civile (AGC),<br />
accompagnato da Pasquale<br />
Cialdini, Segretario AGC.<br />
L’incontro è stato preceduto nei<br />
mesi scorsi da uno scambio<br />
epistolare con il quale il<br />
Presidente dell’AGC ha proposto<br />
una fattiva collaborazione con il<br />
prestigioso Ateneo romano per<br />
l’istituzione di una “Scuola di<br />
alta formazione per una nuova<br />
classe dirigente” eticamente e<br />
professionalmente adeguata allo<br />
svolgimento di rilevanti compiti<br />
nella gestione della “Res<br />
Publica”. L’Associazione metterà<br />
a disposizione il patrimonio<br />
culturale, di conoscenze e di<br />
esperienze maturato in oltre 200<br />
anni dallo storico Corpo del<br />
Genio Civile in materia di “Buon<br />
Governo del Territorio”,<br />
“Habitat”, “Ammodernamento e<br />
organico completamento<br />
sull’intero territorio nazionale<br />
delle reti delle ferroviarie,<br />
portuali e viarie per una mobilità<br />
sostenibile”, come previsto<br />
anche dal Recovery Found. La<br />
Magnifica Rettrice ha<br />
manifestato la sua convinta<br />
approvazione per tale iniziativa,<br />
specificando che “investire nella<br />
formazione della classe dirigente<br />
significa permeare il futuro dei<br />
nostri figli, domani cittadini<br />
attivi e artefici del destino del<br />
nostro Paese”. Nell’incontro del<br />
13 <strong>aprile</strong> sono state poste le<br />
basi per la predisposizione di un<br />
“Protocollo d’intesa” tra<br />
Università La Sapienza e<br />
Associazione Genio Civile che<br />
porterà all’avvio di un Primo<br />
Corso di Alta Formazione, già<br />
nel prossimo anno accademico.<br />
Di questo progetto è stato<br />
informato anche il<br />
Ministro, prof. Enrico Giovannini<br />
a mezzo di una circostanziata<br />
lettera aperta. leStrade terrà<br />
costantemente informati i lettori<br />
sugli sviluppi di questa<br />
importante iniziativa.<br />
GENIOALATO.IT<br />
News Attualità<br />
Sfoglia<br />
il dossier<br />
sui 200<br />
anni del<br />
Genio Civile<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
Napoli, la TBM<br />
arriva a Poggioreale<br />
Il 30 marzo scorso sono stati<br />
ultimati i lavori di scavo della<br />
prima galleria di collegamento<br />
lungo la tratta Capodichino-<br />
Poggioreale della Linea 1 della<br />
metropolitana di Napoli. TBM<br />
(Tunnel Boring Machine) ha<br />
abbattuto l’ultimo diaframma<br />
sfociando, nel penultimo giorno<br />
del mese che tiene a battesimo la<br />
primavera, a Poggioreale. Si è<br />
concluso così il complesso scavo<br />
della prima delle due gallerie della<br />
linea, che collegheranno la<br />
stazione di Capodichino a quella di<br />
Poggioreale. “Il collegamento tra<br />
le due stazioni - citiamo da Il<br />
Mattino di Napoli - è realizzato<br />
con due gallerie affiancate,<br />
ciascuna ad un unico binario.<br />
Quella completata è la prima delle<br />
due gallerie che hanno la<br />
lunghezza di 1 km ciascuna e la<br />
macchina che le sta realizzando<br />
ha un diametro di 6,80 metri. Il<br />
vicesindaco di Napoli Carmine<br />
Piscopo e gli assessori comunali<br />
Per la centralità<br />
del progetto<br />
“Se si abdica alla centralità del<br />
progetto esecutivo il Pnrr<br />
naufragherà”. È questo il monito<br />
che lancia l’OICE che con il<br />
Presidente Gabriele Scicolone<br />
esprime la forte preoccupazione<br />
del settore: “Se dovesse essere<br />
vera l’indiscrezione per cui nella<br />
commissione interministeriale che<br />
sta studiando le semplificazioni<br />
per il Pnrr si starebbe valutando,<br />
per velocizzare l’iter di<br />
realizzazione delle opere del Pnrr,<br />
di affidare appalti integrati sulla<br />
base del progetto di fattibilità,<br />
saremmo di fronte al più<br />
clamoroso degli autogol:<br />
rinunciare alla centralità del<br />
progetto esecutivo, unico<br />
elemento in grado di assicurare<br />
qualità, contenimento di costi, di<br />
varianti e riserve. Sembra quasi<br />
una boutade!”. Per Scicolone la<br />
proposta non reggerebbe neanche<br />
sotto il profilo dei tempi: “Siamo<br />
Alessandra Clemente e Marco<br />
Gaudini, con il presidente di<br />
Metropolitana SpA, Ennio<br />
Cascetta, hanno assistito alla<br />
caduta dell'ultimo diaframma”. La<br />
TBM - chiamata Adriana - è stata<br />
consegnata al cantiere della<br />
stazione di Capodichino nel<br />
gennaio 2020 e da allora si sono<br />
susseguite le diverse fasi di<br />
lavoro, dall’installazione al<br />
montaggio, fino ad arrivare a<br />
quella in cui la macchina è stata<br />
calata nel pozzo a una profondità<br />
di fronte al solito fraintendimento.<br />
Fra valutazione in gara del<br />
progetto definitivo che, a quel<br />
punto, tutti i concorrenti<br />
dovrebbero presentare - anche se<br />
alla fine soltanto uno risulterebbe<br />
vincitore - e successiva redazione<br />
del progetto esecutivo i tempi si<br />
allungano a dismisura, con un<br />
dispendio di energia e costi per<br />
tutti gli attori. Senza poi<br />
considerare che lasciare in mano<br />
all’impresa di costruzioni la fase<br />
progettuale significherebbe<br />
ritornare a far riemergere i vecchi,<br />
ben conosciuti, problemi; la<br />
mancanza di trasparenza, i<br />
conflitti di interesse tra imprese,<br />
progettisti e stazioni appaltanti,<br />
senza nessun reale valore<br />
aggiunto per la velocizzazione<br />
delle procedure. Si ricordi, su<br />
questo, quanto disse l’ANAC due<br />
anni fa: le riserve nel 95% dei<br />
casi corrispondono alla virgola al<br />
ribasso offerto”.<br />
OICE.IT<br />
di circa 40 m. Lo scavo, riporta<br />
sempre il quotidiano, è stato<br />
avviato alla fine del luglio 2020,<br />
per concludersi il 30 marzo a<br />
Poggioreale. La macchina verrà<br />
ora rimontata nel cantiere di<br />
Capodichino per ripartire con la<br />
realizzazione della seconda<br />
galleria di collegamento alla<br />
Sigillatrici<br />
stradali<br />
Sealant melters / Fondoirs a mastic<br />
stazione di Poggioreale. Il termine<br />
delle operazioni di scavo della<br />
seconda galleria è previsto per la<br />
fine del <strong>2021</strong>. I lavori sono stati<br />
affidati mediante procedura di<br />
evidenza pubblica alla società<br />
Sinergo, che fa parte del<br />
Consorzio Integra.<br />
CONSORZIOINTEGRA.IT<br />
Via Buscate 6 - 20020 Magnago (MI) Italy<br />
www.eliaperoni.it e-mail: info@eliaperoni.it<br />
Tel. +39 0331 658090 - Fax. +39 0331 306430<br />
4/<strong>2021</strong>
18<br />
Infrastrutture<br />
e Recovery Plan<br />
Su quali infrastrutture investiremo<br />
per rilanciare il Paese? È intorno a<br />
questo interrogativo, di cruciale<br />
importanza per la ripartenza<br />
italiana, che istituzioni e key<br />
player si sono confrontati l’8 <strong>aprile</strong><br />
scorso in occasione del primo<br />
appuntamento dell’EY<br />
Summit sulle<br />
Infrastrutture <strong>2021</strong><br />
“Costruzioni e<br />
intermodalità”. In<br />
apertura è intervenuto<br />
anche il Ministro delle<br />
Infrastrutture e della<br />
Mobilità sostenibili, Enrico<br />
Giovannini. Ha commentato<br />
Massimo Antonelli, Regional<br />
Partner dell’area Mediterranea e<br />
CEO per l’Italia di EY (foto):<br />
“L’Italia si trova di fronte ad<br />
un’occasione senza precedenti. Le<br />
risorse del Recovery Plan e l’ampio<br />
consenso politico sulla necessità di<br />
trasformare il Paese fanno sì che<br />
oggi ci siano le condizioni ideali<br />
per rendere l’Italia ancora più<br />
attrattiva. Secondo l’indagine EY-<br />
SWG il Recovery Plan è infatti<br />
un’occasione fondamentale di<br />
rilancio per il Paese per il 71%<br />
degli intervistati, e le infrastrutture<br />
sono un tassello chiave per questa<br />
strategia e possono agire da<br />
moltiplicatore di investimento.<br />
Tutto questo passa da una riforma<br />
della Pubblica Amministrazione<br />
che permetta alle aziende di<br />
operare in tempi rapidi,<br />
instaurando così un clima di<br />
fiducia e proficua collaborazione<br />
tra operatori economici ed<br />
istituzioni pubbliche”. L’emergenza<br />
pandemica ha evidenziato<br />
ulteriormente l’importanza di<br />
avere infrastrutture efficienti. È<br />
quanto emerge anche dalla nuova<br />
indagine EY-SWG che ha coinvolto<br />
400 manager e dirigenti italiani,<br />
sul settore infrastrutturale, con un<br />
focus su Recovery Plan, mobilità<br />
sostenibile e smart city. L’indagine<br />
ha messo in evidenza come i<br />
manager italiani riconoscano alle<br />
infrastrutture un ruolo strategico<br />
per il futuro del Paese: il 97% è<br />
News Attualità<br />
infatti convinto che gli<br />
investimenti in questo<br />
settore a favore della<br />
mobilità siano essenziali<br />
per lo sviluppo<br />
economico e la competitività<br />
nazionale. Servono più<br />
investimenti, dunque, ma è<br />
fondamentale che questi siano<br />
indirizzati sulla base di un nuovo<br />
piano integrato per rinnovare la<br />
rete infrastrutturale capace di<br />
esprimere una visione di insieme<br />
delle priorità del Paese (95%). Per<br />
quanto riguarda le tipologie di<br />
infrastrutture, secondo i manager<br />
intervistati, dovremmo puntare<br />
come priorità su quelle digitali<br />
(71%) e sui sistemi integrati di<br />
mobilità metropolitana (50%),<br />
seguiti dall’alta velocità ferroviaria<br />
(43%) e le infrastrutture sanitarie<br />
(41%). Il Recovery Plan viene<br />
considerato da ben 7 manager su<br />
10 come un’occasione unica per<br />
dare un impulso alla crescita<br />
economica italiana, con priorità di<br />
destinazione dei fondi alla<br />
digitalizzazione della Pubblica<br />
Amministrazione (53%) e<br />
all’istruzione (49%), seguite dalle<br />
grandi opere infrastrutturali<br />
(46%). A proposito dei fondi<br />
europei, però, il 55% degli<br />
intervistati dello studio EY-SWG<br />
sostiene che ne sapremo utilizzare<br />
la maggior parte, evidenziando un<br />
generale ottimismo. Tuttavia,<br />
restano dubbi diffusi sulla nostra<br />
capacità di servirci al meglio delle<br />
risorse europee. Soltanto il 27%<br />
crede che investiremo la totalità<br />
dei fondi destinati all’Italia, mentre<br />
e il 18% afferma che ne<br />
impiegheremo meno della metà.<br />
Una delle motivazioni di questo<br />
scetticismo è dovuto ai processi<br />
burocratici del nostro Paese,<br />
considerati troppo lunghi e<br />
complessi. Per questo tra i benefici<br />
del Recovery Fund, secondo il<br />
64% dei manager, ci sarà la<br />
semplificazione del sistema<br />
burocratico e l’accelerazione delle<br />
procedure amministrative. Il<br />
Recovery Plan è indubbiamente un<br />
importante contributo economico<br />
per permettere la crescita del<br />
Paese, ma non può e non deve<br />
essere l’unico, motivo per cui è<br />
fondamentale aumentare<br />
l’attrattività delle infrastrutture<br />
italiane a livello nazionale ma<br />
anche internazionale. Secondo il<br />
78% degli intervistati, i fondi<br />
europei potranno rappresentare<br />
un volano per ulteriori investimenti<br />
privati, siano essi greenfield o<br />
brownfield. L’ammodernamento<br />
del sistema infrastrutturale<br />
italiano, però, passa soprattutto<br />
per l’adozione di innovativi modelli<br />
collaborativi capaci di instaurare<br />
una sinergia virtuosa tra le<br />
istituzioni e le imprese. Secondo<br />
l’83% dei dirigenti italiani per<br />
progettare le nuove opere<br />
strategiche sarà infatti necessario<br />
ripensare ai sistemi di<br />
finanziamento aprendo al settore<br />
privato e a contratti di appalto che<br />
prevedano anche la gestione<br />
dell’infrastruttura. Al centro degli<br />
investimenti europei ci sono<br />
soprattutto le infrastrutture<br />
per la mobilità che, ad opinione<br />
dei manager, dovrebbero<br />
privilegiare la sostenibilità<br />
ambientale (secondo il 53%) e<br />
migliorare il collegamento centroperiferie<br />
(45%).<br />
EY.COM<br />
Grande opera<br />
sulla Napoli-Bari<br />
Nell’ambito della realizzazione<br />
della linea ad alta velocitàcapacità<br />
Napoli-Bari, opera<br />
commissionata da Rete<br />
Ferroviaria Italiana (Gruppo FS<br />
Italiane), a cura di Webuild è<br />
stato installato, nel comune di<br />
Acerra, il primo dei tre ponti ad<br />
arco della tratta Napoli-<br />
Cancello, progettata da Italferr<br />
(Gruppo FS Italiane). La linea<br />
ferroviaria Napoli-Bari punta a<br />
diventare un asse strategico<br />
per lo sviluppo della mobilità<br />
sostenibile nel Sud Italia, con<br />
tempi di percorrenza quasi<br />
dimezzati tra Napoli e Bari,<br />
collegate in sole due ore, e<br />
permetterà inoltre di<br />
avvicinare Nord e Sud, con la<br />
previsione di un viaggio da<br />
Milano a Bari in sei ore. Ma la<br />
realizzazione della nuova linea<br />
si afferma anche come volano<br />
di sviluppo economico ed<br />
occupazionale nell’area: le due<br />
tratte a cui sta lavorando<br />
Webuild - la Napoli-Cancello e<br />
la Apice-Hirpinia - vedono oggi<br />
all’opera 600 persone,<br />
destinate a diventare 930<br />
entro il 2022. Personale a cui<br />
si aggiunge una lunga filiera di<br />
fornitori, che sulla sola tratta<br />
Napoli-Cancello è<br />
rappresentata da ben trecento<br />
aziende italiane di cui ben 183<br />
del Sud. Il ponte installato,<br />
come gli altri due che saranno<br />
posizionati nei prossimi mesi,<br />
ha un peso di 2.500 tonnellate<br />
ed è lungo circa 80 metri con<br />
un’altezza di 21 metri. Dopo<br />
una serie di attività preliminari<br />
per la sistemazione dell’asse<br />
stradale, il ponte, con<br />
un’operazione durata circa 10<br />
ore, è stato preso in carico da<br />
18 speciali carrelloni, che<br />
complessivamente hanno<br />
distribuito il peso su 104 assi<br />
gommati, per essere poi issato<br />
a circa 6 metri da terra tramite<br />
torri di sollevamento (strand<br />
jack). La tratta Napoli Cancello<br />
in cui è stato posizionato il<br />
viadotto consentirà di portare i<br />
binari della linea a servizio<br />
della stazione AV di Napoli-<br />
Afragola, costruita dalla società<br />
Astaldi parte del Gruppo<br />
Webuild, stazione che una<br />
volta operativa diventerà hub<br />
per l’interscambio passeggeri<br />
tra i servizi regionali e AV. Il<br />
tracciato si articola per circa<br />
15,5 km nei territori di<br />
Casoria, Casalnuovo, Afragola,<br />
Caivano e Acerra. La seconda<br />
tratta della linea in<br />
costruzione, Apice-Hirpinia,<br />
invece, supera i 18 chilometri e<br />
prevede l’attraversamento<br />
dell’Appennino e la<br />
realizzazione della stazione<br />
intermedia di Hirpinia. Nel<br />
progetto rientra la costruzione<br />
di tre gallerie naturali e quattro<br />
viadotti in un contesto molto<br />
complesso dal punto di vista<br />
paesaggistico.<br />
WEBUILDGROUP.COM<br />
DAL 1985<br />
PRODUZIONE<br />
E DISTRIBUZIONE<br />
DI PRODOTTI RELATIVI<br />
ALLA SICUREZZA STRADALE,<br />
PER IL MERCATO ITALIANO,<br />
EUROPEO ED INTERNAZIONALE.<br />
SEGNALETICA<br />
VERTICALE<br />
LUMINOSA<br />
COMPLEMENTARE<br />
ORIZZONTALE<br />
FERROVIARIA<br />
ATTENUATORI D’URTO<br />
TMA & TTMA<br />
BARRIERE STRADALI E VARCHI<br />
NASTRI RIFRANGENTI<br />
PREALUX s.r.l. via Angeretti 30<br />
24055 Cologno al Serio (Bg) - Italia<br />
t. +39 035 36.25.10 - f. +39 035 36.25.04<br />
info@prealux.it - www.prealux.it<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade
20<br />
21LS<br />
Pavimentazioni<br />
e sostenibilità<br />
Mapei, tra i leader mondiali nei<br />
prodotti chimici per l’edilizia e<br />
Iren, una delle più importanti e<br />
dinamiche multiutility del<br />
panorama italiano, hanno siglato<br />
un accordo che prevede l’utilizzo di<br />
polimeri termoplastici, provenienti<br />
da processi innovativi di riciclo per<br />
la realizzazione di pavimentazioni<br />
stradali più durature e sostenibili.<br />
Il progetto, gestito da Iren<br />
attraverso la controllata I.Blu,<br />
principale operatore nazionale nel<br />
settore della selezione e riciclo dei<br />
rifiuti di imballaggio in plastica da<br />
raccolta differenziata, rappresenta<br />
un esempio virtuoso di economia<br />
circolare ed ha come obiettivo<br />
l’implementazione di una<br />
tecnologia innovativa, che<br />
permette di ottenere un<br />
significativo aumento della vita<br />
utile delle pavimentazioni stradali.<br />
L’accordo, che per la prima volta<br />
vede collaborare in modo diretto<br />
News<br />
una multiutility e un’azienda<br />
produttrice, entrambe fortemente<br />
impegnate a favorire la<br />
sostenibilità nei rispettivi ambiti di<br />
attività, ha una valenza sia<br />
commerciale che di innovazione.<br />
Mapei si impegna, infatti, a<br />
proporre questa nuova tecnologia<br />
sostenibile per la produzione di<br />
conglomerati bituminosi destinati<br />
alla realizzazione delle<br />
pavimentazioni stradali, utilizzando<br />
tecnopolimeri sviluppati da Mapei<br />
congiuntamente con Iren, tramite<br />
la controllata I.Blu. Test congiunti,<br />
realizzati anche con il supporto del<br />
Laboratorio Stradale del Politecnico<br />
di Milano, hanno consentito di<br />
individuare le formulazioni che,<br />
grazie all’utilizzo di questi additivi,<br />
portano alla realizzazione di asfalti<br />
più sostenibili e duraturi<br />
particolarmente adatti a strade,<br />
autostrade, aree industriali,<br />
aeroporti, centri logistici e<br />
commerciali. I conglomerati<br />
bituminosi (asfalti) additivati con<br />
Prodotti<br />
questi tecnopolimeri conferiscono,<br />
infatti, alle pavimentazioni, a<br />
parità di spessore, un aumento<br />
significativo della vita utile con<br />
conseguente riduzione dei costi di<br />
manutenzione e una resistenza<br />
alla deformazione permanente<br />
dovuta al carico d’esercizio.<br />
Incrementano anche le resistenze<br />
alle escursioni termiche ed ai raggi<br />
UVA, determinando meno degradi<br />
superficiali e riducendo così i<br />
rischi, in particolare, per cicli e<br />
motocicli. Negli anni che hanno<br />
preceduto l’accordo, grazie alla<br />
collaborazione tra Mapei e I.Blu,<br />
sono state realizzate le<br />
pavimentazioni di alcuni tra i<br />
principali scali aeroportuali del<br />
territorio nazionale che hanno<br />
confermato la validità della<br />
tecnologia. “Questo accordo<br />
assume una valenza particolare<br />
nell’ambito delle nuove tecnologie<br />
che permetteranno di allungare la<br />
vita utile delle pavimentazioni e<br />
ridurne il deterioramento - dichiara<br />
Marco Squinzi, Amministratore<br />
Delegato Mapei -. Mapei crede<br />
fortemente nello sviluppo di<br />
questo mercato ed ha<br />
recentemente creato la nuova<br />
linea Road Engineering dedicata<br />
proprio alle tecnologie e soluzioni<br />
per tutto quello che è il mondo dei<br />
conglomerati bituminosi, dalle<br />
grandi opere alle strade comunali<br />
o provinciali. L’economia circolare<br />
implica anche la ricerca di<br />
durabilità. L’utilizzo di tecnologie<br />
innovative per interventi più<br />
risolutivi e più duraturi per<br />
estendere la vita delle strutture,<br />
sia nel nuovo che nel ripristino,<br />
deve diventare un impegno<br />
condiviso nell’ambito delle<br />
infrastrutture e dell’edilizia. Il fatto<br />
che questo si possa ottenere<br />
grazie all’utilizzo di materie prime<br />
seconde, aggiunge valore al<br />
progetto che si inserisce appieno<br />
nella scelta di Mapei di fare della<br />
sostenibilità un pilastro della<br />
propria attività”. “L’accordo<br />
stipulato con Mapei - afferma<br />
l’Amministratore Delegato di Iren<br />
Massimiliano Bianco - interpreta<br />
perfettamente il nostro concetto di<br />
multicircle economy, la nostra<br />
visione industriale a lungo termine<br />
focalizzata sull’uso consapevole ed<br />
efficiente delle risorse”.<br />
MAPEI.COM<br />
GRUPPOIREN.IT<br />
Engineering<br />
in crescita<br />
Il CdA di Fagioli ha approvato il<br />
bilancio relativo all’esercizio 2020<br />
e il consolidato del Gruppo. Nel<br />
2020 il Gruppo ha proseguito la<br />
propria crescita registrando ricavi<br />
pari a 202,7 milioni di euro<br />
(+4,3% rispetto ai 194,3 milioni<br />
di euro al 31 dicembre 2019), il<br />
più alto valore raggiunto dal<br />
2000. La percentuale dei ricavi<br />
all’estero si attesta tra l’80 e<br />
l’85% del volume complessivo<br />
delle attività, di cui circa il 35%<br />
nel mercato nordamericano. Al 31<br />
dicembre 2020 l’EBITDA del<br />
Gruppo è pari a 24,0 milioni di<br />
euro, in crescita del 6,4% rispetto<br />
al 2019. Tali risultati sono dovuti a<br />
una buona performance<br />
trasversale con picchi nelle<br />
business unit Americas, APAC e<br />
Project Forwarding. L’EBIT è<br />
risultato pari a 14,1 milioni di<br />
euro, in crescita del 29,9%<br />
rispetto all’esercizio 2019. Al 31<br />
dicembre 2020 il risultato netto<br />
consolidato è pari a 7,2 milioni di<br />
euro, in forte crescita sul 2019<br />
(+21,4%). Il portafoglio ordini al<br />
31 marzo <strong>2021</strong> si attesta a circa<br />
180 milioni di euro, un valore<br />
superiore alla media degli ultimi<br />
anni. “I risultati ottenuti nel 2020<br />
- dichiara Fabio Belli,<br />
Amministratore Delegato Fagioli<br />
- confermano il trend di crescita<br />
del Gruppo Fagioli registrato negli<br />
ultimi anni, un risultato<br />
significativo considerando l’anno<br />
di grande complessità a causa<br />
della pandemia Covid-19”. “Per il<br />
<strong>2021</strong> - prosegue Belli - ci<br />
attendiamo risultati in linea con<br />
gli anni precedenti, proseguendo<br />
nella diversificazione del business<br />
e puntando in modo deciso sui<br />
settori gas naturale, energie<br />
rinnovabili e infrastrutture”. “I<br />
risultati del bilancio 2020 -<br />
aggiunge Rocco Sabelli,<br />
Presidente Fagioli - sono il frutto<br />
dell’impegno dei nostri oltre 500<br />
addetti impegnati nelle 17 società<br />
operative nel mondo: al<br />
management e a tutti loro vanno<br />
l'apprezzamento ed il<br />
ringraziamento mio, dell'intero<br />
Consiglio di Amministrazione e<br />
degli Azionisti”. Fagioli pone<br />
grande attenzione alla<br />
salvaguardia della salute dei<br />
propri dipendenti e a tutte le<br />
tematiche ESG (Environment,<br />
Social and Governance). Per far<br />
fronte all’emergenza sanitaria<br />
Covid-19, sono state prontamente<br />
messe in atto numerose misure e<br />
procedure di prevenzione e<br />
protezione che hanno permesso di<br />
limitare l’impatto della pandemia,<br />
garantendo allo stesso tempo la<br />
continuità di tutte le attività in<br />
ogni parte del mondo. In tema di<br />
sostenibilità, da sempre parte<br />
integrante del modello di business<br />
di Fagioli, si segnala nel corso del<br />
2020 l’adozione di un sistema di<br />
monitoring e reporting in linea<br />
con gli standard internazionali<br />
ESG. Nel 2020 il Gruppo Fagioli si<br />
è inoltre aggiudicato tre tra i più<br />
ambiti riconoscimenti<br />
internazionali del settore trasporti<br />
e sollevamenti eccezionali, per il<br />
contributo fornito in importanti<br />
progetti tra cui la demolizione del<br />
Ponte Morandi di Genova. Nel<br />
corso del CdA il Presidente e i<br />
consiglieri hanno ricordato con<br />
stima e affetto la figura di<br />
Alessandro Fagioli, fondatore ed<br />
ex Presidente del Gruppo,<br />
scomparso il 22 marzo 2020.<br />
FAGIOLI.COM<br />
News Prodotti<br />
News Prodotti<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
roxtec.com/it
22<br />
23LS<br />
Ingegneria 4.0<br />
in streaming<br />
Da uno dei centri nazionali nel<br />
campo dello sviluppo di<br />
software per i progettisti delle<br />
costruzioni e delle<br />
infrastrutture, CSP Fea, è<br />
arrivata una proposta<br />
convegnistica peculiare, che ha<br />
puntato dritto ai grandi topic e<br />
trend del settore AEC<br />
Architecture Engineering<br />
Construction, il Forum<br />
Ingegneria 4.0 (trasmesso il 16<br />
<strong>aprile</strong> in streaming dall’Infinite<br />
Area di Montebelluna, Treviso).<br />
Lo spirito è stato pionieristico,<br />
l’asticella molto alta: da un lato<br />
valorizzare il design nostrano<br />
facendolo entrare di diritto<br />
nella cornice di Industria 4.0,<br />
seguendo le orme di quanto si<br />
sta delineando nei contesti<br />
News<br />
MOVYON; Francesca<br />
Federzoni, Presidente<br />
Politecnica; Fabrizio<br />
Mazzacurati, Direttore<br />
Ingegneria Heratech; Franco<br />
Guidi, Partner CEO Lombardini<br />
22; Giulio De Carli, Founder &<br />
Managing Partner One Works;<br />
Fabio Tradigo, ARUP, Paolo<br />
Segala, CEO CSPFea; Luigi<br />
Griggio, CEO FEA Engineering.<br />
Presente e futuro<br />
dell’engineering, modelli di<br />
gestione, prospettive di<br />
mercato, digitalizzazione, ma<br />
anche cruciali questioni<br />
tecniche (e non solo) come la<br />
internazionali più avanzati (un<br />
esempio è il piano tedesco<br />
Infrastructure 4.0). Dall’altro,<br />
mettere sotto i riflettori una<br />
serie di temi chiave, di assoluto<br />
interesse per ingegneri,<br />
architetti, impiantisti e<br />
moltissime altre figure<br />
specialistiche, dalle smart road<br />
ai big data. In prima battuta, si<br />
è entrati nel vivo della cultura<br />
d’impresa dei player invitati a<br />
raccontarsi, attraverso la voce<br />
dei loro numeri uno. Nello<br />
specifico, come ha raccontato a<br />
leStrade Paolo Segala, che con<br />
Luigi Griggio è a capo di CSP<br />
Fea, abbiamo affrontato “il<br />
tema della gestione di società<br />
di servizi con centinaia di<br />
dipendenti nella maggior parte<br />
dei casi esperti nel campo<br />
dell’engineering. Quindi<br />
accenderemo i riflettori sui<br />
trend di mercato del prossimo<br />
decennio con un riferimento<br />
particolare al piano Next<br />
Generation EU. Infine, spazio ai<br />
grandi contenitori tematici di<br />
innovazione pura, nel segno<br />
della digitalizzazione, dal BIM<br />
all’Intelligenza Artificiale,<br />
all’Internet of Things”. Il Forum<br />
Ingegneria 4.0 - a iscrizione<br />
gratuita - ha visto la<br />
partecipazione di testimonial di<br />
spicco, impegnati ad<br />
approfondire le questioni<br />
tecnologiche chiave e<br />
potenzialmente disruptive di<br />
cui sopra. Ecco i protagonisti<br />
della giornata: Francesco De<br />
Bettin, Presidente DBA Group;<br />
Gabriele Scicolone, AD Artelia<br />
Italia; Silvia Furlan, AD NET<br />
Engineering; Lorenzo Rossi AD<br />
messa in sicurezza del nostro<br />
patrimonio edile e<br />
infrastrutturale. Tutto quanto<br />
narrato nella mattinata del 16<br />
<strong>aprile</strong> è diventato argomento<br />
di dibattito e confronto anche<br />
nella tavola rotonda del<br />
pomeriggio, moderata da<br />
Fabrizio Apostolo, direttore<br />
editoriale di leStrade, che è<br />
anche media partner<br />
dell'iniziativa. Tra i partecipanti<br />
alla discussione, oltre ai<br />
relatori citati, anche Paolo<br />
Cucino, CEO SWS Engineering;<br />
Stefano Tortella, Socio e<br />
Direttore Tecnico AEGIS<br />
Cantarelli & Partners; Andrea<br />
Barocci, Socio Fondatore IDS<br />
Ingegneria delle Strutture;<br />
Fabio Croccolo, Direttore<br />
Generale ANSFISA.<br />
CSPFEA.NET<br />
Convegni<br />
Ancora cambio data<br />
per Asphaltica <strong>2021</strong><br />
Nel <strong>2021</strong> debutta un nuovo polo<br />
fieristico dedicato interamente<br />
alla filiera stradale: dalle<br />
infrastrutture, alla distribuzione<br />
dei carburanti fino ai servizi per<br />
la mobilità. Da mercoledì 24 a<br />
venerdì 26 novembre, infatti,<br />
Asphaltica e Oil&nonOil si<br />
terranno in contemporanea alla<br />
Fiera di Verona. Due<br />
manifestazioni, entrambe<br />
riferimento per i rispettivi<br />
settori, per la prima volta in<br />
calendario insieme a Verona con<br />
l’obiettivo di creare nuove<br />
sinergie, allargando e<br />
completando l’offerta<br />
merceologica. “Le due rassegne<br />
- spiega Giovanni Mantovani,<br />
direttore generale di Veronafiere<br />
- rappresentano da sempre<br />
settori affini e complementari e<br />
riunirle nelle stesse date<br />
costituirà un sicuro valore<br />
aggiunto per imprese e<br />
operatori, grazie a nuove<br />
opportunità di business. Si<br />
tratta di una offerta che<br />
puntiamo a sviluppare sempre<br />
più, con la creazione di un vero<br />
e proprio polo nazionale di<br />
riferimento per il futuro delle<br />
smart road”. Asphaltica<br />
rappresenta oggi il principale<br />
salone nazionale per tecnologie<br />
e soluzioni per pavimentazioni<br />
stradali, sicurezza e<br />
infrastrutture.<br />
Ad organizzarlo sono<br />
Veronafiere e SITEB- Strade<br />
Italiane e Bitumi. Al fianco di<br />
Asphaltica, nel <strong>2021</strong>, ci sarà<br />
Oil&nonOil, rassegna che porta<br />
dal 2012 a Veronafiere il mondo<br />
della rete distributiva e di<br />
stoccaggio dei carburanti, delle<br />
stazioni di servizio, con uno<br />
sguardo sul futuro delle nuove<br />
energie e della mobilità<br />
alternativa. Programmata in<br />
precedenza quest’anno come<br />
mostra-convegno a Roma,<br />
Oil&nonOil si propone invece per<br />
questa edizione nel quartiere<br />
fieristico veronese: soluzione<br />
ideale per garantire la massima<br />
sicurezza di espositori e<br />
visitatori. I due eventi di<br />
novembre saranno caratterizzati<br />
da una formula in presenza.<br />
Questo grazie ai protocolli<br />
safetybusiness attivati dalla<br />
Fiera di Verona, validati da<br />
Comitato tecnico scientifico,<br />
autorità sanitarie e AEFI<br />
(l’associazione nazionale degli<br />
organizzatori fieristici), e già<br />
collaudati con successo proprio<br />
in occasione di Oil&nonOil 2020.<br />
Stand espostivi, macchine e<br />
attrezzature troveranno posto<br />
nei moderni padiglioni 11 e 12<br />
di Veronafiere, con accesso dalla<br />
porta Re Teodorico, valorizzata<br />
dalle nuove strutture e dalla<br />
recente riqualificazione.<br />
ASPHALTICA.IT<br />
OILNONOIL.IT<br />
News Convegni<br />
News Convegni<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade
24<br />
Agenda<br />
<strong>2021</strong><br />
Convegni, Corsi, Eventi<br />
APRILE<br />
Forum Ingegneria 4.0<br />
16 Aprile <strong>2021</strong><br />
In streaming da<br />
Montebelluna (TV)<br />
CSPFEA.NET<br />
Presentazione<br />
Relazione 2020 ANSFISA<br />
29 Aprile <strong>2021</strong><br />
FERROVIE.ACADEMY<br />
MAGGIO<br />
Kick-off Bauma<br />
Innovation Award 2022<br />
3 Maggio <strong>2021</strong><br />
BAUMA-INNOVATIONSPREIS.DE<br />
Segnaletica stradale:<br />
i problemi del presente<br />
e le sfide del futuro<br />
8 Maggio <strong>2021</strong><br />
Evento Online<br />
AIPSS.IT<br />
GIUGNO<br />
Transpotec Logitec<br />
10-13 Giugno <strong>2021</strong><br />
Milano<br />
TRANSPOTEC.COM<br />
E&E Congress<br />
15-17 Giugno <strong>2021</strong><br />
Edizione virtuale<br />
EECONGRESS<strong>2021</strong>.ORG<br />
SETTEMBRE<br />
Geofluid<br />
15-18 Settembre <strong>2021</strong><br />
Piacenza<br />
GEOFLUID.IT<br />
OTTOBRE<br />
Ecomondo<br />
26-29 Ottobre <strong>2021</strong><br />
Rimini<br />
ECOMONDO.IT<br />
NOVEMBRE<br />
TRAFIC <strong>2021</strong><br />
2-4 Novembre <strong>2021</strong><br />
Madrid (Spagna)<br />
IFEMA.ES/TRAFIC<br />
4 th Construction<br />
Equipment Forum<br />
Berlin <strong>2021</strong><br />
3-4 Novembre <strong>2021</strong><br />
Berlino (Germania)<br />
CONSTRUCTIONFORUM.EU<br />
IRF World Meeting<br />
7-10 Novembre <strong>2021</strong><br />
Dubai (EAU)<br />
WORLDMEETING.IRF.GLOBAL<br />
Asphaltica<br />
24-26 Novembre <strong>2021</strong><br />
Verona<br />
In concomitanza<br />
con Oil&nonOil<br />
ASPHALTICA.IT<br />
© Anas SpA
LS<br />
INFRASTRUTTURE<br />
&MOBILITÀ<br />
INFRASTRUTTURE<br />
n La sfida possibile dei Servizi Ecosistemici<br />
STRADE<br />
n Concentrato di buona tecnica<br />
n Green technology italo-francese<br />
FERROVIE<br />
n La ferrovia vista dal cielo<br />
n Link epocale tra due stazioni<br />
MOBILITÀ&TRAFFICO<br />
n Veicoli autonomi e responsabilità
28<br />
29<br />
LS<br />
Progettazione Ecosostenibile<br />
La sfida possibile<br />
dei Servizi Ecosistemici<br />
NON SOLO GESTIONE TERRITORIALE, MA ANCHE, PARALLELAMENTE, TUTELA<br />
DELLE BIODIVERSITÀ. PER FAR SÌ CHE LE INFRASTRUTTURE SORGANO TENENDO<br />
CONTO DEL “BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO” IN CUI SI VANNO A INSERIRE<br />
RAGGIUNGENDO L’OBIETTIVO DEL “CONSUMO ZERO”. OGGI, QUESTO APPROCCIO<br />
INNOVATIVO È POSSIBILE, GRAZIE A METODOLOGIE AD HOC E CASI SCUOLA.<br />
COME CI SPIEGANO NEL DETTAGLIO GLI AUTORI DI QUESTO CONTRIBUTO.<br />
Dalla nascita delle evidenze ambientali nel campo delle<br />
opere pubbliche, più o meno coincidente con l’istituzione<br />
del Ministero dell’Ambiente, abbiamo usato diverse<br />
forme per voler dire che il progetto deve essere più “ricco”<br />
dal punto di vista del rapporto tra le opere e l’ambiente.<br />
Si è usata la parola “progettazione integrata”, poi ci si è spostati<br />
alla “sostenibilità ambientale” e via dicendo. Oggi abbiamo<br />
assistito alla trasformazione del Ministero dell’Ambiente<br />
in quello della Transizione ecologica e, oltre a una perdita affettiva<br />
per noi che da tanti anni avevamo il MATTM come un<br />
riferimento centrale, ci dobbiamo chiedere cosa significa tutto<br />
ciò. In queste note, oltre a voler cogliere e raccogliere lo<br />
stimolo della costituzione del MiTE, vorremmo porre alla riflessione<br />
del settore delle infrastrutture quanto abbiamo maturato<br />
nel nostro spirito di innovazione e di ricerca del miglioramento<br />
del contributo progettuale. Infatti, se si va a vedere<br />
il mondo accademico (e non solo) è andato molto avanti nel<br />
definire e caratterizzare il settore dell’Ecosostenibilità; oggi<br />
ci sono molti strumenti sia concettuali che previsionali o realizzativi<br />
che possono supportare la “Progettazione” con la “P”<br />
maiuscola e contribuire veramente al passaggio necessario<br />
per rendere le opere di ingegneria ambientalmente compatibili.<br />
Ma questo vuol dire un aggiornamento non solo del paradigma<br />
progettuale, ma anche del “peso” da dare ai diversi<br />
elementi che si pongono alla base della ideazione e realizzazione<br />
di un’opera, ivi inclusi i suoi costi. Non si riesce più a<br />
gestire l’ambiente con costi invariati e, a parere di chi scrive,<br />
giustamente a patto di mantenere l’equilibrio costi-benefici<br />
ovvero considerare che i costi incrementali sono un “investimento<br />
green” i cui effetti si hanno nel tempo e sono da afferire<br />
a un vero e proprio beneficio sociale. Gli aspetti che vanno<br />
secondo questa linea sono molteplici ma in questa sede<br />
ci si vuole soffermare solo su un settore di indagine legato<br />
al consumo di suolo e al ruolo che esso assume nel supportare<br />
quello che va sotto il nome di Servizi Ecosistemici. Dapprima,<br />
quindi, la riflessione sarà sul tema “consumo di suolo”.<br />
Molto si è detto su tale argomento, ma un progettista di<br />
infrastrutture per lo più liquida il tema con frasi del genere:<br />
“Non posso allargare una strada senza usare nuovi territori!<br />
Un insediamento produttivo ha necessità dei suoi spazi!”.<br />
E via dicendo. Sacrosanta affermazione, ovviamente dopo<br />
che se ne è verificata e dimostrata la necessità e l’ottimizzazione<br />
della soluzione, ma non è proprio questo il modo corretto<br />
di affrontare la tematica. Nel seguito proveremo a dare<br />
degli spunti per come l’abbiamo capita e vorremmo svilupparla,<br />
non ultimo con un’implementazione reale anche negli<br />
studi di impatto ambientale.<br />
Il progetto: infrastruttura<br />
e patrimonio del territorio<br />
Interessante a tal riguardo è la Legge n.31/14 della Regione<br />
Lombardia con la quale viene introdotto il Bilancio Ecologico<br />
del Suolo (BES) come “differenza tra la superficie agricola<br />
che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti<br />
di governo del territorio, e la superficie urbanizzata e urbanizzabile<br />
che viene contestualmente ridestinata nel medesimo<br />
strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio<br />
ecologico del suolo è pari a zero, il consumo del suolo è pari<br />
a zero” (art. 2 comma 1 lettera d). Proseguendo su questo<br />
principio, viene proposto il metodo regionale STRAIN - STudio<br />
interdisciplinare sui RApporti tra protezione della natura<br />
ed INfrastrutture (DDG n. 4517/2007), che si pone l’obiettivo<br />
di una quantificazione delle aree da rinaturalizzare come<br />
compensazione a consumi di ambiente da parte di infrastrut-<br />
Mauro Di Prete<br />
Direttore Tecnico Istituto<br />
IRIDE<br />
Antonella Santilli<br />
Responsabile settore<br />
Valutazioni Ambientali<br />
Istituto IRIDE<br />
Daniela Silvestre<br />
Responsabile settore<br />
Valutazioni Ambientali<br />
Strategiche<br />
Istituto IRIDE<br />
1<br />
1. Funzioni ecosistemiche<br />
2. Livelli di applicazione<br />
del metodo STRAIN<br />
2<br />
ture di nuova realizzazione. L’obiettivo è quello di ricostruire<br />
le tipologie di unità ambientale sottratte, attraverso il ripristino<br />
delle funzioni ecologiche oggetto di trasformazione o di<br />
nuove attività. Da qui la prima interpretazione del passaggio<br />
logico di cui sopra. Occorre iniziare ad analizzare il “suolo” interessato<br />
dall’iniziativa in una logica più ampia e più legata ai<br />
principi della biodiversità piuttosto che di luoghi solo governati<br />
da indicazioni teoriche date dagli strumenti di gestione<br />
del territorio, chiave di lettura oggi molto più diffusa. L’attenzione<br />
a un vincolo, a una destinazione d’uso, a uno standard<br />
è certo dovuta, ma non basta in quanto dobbiamo porre l’attenzione<br />
alla sua funzione ecologica. Ne consegue la proposta:<br />
implementare la soluzione di progetto per dar conto di<br />
questo bilancio. Il progetto va considerato necessariamente<br />
diviso in due filoni atti a dar conto dell’opera come infrastruttura<br />
e dell’opera come patrimonio del territorio. Il primo<br />
rientra nella più classica azione progettuale che ad oggi<br />
è ormai implementata con alcuni puntuali approfondimenti<br />
anche di natura ambientale per lo più finalizzati al rispetto<br />
di norme di settore (dal rumore all’inquinamento atmosferico,<br />
dai bilanci dei materiali al riutilizzo di sottoprodotti,<br />
ecc.) mentre il secondo è tutto da sviluppare. Alcuni esempi<br />
ci sono ma sono senz’altro casi sporadici o legati ad Amministrazioni/Progettisti<br />
illuminati. L’opera come patrimonio<br />
del territorio pone almeno due questioni: come determinare<br />
gli input di questa parte del progetto e, non meno importante,<br />
come definire gli ambiti di intervento e la disponibilità di<br />
luoghi in cui poter intervenire. In merito ai primi, le logiche<br />
di lavoro sono molteplici e le relative chiavi di letture altrettanto,<br />
ma l’esperienza maturata dall’Istituto IRIDE ha messo<br />
in evidenza che certamente un aiuto in tale direzione può<br />
essere fornita dall’applicazione della logica dei Servizi Ecosistemici.<br />
Un’ultima precisazione in termini generali è relativa<br />
al fatto che questi ultimi riguardano un ampio spettro di elementi<br />
che concorrono all’obiettivo finale per i quali vengono<br />
considerati, ma in questa sede si pone l’attenzione a quel<br />
sottogruppo che permette di implementare nel progetto il bilancio<br />
ecologico del suolo.<br />
Suolo, lo sviluppo<br />
di un bilancio ecologico<br />
A partire dalla definizione di “Bilancio Ecologico del Suolo”<br />
(BES) fornita dalla legge regionale lombarda e in particolare<br />
dallo stretto rapporto tra il bilancio ecologico del suolo<br />
e il consumo di suolo risulta evidente come le modifiche<br />
apportate al territorio per opera dall’uomo ne determinino<br />
un’evidente modifica. La trasformazione del suolo è spesso<br />
funzione di esigenze progettuali, ma non necessariamente<br />
corrisponde ad un consumo di suolo vero e proprio. Infatti,<br />
nell’ambito della progettazione ciò a cui si vuole tendere<br />
è garantire allo stesso tempo le esigenze infrastrutturali<br />
e quelle territoriali, nel rispetto e salvaguardia dell’uomo<br />
e dell’ambiente. Secondo tale logica si vuole orientare la<br />
progettazione verso un bilancio ecologico del suolo quanto<br />
meno nullo, se non positivo, in modo tale che il suolo sottratto<br />
o trasformato dal progetto infrastrutturale venga restituito<br />
attraverso interventi che incrementino il valore ecologico<br />
nell’ambito dello stesso progetto. Questo “modo di<br />
progettare” tende a traguardare quanto previsto dalla Commissione<br />
europea di giungere entro il 2050 ad una occupazione<br />
netta di suolo pari a zero (consumo zero). In tale ottica<br />
la progettazione deve essere orientata a garantire un<br />
riequilibrio ecosistemico che necessita di una quantificazione<br />
del valore ecologico sia attualmente presente sia di nuova<br />
realizzazione. In tale sede si può fare riferimento al metodo<br />
STRAIN, il quale si pone come obiettivo quello di una<br />
quantificazione delle aree da rinaturalizzare in modo da bilanciare<br />
il consumo di suolo da parte di infrastrutture di nuova<br />
realizzazione. Attraverso l’applicazione di tale metodo,<br />
la cui logica potrebbe essere estesa a ulteriori ambiti territoriali,<br />
è possibile garantire nell’ambito della progettazione<br />
infrastrutturale un bilancio ecologico del suolo attraverso<br />
lo studio delle funzioni ecologiche del territorio attuale<br />
e di quelle previste dal progetto. Si evidenzia come le modalità<br />
di applicazione del metodo siano differenti in funzione<br />
dei livelli di approfondimento del percorso progettuale e<br />
della procedura ambientale di riferimento. Si distinguono 4<br />
livelli di applicazione come riportati in fig. 2.<br />
Infrastrutture<br />
Infrastrutture<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
30<br />
31<br />
LS<br />
3<br />
3. Logica del metodo di<br />
quantificazione del Bilancio<br />
Ecologico del Suolo<br />
4 Servizi Ecosistemici<br />
stimabili con SimulSoil<br />
5<br />
Infrastrutture<br />
4<br />
Qualunque sia il livello di applicazione scelto, all’interno del<br />
processo di bilanciamento del valore ecologico del suolo l’obiettivo<br />
è quello di ricostruire le tipologie di unità ambientali<br />
interessate dalle opere in progetto. Il metodo non fornisce<br />
indicazioni di validità generale sulla scelta delle tipologie di<br />
unità ambientali da realizzare o riqualificare ma la scelta è<br />
di tipo progettuale. Si potrà procedere con il ripristino delle<br />
specie esistenti interessate dalle nuove opere oppure traguardare<br />
porzioni anche differenti ma ecologicamente connesse<br />
purchè sia sempre volta alla salvaguardia del territorio<br />
in cui il progetto infrastrutturale si inserisce, in modo<br />
da conservare o potenziare le funzioni ecologiche dell’area.<br />
Dal punto di vista operativo, il metodo STRAIN prevede i seguenti<br />
passaggi (fig. 3):<br />
• Definizione delle aree di studio distinguendo l’area di progetto<br />
(A) da un’area esterna a quella di progetto (B), utilizzabile<br />
per gli interventi di naturalizzazione;<br />
• Rilevamento e valutazione delle unità ambientali presenti<br />
allo stato attuale in (A) e (B);<br />
• Definizione delle unità ambientali presenti allo stato futuro<br />
in (A) e (B);<br />
• Definizione delle tipologie di interventi previsti di rinaturalizzazione<br />
e incremento del valore ecologico del territorio<br />
al fine di ottenere un bilancio ecologico del suolo almeno<br />
pari a zero.<br />
Il modello di calcolo individua principalmente due grandezze<br />
rappresentative del Valore Ecologico specifico attribuibile<br />
all’area di studio nella sua configurazione attuale e al Valore<br />
Ecologico dell’area nella sua configurazione di progetto.<br />
Dall’applicazione del metodo è possibile ricavare in funzione<br />
della tipologia di aree interessate e della tipologia di interventi<br />
previsti la superficie minima su cui prevedere questi<br />
ultimi interventi al fine di ottenere un bilancio ecologico<br />
idoneo. Grazie, quindi, all’applicazione di un metodo come<br />
STRAIN, è possibile contribuire fattivamente nell’ambito della<br />
progettazione alla salvaguardia e conservazione del territorio<br />
inteso nel suo valore ecologico. In tal modo si cerca<br />
sempre più di racchiudere in un unico momento lo sviluppo<br />
tecnologico proposto dalle iniziative progettuali ed un’attenzione<br />
volta al territorio e alla salute dell’uomo. In altre parole,<br />
con l’implementazione nel progetto del bilancio ecologico<br />
del suolo, il suolo stesso viene nel suo complesso trasformato<br />
ma non consumato, grazie ad un bilanciamento ecologico<br />
che fa sì che ad un’occupazione di suolo corrisponda<br />
una azione di riequilibrio di altro suolo che nel corso del<br />
tempo ha perso la sua funzione naturale.<br />
Un caso applicativo<br />
di servizi ecosistemici<br />
La definizione dei Servizi Ecosistemici in termini quantitativi<br />
ed economici è un tema ampio e complesso in quanto<br />
intervengono diversi e differenti fattori, tra i quali la scaladi<br />
riferimento (ampiezza della porzione di territorio considerata)<br />
e la disponibilità di dati che caratterizzano il territorio<br />
in studio. Considerando che le funzioni ecosistemiche<br />
vengono definite come la capacità dei processi e dei componenti<br />
naturali di fornire beni e servizi che soddisfino, direttamente<br />
o indirettamente, le necessità dell’uomo e garantiscano<br />
la vita di tutte le specie, si può far riferimento al<br />
Millennium Ecosystem Assessment (cfr. life+mgn) ove è indicata<br />
un’ampia e approfondita sistematizzazione delle conoscenze<br />
fino ad oggi acquisite sullo stato degli ecosistemi<br />
del mondo. Questa ha fornito una classificazione utile suddividendo<br />
le funzioni ecosistemiche in 4 categorie principali:<br />
• Supporto alla vita (Supporting): queste funzioni raccolgono<br />
tutti quei servizi necessari per la produzione di tutti gli altri<br />
5 Classi di uso del suolo<br />
(software SimulSoil)<br />
1. Sviluppato nell’ambito del progetto Life<br />
Sam4cp (Soil Administration Model For<br />
Community Profit), finanziato nel quadro<br />
del programma LIFE + (2007-2013 Environment).<br />
Capofila: Città metropolitana di<br />
Torino; Partner: ISPRA Istituto Superiore<br />
per la Protezione e la Ricerca Ambientale,<br />
CSI Piemonte Consorzio per il Sistema<br />
Informativo, Politecnico di Torino -<br />
Dipartimento Interateneo di Scienze Progetto<br />
e Politiche del Territorio, CREA - Consiglio<br />
per la ricerca in agricoltura e l’analisi<br />
dell’economia agraria.<br />
servizi ecosistemici e contribuisce alla conservazione (in situ)<br />
della diversità biologica e genetica e dei processi evolutivi.<br />
• Regolazione (Regulating): oltre al mantenimento della salute<br />
e del funzionamento degli ecosistemi, le funzioni regolative<br />
raccolgono molti altri servizi che comportano benefici<br />
diretti e indiretti per l’uomo (come la stabilizzazione del<br />
clima, il riciclo dei rifiuti), solitamente non riconosciuti fino<br />
al momento in cui non vengono persi o degradati;<br />
• Approvvigionamento (Provisioning): queste funzioni raccolgono<br />
tutti quei servizi di fornitura di risorse che gli ecosistemi naturali<br />
e semi-naturali producono (ossigeno, acqua, cibo, ecc.).<br />
• Culturali (Cultural): gli ecosistemi naturali forniscono una<br />
essenziale “funzione di consultazione” e contribuiscono al<br />
mantenimento della salute umana attraverso la fornitura di<br />
opportunità di riflessione, arricchimento spirituale, sviluppo<br />
cognitivo, esperienze ricreative ed estetiche.<br />
Nello scenario mondiale sono tantissimi gli studi, le proposte<br />
e le metodologie in continua evoluzione, atte a determinare<br />
in modo oggettivo ed efficace le funzioni ecosistemiche<br />
offerte dall’ambiente e come l’intervento dell’uomo<br />
possa incidere su di esse (sia in senso negativo che positivo)<br />
e sono stati sviluppati diversi metodi di elaborazione<br />
molti dei quali anche supportati da software specifici di calcolo.<br />
Tale ultimo aspetto evidenzia un’importante opportunità<br />
che è quella di poter gestire analisi quantitative e non<br />
solo di giudizi soggettivi e come tale particolarmente idonea<br />
alla fase progettuale. Quindi non solo utile per poter definire<br />
lo stato dell’ambiente di una porzione di territorio, ma anche<br />
per poter comprendere come sia possibile intervenire<br />
modificando lo stato dei luoghi per prevederne l’evoluzione<br />
e poter operare sia il confronto di interventi differenti sia gli<br />
equilibri che ci si può attendere nel post operam. Quantificazioni<br />
essenziali in fase di progettazione e delle conseguenti<br />
valutazioni ambientali. Sono state proprio queste possibilità<br />
che hanno portato il gruppo di lavoro di IRIDE a verificare<br />
se si riscontravano gli estremi per una loro applicazione al<br />
mondo della progettazione delle infrastrutture. Il risultato è<br />
decisamente positivo e di seguito si riportano alcuni spunti.<br />
In particolare, sulla scorta delle precedenti considerazioni,<br />
la scelta del software su cui effettuare le prime sperimentazioni<br />
applicative è ricaduta sul simulatore SimulSoil 1 , perché<br />
è sembrato corrispondere al meglio alle necessità specifiche.<br />
Il software permette di stimare alcuni dei servizi ecosistemici<br />
offerti dal suolo come indicati in fig. 4.<br />
L’applicazione per il calcolo è abbastanza semplice e si svolge<br />
in ambiente GIS. Si tratta di individuare l’area di riferimento<br />
(in fig. 5 un esempio elaborato da IRIDE per un’area<br />
urbana di Roma) e di questa definirne l’uso del suolo se-<br />
Infrastrutture<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
32<br />
33<br />
LS<br />
6<br />
6. Mappatura S.E.<br />
“Stoccaggio di carbonio”<br />
su area di esempio<br />
7. Risultato dell’applicazione<br />
e calcolo degli indicatori<br />
(in blu stato attuale in arancio<br />
stato di progetto)<br />
7<br />
Infrastrutture<br />
condo le classi alla base del pacchetto. È questa l’applicazione<br />
più sensibile e alla quale porre la massima attenzione<br />
per far sì che l’applicazione abbia significato e i risultati<br />
siano effettivamente realistici.<br />
La maglia assunta per il calcolo ha una risoluzione pixel 20<br />
x 20 m e in tal modo è possibile ottenere le mappe di distribuzione<br />
dei Servizi Ecosistemici. Risulta evidente come<br />
tale applicazione possa essere fondamentale nell’ottimizzare<br />
le scelte progettuali, mediante il raffronto con i S.E. offerti<br />
dal suolo allo stato attuale e in seguito alla realizzazione<br />
di un’infrastruttura e delle relative opere destinate alla<br />
valorizzazione del territorio.<br />
Con riferimento alla fig. 6 si riporta un esempio pratico. In<br />
ambito limitrofo a un’infrastruttura si prevede la possibilità<br />
di un intervento più estensivo dove un’area a culture agrarie<br />
viene considerata per un intervento di rimboschimento.<br />
Si tratta di leggere mediante il software SimulSoil il territo-<br />
rio allo stato attuale e poi un secondo calcolo introducendo<br />
nella medesima porzione di territorio la situazione che si<br />
associa alla soluzione progettuale.<br />
Ne risulta che l’area considerata in cui sono previsti interventi<br />
di rinaturalizzazione, determinerà un valore del<br />
servizio ecosistemico relativo allo stoccaggio di carbonio<br />
(CS) pari a circa 615 tonnellate, rispetto al valore attuale<br />
pari a circa 200 tonnellate con un beneficio pari a circa<br />
il 300%. E ovviamente i vantaggi non si fermano a questo<br />
aspetto.<br />
Consumo di suolo zero<br />
e potenziamento dei S.E.<br />
Implementare la progettazione di un’infrastruttura con l’obiettivo<br />
di pervenire al consumo nullo del valore ecologico<br />
del suolo e potenziare al contempo i servizi ecosistemici è<br />
quindi una sfida possibile. O per lo meno abbiamo la possi-<br />
bilità di mettere a disposizione del Proponente e dei Progettisti<br />
strumenti adatti allo scopo. Giungere al risultato è ovviamente<br />
un’altra cosa. Perciò, occorre instaurare un clima<br />
più sereno tra i soggetti che partecipano alla definizione e<br />
approvazione dell’opera: le sfide tra guelfi e ghibellini, tra<br />
milanisti e interisti, tra amministratori e cittadini così come<br />
quelle tra proponenti e valutatori, sono scenari ai quali assistiamo<br />
tutti i giorni e in tal modo difficilmente si può arrivare<br />
all’implementazione del progetto nella logica proposta<br />
se non dopo rocambolesche procedure in cui vengono<br />
messi sul campo le forze reciproche. Brutto scenario con<br />
una lettura un po' pessimistica e certamente non proattivo<br />
ma, purtroppo, lo diciamo con fatica, ci sembra quello<br />
che emerge tanto che, ad esempio, un momento di sereno<br />
confronto tra i diversi soggetti introdotto dal Dlgs 50/16<br />
con il dibattito pubblico dopo praticamente 5 anni è ancora<br />
avvolto da un limbo (a meno di alcuni casi illuminati) e non<br />
sembra proprio nella mente di tutti per il prossimo futuro.<br />
Non a caso la cosiddetta legge semplificazioni del 2020 lo<br />
ha ancor più allontanato tradendo lo spirito dal quale è nato<br />
e che invece riteniamo indispensabile recuperare, valorizzare<br />
e promuovere se si vuole poter sviluppare una politica<br />
infrastrutturale coerente con le attese e con gli impegni<br />
assunti in sede internazionale. Potrebbe esserci anche<br />
un’altra chiave di lettura: ovvero dare più risalto e attenzione<br />
alla pianificazione del territorio e alle scelte di sviluppo<br />
delle iniziative infrastrutturali. I piani territoriali molte volte<br />
non considerano i piani di sviluppo infrastrutturali anche<br />
perché quest’ultimi non sono posti alla base del confronto<br />
ma sviluppati in termini aziendali. Gli aspetti sopra riportati<br />
sono certamente all’ordine del giorno del dibattito in atto<br />
e quindi ci attendiamo un cambio di passo per il quale i ragionamenti<br />
esposti nelle presenti note potrebbero essere<br />
un contributo propositivo.<br />
Infatti, quella del consumo del suolo, come detto, è certamente<br />
una sfida importante da affrontare ma come si può<br />
fare se non ci si confronta? Come evidenziato nelle precedenti<br />
note la valorizzazione ecologica del suolo difficilmente<br />
può essere perseguita all’interno di un sedime aeroportuale<br />
o nella fascia stradale per cui il progetto deve aprirsi<br />
necessariamente al territorio.<br />
In fig. 8 si riassume lo schema proposto in cui appare evidente<br />
che ad una acclarata necessità di trasformazione del<br />
suolo per esigenze infrastrutturali può corrispondere lo sviluppo<br />
di un momento progettuale che mira a bilanciare questo<br />
aspetto.<br />
Infrastrutture<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
34<br />
8<br />
produzionepropria.com m.fasson 2020<br />
Il suolo è una risorsa preziosa e non rinnovabile<br />
Infatti, se si considera l’importante contributo dato dalla<br />
logica del Bilancio Ecologico del Suolo, è possibile superare<br />
la fisicità degli ettari di suolo impegnati e rivolgerci a<br />
interventi tesi a porre in equilibrio il loro valore dal punto<br />
di vista ecologico, che è poi quello che interessa per<br />
consentire la conservazione della biodiversità così tanto<br />
sollecitata anche dalla Comunità Europea nelle politiche<br />
generali. L’ulteriore valore aggiunto che è possibile trasferire<br />
nel progetto dalle attività della comunità scientifica<br />
è l’analisi, la scelta e la progettazione del “valore”<br />
che detto suolo può acquisire. Per far questo ci rivolgiamo<br />
alla determinazione del Servizio Ecosistemico che lo<br />
stesso può dare e in questo campo c’è molto da sperimentare<br />
e sviluppare.<br />
ta da costruire. Come costruirla? Con un’evoluzione del<br />
“Progetto” ma anche con un maggiore confronto tra i soggetti<br />
interessati alla gestione delle opere e del territorio<br />
in senso generale. nn<br />
8. La progettazione<br />
nella logica della difesa<br />
del consumo di suolo<br />
Raddoppia la vita utile dell’asfalto<br />
Riduce i costi di<br />
manutenzione stradale<br />
Permette il riciclo<br />
di plastiche dure selezionate<br />
Riduce le emissioni di CO2eq del 70%<br />
Previene gli ammaloramenti<br />
Riciclabile 100%<br />
nei successivi cicli produttivi<br />
Spunti di riflessione<br />
Nell’esempio riportato in questo articolo ci si è riferiti a un<br />
solo aspetto dei servizi che si possono considerare, certamente<br />
importante perché aiuta alla lotta contro i cambiamenti<br />
climatici, ma anche parziale rispetto a quello<br />
che si può fare. Come illustrato in precedenza, detti servizi<br />
riguardano la biodiversità ma anche l’ambiente idrico,<br />
la qualità della vita e il bilancio delle materie prime,<br />
la salvaguardia della vegetazione, ma anche il patrimonio<br />
culturale, quindi ciò che si vuole lasciare come ulteriore<br />
spunto di riflessione è la possibilità che, a seconda<br />
degli obiettivi che il singolo progetto intende perseguire<br />
nonché del contesto specifico nel quale si interviene, il<br />
bilancio del suolo può assumere diverse sfaccettature e<br />
la sua declinazione in termini progettuali è ampia e tut-<br />
© leStrade<br />
9. Infrastrutture e contesto:<br />
tema antico il cui bilancio<br />
oggi può essere migliorato<br />
sensibilmente anche<br />
grazie al nuovo approccio<br />
progettuale basato sui Servizi<br />
Ecosistemici che abbiamo<br />
illustrati in questo articolo<br />
Supermodificante high-tech con G+ Graphene plus<br />
brevettato e studiato per la sostenibilità e la compatibilità ambientale<br />
100% riciclabile, sostenibile, conveniente, dura più del doppio<br />
Strade durature, sicure ed ecosostenibili<br />
Tutela del suolo, patrimonio ambientale, paesaggio, riconoscimento del valore delle risorse naturali. L’Europa e le Nazioni Unite<br />
chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il degrado del territorio<br />
entro il 2030. gipave® nuovo supermodificante high-tech a base di grafene per aumentare la vita utile delle strade, ridurre l’impatto<br />
ambientale, offrire maggiore sicurezza e risparmio sulla manutenzione, riutilizzare nuovamente i materiali nei successivi cicli produttivi, minimizzare<br />
sprechi di energia e lo sfruttamento di risorse naturali, adottando un modello di economia circolare. Con gipave® per ogni chilometro si<br />
recuperano 18 tonnellate di plastica riciclata, si risparmiano oltre 15 milioni di tonnellate di materia prima, si evitano 1400 kg di CO2<br />
equivalente - si riducono del 70% le emissioni di CO2eq rispetto all’asfalto lavorato in modo tradizionale.<br />
Infrastrutture<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
High-tech additives for the road industry<br />
Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale<br />
www.iterchimica.it
36<br />
37<br />
LS<br />
Nuove Opere<br />
Concentrato<br />
A cura della redazione<br />
2. Imbocco della galleria<br />
Sant’Augusta<br />
3. Tratto interno della galleria<br />
stradale<br />
© Anas SpA<br />
3<br />
di buona tecnica<br />
ANAS (GRUPPO FS ITALIANE) APRE AL TRAFFICO LA NUOVA VARIANTE<br />
DI VITTORIO VENETO, IN PROVINCIA DI TREVISO, UN’INFRASTRUTTURA<br />
VIARIA DI “SOLI” DI 2 KM DI ESTENSIONE MA DALLE MOLTE PECULIARITÀ<br />
INGEGNERISTICHE, ESEMPLIFICATE DALLA GALLERIA SANT’AUGUSTA,<br />
OPERA D’ARTE PRINCIPALE DI UN INTERVENTO CHE HA COMPORTATO<br />
UN INVESTIMENTO COMPLESSIVO DI 65 MILIONI DI EURO.<br />
Anas (Gruppo FS Italiane) il 24 marzo scorso ha<br />
aperto al traffico la nuova variante di Vittorio Veneto<br />
(Tangenziale Est), in provincia di Treviso. La<br />
nuova opera, del valore complessivo di circa 65 milioni di<br />
euro, rientra nell’ambito degli interventi del primo Stralcio<br />
del nuovo tracciato “La Sega-Rindola” per il più ampio<br />
progetto di collegamento “La Sega-Ospedale”. L’apertura<br />
al traffico è stata effettuata nel corso di un incontro<br />
online in diretta, sui canali social e YouTube di Anas, alla<br />
presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia<br />
e della Vicepresidente Elisa De Berti, del Sindaco di Vittorio<br />
Veneto Antonio Miatto, del Presidente di Anas Claudio<br />
1. Primo piano sulla trincea<br />
della Variante di Vittorio<br />
Veneto<br />
4. Un’opera inserita<br />
sapientemente nel contesto<br />
paesaggistico<br />
2<br />
© Anas SpA<br />
Andrea Gemme e dell’Amministratore delegato di Anas<br />
Massimo Simonini. “Quando ho preso le redini del Veneto<br />
- ha dichiarato Zaia - erano due i fronti problematici<br />
su cui mi sono subito ripromesso che avremmo garantito<br />
delle migliorie che i cittadini avrebbero potuto toccare<br />
con mano: la sanità e i trasporti. Una sanità al passo con<br />
i tempi, capace di rispondere in maniera ampia e concreta<br />
ai bisogni dei veneti ed infrastrutture e trasporti all’avanguardia,<br />
capaci di proiettarci nel futuro, non solo con<br />
l’immaginazione, per una tecnologia sempre più innovativa<br />
e una mobilità più green”. “L’importante risultato - ha<br />
continuato il Presidente Zaia - che presentiamo è la dimostrazione<br />
che, condividendo obiettivi e progetti, a trarne<br />
vantaggio sono ancora una volta i cittadini verso cui è<br />
rivolta la nostra massima attenzione. Cittadini che risiedono<br />
a Vittorio Veneto e che necessitano, nella loro quotidianità,<br />
di una viabilità sicura, snella e veloce, ma anche<br />
cittadini-turisti che, per vacanza e svago, potranno<br />
percorrere e godere di questo nuovo passante. Con oggi,<br />
infatti, debutta un altro tassello dei lavori sulla viabilità<br />
1<br />
4© Anas SpA<br />
© Anas SpA<br />
Strade<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
con
38<br />
39 LS<br />
© Anas SpA<br />
5<br />
8. Apertura al traffico<br />
dell’opera, il 24 marzo scorso<br />
zione verso il territorio e le persone che lo abitano - ha dichiarato<br />
l’AD di Anas Massimo Simonini -. La variante che<br />
apriamo al traffico comporta benefici in termini di tempi<br />
di percorrenza, comfort di guida e sicurezza stradale, liberando<br />
il borgo antico di Serravalle soprattutto dai mezzi<br />
pesanti e consente di raggiungere la strada statale 51<br />
“di Alemagna” tramite l’innesto con via Carso. Il completamento<br />
di questo tracciato si inquadra anche nel piano<br />
di investimenti Anas in Veneto, investimenti per un valore<br />
complessivo pari a circa 2 miliardi e 923 milioni di<br />
euro, ripartiti tra nuove opere per circa 2 miliardi, manutenzione<br />
programmata per 922 milioni di euro. In particolare,<br />
i 2 miliardi di Nuove Opere comprendono 110,95<br />
milioni di euro di interventi ultimati, 70,4 milioni di euro<br />
in corso di esecuzione, 35 milioni di euro di prossimo avvio<br />
e 1.278 milioni di euro di interventi previsti in Contratto<br />
di Programma.<br />
A questi si aggiungono 472,5 milioni di ulteriori Nuove<br />
opere in corso di progettazione inserite nel Piano Milano<br />
Cortina 2026. Gli oltre 922 milioni in manutenzione programmata<br />
riguardano lavori ultimati per 103,60 milioni<br />
di euro, in corso di esecuzione per 182,62 milioni di euro,<br />
di prossimo avvio per 14,63 milioni di euro e in progettazione<br />
per 621,41 milioni di euro. Nel 2020 la manutenzione<br />
programmata ha avuto un valore di 55,76 milioni<br />
di euro, con un incremento del 49,6% rispetto al 2019<br />
dove sono stati impiegati 37,28 milioni di euro, a testimonianze<br />
concreta dell’impegno aziendale nel migliorare<br />
la rete esistente”.<br />
Fotografia tecnica<br />
La variante, lunga 2,05 km, attraversa in galleria la dorsale<br />
di Serravalle e si sviluppa sulla sinistra del fiume Meschio.<br />
È costituita da un tratto principale delimitato da 2 rotatorie<br />
denominate “la Sega” e “Rindola”, aventi un diametro di circa<br />
45 m, e un ramo di collegamento sud denominato “Vittorio<br />
Veneto centro” che termina con la rotatoria su via Carso.<br />
L’opera d’arte principale della variante è la galleria “Sant’Augusta”,<br />
che risponde ai più elevati standard di sicurezza ed<br />
è dotata di Illuminazione a Led, garantendo così un’alta efficienza<br />
energetica.<br />
Il nuovo tunnel è lungo circa 1,5 km, realizzato con una superficie<br />
di scavo di 175 metri quadrati e un diametro di 15<br />
m. All’interno della galleria è stato anche realizzato un cunicolo,<br />
collegato all’esterno in corrispondenza di entrambe gli<br />
imbocchi e munito di 5 uscite di sicurezza, da utilizzare come<br />
via di fuga in caso di emergenza.<br />
Le altre opere realizzate sono il ponte “Meschio” per una lunghezza<br />
pari a 22 m; è stato inoltre realizzato un tratto di circa<br />
200 m all’interno di una trincea, in corrispondenza dell’imbocco<br />
sud della galleria, caratterizzato da un’importante opera di<br />
sostegno costituita da pali di grande diametro e rivestita con<br />
pannelli prefabbricati che riproducono i tipici muri di confine<br />
della zona al fine di mitigare l’impatto paesaggistico dell’opera.<br />
La funzionalità dell’opera si completa con il cavalcavia<br />
di Rindola con una estensione di 13 metri che sovrappassa<br />
la viabilità comunale. I lavori di realizzazione della Variante<br />
proseguiranno con gli interventi previsti nel 2° Stralcio Rindola-Savassa<br />
il cui progetto è in fase di avvio. nn<br />
Strade<br />
6 7<br />
© Anas SpA<br />
© Anas SpA<br />
8<br />
veneta, attesa da molti anni e, finalmente, completato: il<br />
primo lotto della tangenziale di Vittorio Veneto è ora una<br />
realtà. Con questa infrastruttura, oltre a raggiungere più<br />
agevolmente la SS51, anche in vista dei prossimi Giochi<br />
Olimpici, si potrà alleggerire dal normale traffico pesante<br />
l’abitato di Serravalle. Infine, mi auguro che, assieme<br />
ad ANAS, si potranno per il futuro attivare ancor nuove<br />
ed efficaci migliori sinergie”.<br />
Viabilità potenziata<br />
“Stiamo potenziando la viabilità in Veneto con infrastrutture<br />
che possano accogliere in maniera adeguata una mobilità sostenibile<br />
- ha dichiarato il Presidente di Anas Claudio Andrea<br />
Gemme. Sono fermamente convinto che si possano gestire le<br />
reti viarie con modalità green, anche grazie alle nuove tecnologie,<br />
con risultati significativi in termini di maggiore sicurezza<br />
e di innalzamento degli standard di servizio delle strade.<br />
Ottenendo vantaggi concreti sia per chi si sposta ogni giorno<br />
per lavoro, sia per tutti coloro che scelgono di visitare questo<br />
territorio che rappresenta la prima regione turistica d’Italia.<br />
Il nostro impegno continua su questa linea, in vista delle<br />
grandi sfide che ci attendono, tra cui le Olimpiadi Invernali<br />
Milano Cortina 2026”.<br />
“Anas continua a garantire il suo impegno e la sua atten-<br />
5. Ponte Maschio e galleria<br />
Sant’Augusta<br />
6, 7. L’intervento ha previsto<br />
anche la realizzazione<br />
di rotatorie<br />
© Anas SpA<br />
Strade<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
con
40<br />
41<br />
LS<br />
Sicurezza Viaria<br />
1<br />
Entriamo nel vivo di questa collaborazione: quali sono<br />
state le prime tappe del vostro percorso comune?<br />
Ci siamo preparati molto, sia sul piano tecnico sia su quello<br />
commerciale e del marketing, il che è essenziale per far<br />
capire ai nostri clienti i punti di valore di questa nuova gamma,<br />
che è molto completa, potendo contare su barriere che<br />
vanno dalla già citata bordo-ponte a una soluzione per spartitraffico<br />
centrale. Riguardo a questo specifico aspetto, per<br />
prima cosa abbiamo provveduto a tradurre tutta la documentazione<br />
in francese.<br />
Strade<br />
Green technology<br />
italo-francese<br />
Fabrizio Apostolo<br />
L’AZIENDA FRANCESE SOLOSAR DIVENTA DISTRIBUTORE UFFICIALE<br />
PER IL TERRITORIO TRANSALPINO DELLE BARRIERE ITALIANE VITA<br />
INTERNATIONAL IN LEGNO E ACCIAIO, POTENZIANDO UNA GAMMA GIÀ VOTATA<br />
ALLA QUALITÀ. PER RACCONTARE QUESTA PARTNERSHIP IN PURO STILE<br />
GREEN DEAL EUROPEO, ABBIAMO INTERVISTATO PATRICK ASIMUS, DIRETTORE<br />
GENERALE DELL’AZIENDA DEL GRUPPO HEINTZMANN.<br />
Dopo aver raccontato la partnership Italia-Cile tra<br />
Vita International e Tecnovial sul numero di le-<br />
Strade Gennaio-Febbraio, torniamo a “viaggiare”,<br />
questa volta non oltre Atlantico, ma nel cuore d’Europa,<br />
per dare notizia e qualche cenno di approfondimento<br />
a proposito una nuova collaborazione che vede protagonista<br />
l’azienda bresciana guidata da Irina Mella Burlacu,<br />
operatore dalla particolare vocazione alla sostenibilità<br />
ambientale e, come abbiamo già avuto modo di ricordare<br />
e come diremo meglio tra breve, all’innovazione. Siamo<br />
a Sarreguemines, non lontano da Strasburgo, lungo<br />
il confine che separa Francia e Germania, anche se sarebbe<br />
più appropriato parlare non tanto di “separazione”,<br />
quanto di piena “unione”, capace di sviluppare e produrre<br />
barriere senza confini. Anche in ragione del fatto che<br />
l’azienda francese di cui ci diremo, Solosar, fa parte del<br />
gruppo tedesco Heintzmann. La notizia è la seguente: dal<br />
<strong>2021</strong> Solosar ha potenziato notevolmente la sua gamma<br />
di barriere stradali di sicurezza in legno e acciaio diventando<br />
distributore ufficiale per la Francia dei prodotti di<br />
Vita International e dando vita a un’alleanza tra Made in<br />
Italy e Made in France che, date le premesse, non potrà<br />
che dare buoni frutti. Ce la racconta nel dettaglio Patrick<br />
Asimus, direttore generale di Solosar.<br />
1. Barriera modello Treviade<br />
di Vita International<br />
2. Un momento della<br />
formazione presso Solosar:<br />
si riconosce, con la giacca<br />
arancione, il direttore<br />
generale Patrick Asimus<br />
3. Catalogo Solowood<br />
potenziato, grazie all’arrivo<br />
dei prodotti Vita<br />
4. La sede dell’azienda<br />
del gruppo Heintzmann<br />
3<br />
Iniziamo dalla vostra esperienza specifica in materia<br />
di dispositivi di sicurezza in legno e acciaio.<br />
Solosar, il cui azionista di riferimento è il gruppo tedesco<br />
Heintzmann, è un’azienda francese storica, avendo avviato la<br />
propria attività ben 43 anni fa (per una panoramica completa<br />
delle soluzioni Solosar rimandiamo al sito web solosar.fr).<br />
Abbiamo iniziato a testare i primi dispositivi in legno e acciaio<br />
nel 2002 dando vita a una gamma ad hoc, composta dai<br />
prodotti Solobois/Solowood. Le soluzioni Solobois sono tutte<br />
prodotte e assemblate presso la nostra sede di Sarreguemines.<br />
Il legno, pino silvestre di alta qualità, arriva esclusivamente<br />
dalla Germania, mentre l’acciaio viene prodotto in<br />
Francia o in Germania.<br />
Quindi, ecco il potenziamento di gamma, con l’approdo<br />
delle barriere italiane. Quando e come è avvenuto<br />
questo incontro?<br />
Abbiamo iniziato a dialogare con Vita International nell’autunno<br />
scorso: cercavamo una serie di soluzioni qualitativamente<br />
performanti che andassero a potenziare e integrare<br />
la nostra gamma andando a rivolgersi a situazioni applicative<br />
peculiari, mi riferisco per esempio alle “bordo-ponte” o<br />
a barriere dotate di W (spazio di lavoro) più stretto rispetto<br />
alle nostre soluzioni. Questo in virtù della crescita della<br />
domanda, sul mercato francese, di dispositivi di protezione<br />
di questo genere. La partnership con Vita è diventata pienamente<br />
operativa a partire da questo <strong>2021</strong>: distribuiremo<br />
una serie di loro prodotti sul mercato francese, ma anche in<br />
Algeria e Marocco.<br />
2<br />
4<br />
Quali sono, nello specifico, i prodotti Vita che andrete<br />
a commercializzare?<br />
Sono numerosi e rispondono pienamente alle esigenze del<br />
mercato. Abbiamo per esempio le barriere Treviade, dalla classe<br />
N2 a quella H1, quindi Garda (H2), Iseo (H2) e Idro (H2), il<br />
primo dispositivo in legno e acciaio a me noto per spartitraffico<br />
centrale. In altri termini: un’innovazione assoluta. Oltre, naturalmente,<br />
ai vari accessori di gamma. In futuro, puntiamo però<br />
anche a mettere sul mercato GuardLED, il rivestimento in poliuretano<br />
con Led sviluppato da Roadlink. Stiamo già facendo<br />
formazione tecnica su questo prodotto, davvero rivoluzionario.<br />
A parte la qualità generale Made in Italy e la novità<br />
Idro, quale considera la principale innovazione della<br />
gamma Vita?<br />
Il fatto, per esempio, che si tratti di dispositivi testati sia con<br />
sia senza il rivestimento in legno, il che rappresenta un chiaro<br />
punto di valore per i gestori: in qualsiasi caso è garantita<br />
la costanza delle prestazioni. Poi vorrei sottolineare la grande<br />
versatilità: la gamma completa, infatti, è disponibile sia<br />
in acciaio zincato o con finiture in acciaio Corten.<br />
Qual è l’obiettivo di questa partnership?<br />
Potenziarci, e non poco, nell’ambito di un mercato in cui le soluzioni<br />
in legno e acciaio sono molto presenti e la concorrenza è<br />
agguerrita. Con Vita, con questa completezza di gamma e con<br />
questi standard tecnologici, pensiamo davvero di potercela fare.<br />
Prendiamo spunto da questa sua ultima risposta per<br />
chiederle di tratteggiarci meglio le peculiarità del contesto<br />
francese, proprio per quanto riguarda la presenza<br />
storica di soluzioni di protezione stradale ad alta valenza<br />
paesaggistica.<br />
Il punto nodale è che in Francia è da tempo molto forte la domanda<br />
di prodotti dall’aspetto il più possibile naturale. Il legno<br />
deve apparire in tutto e per tutto uguale a quello del cuore<br />
dell’albero, i dispositivi si devono integrare perfettamente,<br />
oserei dire naturalmente, con l’ambiente circostante. Dal nostro<br />
punto di vista, oltre che con le barriere, abbiamo sviluppato<br />
una forte esperienza di questo approccio con la linea Solo-<br />
Nature, la nostra gamma per l’arredo urbano, che si avvale di<br />
soluzioni in legno, ovviamente, ma anche di elementi in acciaio<br />
Corten, come per esempio le fioriere. Ecco, ricercare un’armonia<br />
sempre più forte tra dotazioni per l’arredo urbano e soluzioni<br />
di sicurezza stradale, nel rispetto dell’ambiente, è uno<br />
degli obiettivi che non caratterizza solo noi come azienda, ma<br />
l’intera cultura stradale francese, a partire da quella sviluppa-<br />
Strade<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
42<br />
5. Modelli Vita in gamma<br />
e classi di contenimento<br />
6, 7. Modello Iseo in versione<br />
per spartitraffico centrale<br />
5<br />
ta nei piccoli centri a forte vocazione turistica. È un percorso,<br />
questo, che è stato avviato già dagli anni Sessanta e che pone<br />
le nostre amministrazioni in una posizione di vantaggio rispetto,<br />
per esempio, a paesi quali Germania, Olanda o Italia, anche<br />
se noto con piacere che in tutta Europa la cultura green,<br />
anche nelle infrastrutture viarie, sta crescendo notevolmente.<br />
6<br />
7<br />
Torniamo alla gamma Vita, in cui peraltro l’acciaio Corten,<br />
che lei ha appena citato, gioca un ruolo cruciale.<br />
Come avete acquisito la conoscenza tecnica delle<br />
loro soluzioni?<br />
Dopo alcune sessioni di formazione a distanza e la traduzione<br />
di tutta la documentazione, non solo commerciale, di cui<br />
ho detto, ma anche tecnica (penso essenzialmente ai manuali<br />
di installazione), abbiamo ricevuto dall’Italia una serie<br />
di campioni di diverse tipologie di barriere e abbiamo provveduto<br />
a organizzare un’intera giornata di formazione a cui<br />
hanno partecipato tutti i nostri dipendenti e collaboratori,<br />
non solo i tecnici ma anche i commerciali. In pratica, abbiamo<br />
studiato e applicato nella pratica i manuali di installazione<br />
pagina per pagina, in modo tale da avere piena confidenza<br />
con i prodotti ed essere quindi pronti a “spiegarli” ai nostri<br />
clienti. Ora siamo davvero pronti a partire.<br />
La prima vendita?<br />
Già avvenuta. Si tratta di oltre 100 m di barriera Treviade N2<br />
nei dintorni di Marsiglia, a protezione di una strada di accesso<br />
a un piccolo comune. Siamo ormai prossimi all’installazione.<br />
Cosa vi riserva, infine, il futuro?<br />
Tra i temi di cui ci stiamo occupando e in cui vogliamo essere<br />
protagonisti c’è il dialogo tecnologico tra le barriere stradali<br />
e i veicoli, in ottima Smart Road. GuardLED potrò essere<br />
8<br />
senz’altro un primo, significativo tassello di questa strategia<br />
che andrà in ogni caso implementata. Siamo convinti che il<br />
nostro settore possa fare molto, per esempio, per favorire lo<br />
sviluppo dei veicoli a guida autonoma. nn<br />
8. Modello Garda<br />
9<br />
9. Ancora un momento<br />
del training in azienda<br />
Strade<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade
44<br />
45<br />
LS<br />
1<br />
2. Cielo e terra: drone<br />
e alta velocità<br />
2<br />
3. La ferrovia vista<br />
dall’alto<br />
4. La “drone box” RFI,<br />
uno degli sviluppi tecnologici<br />
della sperimentazione<br />
condotta con l’Università<br />
di Siena<br />
© liguria.bizjournal.it<br />
3<br />
Tecnologie Innovative<br />
La ferrovia<br />
vista dal cielo<br />
© RFI (Gruppo FS Italiane)<br />
© RFI (Gruppo FS Italiane)<br />
© RFI (Gruppo FS Italiane)<br />
4<br />
UN CONVEGNO IDEATO PER “LEGARE” LE INFRASTRUTTURE<br />
DI TERRA E LE TECNOLOGIE D’ARIA FA IL PUNTO SULLE<br />
SPERIMENTAZIONI COMPIUTE DA RFI, RETE FERROVIARIA<br />
ITALIANA, IN MATERIA DI IMPIEGO DI AEROMOBILI A PILOTAGGIO<br />
REMOTO - ALTRIMENTI DETTI “DRONI” - COME AUSILIO ALLE<br />
ISPEZIONI DI PONTI E VIADOTTI FERROVIARI. UNA NUOVA<br />
FRONTIERA TUTTA DA ESPLORARE.<br />
Il supporto dei droni come nuova frontiera volta al miglioramento<br />
di servizi commerciali, industriali e al monitoraggio<br />
delle infrastrutture critiche, a tutela della sicurezza<br />
e della crescita. Se ne è discusso il 31 marzo scorso<br />
nell’ambito del convegno dal titolo “L’impiego dei velivoli a<br />
pilotaggio remoto in ambito civile”, organizzato in modalità<br />
web dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza e da<br />
RFI Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con il patrocinio<br />
di ENAV ed ENAC. A moderare l’incontro la presidente di<br />
RFI, Anna Masutti. Per il Gruppo FS erano presenti anche<br />
l’amministratrice delegata di RFI Vera Fiorani e il responsabile<br />
ricerca e sviluppo di RFI Eugenio Fedeli. All’evento hanno<br />
partecipato anche importanti aziende come Leonardo,<br />
Terna, Telespazio e Oliver Wyman.<br />
Supporto alle ispezioni<br />
Dopo aver portato i saluti dell’azienda l’AD Fiorani ha ricordato<br />
il ruolo della componente aerea dedicata all’alimentazione<br />
elettrica legata all’infrastruttura ferroviaria, e di<br />
Ferrovie<br />
come RFI abbia avuto modo di sperimentare l’uso dei droni<br />
nel monitoraggio per la sicurezza della propria infrastruttura.<br />
“Gestiamo circa 16mila chilometri di linee ferroviarie, che<br />
sono fortemente ancorate a terra”, ha spiegato Fiorani, indicando<br />
che RFI ha già sperimentato la possibilità di “innalzarsi”<br />
da terra, dove è collocata l’infrastruttura ferroviaria,<br />
per raggiungere la parte aerea della stessa (rappresentata<br />
dal sistema elettrico) posta a circa 4 metri e mezzo da terra.<br />
“Abbiamo utilizzato lo spazio al di sopra dei corridoi ferroviari<br />
per utilizzare questi mezzi a pilotaggio remoto e abbiamo<br />
risolto così il problema, utilizzando i nostri spazi”, ha<br />
quindi sottolineato l’AD. Sull’utilizzo di questa tecnologia in<br />
volo nell’ambito ferroviario è intervento anche il manager<br />
RFI Eugenio Fedeli, che ha illustrato come le sperimentazioni<br />
in tale ambito, iniziate già dal 2013, abbiano dato seguito<br />
principalmente al supporto per verifiche e ispezioni periodiche<br />
di opere come viadotti, ponti e sottovia presenti lungo<br />
le linee, oltre che per attività di security riferite ad asset<br />
strategici o aree sensibili dell'infrastruttura.<br />
A cura della redazione<br />
1. Pilotaggio remoto: un tema<br />
all’attenzione del mondo<br />
ferroviario già da diversi anni<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
5. La componente aerea<br />
dell’alimentazione elettrica<br />
5<br />
© RFI (Gruppo FS Italiane)<br />
Sicurezza e manutenzione<br />
Tra i benefici c’è quello di poter impiegare i droni in zone<br />
impervie o raggiungibili in maniera difficoltosa per motivi<br />
di origine naturale o antropica, al fine di poter soddisfare<br />
le esigenze in occasione di controlli di tipologia prettamente<br />
visiva o per interventi programmati nel processo manutentivo<br />
sugli stati conservativi delle strutture e dei loro rivestimenti.<br />
A partire dal 2013, RFI ha avviato una prima<br />
campagna sperimentale, terminata nel 2016, per l’utilizzo<br />
di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) come ausilio<br />
alle ispezioni di ponti e viadotti ferroviari, che ha consentito<br />
il controllo di otto opere per un totale di 36 campate, e<br />
una seconda sperimentazione, ancora in corso, per verifiche<br />
su cento opere distribuite su tutto il territorio nazionale.<br />
Le opere oggetto di indagine e i dati che le riguardano vengono<br />
debitamente classificati insieme alle eventuali tipologie<br />
di anomalie, mentre sono in corso sviluppi del software<br />
di gestione e catalogazione automatica dei difetti riscontrati.<br />
Grazie ad algoritmi dedicati e a meccanismi di intelligenza<br />
artificiale si potrà quindi intervenire ancora più tempestivamente<br />
sul tipo di criticità riscontrata.<br />
Nel 2019 RFI ha concluso con successo un progetto di<br />
innovazione, sperimentazione e ricerca in collaborazione<br />
con l’Università di Siena sulla realizzazione di un aeroporto<br />
mobile completamente automatizzato dedicato a droni,<br />
dove poter svolgere operazioni come la ricarica del mezzo<br />
o la programmazione degli itinerari destinati ad attività di<br />
security da realizzare, ad esempio, su tecnologie dell’Alta<br />
Velocità, magazzini materiali, o nell’ambito delle sottostazioni<br />
per l’alimentazione delle linee elettriche. Il progetto<br />
è stato oggetto di brevetto sia italiano che europeo<br />
del Gruppo FS. nn
46<br />
47<br />
LS<br />
Trasporti Eccezionali<br />
A cura della redazione<br />
Link epocale<br />
tra due stazioni<br />
2. La velocità del trasporto<br />
è stata perfettamente<br />
calibrata per integrarsi con<br />
le altre fasi esecutive<br />
1<br />
GRAZIE AL LAVORO DI UN TEAM DI SPECIALISTI E ALL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE<br />
DI PRIM’ORDINE, UN IMPALCATO IN ACCIAIO DI 820 TONNELLATE È STATO<br />
PERFETTAMENTE INNESTATO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA DA STOCCARDA<br />
A ULM, IN GERMANIA. TRA I PROTAGONISTI DELL’IMPRESA, ESEMPLARE PER<br />
PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE, ANCHE I VEICOLI SEMOVENTI COMETTO SPMT.<br />
ECCO LA CRONACA DI UN INTERVENTO CHE RIMARRÀ NEGLI ANNALI.<br />
Il nodo ferroviario di Wendlingen è un punto chiave<br />
nell’ampliamento della linea ICE in Germania tra Stoccarda<br />
e Ulm. Per il suo completamento, deve essere<br />
spostato un ponte d’acciaio del peso di 820 tonnellate. Un<br />
lavoro mastodontico a cui partecipano diversi operatori spe-<br />
cializzati che procedono impiegando tecnologie avanzate:<br />
tra queste, anche le 24 linee di assi del semovente Cometto<br />
SPMT. Quello che si snoda parallelamente all’autostrada<br />
A8, lungo la strada federale numero 313, non è un trasporto<br />
ordinario. Anche in virtù della compresenza di diversi fattori<br />
1. Cometto SPMT<br />
su strada con sopra il peso<br />
delle 820 tonnellate del ponte<br />
di cui tener conto: il punto nodale, spiega Marco Wilhelm,<br />
responsabile di progetto dell’impresa Wiesbauer, “è l’impiego<br />
in contemporanea di tre sistemi diversi, che anche per<br />
noi rappresenta una prima volta assoluta. Devono essere<br />
coordinati, infatti, il Cometto SPMT, lo scivolo dell’impresa<br />
Schachtbau Nordhausen e la nostra gru cingolata da 1.000<br />
tonnellate”. Tutti gli attori protagonisti dell’intervento sono<br />
concentrati e preparati al meglio. Laddove tra poche ore un<br />
3. Particolare dei<br />
moduli semoventi<br />
Cometto SPMT<br />
nuovo ponte dovrà dar vita al collegamento tra le due sezioni<br />
ferroviarie c’è ancora un grande buco. Per questa operazione,<br />
Wiesbauer ha messo a punto la sua combinazione<br />
SPMT nella disposizione 12+12 in abbinamento laterale.<br />
Avanzamento fluido<br />
grazie alla pianificazione<br />
L’attenzione dell’opinione pubblica interessata a quanto<br />
accade nell’area è alta, nel giorno dell’intervento. Anche<br />
una diretta streaming fornisce informazioni in tempo reale.<br />
Wiesbauer ha alle spalle settimane e settimane di preparazione.<br />
Ancora Marco Wilhelm fa notare che “nella fase<br />
di preparazione del progetto, il programma di pianificazione<br />
Cosmo di Cometto è stato utilizzato per un controllo incrociato<br />
dei valori e delle forze di spinta forniti dal cliente.<br />
Questo per muovere il ponte d’acciaio da 820 tonnellate<br />
con la giusta forza, centimetro per centimetro e, soprattutto,<br />
senza scossoni, sullo scivolo verso la gru cingolata”.<br />
Così, la teoria si trasforma in pratica operativa vissuta: “Mi<br />
entusiasma la tecnologia ogni qualvolta che i valori e i processi<br />
determinati in precedenza trovano piena corrispondenza<br />
nella realtà. Solo un’intensa e anticipata pianificazione<br />
permette a tutti coloro che lavorano nel cantiere di<br />
andare sempre sul sicuro”.<br />
Ferrovie<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
48<br />
Quel tecno-ariete<br />
che spinge i ponti<br />
Anche Mattias Roeder, responsabile di progetto di<br />
Schachtbau Nordhausen, segue i processi in modo attento,<br />
ma rilassato: “Grazie ai veicoli modulari semoventi Cometto<br />
SPMT di Wiesbauer e al controllo permanente della<br />
posizione da parte del nostro ingegnere specializzato,<br />
è stato possibile posizionare con precisione la struttura,<br />
lunga 52 metri. Impossibile essere più precisi! In poche<br />
parole, viene impiegata una tecnica perfetta con operatori<br />
al top in tutti i ruoli. A questo punto vogliamo ancora<br />
una volta mandare un grande ringraziamento a tutti<br />
gli operatori coinvolti, perché insieme siamo stati in grado<br />
di rispettare nel dettaglio quanto programmato”. Con<br />
precisione centimetrica, l’enorme costruzione di acciaio<br />
copre la distanza sui semoventi modulari. Poco prima<br />
di raggiungere la posizione finale, un lato del ponte viene<br />
collocato uno scivolo. In seguito, sul semovente viene<br />
avvitata una sorta di “ariete” e l’SPMT spinge il ponte<br />
verso la posizione finale della spalla. Il caposquadra Fabian<br />
Spathelf, della Gottlob Rommel Bauunternehmung di<br />
Stoccarda prende atto, soddisfatto, della fluidità dei processi:<br />
“Durante lo spostamento del ponte, vale il motto:<br />
la calma è la virtù dei forti. Con il Cometto SPMT la velocità<br />
di trasporto viene regolata in modo talmente preciso<br />
da essere ottimale per l’inserimento delle piastre di<br />
teflon nello scivolo”.<br />
Grande trasporto<br />
radiocomandato<br />
Leonard Schmid è l’uomo che manovra il semovente in ogni<br />
situazione in modo sicuro e attento. Lo specialista di carichi<br />
pesanti è un conoscitore della materia e cita alcuni<br />
punti di forza del “suo” Cometto SPMT in questo progetto:<br />
“Ci aiuta davvero molto il fatto che possa regolare la potenza<br />
delle due unità Power Pack tramite il potenziometro<br />
del radiocomando, in modo tale che sia possibile rispettare<br />
alla lettera le istruzioni di avanzamento di Schachtbau<br />
Nordhausen. Solo questo rende possibile procedere lentamente<br />
in avanti”.<br />
Una best practice<br />
da cui imparare<br />
Dopo otto ore di lavoro, il ponte d’acciaio è collocato saldamente<br />
nella sua nuova posizione. Un progetto di trasporto<br />
riuscito, in cui si è fatto ricorso a un noleggio “cross-hire”<br />
di alcune linee di assi. Oltre alle 12 linee di assi di Cometto<br />
e alle due unità Power Pack del parco veicoli di Wiesbauer,<br />
sono state coinvolte anche 12 unità MSPE della società<br />
Schares di Bocholt. Nella costruzione e manutenzione di<br />
ponti ci attendono anni decisivi. Nel futuro, questi lavori<br />
avranno un ruolo centrale nel piano infrastrutturale della<br />
Germania e dell’intera Europa. Il progetto di Wendlingen<br />
ha messo in luce che una pianificazione competente<br />
e soluzioni di trasporto tecnicamente sofisticate sono fattori<br />
a elevato valore aggiunto, determinanti per la buona<br />
riuscita di interventi tecnicamente complessi e insieme<br />
affascinanti. nn<br />
Ferrovie<br />
4. Vista d’insieme<br />
di questo trasporto,<br />
del tutto eccezionale<br />
5. Largo alle gru:<br />
il manufatto sta<br />
per essere collocato<br />
sulla sede ferrovaria<br />
6. Grande opera<br />
compiuta tra<br />
autostrada e ferrovia<br />
Photo: Le Matériel de Sondage<br />
Uomo e macchina<br />
Quando la tecnologia affianca<br />
la professionalità.<br />
Strumenti - anche a noleggio - per:<br />
Studio del sottosuolo<br />
Georadar, sismica, geoelettrica …<br />
Ingegneria civile<br />
Georadar 3D, laser scanner, inclinometri …<br />
Monitoraggio sismico<br />
Sismometri, strong motion, reti early warning …<br />
Monitoraggio ambientale<br />
Magnetometri, elettromagnetometri …<br />
Studio di strutture subacquee e fondali<br />
Droni idrografici, ecoscandagli, SSS …<br />
CODEVINTEC<br />
Tecnologie per le Scienze della Terra e del Mare<br />
tel. +39 02 4830.2175 | info@codevintec.it | www.codevintec.it
50<br />
51<br />
LS<br />
Driverless Technology<br />
Veicoli autonomi<br />
e responsabilità<br />
Leonardo Annese<br />
PIARC Italia<br />
World Road Association<br />
In collaborazione con<br />
DALLA TRASFORMAZIONE DEL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ ALLE COPERTURE<br />
ASSICURATIVE NEL SETTORE PROSSIMO VENTURO DEI CAV, I CONNECTED<br />
AUTOMATED VEHICLES, OVVERO LE AUTO A GUIDA AUTONOMA. QUALI SCENARI<br />
NORMATIVI E DI TUTELA ASSICURATIVA, SU QUESTI SPECIFICI ASPETTI,<br />
ACCOMPAGNERANNO L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA IN ATTO? E COME SI<br />
CONFIGURERANNO? QUALCHE PRIMA RISPOSTA, IN QUESTE RIFLESSIONI.<br />
Quello relativo alla responsabilità per la circolazione dei<br />
veicoli autonomi su strade e autostrade pubbliche è un<br />
tema delicato e problematico, che comporterà verosimilmente<br />
opportuni e notevoli cambiamenti di prospettive e di<br />
scenario rispetto al quadro attuale e che avrà ripercussioni anche<br />
sulla definizione delle coperture assicurative. Infatti, se certamente<br />
l’introduzione del sistema di guida autonoma ci potrà<br />
affrancare dai rischi connessi con i comportamenti umani, eliminando,<br />
più o meno parzialmente, gli incidenti dovuti a incapacità,<br />
insufficienze, disattenzioni, stati fisici del conducente, è<br />
però altrettanto verosimile che il complesso sistema “autonomo”<br />
che verrà posto in essere possa presentare difetti specifici<br />
che ne condizionino la piena efficienza. Uno dei profili che cambierà<br />
in modo sostanziale è certamente quello relativo al diverso<br />
coinvolgimento del costruttore di automobili, in quanto responsabile<br />
della progettazione, della realizzazione e della messa<br />
in commercio di prodotti dotati di sistemi hardware e software<br />
di gestione del veicolo automatico e di comunicazione con altri<br />
veicoli/infrastrutture e che, anche dopo la vendita del veicolo,<br />
sarà tenuto a un costante e tempestivo aggiornamento dei<br />
sofisticati sistemi installati, dovendo altresì, tempo per tempo,<br />
fornire le eventuali ulteriori istruzioni/cautele al proprietario del<br />
veicolo autonomo. Specularmente agli obblighi del costruttore,<br />
anche il proprietario del veicolo autonomo dovrà attivarsi per<br />
procedere a revisioni di carattere tecnologico del proprio veicolo<br />
non solo a scadenze programmate, ma anche su richiesta<br />
del costruttore o di uno degli stakeholder coinvolti nella circolazione<br />
e dovrà anche rispondere, al di fuori del suo ordinario utilizzo,<br />
per mancato rispetto delle istruzioni o avvertenze comunicate<br />
dal costruttore. Vi è poi la problematica connessa con la<br />
possibilità di mancanza di comunicazione, per i motivi più vari,<br />
del singolo veicolo automatico con le infrastrutture e con gli altri<br />
veicoli circolanti (difetto occasionale di funzionamento di qual-<br />
Mobilità&Traffico<br />
che indice interno, assenza di copertura delle comunicazioni o<br />
della geolocalizzazione, difetti delle altre vetture circolanti, carenze<br />
o interruzioni di servizio delle infrastrutture, rischio di<br />
azione da parte di pirati informatici, profili inerenti alla cybersecurity,<br />
ecc.). Infine, anche per i gestori di strade e autostrade<br />
e per quelli dei sistemi ITS si pongono le stesse problematiche<br />
già prospettate nei confronti dei costruttori, giacché anche per<br />
essi si deve pensare alla costituzione di uno o più organismi tra<br />
le imprese esercenti e a un’assicurazione obbligatori. Anche se<br />
di fatto tale prototipo di copertura assicurativa al momento non<br />
può trovare concreto utilizzo, non essendo ancora in circolazione<br />
auto completamente autonome su strade pubbliche, questa<br />
nuova formula contrattuale - già ipotizzata per esempio in<br />
UK - è particolarmente interessante, perché si pone nell’ottica<br />
di creare le condizioni necessarie per la diffusione della nuova<br />
forma di mobilità. Ovviamente si tratta di una prima ipotesi,<br />
fermo restando che ogni singolo mercato studierà i prodotti<br />
assicurativi più adatti alle proprie peculiarità.<br />
Rivoluzione assicurativa<br />
L’introduzione del veicolo autonomo comporterà un radicale<br />
cambiamento per quanto riguarda il sistema delle assicurazioni<br />
auto. Se oggi, infatti, la RC auto copre solo gli eventuali ri-<br />
© connectedautomateddriving.eu<br />
schi cagionati a persone o cose, quando le automobili driverless<br />
termineranno la lunga fase di sperimentazione e arriveranno<br />
su strada, sarà probabilmente necessario assicurare anche il<br />
software, i sensori e i produttori della macchina. L’obiettivo sarà<br />
quello di trovare una base comune per armonizzare l’accesso ai<br />
dati, la regolamentazione in materia di responsabilità, la tecnologia<br />
e lo spettro radio per la connettività. Il tema è molto sentito<br />
perché si stima che l’avvento delle auto driverless potrebbe<br />
portare enormi benefici per la sicurezza sulle strade, dato<br />
che il 90% degli incidenti d’auto sono causati da errori umani.<br />
Sulle case non ricadrà la responsabilità oggettiva, ma gli enti<br />
saranno responsabili del mantenimento dei servizi. La futura<br />
rivoluzione delle auto a guida autonoma (per ora è guida assistita),<br />
se e quando avverrà, avrà ripercussioni anche sul settore<br />
assicurativo. Oggi, infatti, la RCA obbligatoria copre i danni<br />
a terzi causati dal guidatore, mentre il risarcimento spetta per<br />
intero alla compagnia. Ma un domani, con le vetture robot senza<br />
conducente, su chi ricadrà la responsabilità? Un documento<br />
dell’ANIA (l’Associazione delle assicurazioni) cerca di analizzare<br />
i possibili scenari che riguardano le compagnie in materia<br />
di RCA, in presenza di incidenti che coinvolgono le “self-driving<br />
cars”: si tratta di riflessioni su come potrebbe evolversi il settore<br />
RC auto nelle “smart cities”, le “città intelligenti”, con infrastrutture<br />
adeguate alle macchine che guidano da sé e che sono<br />
sempre connesse. In basso trovate solo alcuni spunti tratti dal<br />
documento Ania, che è molto lungo e articolato.<br />
Situazione attuale<br />
e cambiamenti futuri<br />
Oggi, la responsabilità del proprietario e del conducente del veicolo<br />
in caso di incidenti da circolazione stradale, secondo i sistemi<br />
giuridici, può essere configurata in vario modo. In Italia, una<br />
volta acquistato e omologato, un veicolo a motore entra nel possesso<br />
e nella disponibilità del suo proprietario: questi risponde<br />
pienamente del veicolo e di quanto avviene con il suo consenso,<br />
per difetti di manutenzione e persino per i vizi di costruzione.<br />
C’è una specie di responsabilità aggravata. Uno dei primi profili<br />
che cambierà in modo sostanziale è quello relativo al diverso<br />
coinvolgimento del costruttore di auto, dice l’ANIA. Infatti, è la<br />
Casa che metterà sul mercato veicoli dotati di sistemi hardware<br />
e software di gestione del mezzo autonomo e di comunicazione<br />
con altri veicoli/infrastrutture. Risultato: c’è la probabilità<br />
di un aggravio del grado di responsabilità della Casa in caso<br />
si verifichi un sinistro. Anche dopo la vendita del veicolo, il produttore<br />
sarà comunque tenuto a un aggiornamento dei sistemi<br />
ingegneristici. E dovrà fornire le eventuali ulteriori istruzioni/cautele<br />
al proprietario del veicolo autonomo. Non ci sarà una<br />
responsabilità oggettiva delle Case: per il proprietario del veicolo<br />
autonomo si potrebbe configurare una sorta di responsabilità<br />
in solido con quella del costruttore. Per ipotesi, il proprietario<br />
resta anche responsabile di uso del veicolo autonomo sia quando<br />
il “pilota automatico” è disinserito, sia quando l’auto autonoma<br />
è utilizzata oltre le sue possibilità o capacità.<br />
Responsabilità di gestori<br />
e ruolo degli assicuratori<br />
Attenzione poi alle responsabilità poste a carico dei gestori<br />
(pubblici e privati) di strade e autostrade e dei gestori (pubblici)<br />
dei sistemi che le realizzano e gestiscono. A questo fine,<br />
occorre definire un quadro tecnico operativo comune: l’ANIA<br />
parla di una lista minima di standard e di funzioni necessarie<br />
per tutti gli operatori coinvolti nell’ambito dei sistemi stradali<br />
e delle “smart road”. Alcune responsabilità, infatti, potrebbero<br />
interessare la mancata messa in sicurezza della viabilità.<br />
La circolazione delle auto robot, per l’ANIA, non è neppure<br />
immaginabile senza l’intervento e il sussidio degli assicuratori<br />
a protezione degli utenti. Inoltre, per registrare e comunicare<br />
informazioni, il veicolo autonomo dovrebbe essere dotato<br />
di una propria scatola nera sofisticata. L’obiettivo? Monitorare<br />
costantemente il comportamento della vettura e segnalare<br />
eventuali problemi.<br />
Incidenti e incassi RCA<br />
L’eventuale errore nella predisposizione di un software di guida,<br />
evidenzia l’ANIA, potrebbe produrre effetti catastrofici:<br />
meno sinistri di entità minore, che sono attualmente la maggioranza<br />
degli incidenti, ma più incidenti gravi. Il motivo? Il<br />
maggior grado di sofisticazione e il maggior valore dei veicoli<br />
autonomi e dei danni materiali subiti. Stando a stime recenti,<br />
le auto saranno sempre più sicure con l’utilizzo della tecnologia<br />
e si verificheranno molti meno incidenti. Si calcola che in<br />
totale le perdite del settore, relative agli importi pagati per gli<br />
incidenti automobilistici, potrebbero ammontare a circa 122<br />
miliardi di dollari, grazie alla riduzione del numero di incidenti.<br />
Con un calo della frequenza dei sinistri di circa il 90% entro<br />
il 2050, ed evidenti impatti sui premi Rc auto.<br />
I numeri<br />
Già oggi 7 consumatori su 10 ritengono che siano più abili dei<br />
piloti in carne e ossa e che supereranno le capacità umane entro<br />
il 2029. Appuntamento quindi a tra dieci anni per verificare<br />
l’Ansys Global Autonomous Vehicles Report, uno studio realizzato<br />
per valutare le percezioni degli utenti di tutto il mondo<br />
riguardo ai veicoli autonomi. Percezioni che sembrano ottime,<br />
dato che per molti, il 71%, le auto a guida autonoma<br />
sono meglio delle attuali vetture. E una percentuale ancora più<br />
alta, l’83%, è convinta che nel volgere di dieci anni questi veicoli<br />
saranno più sicuri delle auto guidate da veri piloti, mentre<br />
il 38% pensa che lo siano già. Ovviamente i mezzi che vanno<br />
da soli solleticano soprattutto la fantasia degli utenti più giovani:<br />
l’87% degli intervistati con età tra i 18 e i 24 anni e l’88%<br />
di quelli tra i 25 e i 34 anni hanno dichiarato di essere pronti<br />
a utilizzare un’auto autonoma. Viceversa, il 43% degli intervistati<br />
con più di 65 anni ha risposto che non lo farebbe mai.<br />
Il rapporto con questo genere di veicoli cambia anche a seconda<br />
del Paese di provenienza. E così abbiamo il 97% dei<br />
consumatori cinesi che sono pronti a salire a bordo di un’auto<br />
a guida autonoma, mentre soltanto il 57% dei britannici,<br />
evidentemente più tradizionalisti, si dichiara attratto dall’idea.<br />
Di certo il 59% tra tutti i consumatori intervistati teme<br />
ancora possibili guasti tecnologici. Perché la guida autonoma<br />
diventi una realtà commerciale di cui la gente si fida per<br />
i propri spostamenti, hanno dichiarato i curatori del sondaggio,<br />
è necessario convincere gli utenti, comunque ottimisti,<br />
che gli algoritmi siano in grado di guidare in modo più affidabile<br />
degli uomini.<br />
4/<strong>2021</strong><br />
Mobilità&Traffico
52<br />
Sfida assicurativa senza precedenti<br />
“Assicurare le auto a guida autonoma è una sfida assicurativa<br />
senza precedenti, in quanto genereranno enormi volumi di<br />
dati da una varietà di parti e saranno costituiti da sistemi complessi<br />
che condividono la responsabilità in modi interconnessi”,<br />
sottolinea Haywood Marsh direttore generale di NetClaim,<br />
una filiale del software assicurativo di NAVEX Global, alla media<br />
company USA Axios. Servono programmi in grado di estrapolare<br />
dati da un numero piccolo di incidenti.<br />
Per questo, si legge su Axios, ciò che serve veramente “indipendentemente<br />
da ciò che sta dietro a un sinistro” è comprendere<br />
il fatto che “l’assicurazione si basa sui dati del passato<br />
per l’analisi predittiva”. E “poiché le auto a guida autonoma<br />
non hanno decenni di registrazioni di sicurezza, gli assicuratori<br />
avranno bisogno di programmi in grado di estrapolare il<br />
maggior numero possibile di informazioni da un piccolo numero<br />
di incidenti iniziali. Una volta stabiliti i set di dati iniziali,<br />
gli assicuratori avranno comunque bisogno di un’intelligenza<br />
artificiale in grado di vagliare tutti i dati rilevanti di un veicolo<br />
da ogni incidente segnalato per assegnare la responsabilità”.<br />
Intelligenza Artificiale<br />
L’Intelligenza Artificiale è già utilizzata nell’assicurazione contro<br />
le tempeste catastrofiche, un’altra sfida assicurativa che comporta<br />
eventi senza precedenti e il vaglio di enormi quantità di<br />
dati. I sistemi basati sull’IA possono funzionare per gli autoveicoli<br />
a guida autonoma in diversi modi, secondo Axios: “Gli<br />
assicuratori potrebbero implementare l’informatica avanzata<br />
dal momento in cui un cliente presenta una richiesta di risarcimento<br />
per iniziare a ordinare i dati del veicolo in base all’incidente<br />
in questione”, osserva Marsh. Inoltre “l’intelligenza artificiale<br />
potrebbe stabilire le priorità e indagare le domande più<br />
importanti in un dato momento e combinare i sinistri segnalati<br />
con le previsioni del tempo e i dati provenienti dai sensori<br />
a terra per ottenere il contesto completo di un incidente”. L’utilizzo<br />
dell’IA durante tutto il processo di revisione dei sinistri<br />
potrebbe infine “aiutare i gestori del rischio a individuare i modelli<br />
e anticipare altri report che potrebbero seguire, sia che si<br />
tratti di un evento meteorologico o di un grande evento di traffico<br />
o di un componente difettoso all’interno dello stack tecnologico<br />
di un’auto a guida autonoma”, ha ammesso il manager.<br />
“L’assicurazione degli autoveicoli a guida autonoma si baserà<br />
su numerosi strumenti di analisi dei dati basati sull’IA: per la<br />
creazione di un database preliminare, per l’analisi dei singoli<br />
incidenti e per l’identificazione di modelli al fine di migliorare<br />
la sicurezza in futuro”, ha concluso Marsh. Axa XL ha annunciato<br />
il lancio di una nuova soluzione assicurativa per coprire i<br />
rischi associati ai veicoli autonomi. La polizza fornisce una copertura<br />
di base della responsabilità civile, danni alla proprietà<br />
assicurata e furto del veicolo. Sono disponibili, inoltre, opzioni<br />
di copertura modulari (ad esempio la responsabilità per danni<br />
a carico dell’assicurato) ed estensioni (copertura informatica).<br />
“Secondo gli analisti del venture capital Pitchbook, negli ultimi<br />
anni gli investimenti nello sviluppo di tecnologie autonome<br />
sono cresciuti enormemente. Nel solo 2018 hanno raggiunto<br />
i 10,3 miliardi di dollari. E anche il numero di aziende che<br />
utilizza macchine intelligenti è in aumento”, spiega Mukadder<br />
Erdoenmez, capo di International Casualty for Europe di Axa<br />
© fintechnews.hk<br />
XL, che guida il team New Economy, Autonomy & Technology<br />
di Axa XL (Neat). Di qui la decisione di creare una polizza ad<br />
hoc come racconta Sinan Geylani, Underwriting Manager, Autonomous<br />
Systems & Vehicles di Axa XL: “Letti i numeri abbiamo<br />
creato una singola polizza personalizzabile per supportare<br />
quelle aziende lungimiranti che stanno già dando forma e utilizzando<br />
tecnologie autonome”. Le tecnologie autonome non<br />
sono una novità per Axa XL. Il player assicurativo del mercato<br />
danni ha all’attivo dal 2016 una collaborazione con Oxbotica,<br />
un’azienda tecnologica specializzata in robotica mobile e sistemi<br />
autonomi mentre nel 2017 ha aderito al consorzio Driven<br />
sostenuto dal governo britannico per contribuire allo spiegamento<br />
di una flotta di veicoli autonomi tra Oxford e Londra. È<br />
del 2018, invece, l’istituzione di un Centro di eccellenza multidisciplinare<br />
sulle tecnologie autonome.<br />
Conclusioni<br />
Per garantire che i rischi associati ai CAV (Connected Automated<br />
Vehicles) siano gestiti in modo appropriato, i politici e i regolatori<br />
possono prendere in considerazione uno spostamento da<br />
una responsabilità personale basata sulla colpa del conducente<br />
o sulla negligenza a un contesto di responsabilità per i prodotti.<br />
Questo passaggio è possibile solo attraverso attente considerazioni.<br />
I meccanismi con cui la responsabilità CAV dovrebbe<br />
essere valutata, e la responsabilità valutata, sono questioni<br />
complesse che implicano dei compromessi. Gli assicuratori dovranno<br />
adattare i loro modelli di tariffazione della copertura assicurativa.<br />
Questi modelli dovranno riconoscere il miglioramento<br />
delle prestazioni della tecnologia nel corso degli anni. I rischi<br />
dovranno anche essere valutati e confrontati con parametri di<br />
riferimento appropriati ed essere considerati in modo olistico.<br />
Affinché i CAV guadagnino un certo slancio, la raccolta dei dati<br />
dovrebbe essere uno sforzo di cooperazione tra tutte le parti<br />
interessate. Durante i test e l’apprendimento, è importante<br />
che l’ecosistema si riunisca. Armati di informazioni condivise,<br />
tutte le parti interessate possono imparare dalle sfide e dalle<br />
esperienze reciproche ed elaborare una tabella di marcia per<br />
la diffusione sicura dei CAV. Le difficoltà intorno ai tentativi di<br />
adattare la legge attuale probabilmente porteranno ad anni di<br />
incertezza per i conducenti e le persone ferite man mano che<br />
l’uso dei CAV aumenta. Ecco perché un maggiore dialogo tra<br />
il pubblico e il governo è importante e probabilmente avrà un<br />
impatto sull’appetito dei consumatori per i CAV. nn<br />
LS<br />
GALLERIE&OPERE<br />
IN SOTTERRANEO<br />
IN QUESTO NUMERO<br />
n Rinascimento ferroviario<br />
n La grande sfida della Periadriatica<br />
n Laboratorio europeo di gestione green<br />
n Chiaia, la stazione che fa viaggiare<br />
la luce agli inferi<br />
n Dalla geometria alla bellezza<br />
n Risolvere i problemi grazie<br />
al know-how<br />
Mobilità&Traffico<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade
54<br />
55<br />
LS<br />
Nodi Urbani<br />
Rinascimento<br />
ferroviario<br />
Edvige Viazzoli<br />
2. Rete TEN-T e strategicità<br />
di Firenze nel contesto del Corridoio<br />
Scandinavo-Mediterraneo<br />
vimento di persone, merci, beni e servizi. Dei nove corridoi<br />
TEN-T, quattro interessano direttamente l’Italia, il più esteso<br />
dei quali è il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, ed è proprio<br />
in questo contesto che si inserisce il Nodo AV di Firenze.<br />
Si tratta dunque di un’opportunità unica di sviluppo per l’accessibilità<br />
e la centralità di Firenze, una delle città d’arte più<br />
visitate in Europa.<br />
La nuova configurazione del Nodo AV permetterà di raggiungere<br />
il capoluogo toscano con maggiore velocità e frequenza,<br />
e lo doterà di una grande e nuova stazione a servizio, non<br />
solo dell’utenza ferroviaria, ma dell’intero tessuto urbano. Il<br />
sistema di mobilità urbana ne trarrà importanti benefici: l’intervento<br />
complessivo consentirà infatti di superare la congestione<br />
del traffico ferroviario in entrata nella stazione di Santa<br />
Maria Novella, attraverso una riduzione dei tempi di transito<br />
e la separazione tra treni regionali e treni AV. Permetterà<br />
inoltre di sviluppare il sistema ferroviario metropolitano della<br />
Città di Firenze e di garantire la regolarità del Nodo AV. Dal<br />
punto di vista urbanistico, la realizzazione di gran parte delle<br />
opere in sotterraneo garantirà il rispetto dei vincoli paesaggistici<br />
e architettonici a tutela dell’estetica di Firenze, città patrimonio<br />
dell’Unesco sin dal 1982. Lo sviluppo del progetto<br />
Gallerie<br />
1. Vediamo il futuro: rendering<br />
della nuova stazione AV di Firenze<br />
Belfiore e riqualificazione a verde<br />
dell’area<br />
3. Tracciato<br />
dell’infrastruttura<br />
FOCUS SULLA NUOVA CONFIGURAZIONE PROGETTUALE DEL NODO FIORENTINO<br />
DELL’ALTA VELOCITÀ E SULLE LINEE STRATEGICHE CHE NE GUIDANO<br />
L’AZIONE, A PARTIRE DALLA SOSTENIBILITÀ (CON L’ADESIONE A ENVISION)<br />
E AL COINVOLGIMENTO DI SCUOLE E COMUNITÀ. L’INFRASTRUTTURA<br />
SOTTERRANEA - DUNQUE IDEALE PER IL CONTESTO - PORTERÀ NOTEVOLI<br />
BENEFICI ANCHE IN TERMINI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA.<br />
Nel mese di marzo 2020 Infrarail Firenze, società del<br />
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è stata incaricata<br />
da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) dell’aggiornamento<br />
del Progetto Esecutivo del “Nodo AV di Firenze”, in vista<br />
del successivo riavvio dei lavori. Il progetto si inserisce<br />
in un più ampio progetto europeo, la Rete Transeuropea dei<br />
Trasporti TEN-T (Trans-European Transport Network), il quale<br />
si pone come obiettivo principale la creazione di un’“Europa<br />
connessa”, attraverso una rete dei trasporti in grado di promuovere<br />
la crescita e la competitività grazie alla libertà di mo-<br />
nel suo complesso punta anche alla valorizzazione e alla riqualificazione<br />
del contesto urbano circostante la nuova stazione<br />
AV Belfiore, con l’idea di restituire alla città di Firenze,<br />
una volta ultimati i lavori, un’area urbana che possa integrarsi<br />
al meglio con il nuovo nodo intermodale, attraverso la realizzazione<br />
di un hub, anche con funzione di terminale per gli<br />
autobus turistici e regionali, e di un people mover collegato<br />
alla Stazione di Santa Maria Novella.<br />
Mobilità integrata e sostenibile<br />
Il collegamento tra Santa Maria Novella e la nuova stazione di<br />
Firenze Belfiore, nonché lo studio del nuovo assetto del nodo,<br />
parte dagli assunti presenti nel Piano Urbano della Mobilità<br />
Sostenibile (PUMS): la città di Firenze, infatti, tramite l’adozione<br />
del PUMS (1/8/2019), ha posto come obiettivo prin-<br />
4. Itinerario e numeri del progetto<br />
Gallerie<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
56<br />
57<br />
LS<br />
5. Sezione dell’opera<br />
9<br />
cipale la realizzazione di un sistema di mobilità integrato e<br />
sostenibile, articolato in diverse modalità, orientate al contenimento<br />
degli impatti generati dai mezzi di trasporto. La<br />
strategia del Piano, ripresa dalle Ferrovie dello Stato Italiane,<br />
si fonda su un insieme equilibrato di interventi che conducono<br />
al potenziamento del trasporto pubblico intermodale<br />
e, contemporaneamente, individuano un assetto del trasporto<br />
privato, in grado di agevolare gli spostamenti, eliminando<br />
i punti di congestione e di frizione con il trasporto pubblico. Il<br />
tratto urbano della nuova linea AV/AC si svilupperà per oltre<br />
7 km in sotterraneo, con due gallerie a singolo binario, tra le<br />
attuali stazioni di Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte e,<br />
in superficie, nei tratti terminali di Castello-Rifredi e di Campo<br />
di Marte-Rovezzano. Nell’ambito del potenziamento della<br />
linea AV Roma-Milano, lungo il tracciato in sotterraneo in<br />
zona Belfiore-Macelli, è prevista la realizzazione della nuova<br />
Stazione AV di Firenze Belfiore, un hub intermodale baricentrico<br />
fra l’aeroporto di Firenze Peretola e la stazione di Santa<br />
Maria Novella, tramite una fermata dedicata lungo la nuova<br />
linea tramviaria 2 “Piazza dell’Unità-Aeroporto Peretola”.<br />
Della stazione sono già state ultimate le opere perimetrali di<br />
contenimento del camerone interrato.<br />
Scavo meccanizzato<br />
L’utilizzo dello spazio sotterraneo di Firenze è reso possibile<br />
grazie alla sapiente interazione tra uomo e macchina: da un<br />
lato l’applicazione delle più affidabili tecnologie costruttive,<br />
dall’altro il continuo confronto e il rigoroso coordinamento di<br />
ingegneri, architetti, geologi, geotecnici, ecc.<br />
Tutto ciò è indispensabile specialmente in contesti urbani in<br />
cui è necessario adottare le più attente e adeguate precauzioni,<br />
affinché si possano minimizzare gli impatti negativi<br />
sullo spazio sotterraneo, il quale costituisce di per sé una risorsa<br />
naturale da preservare. Lo scavo delle gallerie avverrà<br />
per mezzo di una TBM EPB, che scaverà da Campo di Marte<br />
fino al diaframma Sud del camerone di Stazione (ubicato<br />
in corrispondenza dell’attuale fermata della tramvia “Viale<br />
Redi”). La TBM, dopo essere stata traslata all’interno del<br />
6<br />
7<br />
6. Conci (modello BIM)<br />
7. TBM (Tunnel Boring<br />
Machine)<br />
8<br />
8. Scudo<br />
9. Back-up della maxifresa<br />
in notturna<br />
10. Sezioni e vista prospettica<br />
della stazione<br />
camerone di Stazione e delle gallerie a doppio binario a Nord<br />
della stessa, riprenderà poi lo scavo dal pozzo di ventilazione<br />
Nord (ex Centrale del Latte) fino a Rifredi. A ridosso del<br />
cosiddetto “Scavalco”, è previsto il “pozzo di smontaggio fresa”<br />
dove verrà smontato lo scudo e, successivamente, tutti<br />
gli altri elementi della TBM, i quali verranno trasferiti a Campo<br />
di Marte e riassemblati per lo scavo della seconda galleria.<br />
La tecnica di scavo utilizzata permette di mantenere sempre<br />
una pressione sul fronte e di contenere le deformazioni del<br />
cavo, rivestendo la galleria, a brevissima distanza dal fronte,<br />
con anelli prefabbricati impermeabili. Tale operazione avviene<br />
man mano che avanzano gli scavi e ciò consente di assi-<br />
10<br />
curare la stabilità e l’impermeabilità della cavità. I conci impiegati<br />
avranno guarnizioni incassate, in grado di assicurare<br />
il mantenimento in sede della guarnizione stessa in fase di<br />
posa. Attraverso la contropressione esercitata sul fronte di<br />
scavo dal “cake” presente nella camera di scavo della macchina,<br />
il sistema è in grado di evitare venute d’acqua dal fronte,<br />
anche con l’aiuto di additivi iniettati direttamente nella camera<br />
di scavo. In questo modo, è possibile evitare di turbare<br />
le condizioni idrogeologiche e di innescare inauspicati cedimenti<br />
del terreno. L’adozione della tecnologia meccanizzata<br />
per lo scavo delle gallerie comporta l’impiego di schiume,<br />
fanghi polimerici o bentonitici. Nel caso specifico del Passante<br />
AV di Firenze, le desiderate caratteristiche del cake saranno<br />
ottenute impiegando:<br />
• Schiuma → Polyfoamer ECO/100 (2,25 l/m 3 terreni argillosi<br />
- 1,75 l/m 3 terreni sabbiosi)<br />
• Acqua → 400 ÷ 500 l/m 3<br />
• Polimeri/bentonite →1 ÷ 3%.<br />
La schiuma Polyfoamer ECO/100 è una schiuma testata dal<br />
CNR in grado di garantire che, alla sua disidratazione, il materiale<br />
di scavo rispetti i limiti di CSC (Concentrazioni Soglia<br />
di Contaminazione) previsti nella Colonna A della Tabella 1,<br />
Allegato 5, Parte IV del D.lgs. 152/2006.<br />
Dunque, una volta trattato secondo i protocolli stabiliti dal<br />
“Piano di Utilizzo delle Terre”, il materiale scavato non presen-<br />
Gallerie<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade
58<br />
59<br />
LS<br />
terà alcuna tossicità, ma, al contrario, potrà essere utilmente<br />
reimpiegato nella realizzazione del progetto di rinaturazione<br />
della ex cava di lignite ubicata in località S.Barbara (Cavriglia-<br />
AR), sfruttata dall’ ENEL per alimentare la vecchia centrale<br />
a carbone, oggi soppiantata da una centrale Turbogas. Pertanto,<br />
nel realizzare l’indispensabile infrastruttura ferroviaria<br />
in Firenze, si rimodella una vasta area ubicata a circa 50 km,<br />
altrimenti destinata ad un inevitabile degrado ambientale.<br />
La nuova stazione di Firenze Belfiore<br />
La nuova stazione AV di Firenze Belfiore sorgerà su parte<br />
dell’area Belfiore-Macelli, adiacente all’attuale sede ferroviaria.<br />
Il progetto, redatto da Foster & Arup, prevede la costruzione<br />
di una struttura con il livello delle rotaie collocato a circa<br />
25 metri sotto il livello del suolo (+ 24.50 m s.l.m.), nonché<br />
una camera sotterranea lunga 454 m e larga 53 m. Nel progetto<br />
si possono riconoscere tre elementi principali:<br />
• Il volume interrato, detto “Camerone”;<br />
• I piani fuori terra;<br />
• La copertura a volta ribassata.<br />
L’elemento architettonico di maggiore rilievo della nuova Stazione<br />
AV di Firenze Belfiore è rappresentato da una grande<br />
copertura vetrata sorretta da una struttura in acciaio, che richiama<br />
la tradizione delle imponenti stazioni ferroviarie, sicuramente<br />
tra i più begli esempi di architettura industriale ereditati<br />
dall’Ottocento. Ma la copertura di Foster ha contenuti<br />
innovativi, quali un sistema multilayer dove ciascuna componente<br />
assolve a funzioni diverse; la copertura è articolata in<br />
elementi, la cui struttura variabile garantisce il controllo ambientale<br />
e acustico, l’illuminazione naturale, il ricambio dell’aria<br />
e l’evacuazione dei fumi. Qui, come nei suoi più recenti<br />
edifici, Sir Norman Foster ha adottato soluzioni tecnologiche<br />
che prevedono l’impiego di materiali rinnovabili, riducono il<br />
fabbisogno di energia e l’emissione di sostanze inquinanti.<br />
Quella di Firenze è una tipologia di stazione completamente<br />
nuova per l’Italia. Si tratta, infatti, di una stazione interrata,<br />
nella quale anche i livelli inferiori godono di illuminazione<br />
naturale grazie alla felice configurazione verticale dell’opera,<br />
così facilitando l’orientamento dei viaggiatori e rendendo<br />
maggiormente vivibili tutti gli spazi a disposizione.<br />
Obiettivo sostenibilità<br />
Il progetto della Stazione Alta Velocità di Firenze non solo si<br />
prefigge l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei passeggeri<br />
e dei visitatori della stazione, ma offre anche nuove opportunità<br />
per il commercio e il tempo libero alla comunità locale,<br />
proponendosi di addivenire alla realizzazione di un’opera<br />
realmente “sostenibile”. Ed è proprio quest’ultima che Infrarail<br />
Firenze intende coinvolgere a 360 gradi nel corso dell’avanzamento<br />
dei lavori. Il coinvolgimento della popolazione<br />
locale è un elemento fondamentale anche nell’ambito della<br />
progettazione e della realizzazione di un’infrastruttura sostenibile.<br />
Uno degli obiettivi che si pone IFR è infatti quello di<br />
aderire al protocollo Envision, sistema di rating internazionale<br />
utilizzato per misurare la sostenibilità di un progetto infrastrutturale.<br />
Questo sistema consente di valutare l’impatto<br />
potenziale di un’opera sulla collettività e sul territorio. Gli<br />
elementi specifici, oggetto di valutazione, sono i seguenti:<br />
11<br />
12<br />
• Effetti sulla qualità della vita;<br />
• Effetti sulla mobilità;<br />
• Grado di coinvolgimento della collettività;<br />
• Sviluppo economico che deriva dalla realizzazione dell’infrastruttura;<br />
• Grado di utilizzo delle risorse naturali e delle energie rinnovabili;<br />
• Grado di salvaguardia dell’ambiente naturale;<br />
• Riduzione delle emissioni.<br />
In questa prima fase del progetto, gli accorgimenti che IFR<br />
sta mettendo in atto nell’ambito delle strategie per lo sviluppo<br />
sostenibile, spaziano dalla scelta di impiegare, per tutta la<br />
durata dei cantieri di costruzione, macchinari, attrezzature e<br />
11. Rendering esterno<br />
12. Rendering interno<br />
13 14<br />
13, 14. Infopoint Infrarail<br />
Firenze<br />
15. Modello in Lego della<br />
stazione AV<br />
16. “Rinascimento” fiorentino<br />
in corso, anche grazie<br />
ad approcci alla costruzione<br />
di infrastrutture di comunità<br />
come quello di Infrarail<br />
Firenze<br />
Si ringrazia Raffaele Zurlo, Amministratore<br />
Delegato di Infrarail<br />
Firenze (Gruppo FS Italiane) e<br />
Noemi Caruana, Infrarail Firenze,<br />
per la collaborazione prestata<br />
nella stesura di questo articolo.<br />
16<br />
mezzi d’opera “green”, dotati di motori ibridi e, in alcuni casi,<br />
di motori elettrici all’utilizzo di materiale di consumo biodegradabile<br />
presso gli uffici di cantiere e il campo base (carta,<br />
sacchetti, bicchieri, piatti, posate, ecc.). Al fine di incoraggiare<br />
la partecipazione della comunità e informarla in merito<br />
ai benefici derivanti dalla costruzione delle opere del progetto,<br />
IFR ha messo a disposizione della popolazione, presso il<br />
campo base della stazione AV, sito in via Circondaria, 32-34<br />
- 50127 Firenze, un Infopoint all’interno del quale, durante<br />
l’intero periodo di esecuzione dei lavori, sarà possibile avere<br />
notizie e curiosità sul Nodo AV di Firenze e sullo stato di<br />
avanzamento dei lavori stessi.<br />
Laboratorio di futuro<br />
I princìpi ai quali si ispira IFR sono, infatti, quelli della corretta<br />
informazione e della massima trasparenza. Tra i principali<br />
obiettivi della Società, oltre al miglioramento della mobilità<br />
urbana e alla preservazione della grande bellezza di Firenze,<br />
vi è anche la sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso la<br />
realizzazione di infrastrutture moderne, efficienti e sostenibili,<br />
strumento indispensabile ai fini del decongestionamento del<br />
traffico delle nostre città e di una significativa riduzione dell’impatto<br />
ambientale. Nell’ambito delle attività di comunicazione<br />
e formazione, IFR incoraggia altresì la collaborazione con università<br />
e scuole di ogni ordine e grado. Nel 2020, attraverso la<br />
collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, sono sta-<br />
15<br />
ti avviati N° 3 stage formativi, grazie ai quali tre studentesse<br />
della Facoltà di Ingegneria Civile di Firenze sono state impiegate<br />
all’interno della Struttura “Servizi Tecnici di Progettazione”<br />
di Infrarail e, successivamente, al termine del periodo di<br />
stage, inserite nell’organico di Infrarail. È stato inoltre avviato<br />
uno stage nell’ambito del Master “Geotecnica per le Infrastrutture”<br />
dell’Università di Napoli Federico II, nell’ambito della<br />
struttura “Servizi Tecnici di Cantiere” di Infrarail. La Società<br />
sta dando vita a una vera e propria “Infrarail Academy”, grazie<br />
alla quale sarà possibile contribuire alla ricerca, allo scambio<br />
culturale e alla formazione dei giovani nell’ambito della progettazione<br />
e della costruzione del “Nodo AV di Firenze”. Come<br />
si è avuto modo di constatare in altri ambiti, quali la Galleria<br />
di Base del Brennero, l’abbinamento dell’insegnamento universitario<br />
e l’attività sul campo, ove opportunamente dosato e<br />
guidato da docenti e da tecnici esperti, consente di pervenire<br />
a risultati molto soddisfacenti. Per la Società pubblica Infrarail<br />
Firenze, coerentemente con gli indirizzi del Gruppo Ferrovie<br />
dello Stato Italiane, l’osservanza rigorosa delle norme vigenti,<br />
il rispetto delle posizioni di tutti gli stakeholders e la trasparenza<br />
nell’agire sono valori ed obblighi imprescindibili. nn<br />
Gallerie<br />
Gallerie<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
60<br />
61<br />
LS<br />
Trafori Alpini<br />
La grande sfida<br />
della Periadriatica<br />
David Marini<br />
Giuseppe Venditti<br />
Galleria di Base del Brennero<br />
Brenner Basistunnel BBT SE<br />
A DIECI ANNI DALL’AVVIO DEI LAVORI DEL LOTTO (2011), GLI SPECIALISTI DI BBT<br />
RICOSTRUISCONO L’ESPERIENZA MATURATA NELL’ATTRAVERSAMENTO DELLA<br />
FAGLIA TETTONICA “PERIADRIATICA”, NELL’AMBITO DEL CUNICOLO ESPLORATIVO.<br />
UN INTERVENTO DI ALTO VALORE INGEGNERISTICO NEL QUALE L’APPROCCIO CON<br />
MONITORAGGIO CONTINUO, SUL CAMPO, È RISULTATO DETERMINANTE DA UN<br />
LATO PER COMPIERE LE MIGLIORI SCELTE ESECUTIVE, DALL’ALTRO PER ACQUISIRE<br />
METODICHE E DATI PREZIOSI PER GLI INTERVENTI SUCCESSIVI.<br />
Sotto il Passo del Brennero, tra Italia e Austria, è in corso<br />
di realizzazione il collegamento ferroviario sotterraneo<br />
destinato a diventare il più lungo del mondo nel<br />
suo genere: la Galleria di Base del Brennero, che collegherà<br />
il Land Tirolo con l’Alto Adige consentendo di superare la<br />
barriera naturale delle Alpi e riducendo in modo significativo<br />
i tempi di percorrenza sia per quanto riguarda il traffico merci,<br />
sia per il trasporto delle persone. L’opera fa parte del corridoio<br />
comunitario TEN-T Scandinavo-Mediterraneo (SCAN-<br />
MED) ed è considerata “a priorità elevatissima” nei piani di<br />
infrastrutturazione dell’Unione Europea. La Galleria di Base<br />
1<br />
del Brennero è unanimemente riconosciuta come un’opera di<br />
ingegneria all’avanguardia, fondata su un sistema di costruzioni<br />
sotterranee comprendente un cunicolo esplorativo, due<br />
gallerie principali e quattro gallerie di accesso laterali. Queste<br />
ultime - ubicate ad Ampass, nella Ahrental, a Wolf (Steinach<br />
am Brenner) sul lato austriaco e vicino a Mules, su quello italiano<br />
- assolvono a un duplice compito: collegare la superficie<br />
con le canne principali e, in fase di costruzione, fungere<br />
da canale logistico sia per il trasporto nei depositi del materiale<br />
da scavo, sia per garantire la fornitura dei materiali per<br />
la costruzione del sistema di tunnel. Tra Innsbruck e Fortez-<br />
1. Immagine del fronte<br />
di scavo<br />
2. Tratto della Galleria di Base<br />
del Brennero interferente con<br />
la Faglia Periadriatica<br />
3. Sezione di scavo<br />
prevalentemente applicata<br />
2<br />
3<br />
za è quindi prevista la realizzazione di due canne principali a<br />
binario semplice, con interasse pari a circa 70 m. Ogni 333 m<br />
saranno invece realizzati cunicoli trasversali di collegamento<br />
tra le canne principali, anch’essi aventi a funzioni logistiche<br />
e, soprattutto, futuri elementi chiavi nei piani di gestione<br />
delle emergenze. Una particolarità della Galleria di Base<br />
del Brennero è infine costituita dall’infrastruttura “cunicolo<br />
esplorativo”, che si estende da un’estremità all’altra dell’itinerario<br />
ferroviario sotterraneo sviluppandosi in asse a un<br />
quota di circa 12 m sotto le due canne principali. Il cunicolo<br />
esplorativo è risultato determinante nella fase delle prospezioni<br />
geologiche, lo è nell’attuale fase di costruzione nelle attività<br />
connesse alla logistica di cantiere e lo sarà durante la<br />
fase di esercizio, nelle operazioni di manutenzione e drenaggio.<br />
Nel suo complesso, il progetto Galleria di Base del Brennero<br />
comprende oltre 200 km di gallerie: una vera e propria<br />
“città sotterranea”.<br />
Contesto esecutivo<br />
Attualmente sono attivi quattro cantieri principali includendo<br />
sia quelli sul lato Austria (Gola del Sill, Tulfes-Pfons), sia quelli<br />
sul lato Italia (Sottoattraversamento Isarco e Mules 2-3). In<br />
questo articolo tecnico, approfondiremo alcuni aspetti geologici<br />
e geotecnici riguardanti una serie di attività e lavorazioni<br />
avvenute proprio in Italia, nell’ambito della realizzazione del<br />
tratto di cunicolo esplorativo denominato “Linea Periadriatica”.<br />
Attraverso il prolungamento del cunicolo all’interno di<br />
una zona geologicamente complessa come, per l’appunto, la<br />
“Linea Periadriatica” e la contestuale costruzione di una serie<br />
di opere di supporto logistico in ambito Mules, è stato infatti<br />
possibile da un lato acquisire le informazioni necessarie<br />
per supportare la progettazione delle tratte di galleria di<br />
linea in quel particolare contesto geologico, dall’altro organizzare<br />
la logistica di gestione dei materiali di smarino e approvvigionamento,<br />
così da ridurre al minimo l’impatto delle<br />
attività sul territorio, ottimizzando infine i tempi di costruzione<br />
degli interventi principali.<br />
Nello specifico, le opere realizzate in questo lotto costruttivo<br />
sono consistite in un tratto del cunicolo esplorativo attraverso<br />
il lineamento tettonico “periadriatico”, per un’estensione di<br />
circa 2 km in direzione Nord a partire dal punto di innesto della<br />
Finestra di Mules e in asse al tracciato delle gallerie di linea<br />
della Galleria di Base del Brennero, nonché, come accennato,<br />
nelle cosiddette “Opere Propedeutiche ambito Mules”, una<br />
serie di cunicoli, caverne e gallerie, sempre localizzate in corrispondenza<br />
del punto d’innesto della Finestra di Mules, per<br />
un’estensione pari a circa 200 m in direzione Sud e a circa 1,5<br />
km in direzione Nord. I lavori del lotto, a seguito di gara d’appalto<br />
europea, sono stati affidati al Consorzio Brennero 2011,<br />
costituito dalle imprese PAC SpA, Oberosler Cav. Pietro SpA,<br />
Implenia Construction SA e Cogei SpA, che hanno avviato i<br />
cantieri nel settembre 2011. Le attività esecutive, svolte nel rispetto<br />
dei tempi e dei costi disciplinati contrattualmente, sono<br />
state quindi concluse nel luglio 2015. Ci troviamo dunque a<br />
esattamente dieci anni dall’inizio delle lavorazioni: una “giusta<br />
distanza” a cui va sommato, retrospettivamente, il periodo<br />
dell’articolata attività progettuale e dei contestuali monitoraggi.<br />
Con il senno di poi, come vedremo, possiamo dire che un<br />
Gallerie<br />
Gallerie<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
62<br />
63<br />
LS<br />
approccio di questo genere alle particolari complessità tecniche<br />
che un’opera di attraversamento come quella del Brennero<br />
può riservare alla fine si è rivelato foriero di buone pratiche<br />
metodologiche e operative. Di qui l’interesse nel divulgarlo in<br />
varie sedi, scientifiche così come informative, e condividerlo<br />
dunque con la più ampia comunità tecnica.<br />
Cenni geologici<br />
Prendendo in considerazione il solo tratto del versante italiano,<br />
la Galleria di Base del Brennero attraversa le maggiori<br />
unità tettoniche che compongono la catena delle Alpi,<br />
che si presentano in genere sotto forma di falde sovrapposte<br />
e rappresentano i residui dell’area di collisione tra la<br />
placca europea e quella adriatico-africana. Le Faglie di Mules<br />
e della Pusteria, nello specifico, appartengono al Lineamento<br />
Periadriatico, un insieme di dislocamenti tettonici<br />
a scala regionale che si estendono lungo tutto l’arco alpino<br />
separando due catene orogeniche a vergenza opposta. Attivo<br />
fin dal Giurassico, il Lineamento Periadriatico assume<br />
diverse denominazioni a seconda della regione di interesse:<br />
Linea Insubrica, Linea delle Giudicarie, Linea del Canavese<br />
e via dicendo.<br />
Nell’area interessata dalla realizzazione della Galleria di Base<br />
del Brennero si interpone tra il Granito di Bressanone, a Sud,<br />
e il basamento polimetamorfico indifferenziato Austroalpino<br />
a Nord. Riservando ad altri contesti e ad altre sedi approfondimenti<br />
più dettagliati sul quadro geologico dell’area, frutto<br />
peraltro di continui approfondimenti geognostici, ci limitiamo<br />
qui a riportare alcune considerazioni di evoluzione progettuale<br />
utili a comprendere meglio il contestuale modus<br />
operandi. In fase di progetto preliminare (2002) era stata<br />
ipotizzata una potenza complessiva di roccia interessata dal<br />
disturbo tettonico pari a circa 1 km, comprensiva però della<br />
lamella tonalitica. Il progetto definitivo del 2008 aveva invece<br />
individuato due gruppi di strutture: la Faglia della Pusteria<br />
a Sud delle tonaliti e l’insieme di faglie di Sprechenstein/Val<br />
di Mules a Nord, rispettivamente caratterizzate da un’estensione<br />
di circa 150 e 400 m. Un assetto strutturale confermato<br />
nell’aggiornamento del 2013, che aveva anche attestato<br />
un incremento di potenza delle due faglie portandole a 220<br />
e 600 m. A consuntivo, nel 2014, questo incremento fu confermato<br />
soltanto per le faglie di Sprechenstein/Val di Mules<br />
(che nella presente trattazione rappresentano la “Periadriatica”<br />
propriamente detta) valutandone le potenza nell’ordine,<br />
per l’appunto, di quasi 800 m di rocce cataclasate. La core<br />
zone del Lineamento Periadriatico è risultata alla fine composta<br />
prevalentemente da cataclasiti, miloniti, ultracataclasiti<br />
(cachiriti) con intervalli decametrici di corpi quarzitici e<br />
metarenitici che, essendo caratterizzati da maggiore competenza,<br />
hanno meglio resistito alla deformazione risultando<br />
dunque meno danneggiati.<br />
Indagini e sondaggi<br />
Per quanto riguarda l’esplorazione geologica e idrogeologica<br />
funzionale alla realizzazione della Galleria di Base del Brennero,<br />
in primo luogo sono stati eseguiti estesi rilievi di superficie<br />
e numerosi carotaggi profondi, che in parte hanno raggiunto<br />
la quota galleria. Dai fori di sondaggio sono state effettuate<br />
prove geofisiche, idrauliche, meccaniche, nonché prove per la<br />
determinazione dello stato tensionale in sito. L’analisi dei dati<br />
raccolti ha permesso la definizione di un modello geologico e<br />
di un modello idrogeologico di previsione, sulla base dei quali<br />
è stato quindi definito il modello geomeccanico. La zona interessata<br />
dalle esplorazioni geologiche presenta uno spessore<br />
di copertura rocciosa compreso tra 500 e 1000 m, nonostante<br />
l’impiego delle tecniche geognostiche più elevate, permaneva<br />
tuttavia una residua “incertezza” di natura geologica per<br />
fugare la quale il progetto della Galleria di Base del Brennero<br />
ha previsto lo scavo preventivo di un cunicolo esplorativo, con<br />
finalità geognostiche, in grado di fornire elementi conoscitivi<br />
in tempo utile per l’ottimizzazione dello scavo delle successive<br />
gallerie di linea. In generale, oltre alle informazioni originate<br />
dalla fase progettuale, gli esecutori hanno sempre potuto contare<br />
su un cospicuo corpus di dati derivanti dalla sistematica<br />
esecuzione di sondaggi contestuali all’avanzamento dal fronte<br />
di scavo del cunicolo esplorativo, che, per così dire, si trovava<br />
ad “anticipare” di alcuni chilometri lo scavo delle gallerie<br />
di linea. Questo approccio, come già rilevato in precedenza,<br />
avrebbe pertanto apportato un contributo oltremodo significativo<br />
nella gestione dei rischi di natura geologica derivanti dallo<br />
scavo degli stessi “main tunnel”.<br />
5<br />
4<br />
4. Dettaglio dello schema<br />
tettonico nell’area<br />
di interesse della Galleria<br />
di Base del Brennero<br />
(linea rossa)<br />
5. Perforazioni in<br />
avanzamento con “preventer”<br />
per il controllo della portata<br />
e della pressione dell’acqua<br />
dal foro<br />
6, 7, 8. Fasi esecutive<br />
dall’album fotografico del<br />
grande cantiere della Linea<br />
Periadriatica<br />
6<br />
7<br />
8<br />
Rilievo e scavo<br />
Le prospezioni in avanzamento sono state inizialmente realizzate<br />
con carotaggi “a recupero”, di lunghezza fino a 350 m,<br />
effettuati a partire da piazzole laterali predisposte all’interno<br />
del cunicolo. Per la gestione del rischio idraulico, è stato invece<br />
impiegato sistematicamente un preventer meccanico, dimensionato<br />
per contrastare pressioni fino a 100 bar: seppure<br />
in assenza di venute significative (le portate temporanee<br />
misurate nel foro di sondaggio sono state di inferiore ai 5l/s),<br />
sono state misurate pressioni fino a quasi 50 bar. Sono state<br />
utilizzate, in corso d’opera, tipologie di indagini con minore in-<br />
cidenza sulla produzione generale del cantiere. Dai sondaggi<br />
a carotaggio continuo si è passati così ai più flessibili sondaggi<br />
“a distruzione”. I carotaggi a recupero, grazie alla possibilità<br />
di effettuare analisi e prove sulle carote estratte, restituivano<br />
in informazioni più complete, ma allo stesso tempo determinavano<br />
delle difficoltà operative, nonché sfavorevoli incidenze<br />
sulla produttività. Le attività di avanzamento per l’attraversamento<br />
della Faglia Periadriatica, dal punto di vista cantieristico,<br />
hanno preso avvio dal preventivo consolidamento del fronte<br />
di scavo e dell’estradosso attraverso l’impiego di barre autoperforanti<br />
cementate. A seguire, lo scavo a piena sezione con<br />
martellone, spesso era sufficiente il solo ripper montato su<br />
escavatore, le attività di smarino, la posa del primo strato di<br />
betoncino proiettato fibrorinforzato, l’applicazione delle centine<br />
e chiodi radiali autoperforanti. A una distanza di pochi metri<br />
dal fronte si è proceduti a realizzare l’arco rovescio ed un secondo<br />
stato si spritz-beton strutturale di prima fase con l’utilizzo<br />
di doppia rete elettrosaldata,. Questo ciclo di lavorazioni,<br />
ripetute secondo lo schema esposto, era contestuale al consolidamento<br />
a contorno, eseguito ogni due centine, e a quello<br />
del fronte, in questo caso ogni quattro centine. La produzione<br />
era di ca. 12 m di avanzamento settimanale, con una produzione<br />
media di circa 1,5 m al giorno. All’interno del ciclo si<br />
collocavano sia scavo e getto dell’arco rovescio armato, sia il<br />
sondaggio a distruzione in avanzamento della lunghezza pari<br />
a circa 40 m. Quest’ultima attività veniva tuttavia realizzata<br />
senza condizionare l’avanzamento dello scavo.<br />
Tecniche costruttive<br />
Già dai primi studi eseguiti era emersa l’opportunità di eseguire<br />
con metodo tradizionale il tratto di cunicolo esplorativo nel<br />
punto di faglia caratterizzato dal contatto tettonico tra Placca<br />
Europea e Placca Africana (all’incirca tra il km 11+500 e il km<br />
12). Una volta oltrepassata la Faglia di Sprechenstein/Faglia<br />
della Val di Vizze (contraddistinta dalla presenza di cachiriti,<br />
cataclasiti, miloniti tonalitiche), il piano degli scavi prevedeva<br />
di poter proseguire impiegando una TBM fino al Confine di Stato.<br />
Dai dati raccolti emerge chiaramente che, l’ammasso con<br />
presenza delle citate cachiriti, cataclasiti e miloniti tonalitiche<br />
ha espresso valori di resistenza sensibilmente inferiori rispetto<br />
a quelli del materiale “sano” (granito e tonalite), provocando<br />
maggiori deformazioni con la conseguente generazione di<br />
un’estesa fascia plastica intorno al cavo stesso. Inoltre, lungo<br />
il percorso sono state rilevate zone intensamente fratturate,<br />
rese tali a seguito di movimenti tettonici.<br />
Il progetto a base di gara identificava un tratto significativo<br />
caratterizzato da un rapporto resistenza d’ammasso/tensione<br />
geostatica (Ơ cm /p o ) minori di 0,2, nonché da deformazioni<br />
del cavo nettamente superiori al 3% del raggio, con<br />
conseguenti condizioni di instabilità del fronte e incipienti<br />
plasticizzazioni del materiale. Poco prima di avviare lo scavo<br />
in zona di faglia, è stato quindi eseguito un sondaggio orizzontale<br />
di lunghezza pari a 330 m. I dati registrati del sondaggio<br />
(DAC test), così come quelli derivanti da una serie di<br />
prove meccaniche di laboratorio eseguite hanno portato a<br />
un aggiornamento nella classificazione del materiale. L’analisi<br />
complessiva eseguita [1] ha quindi determinato la condizione<br />
di comportamento dell’ammasso descritta in fig. 8.<br />
Gallerie<br />
4/<strong>2021</strong>
64<br />
9<br />
9. Condizione<br />
di comportamento<br />
dell’ammasso [8]<br />
La parametrizzazione aveva evidenziato la necessità di prevedere<br />
importanti consolidamenti del fronte, che comunque, in<br />
alcuni casi, non permettevano di ridurre la convergenza al fronte<br />
stesso entro limiti ritenuti accettabili (3% del raggio di scavo).<br />
In tali situazioni, il valore molto elevato delle pressioni di<br />
confinamento necessarie a garantire l’equilibrio della cavità in<br />
corrispondenza delle convergenze relative, benché ridotte per<br />
l’effetto dei consolidamenti sul contorno, era tale da sconsigliare<br />
l’adozione di rivestimenti rigidi. Nella casistica in questione,<br />
è stata pertanto prevista l’adozione di una deformazione controllata<br />
della cavità, da modulare in funzione delle deformazioni<br />
massime attese. Nella fase propriamente esecutiva, a partire<br />
dall’impiego del “Metodo Osservazione” (“Tentative Solution”)<br />
combinato a un attento controllo e monitoraggio, è stato rilevato<br />
un forte comportamento asimmetrico, con elevate deformazioni<br />
in asse galleria e minori in direzione radiale. Tale condizione<br />
ha determinato l’opportunità di adottare un rivestimento<br />
“rigido” per la messa in sicurezza della cavità, in combinazione<br />
con il consolidamento al fronte che ha permesso di contenere<br />
in limiti accettabili le deformazioni in asse galleria; è stata quindi<br />
applicata la sezione di scavo rappresentata in fig. 2. Sempre<br />
in corso d’opera, è stato inoltre eseguito anche un approfondito<br />
monitoraggio, basato sull’impiego di estensimetri al fronte,<br />
misure di convergenza, strain gauge e celle di carico montate<br />
sulle centine, nonché chiodi ed estensimetri multibase radiali.<br />
Infine, sono state condotte delle accurate back-analysis, sulla<br />
base delle esperienze di comportamento dell’ammasso registrate,<br />
ed è stato aggiornato il modello di calcolo [9].<br />
Dai dati alle scelte<br />
Dall’interpretazione giornaliera dei dati da parte di un apposito<br />
tavolo tecnico composto da rappresentanti di Committente,<br />
Impresa, Progettista e Responsabile della Sicurezza, è stato<br />
così possibile decidere in tempo reale come procedere con<br />
l’avanzamento, sulla base degli aggiornamenti geologici-geotecnici<br />
ricavati dal campo, dei dati di monitoraggio e dei risultati<br />
delle prove di laboratorio: un’autentica sfida, vinta anche grazie<br />
alla stretta collaborazione e alla competenza di tutti i soggetti<br />
coinvolti. I dati di monitoraggio hanno fatto emergere la sussistenza<br />
di un forte comportamento asimmetrico, con elevate<br />
Gallerie<br />
deformazioni in asse alla galleria e minori in direzione radiale.<br />
Dalle interpretazioni fornite, tale fenomeno avrebbe portato<br />
a un’ulteriore modifica della sezione di scavo, mantenendo sì<br />
un cospicuo consolidamento del fronte, ma mettendo in opera<br />
un rivestimento strutturale di prima fase “rigido”: una sezione<br />
così concepita si sarebbe dimostrata del tutto efficace, nonché<br />
adattata all’effettivo stato tenso-deformativo dell’ammasso.<br />
L’interpretazione dei dati raccolti ha pertanto permesso di anticipare<br />
situazioni di possibili instabilità nell’avanzamento e di<br />
reagire in tempo reale alle esigenze del cantiere (questo sia in<br />
termini di sicurezza, che di avanzamento dello scavo). In generale,<br />
il tratto della zona di faglia si è prolungato di quasi 300<br />
m rispetto alle previsioni originarie (dagli iniziali 500 m circa<br />
agli 800 documentati) e ha determinato anche lo spostamento<br />
verso Nord della realizzazione del camerone di montaggio<br />
TBM. Un altro aspetto rilievo, é rappresentato dall’incremento<br />
degli sforzi sviluppati nel rivestimento del cunicolo a seguito<br />
dello scavo delle gallerie di linea: nelle “core zone” dei tratti in<br />
faglia del lotto costruttivo in questione, sono infatti stati rilevati<br />
incrementi sistematici degli sforzi nell’ordine del 30%. Questo<br />
approccio basato sul monitoraggio continuo è risultato infine<br />
perfettamente funzionale a supportare le metodiche messe in<br />
atto da Galleria di Base del Brennero in materia di valutazione<br />
del rischio, un “mainstream” seguito in tutte le fasi dell’opera,<br />
dalla progettazione al cantiere, con l’obiettivo di individuare,<br />
step by step, le più opportune misure di contenimento prima<br />
che il rischio stesso possa generarsi. nn<br />
Bibliografia<br />
[1] Galleria di Base del Brennero, Progettazione Esecutiva - Cunicolo esplorativo Tratta Lineamento Periadriatico<br />
- Documentazione geologica e geotecnica di base - Tipi di ammassi rocciosi, Comportamento Zone di<br />
Faglia, Aprile 2009.<br />
[2] Galleria di Base del Brennero, Progettazione Esecutiva - Cunicolo esplorativo Tratta Lineamento Periadriatico<br />
- Documentazione geologica e geotecnica di base - Sondaggio in avanzamento a carotaggio continuo<br />
PK 11+731,8, Dicembre 2011.<br />
[3] Galleria di Base del Brennero, Progettazione Esecutiva - Cunicolo esplorativo Tratta Lineamento Periadriatico<br />
- Documentazione geologica e geotecnica di base - Rapporto geotecnico, Marzo 2009.<br />
[4] Barovero G., Casale S., Egger H., Barnabei E., “BBT SE: The role of direct investigations ahead of the tunnel<br />
face in the construction cycle of a conventional and mechanized tunnel”, WTC 2019 Bergen (Norvegia).<br />
[5] TBM Excavation of Long and Deep Tunnels Under Difficult Rock Conditions - ITA Working Group n°17 -<br />
Long Tunnels at Great Depth, ITA Report n°19, Maggio 2017.<br />
[6] Fuoco S., Zurlo R., Marini D., Pigorini A. (2016), Tunnel Excavation Solution in Highly Tectonized Zones,<br />
WTC 2016, San Francisco (California).<br />
[7] Zurlo R., BBT SE, la scelta della Committenza e l’avanzamento lavori, GEOALP 2017.<br />
[8] Pizzarotti, E. M., Galleria di Base del Brennero - Progetto Esecutivo di Dettaglio del Cunicolo esplorativo<br />
Periadriatica e Opere Propedeutiche ambito Mules - Cunicolo Esplorativo: Attraversamento Lineamento Periadriatico:<br />
Relazione Tecnica, 2012.<br />
[9] Marini D. Galleria di Base del Brennero - Progetto Esecutivo del Cunicolo esplorativo Periadriatica e Opere<br />
Propedeutiche ambito Mules: Relazione statica del rivestimento di prima fase - Gallerie di Linea, 2013.
66<br />
67<br />
LS<br />
Torino-Lione<br />
Laboratorio europeo<br />
di gestione green<br />
FOCUS SULLA GESTIONE DEI<br />
MATERIALI DA SCAVO DELLA<br />
SEZIONE TRANSFRONTALIERA<br />
DELLA NUOVA LINEA TORINO<br />
LIONE, DOVE IL PRESENTE<br />
CI RACCONTA DI UNA<br />
STRATEGIA DI RIUTILIZZO<br />
BASATA SU RICERCA<br />
APPLICATA E TECNOLOGIE<br />
LOGISTICHE AVANZATE,<br />
MENTRE IL FUTURO È GIÀ<br />
ANIMATO DA UN’AUTENTICA<br />
SFIDA NORMATIVA:<br />
ABBATTERE LE FRONTIERE<br />
NAZIONALI E GESTIRE INSIEME<br />
I 37 MILIONI COMPLESSIVI<br />
DI TON SCAVATI E DA SCAVARE<br />
TRA ITALIA E FRANCIA.<br />
La costruzione delle due canne di 57,5 km del tunnel di<br />
base della linea ferroviaria Torino-Lione comporterà la<br />
produzione di rilevanti quantità di materiali di scavo la<br />
cui mancata valorizzazione o il trattamento come rifiuto, implicherebbe<br />
considerevoli aumenti dell’impatto e del costo<br />
dell’opera. Nel quadro della realizzazione della sezione transfrontaliera,<br />
i materiali verranno estratti per un arco di tempo<br />
di circa di 10 anni e sono destinati a essere reimpiegati<br />
per lo più nel quadro del progetto stesso. La sola parte non<br />
valorizzabile sarà conferita a deposito nei siti di riambientalizzazione<br />
che il progetto ha individuato. Il progetto tecnico<br />
risponde dunque a una logica operativa, ma è ispirato an-<br />
1. Il grande cantiere dell’imbocco lato Francia<br />
della Torino-Lione<br />
Eleonora Cesolini<br />
Senior Project Manager<br />
TELT Tunnel Euralpin<br />
Lyon Turin<br />
Sara Settembrino<br />
Comunicazione<br />
esterna Italia<br />
TELT Tunnel Euralpin<br />
Lyon Turin<br />
2. Dati sul recupero<br />
del materiale da scavo<br />
in Italia e in Francia<br />
© Caroline Moreaux<br />
Ricerca applicata<br />
e tecnologie per la logistica<br />
Nel quadro degli studi varati fin dall’inizio del progetto, TELT<br />
si è molto impegnata nella ricerca di soluzioni e tecnologie<br />
per la valorizzazione. Fin dal 1997 prima la società Alpetunnel<br />
e LTF dopo, hanno condotto diversi studi orientati al reimpiego<br />
dei materiali di scavo, oggetto di diverse pubblicazioni<br />
tecnico-scientifiche, inclusa la realizzazione di una stazione<br />
sperimentale di trattamento dei materiali sul sito dei lavori<br />
della discenderia di Modane. Un gruppo di lavoro multidisciplinare<br />
è operativo, appositamente incaricato di cercare<br />
soluzioni a servizio della valorizzazione dei materiali, sulla<br />
base dell’esperienze del CETU (Centre d’Étude des Tunnels)<br />
del ministero dei Trasporti francese, e dell’AFTES - Association<br />
Française des Travaux en Souterrain, il cui ultimo lavoche<br />
da una volontà più alta: la ricerca di soluzioni innovative<br />
per la sua concreta attuazione, mediante ricorso a soluzioni,<br />
strumenti e tecnologie espressamente pensate per le esigenze<br />
del progetto. In concreto TELT ha scelto, valorizzando<br />
al massimo gli strumenti normativi che già lo permettono,<br />
di reimpiegare nell’opera la quantità più elevata possibile di<br />
materiale estratto in Italia e Francia, con una quota prevista<br />
oltre il 50%, in diverse applicazioni: calcestruzzi strutturali<br />
dei rivestimenti della galleria (conci); rilevati stradali e riempimenti;<br />
rimodellamenti.<br />
Ma la sfida consiste nell’adottare un approccio proattivo che<br />
integri il rigoroso rispetto delle disposizioni di legge, con una<br />
strategia globale di gestione dei materiali di scavo, di massimizzazione<br />
del loro impiego, preservazione delle risorse<br />
naturali e contenimento dei costi. Per questo tale strategia<br />
messa in campo da TELT si basa su quattro attività cardine:<br />
valorizzazione massima, ricerca applicata e sviluppo di tecnologie<br />
per la logistica (in collaborazione con istituti e università),<br />
tracciabilità informatica e valorizzazione in chiave<br />
binazionale.<br />
La massima valorizzazione<br />
dei materiali nel progetto<br />
La variante di cantierizzazione del progetto, approvata nel<br />
2018, che prevede lo scavo del tunnel di base lato Italia a<br />
partire da Chiomonte invece che da Susa, ha comportato un<br />
aggiornamento nella gestione dei materiali di scavo, le cui<br />
maggiori novità riguardano:<br />
• La riduzione della produzione del materiale di scavo rispetto<br />
al Progetto Definitivo approvato nel 2015 di circa 400.000,00 t;<br />
• Il ritorno di esperienza della galleria geognostica della Maddalena,<br />
ove i test di laboratorio eseguiti sul materiale di scavo<br />
hanno permesso di approfondire le valutazioni sul coefficiente<br />
di valorizzazione per produzione di inerti da calcestruzzo e<br />
quindi aumentare le quantità di aggregati che si prevede di<br />
reimpiegare (circa 1.000.000 t più delle previsioni originarie);<br />
• Lo stoccaggio in sotterraneo di rocce verdi direttamente nelle<br />
gallerie che non verranno più utilizzate in fase di esercizio,<br />
evitando l’uscita all’esterno di questa tipologia di materiali.<br />
Ad oggi, in base alle ultime stime, il volume totale dei mate-<br />
riali da scavare è pari a circa 37 milioni di tonnellate, di cui 30<br />
milioni di tonnellate sul versante francese e circa 7 milioni di<br />
tonnellate sul versante italiano. Si prevede che oltre il 50%<br />
di questa roccia sarà trasformata e utilizzata per le esigenze<br />
del progetto, anche se è il materiale italiano quello risulta più<br />
adatto ad essere riutilizzato: il 68% è infatti adatto al reimpiego<br />
in calcestruzzo e rilevati a fronte del 45% del materiale<br />
estratto in Francia. La valorizzazione avverrà in siti industriali<br />
dedicati, che opereranno in modo trasversale a servizio dei<br />
vari cantieri operativi. In tali siti il materiale, con le caratteristiche<br />
adatte, sarà lavorato e trasformato in inerti pregiati,<br />
certificato e trasferito alle centrali di produzione del calcestruzzo,<br />
sia degli anelli che rivestiranno la galleria, ma anche<br />
nei calcestruzzi delle opere civili. Inoltre, sempre sulla base<br />
delle specifiche caratteristiche degli aggregati, se ne prevede<br />
l’impiego anche in altre parti d’opera e nei rilevati ferroviari.<br />
Nella revisione finale del progetto di riferimento, lato Italia,<br />
ai materiali estratti viene assegnata la destinazione stabilita<br />
nell’ambito dei piani di gestione. Il piano di gestione italiano<br />
è parte integrante del progetto e si sostanzia nel Piano di<br />
Utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto ai sensi dell’art.<br />
5 del DM 161/2012, che definisce le procedure per la corretta<br />
gestione e il riutilizzo dei Materiali da Scavo (MATEX) in<br />
qualità di sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs.<br />
152/06 e s.m.i., verificato ai sensi dell’art. 167 comma 5 e<br />
art. 183 del Dlgs 163/06 e soggetto a Parere VIA – VAS n.<br />
2647 e delibera CIPE n. 30/2018 e 39/2019. La simmetria<br />
lato Francia indica procedure diverse, ferma restando l’adozione<br />
di un analogo piano di gestione che prevede di classificare<br />
i materiali di scavo, individuarne la destinazione, con la<br />
medesima logica di massimo impiego di quello disponibili e<br />
di salvaguardia delle risorse naturali. Tuttavia, la qualifica di<br />
rifiuto, oggi assunta dai materiali di scavo qualora essi escano<br />
al fuori del cantiere in cui sono prodotti, privilegia ancora<br />
una logica di semplice “ubicazione” piuttosto che di “prestazione“<br />
offerte dalle caratteristiche fisico-chimiche proprie dei<br />
materiali, ai fini del loro reimpiego. Per tale ragione le consultazioni<br />
sul disegno di legge anti-spreco e sull’economia circolare,<br />
all’esame dell’Assemblea nazionale, fanno ben sperare<br />
nell’estensione del concetto di sottoprodotto, nel solco di un<br />
miglioramento progressivo del quadro normativo verso strumenti<br />
di sostegno concreto all’economia circolare.<br />
Gallerie<br />
Gallerie<br />
4/<strong>2021</strong>
68<br />
69<br />
LS<br />
3<br />
ro di revisione della “Raccomandazioni sulla gestione e l’impiego<br />
dei materiali di scavo”, fornisce un quadro aggiornato<br />
delle più importanti esperienze di settore, completo di metodi<br />
di scavo, informazioni su MATEX (MATèriaux EXcavès) di<br />
terreni sciolti che sono la prevalenza negli scavi meccanizzati,<br />
oltre a utili informazioni giuridiche, pubblicato sul sito web<br />
della SIG Società Italiana Gallerie. Grazie anche a tali iniziative,<br />
progressi significativi sono stati raggiunti nell’utilizzo di<br />
cutter strumentati, sviluppati nel quadro del progetto DRA-<br />
GON, nell’analisi dell’immagine eseguite al fronte, alla testa<br />
della TBM, nonché nelle analisi così detta in linea di colore,<br />
chimica (PGNAA) e granulometrica. Progressi a supporto di<br />
tutta la catena di gestione materiali, con anticipazione della<br />
classificazione MATEX fin dall’identificazione al fronte, facilitandone<br />
il corretto indirizzamento di processo (aggregati<br />
o altro) e riducendo perdite di tempo e inefficienze. Proprio<br />
la catalogazione in linea dei materiali e l’identificazione delle<br />
loro caratteristiche fisico-chimiche, quanto più anticipata possibile,<br />
rappresenta la soluzione possibile in quanto strumento<br />
chiave di ausilio della logistica nelle piattaforme di cantiere,<br />
spesso limitate per disponibilità di superfici, oltre che per<br />
complessità e eterogeneità delle operazioni in atto.<br />
La collaborazione<br />
con il Politecnico di Torino<br />
In questo quadro si colloca la collaborazione che TELT sta avviando<br />
con il Centro interdipartimentale SISCON (Safety of<br />
InfraStructures and CONstruction) del Politecnico di Torino<br />
per la ricerca di strumenti innovativi da utilizzare nella catena<br />
di gestione delle rocce e terre da scavo. Partecipano al team<br />
di ricerca i dipartimenti di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio<br />
e delle Infrastrutture (DIATI), di Scienza applicata e<br />
Tecnologia (DISAT) e di Ingegneria strutturale Edile e Geotecnica<br />
(DISEG). Scopo della collaborazione è la ricerca operativa<br />
di soluzioni per “industrializzare” il processo di caratte-<br />
4<br />
rizzazione dei materiali (che sono allo scavo sostanzialmente<br />
indifferenziati) fin dalla fase di estrazione, e poi durante il trasporto<br />
su nastro, fino all’accumulo a bocca galleria. L’idea è<br />
di ricercare quelle tecnologie che favoriscano il controllo automatico<br />
del processo e della tracciabilità, al fine di conferire<br />
robustezza e velocità a tutte le operazioni. Lo studio prevede<br />
più fasi e linee di attività quali:<br />
• Analisi automatizzata o semiautomatizzata del marino in<br />
area laterale al nastro: applicazione delle tecniche di riconoscimento<br />
anticipato delle caratteristiche chimiche, mineralogiche<br />
e dimensionali sia su materiali tal quali che dopo lavaggio.<br />
• Regolazione dei parametri del processo di vagliatura e frantumazione<br />
sulla base delle caratteristiche individuate e delle<br />
necessità di riutilizzo.<br />
• Definizione di curve granulometriche ottimali per l’impiego<br />
© TELT<br />
3. Lato Italia: vista aerea<br />
del cantiere di Chiomonte<br />
4. Recupero di smarino<br />
su nastro trasportatore<br />
© TELT<br />
5. Metodi di scavo:<br />
tradizionale<br />
6. Con TBM (Tunnel<br />
Boring Machine)<br />
7. Esempio di<br />
geolocalizzazione trasporti<br />
su mappa e informazioni<br />
trasporto<br />
5<br />
6<br />
© TELT<br />
più efficiente dei materiali trasformati.<br />
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e<br />
delle Infrastrutture (DIATI) fornirà le proprie competenze<br />
sull’analisi del ciclo di scavo e dell’interazione fra sistemi di<br />
scavo e di trasporto, nonché sulla misura delle variazioni delle<br />
caratteristiche meccaniche e composizionali dei materiali<br />
mediante tecniche visuali innovative 2D, laser scanner (3D)<br />
sincronizzato con le analisi di pezzatura. Per la valutazione<br />
mineralogica e petrografica anticipata del marino si approfondiranno<br />
le possibilità offerte dall’analisi di immagini iperspettrali<br />
con camera digitale, intelligenza artificiale (Machine<br />
Learning/deep Learning, LIBS Laser Induced Breakdown<br />
Spectroscopy). Il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia<br />
(DISAT) contribuirà all’analisi chimica (qualitativa e<br />
quantitativa) del marino con metodi innovativi e non distruttivi<br />
(spettroscopia Raman, diffrazione raggi X (XRD) accoppiata<br />
alla fluorescenza X (XRF)), per l’identificazione dei minerali<br />
costitutivi e all’evidenziazione di eventuali fasi nocive<br />
per il confezionamento di calcestruzzi (silice amorfa, solfati,<br />
materiali carboniosi, sali…). Il Dipartimento di Ingegneria<br />
Strutturale Edile e Geotecnica (DISEG) lavorerà infine all’ottimizzazione<br />
eco-meccanica delle miscele di calcestruzzo contenenti<br />
materiale di scavo, calcestruzzi green, definendone<br />
le caratteristiche meccaniche e di sostenibilità.<br />
Tracciabilità informatica<br />
dei materiali<br />
Altro elemento di solidità nella catena delle operazioni di gestione<br />
dei materiali di scavo, è la completa tracciabilità dei<br />
materiali stessi, da e per i cantieri, con ausilio di un sistema<br />
di tracking che consenta, in qualunque fase temporale, di conoscere<br />
in tempo reale il quadro aggiornato dei movimenti<br />
materie. Il sistema di cui si intende dotare la flotta di mezzi<br />
impegnata nella movimentazione, si avvarrà di sistemi di<br />
monitoraggio satellitare dei trasporti e tracciabilità digitale<br />
dei flussi, e si baserà sui seguenti presupposti:<br />
• Tutti i mezzi dedicati al trasporto dei materiali di scavo saranno<br />
dotati di localizzatore satellitare, e gli autisti saranno<br />
dotati di palmare per la registrazione dei dati di carico/scarico<br />
dello smarino trasportato (es. classe dei materiali - Cl1,<br />
Cl2, Cl3, peso dei materiali trasportati);<br />
• Una piattaforma web dedicata, consentirà, in tempo reale<br />
consentirà (al titolare del contratto lavori, alla Direzione Lavori,<br />
agli Enti di controllo) di visionare l’ubicazione dei mezzi, il<br />
loro percorso, il carico contenuto; tale piattaforma<br />
dovrà consentire la produzione di report automatici<br />
circa i viaggi/gg effettuati da e per ogni singolo<br />
cantiere, i quantitativi totali di materiale trasportato,<br />
le caratteristiche (es. Cl1, Cl2, Cl3, aggregati<br />
valorizzati) trasportati. Tale piattaforma sarà accessibile<br />
tramite specifica App su smartphone per<br />
gli utenti autorizzati all’accesso;<br />
• Il sistema di tracciabilità dei trasporti comprenderà<br />
anche al trasporto su ferrovia verso i siti di<br />
destinazione finale dei materiali, dotando i treni<br />
trasporto anch’essi di rilevatore GPS e abbinando<br />
a ciascun convoglio le informazioni circa il quantitativo<br />
di materiale trasportato e i dettagli di cia-<br />
Gallerie<br />
Gallerie<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
70<br />
71<br />
LS<br />
8<br />
© TELT<br />
scun trasporto;<br />
• I responsabili di cantiere dei siti di deposito intermedio o di<br />
destinazione finale dei materiali disporranno di palmari con<br />
cui effettuare la presa in carico del materiale, respingere il carico,<br />
o evidenziare eventuali commenti al trasporto (es. carichi<br />
difformi da quanto riportato nella bolla di trasporto, anomalie,<br />
pesi difformi a quanto dichiarato ecc.).<br />
La predisposizione di un set informativo completo e mirato<br />
alle esigenze, esaminato e validato congiuntamente agli Enti<br />
di controllo, consentirà di rendere il processo di tracciabilità<br />
dei materiali di scavo del tutto informatizzato, inclusa la produzione<br />
di DDT con modalità automatizzata, sicura e certificata.<br />
A valle di un affiancamento iniziale al tradizionale documento<br />
cartaceo, previsto dall’Allegato 6 del DM 161/12, la<br />
volontà è quella di operare una completa transizione digitale<br />
di tutta la documentazione di processo, con evidenti vantaggi<br />
operativi di semplificazione, dematerializzazione dei documenti<br />
e accessibilità agevolata, assicurando trasparenza<br />
completa e la più severa garanzia di legalità.<br />
L’approccio binazionale<br />
e il quadro sovranazionale<br />
L’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo<br />
della Repubblica francese del 30 gennaio 2012 e quello per<br />
l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della<br />
nuova linea ferroviaria Torino-Lione del 24/2/2015, costituiscono<br />
i documenti di riferimento per la costruzione dell’opera<br />
e, nello specifico, prevedono che le procedure relative<br />
all’ambiente, che integrano la gestione dei materiali di scavo,<br />
debbano essere conformi alle normative nazionali. Il riferimento<br />
comune, nella materia, è quello definito dalla direttiva<br />
comunitaria 2008/98/CE che definisce le nozioni di rifiuto<br />
e sottoprodotto. Il motivo di tale distinzione è legato alle conseguenze<br />
in termini di responsabilità (amministrativa, civile<br />
e penale), di tracciabilità dei materiali, nonché di procedure<br />
contrattuali e di eventuali trasferimenti transfrontalieri. Ma la<br />
direttiva non è stata recepita negli stessi termini in Francia e<br />
in Italia: l’Italia ha infatti emanato il decreto n. 152 del 2006<br />
e, successivamente, il decreto n. 161/2012, nonché il Regolamento<br />
recante la disciplina semplificata della gestione delle<br />
terre e rocce da scavo contenuta nel DPR 13 giugno 2017,<br />
n. 120, in cui sono specificate le condizioni in cui terre e rocce<br />
di scavo si possono considerare sottoprodotti e non rifiuti.<br />
La Francia ha invece recepito la direttiva con l’ordinanza<br />
del 17 dicembre 2010, senza adottare un decreto attuativo.<br />
Tuttavia, come già rappresentato, la legge è tuttora in evoluzione,<br />
come conferma la linea tracciata dalla legge in materia<br />
di transizione energetica votata dal Parlamento francese<br />
nel 2015. In tale quadro, la politica nazionale di prevenzione<br />
e gestione dei “rifiuti” è fattore essenziale per la transizione<br />
verso l’economia circolare fondata sul consumo sobrio e responsabile<br />
delle risorse naturali, che tenga conto del ciclo di<br />
vita di un prodotto, dalla sua fabbricazione, fino al ciclo finale<br />
di smaltimento e recupero. Ciò premesso, ma in continuità<br />
con le scelte operate, l’attività per la gestione dei materiali<br />
di scavo del Grant Agreement (l’accordo tra Unione Europea,<br />
Italia e Francia nell’ambito della Connecting Europe Facility,<br />
CEF, per il finanziamento comunitario all’opera) prevede l’obbligo<br />
del riutilizzo per quanto possibile dei materiali di scavo<br />
prodotti durante la costruzione.<br />
In coerenza con l’adesione nel novembre 2015 al programma<br />
Global Compact delle Nazioni Unite e al Global Compact<br />
8, 9, Produzione di conci<br />
nello stabilimento francese<br />
France, TELT ha assunto l’impegno di rispettare i suoi 10 principi<br />
tra cui la promozione di una maggiore responsabilità ambientale,<br />
il principio precauzionale, lo sviluppo e la diffusione<br />
di tecnologie rispettose dell’ambiente. In questo senso la<br />
decisione ministeriale del 2 giugno 2015, indirizzata al Presidente<br />
di TELT e relativa all’approvazione del progetto di riferimento<br />
della sezione transfrontaliera, ha ricordato la necessità<br />
di perseguire il programma di studio di valorizzazione<br />
dei materiali in modo da ottimizzare le possibilità d’impiego<br />
nei rilevati o nella produzione di inerti, limitando così gli impatti<br />
connessi alla movimentazione e al conferimento in deposito.<br />
Ne consegue il percorso logico che, oltre al ricorso<br />
massivo a tecnologie e strumenti di efficientamento del processo,<br />
si confronta con la consapevolezza che la quota di riutilizzo<br />
dei materiali potrebbe aumentare se fosse consentita<br />
una valorizzazione in chiave binazionale. Una procedura il<br />
cui quadro giuridico è ancora da definire. Infatti, atteso che<br />
la produzione e il fabbisogno di materiali sullo stesso sito di<br />
scavo non sono concomitanti, la mobilitazione e l’utilizzo dei<br />
materiali da una parte e dall’altra della frontiera/del cantiere<br />
sarebbe ipotizzabile e di forte valore aggiunto del progetto.<br />
Un cantiere unico<br />
In questo contesto generale si collocano due azioni orientate<br />
all’esigenza di poter considerare il cantiere nel suo insieme<br />
come un ambiente unico e coerente, senza distinzioni di<br />
frontiera. Da un lato Regione Piemonte, Auvergne Rhône-<br />
Alpes e TELT, rispondendo alla Consultazione pubblica della<br />
Commissione ENVE del Comitato europeo delle Regioni sul<br />
New Circular Economy Action Plan, su cui sta lavorando l’Europa,<br />
hanno proposto di uscire dalle logiche nazionali per considerare<br />
il perimetro delle aree di lavoro delle grandi opere<br />
transnazionali come un unico cantiere europeo e poter così<br />
incentivare il riutilizzo del materiale estratto dove serve, indipendentemente<br />
dalla nazionalità dello scavo. Il tema è entrato<br />
tra i punti dell’opinione adottata dalla sessione plenaria<br />
9<br />
© TELT<br />
del Comitato, il cui documento programmatico è stato inviato<br />
alla UE per il percorso legislativo sul nuovo piano di economia<br />
circolare. Il 27 gennaio <strong>2021</strong> il Parlamento europeo<br />
ha adottato una proposta di risoluzione finale sul nuovo piano<br />
di circular economy e il 9 febbraio è stata votata una relazione<br />
d’iniziativa in cui viene recepita la proposta di gestione<br />
transfrontaliera dei materiali. L’ultimo passaggio spetta alla<br />
Commissione europea che dovrà ora trasformare il piano in<br />
proposta di legge in cui si vedrà come sarà declinato il punto<br />
sui materiali di scavo. Parallelamente è operativo un gruppo<br />
di lavoro all’interno della Conferenza intergovernativa della<br />
Torino Lione (CIG), per verificare la fattibilità di istituire una<br />
gestione binazionale dei materiali, da un punto di vista regolamentare<br />
e tecnico-operativo. Infatti, nell’attesa di un testo<br />
più specifico in merito alla declinazione dell’economia circolare,<br />
occorre operare nel contesto giuridico attuale, continuando<br />
a valorizzare i materiali di scavo nelle condizioni più<br />
sicure, garantendo la piena tracciabilità dei materiali ed evitando<br />
al contempo di stravolgere il mercato di riferimento.<br />
Conclusioni<br />
La costruzione della sezione transfrontaliera della Nuova Linea<br />
Ferroviaria Torino-Lione è destinata a costituire un grande<br />
campo sperimentale per un arco di tempo non breve, dove<br />
tecnologia, visione e modernizzazione possono fornire strumenti<br />
nuovi e utili alla trasparenza e all’efficienza nella gestione<br />
di grandi quantità di materiale di scavo, risolvendo i<br />
rischi e le diffidenze che sempre accompagnano questa tipo<br />
di attività. Il rigoroso rispetto delle disposizioni di legge non<br />
può infatti prescindere da una strategia globale di gestione,<br />
centrata sulla massimizzazione del reimpiego, preservazione<br />
delle risorse naturali e dell’ambiente attraversato, con una<br />
gestione attenta e commisurata dei costi. Strategia che impegna<br />
la stazione appaltante in un percorso non facile di rigorosa<br />
pianificazione, severo controllo e ricerca costante delle<br />
soluzioni e delle risposte necessarie. nn<br />
Gallerie<br />
Gallerie<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
72<br />
73<br />
LS<br />
1<br />
IL POZZO DI LUCE CHE PORTA AGLI “INFERI”, OVVERO LA<br />
NUOVA STAZIONE CHIAIA DELLA LINEA 6 DELLA METRO DI<br />
NAPOLI, È UN’OPERA UNICA CHE STA SORGENDO NEL VENTRE<br />
DEL CAPOLUOGO PARTENOPEO. A RENDERLA TALE IL CONNUBIO<br />
DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ARTE CHE STA DANDO VITA<br />
AL “MIRACOLO” DI FAR VIAGGIARE IL SOLE A 44 METRI<br />
DI PROFONDITÀ, ATTRAVERSO FORME ARCHETIPICHE,<br />
FIGURE MITOLOGICHE E VISIONI DANTESCHE.<br />
Gallerie<br />
È<br />
qualche anno ormai che abbiamo iniziato un viaggio<br />
tecnico-fotografico con i lettori di leStrade e riteniamo,<br />
oggi, che sia tempo di proseguirlo con altre tappe<br />
nel nostro incredibile mondo sotterraneo. In questa occasione,<br />
per essere precisi, la tappa sarà solo una: la stazione<br />
Chiaia della Linea 6 della metropolitana di Napoli, perché,<br />
a pochi mesi dall’ultimazione dei lavori, merita già da sola<br />
un intero racconto. In realtà tutta la Linea 6, come la Linea<br />
1 che i lettori hanno imparato a conoscere anche da utenti<br />
e che stiamo ultimando nella tratta alta dalla stazione Garibaldi<br />
fino all’aeroporto di Capodichino, segue il modello<br />
napoletano delle metropolitane caratterizzato da stazioni<br />
dell’arte e grande ingegneria nell’esecuzione di lavori in sotterraneo,<br />
in un contesto fortemente vincolato e densamente<br />
urbanizzato. La Linea 6, la cui concessionaria per il Comune<br />
di Napoli è la società Hitachi Rail STS SpA, è progetta-<br />
ta Metropolitana di Napoli SpA e costruita dal gruppo ICM.<br />
Partendo dalla stazione Mostra, la Linea 6 collega la zona<br />
Ovest della città di Napoli, precisamente il quartiere Fuorigrotta<br />
(che insieme a Bagnoli costituisce la X Municipalità),<br />
con l’area porto di piazza Municipio (I Municipalità). Proprio<br />
in questa grande piazza, la Linea 6 è strettamente legata<br />
alla Linea 1 tanto da avere nella stazione Municipio un’unica<br />
tornelleria, posta nell’area comune sottostante le sue 5<br />
uscite (ad oggi sono in esercizio 3 su 5, in attesa dell’ultimazione<br />
dei lavori dell’uscita Porto e dell’uscita Area archeologica<br />
nel fossato del Castel Nuovo). La Linea 6 non ha avuto<br />
negli anni uno sviluppo semplice: è, infatti, costituita da<br />
una prima tratta, Mostra-Mergellina, già ultimata ed esercita<br />
per qualche tempo e da una seconda tratta, Mergellina-<br />
Municipio. Nel corso del <strong>2021</strong>, l’ultimazione di buona parte<br />
dei lavori di questa seconda tratta farà sì che si possa apri-<br />
2<br />
Opere Metropolitane/1<br />
Chiaia, la stazione<br />
che fa viaggiare<br />
la luce agli inferi<br />
Maria Luisa<br />
De Guglielmo<br />
Coordinatore della<br />
progettazione<br />
Direzione Tecnica OOCC<br />
Metropolitana<br />
di Napoli SpA<br />
Antonello De Risi<br />
Senior Advisor<br />
Direzione Tecnica OOCC<br />
Metropolitana<br />
di Napoli SpA<br />
1. Cupola inferiore (sfera)<br />
con l’opra d’arte di Peter<br />
Greenway<br />
Foto Riccardo Siano<br />
2. Il tracciato della Linea 6<br />
che comprende la stazione<br />
Chiaia<br />
Gallerie<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
74<br />
75<br />
LS<br />
3<br />
3. Il ponte di Chiaia<br />
in due immagini del tempo<br />
e l’ubicazione della seconda<br />
uscita della stazione<br />
Chiaia sull’omonima strada<br />
(foto dal web e render su foto<br />
attuale con il ponte Monterey<br />
oggi restaurato)<br />
4. La stazione è collocata<br />
al di sotto di piazza Santa<br />
Maria degli Angeli, piccolo<br />
vuoto urbano tangente alla via<br />
Gennaro Serra che la collega<br />
alla nota piazza Plebiscito<br />
5. Bozzetto sulla sezione<br />
trasversale: il pozzo<br />
di luce secondo Uberto Siola<br />
& Partners<br />
6. La composizione<br />
architettonica con evidenza<br />
dei tre volumi principali di<br />
cui è composta la stazione<br />
secondo Uberto Siola<br />
& Partners<br />
7. Il percorso mitologico della<br />
discesa agli inferi secondo<br />
Peter Greenway<br />
5 6<br />
Gallerie<br />
re all’esercizio il percorso Mostra-San Pasquale, cui seguirà,<br />
ultimate le stazioni Chiaia e Municipio, l’intero ordinario<br />
esercizio che la città attende.<br />
4<br />
La stazione Chiaia<br />
e lo spazio urbano<br />
La stazione Chiaia è ubicata in un piccolo vuoto urbano, in<br />
un’area storica della città di Napoli a cavallo tra il quartiere<br />
Chiaia e il quartiere Monte di Dio. È già questo un aspetto interessante<br />
del progetto che, aggiunge alle funzioni trasportistiche<br />
dell’infrastruttura metropolitana, una particolare funzione<br />
urbanistica: la stazione, infatti, connette i due quartieri Monte<br />
di Dio e Chiaia che, posti a una quota altimetrica diversa, sono<br />
frutto di una stratificazione storica e architettonica della città.<br />
La necessità di connessione era già sentita quando con il ponte<br />
“Monterey” nel 1636 si cercò di unire la collina di Pizzofalcone<br />
con quella delle Mortelle e, ancora, con la via Chiaia di Domenico<br />
Fontana attraverso una ripida rampa che Ferdinando<br />
II delle Due Sicilie decise di eliminare. Infatti, quest’ultima divenne<br />
ben presto area di degrado che nemmeno l’espediente<br />
del grande crocifisso del dominicano padre Rocco, prodigo<br />
di opere di assistenza e apostolato con tanta influenza a corte<br />
e ispiratore del Real Albergo dei Poveri dell’architetto Fuga,<br />
riuscì a tenere libera. Sotto il crocifisso, per devozione popolare,<br />
i tanti lumini offerti realizzarono una certa illuminazione<br />
notturna che, però, poco poté contro il perdurare delle cattive<br />
frequentazioni. Nel 1834 la rampa fu sostituita da un torrino<br />
a scale, all’interno del quale nel 1956 venne realizzato l’ascensore<br />
di Chiaia, tutt’ora esistente, che costituisce uno dei<br />
4 ascensori pubblici gratuiti della città. L’ascensore rese possibile<br />
raggiungere velocemente via Giovanni Nicotera, la strada<br />
che passa sul ponte, e la piazza S. Maria degli Angeli. La<br />
stazione Chiaia, nei suoi primi livelli interrati, riassume quindi<br />
in sé secoli di storia politica e sociale della città. Il passaggio<br />
tra i due quartieri avviene tra l’ingresso principale della stazione<br />
in piazza S. Maria degli Angeli (+40,50 m slm) e via Chiaia<br />
(+24,70 m) senza interessare le tornellerie di stazione poste<br />
nel mezzanino a quota +6.94 m da cui partono le discenderie<br />
per le banchine a quota -3.35 m.<br />
Il pozzo di luce<br />
nell’architettura<br />
Nella visione dello studio Siola & Partners, firma prestigiosa<br />
dell’architettura napoletana, la stazione posta in un fazzoletto<br />
di spazio doveva diventare un “pozzo di luce”. A tal<br />
fine, il progetto esalta e accompagna la luce naturale fino<br />
44 m sotto il piano piazza, cioè al piano del ferro, cosa non<br />
usuale per una metropolitana, attraverso una sapiente composizione<br />
architettonica di volumi pieni e di vuoti e nell’uso<br />
di finiture di grandissimo pregio. La discesa della luce captata<br />
dalla cupola superiore passa attraverso quattro episodi<br />
architettonici, per dirla con le parole del professor Siola:<br />
il cilindro della discesa da piazza S. Maria degli Angeli a<br />
via Chiaia all’interno della quale s’innesta una spettacolare<br />
scala elicoidale, il cubo che unisce Chiaia alla zona dei binari<br />
e che di fatto funziona come smistatore dei traffici nei due<br />
7<br />
possibili utilizzi della stazione, la cosiddetta zona dell’ottagono<br />
anch’essa di smistamento, ma verso le due direzioni<br />
dei binari, e la sfera della grande cupola inferiore che coinvolge<br />
i binari e le banchine.<br />
La discesa agli inferi<br />
nell’arte figurativa<br />
Il concept architettonico è stato interpretato, dal punto di<br />
vista artistico, dall’intervento di Peter Greenway, considerato<br />
uno dei più significativi cineasti britannici contemporanei.<br />
Greenway, come diretta conseguenza della sua formazione<br />
pittorica, ha visto nella stazione una tela su cui<br />
esercitare le tecniche dell’arte figurativa in generale. Egli,<br />
infatti con l’apprezzamento e la condivisione del progettista<br />
Siola, ha evidenziato la successione dei volumi architettonici<br />
primari con l’uso di differenti colori (blu cobalto, verde<br />
smeraldo, giallo arancio, rosso cremisi) e lasciando il bianco<br />
ad esaltazione della luminosità naturale proveniente attraverso<br />
il pozzo centrale. Questo microcosmo sotterraneo<br />
riordina, nei colori, cinque figure mitologiche che, partendo<br />
dall’alto, interpretano Giove, Nettuno, Cerere, Proserpina e<br />
Plutone. Il primo passaggio mitologico avviene tra Giove e<br />
Nettuno attraverso una scala elicoidale che, nella visione di<br />
Greenway, diviene uno spartito in cui suggestivamente ripetere<br />
la frase di Ovidio dell’esaltazione dell’acqua (Est in<br />
aqua dulci non invidiosa voluptas). Il verde della fascia centrale<br />
rappresenta la terra e onora Cerere; esso lascia poi il<br />
posto all’arancio con l’installazione di melograni in ceramica<br />
che riportano al rapimento di Proserpina da parte di Plutone.<br />
Infine, si giunge al livello banchina, rosso nella tonalità<br />
classica degli inferi. Il piano banchina è sovrastato dalla<br />
Gallerie<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade
76<br />
77<br />
LS<br />
8<br />
8. Planimetria degli ingombri<br />
di stazione con indicazione<br />
delle opere di contenimento<br />
9. Demolizione galleria<br />
di linea e realizzazione, per<br />
allargamento, della galleria<br />
di stazione<br />
Gallerie<br />
10. Realizzazione<br />
delle gallerie di stazione<br />
11. Galleria di banchina<br />
lato Municipio. Sezione<br />
trasversale con interventi<br />
da galleria TBM<br />
cupola inferiore, all’intradosso della quale la moltitudine di<br />
occhi delle anime degli inferi, derivanti dal modello dipinto<br />
dallo stesso Greenway, è volutamente in attesa di mischiarsi<br />
agli occhi dei viaggiatori che, diretti in banchina, si affacceranno<br />
nei grandi oblò.<br />
Il connubio tra l’arte e l’architettura ha, anche in superificie,<br />
la sua grande espressione nella realizzazione di un’imponente<br />
statua di Giove con 24 braccia, come le ore del giorno,<br />
su disegno di Greenway. Altre 8 statue, riproduzioni di statue<br />
classiche del Museo Nazionale di Napoli (MAN), verranno<br />
collocate in una precisa successione nel corpo centrale<br />
della stazione, in corrispondenza dei pianerottoli di sbarco<br />
delle scale, diventando così una maestosa galleria d’arte in<br />
cui il viaggiatore sarà totalmente immerso.<br />
9<br />
12. Struttura definitiva<br />
in risalita (cilindro)<br />
13, 14. La straordinaria<br />
discesa agli “inferi”<br />
della nuova stazione Chiaia<br />
13 14<br />
12<br />
L’ingegnerizzazione<br />
La suddivisione della stazione in episodi architettonici e in<br />
tre principali volumi (il cilindro, il cubo e la sfera) ad opera<br />
del professor Uberto Siola non è affatto casuale perché<br />
corrisponde a tre distinte sezioni geologiche che hanno<br />
condizionato in maniera diversa lo scavo della stazione,<br />
totalmente realizzato a cielo aperto. Partendo dalla quota<br />
della piazza S. Maria degli Angeli fino alla quota di via<br />
Chiaia, lo scavo del cilindro è proceduto in materiale sciolto<br />
dopo aver realizzato paratie di pali Φ 1000 che si sono<br />
spinte fino alla quota del tufo. La stabilità della paratia è<br />
stata, in questo primo stadio, assicurata da tre/quattro ordini<br />
di tiranti per tre dei quattro lati, mentre il quarto, prospiciente<br />
la via Chiaia, è stato assicurato con due puntoni<br />
agli angoli necessari per la presenza del fabbricato che si<br />
sviluppa da via Chiaia fino alla piazza.<br />
Lo scavo in tufo, da poco al di sotto della quota di +24.00<br />
m di via Chiaia e fino all’incirca alla quota +6,50 m del lucernario<br />
posto al di sopra del piano del ferro in corrispondenza<br />
della sezione achitettonica a forma di cubo, è stato<br />
realizzato stabilizzando le pareti del tufo con spritzbeton e<br />
chiodature. L’ultima sezione di scavo, corrispondente alla<br />
sfera, è stata realizzata come la precedente ma, essendo<br />
in buona parte sotto falda, tenendone bassa la quota con<br />
10<br />
11<br />
l’impiego di pozzi di emungimento per consentire lo scavo<br />
in asciutto. Durante lo scavo di quest’ultima sezione si<br />
è dovuto demolire il rivestimento della preesistente galleria<br />
di linea che, partendo dalla stazione Mergellina, era<br />
già stata realizzata fino al pozzo di estrazione della TBM<br />
in prossimità di piazza Municipio. Infatti, la scelta progettuale<br />
per la Linea 6 è stata quella di realizzare prima tutta<br />
la galleria di linea con il passaggio della TBM e poi, in corrispondenza<br />
dei pozzi di stazione, demolire quella di linea<br />
per realizzare i due tronchi di galleria di stazione in allargamento<br />
rispetto alla sezione circolare iniziale.<br />
In questa stazione, la delicatezza delle lavorazioni di scavo<br />
è stata accentuata dalla presenza di una cavità centrale<br />
censita a ridosso del pozzo di stazione, verso l’edificio<br />
prospieciente via Chiaia, e di ulteriori cavità non censite di<br />
cui una interferente, in particolare, con la galleria di banchina<br />
lato Municipio. L’impostazione progettuale per le cavità<br />
interferenti è stata la bonifica e il successivo riempimento<br />
parziale o totale, in funzione della loro geometria<br />
e posizione, al fine di realizzare un complesso omogeneo.<br />
La cavità interferente con la galleria di banchina lato Municipio<br />
è stata oggetto di chiodature e iniezioni eseguite<br />
dall’interno della galleria TBM a garanzia di cucitura e resistenza.Terminato<br />
l’allargamento della galleria si è impermeabilizzata<br />
tutta la parte di stazione sotto falda con teli<br />
in pvc e successivo rivestimento in c.a. Le strutture defi-<br />
Gallerie<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
78<br />
79<br />
LS<br />
nitive sono, quindi, state realizzate, in risalita di ben 50<br />
m dal fondo pozzo. In corrispondenza della sezione cubo,<br />
il contrasto delle pareti laterali del grande pozzo è stato assicurato<br />
da una maglia di travi puntone atte a separare la<br />
parte centrale del cubo stesso con lo spazio a contorno rimasto<br />
funzionale all’inserimento dei gruppi scale.<br />
La stazione Chiaia, come si è capito da quanto esposto e<br />
dalle immagini che abbiamo voluto mostrarvi, è oggetto di<br />
una grande curiosità. I quotidiani, infatti, hanno iniziato recentemente<br />
a diffondere le prime foto della struttura riscuotendo<br />
un certo entusiasmo da parte dei cittadini mentre l’industria<br />
televisiva l’aveva utilizzata come set, già nel 2018,<br />
per una puntata dei Bastardi di Pizzofalcone. Alla luce di ciò<br />
che accade nelle stazioni della Linea 1, siamo certi che anche<br />
questa stazione, e tutta la Linea 6, avrà ben presto un<br />
lungo curriculum nel settore visivo della comunicazione. Il<br />
risultato più prezioso è, tuttavia, la consapevolezza di aver<br />
realizzato con le nuove linee metropolitane, in generale,<br />
una svolta nella vivibilità della città di Napoli e, in particolare<br />
con la stazione Chiaia, di aver vinto la scommessa di<br />
’portare la luce agli inferi’.<br />
16<br />
15<br />
La progettazione e la costruzione di opere complesse è<br />
attività corale e anche un semplice racconto non può che<br />
tenerne conto. I nostri ringraziamenti vanno, pertanto,<br />
al presidente prof. ing. Ennio Cascetta e al direttore generale<br />
ing. Fabio Giannelli e a tutti i colleghi della Metropolitana<br />
di Napoli SpA, nonché ai tecnici del gruppo ICM,<br />
rappresentati dall’ing. Giancarlo Acchiappati, e a tutte le<br />
maestranze impiegate a vario titolo nella realizzazione delle<br />
nostre opere. nn<br />
15. Rustico della scala<br />
elicoidale (interno cilindro)<br />
16. Ultimazione lavori area<br />
museale Foto Riccardo Siano<br />
Opere Metropolitane/2<br />
Dalla geometria<br />
alla bellezza<br />
Fabrizio Apostolo<br />
UN NUOVO LUOGO URBANO, CHE VALORIZZA LA TRADIZIONE MULTI-PIANO<br />
DELLA CITTÀ E INSIEME SA CREARE INNOVAZIONE E SVILUPPO SOCIALE<br />
E CULTURALE. SARÀ TUTTO QUESTO LA STAZIONE CHIAIA, I CUI ELEMENTI<br />
ARCHITETTONICI PORTANO UNA FIRMA D’ECCEZIONE, QUELLA DEL PROFESSOR<br />
UBERTO SIOLA, CHE CI RACCONTA NON SOLO IL PROGETTO, MA ANCHE I SUOI<br />
PRESUPPOSTI IDEALI E I SUOI FINI, IN QUEST’INTERVISTA TUTTA DA GUSTARE.<br />
1. Il professor Uberto Siola<br />
1<br />
Un nuovo centro cittadino per una città unica. Un nuovissimo<br />
“luogo urbano” - come lo definisce l’autore<br />
del progetto architettonico della stazione Chiaia, Linea<br />
6 della Metropolitana di Napoli, ovvero l’architetto Uberto<br />
Siola, a capo dello studio Siola & Partners - che va però a<br />
innestarsi, rispettandola profondamente e insieme innovandola<br />
sensibilmente, in una cultura antichissima. Cultura tec-<br />
nico-costruttiva, ma anche e soprattutto sociale e, è il caso<br />
di dirlo, popolare, ovvero capace di amalgamare più “popoli”,<br />
quelli dell’alto e del basso, non solo nel senso di classe,<br />
ma anche di plastica fisicità. Se dal punto di vista ingegneristico,<br />
come ben ci hanno illustrato i tecnici di Metropolitana<br />
di Napoli nell’articolo che trovate nelle pagine precedenti, si è<br />
trattato tra le altre cose di rendere possibile un “cantiere impossibile”<br />
nel cuore di Napoli, inventando quotidianamente<br />
una logistica che ha consentito di muovere circa 10mila bilici<br />
colmi di terre, nonché soluzioni ardite quali la realizzazione<br />
di tiranti con ancoraggi direttamente nel tufo, dato l’alto<br />
rischio di realizzare i bulbi sotto le fondazioni dei palazzi storici<br />
dell’area, da quello strettamente architettonico l’impresa<br />
tra le imprese è stata - più poeticamente ma non meno faticosamente<br />
- quella di portare il sole partenopeo a 44 metri<br />
di profondità, facendogli compiere un viaggio tra le geometrie<br />
(di Siola) e i colori (di Peter Greenway). Per raccontare<br />
come si deve questo viaggio, abbiamo avuto l’opportunità di<br />
conversare direttamente con il professor Uberto Siola. Ecco<br />
il resoconto del nostro colloquio.<br />
Gallerie<br />
Professor Siola, dal paradiso all’inferno dunque, che<br />
poi, sul piano costruttivo, trasportistico e anche urbanistico,<br />
è da considerare, in fondo, un altro “paradiso”.<br />
Prima di parlare dell’“enciclopedia Chiaia” e dei suoi<br />
tomi, però, può descriverci il suo personale punto di<br />
vista sul tema-infrastrutture: che ruolo possono e devono<br />
avere nella nostra contemporaneità?<br />
Nella mentalità comune le infrastrutture sono considerate<br />
più un vettore di servizi, che opere meritevoli di attenzioni<br />
estetiche. Nel caso delle stazioni della Metropolitana di Na-<br />
Gallerie<br />
4/<strong>2021</strong>
80<br />
81<br />
LS<br />
2 3<br />
poli, invece, questa idea è stata abbondantemente superata,<br />
perché qui le infrastrutture agiscono sulla città come<br />
potatrici di valori di sistema, come moltiplicatori di benefici:<br />
e questo è a tutti gli effetti un forte messaggio culturale.<br />
Lo stesso, del resto, avviene in molti scenari internazionali<br />
ed è già avvenuto, nella Storia. Pensiamo alla metropolitana<br />
di Mosca e ai suoi messaggi anche propagandistici, ma<br />
non solo. A Napoli, il merito della metropolitana dell’arte è<br />
quello di aver intuito che anche un sistema infrastrutturale<br />
può essere messaggero di cultura e di bellezza, oltre che<br />
naturalmente veicolo di miglioramento trasportistico e sviluppo<br />
economico.<br />
Entriamo nel vivo del progetto Chiaia: qual è a suo avviso<br />
la peculiarità, il tratto di unicità di un intervento<br />
come questo?<br />
L’unicità di Chiaia risiede nel fatto che questo progetto coglie<br />
appieno l’essenza di Napoli. Operiamo infatti in una città<br />
che, a differenza di molte altre, è cresciuta non in orizzontale,<br />
ma in verticale, ovvero su più livelli. Vi sono luoghi urbani<br />
in cui queste stratificazioni sono più evidenti, più tangibili,<br />
che in altri e uno di questi è proprio l’asse che lega Chiaia<br />
con Pizzofalcone. Dove, realizzando un sistema di trasporto<br />
collettivo, possiamo andare a intercettare non uno, ma ben<br />
due piani urbani distinti, e questo è senza dubbio già un elemento<br />
vincente. Chiaia significa due città, quella dei Borbone<br />
che conquistano la playa, chiaia per l’appunto, e quella<br />
degli alloggiamenti militari sovrastanti, i Quartieri Spagnoli.<br />
I due piani sono sempre stati in qualche modo collegati, tramite<br />
l’antica rampa o le odierne scale a torretta. Aver avuto<br />
la possibilità di poter lavorare su un nuovo, ulteriore collegamento<br />
tra la Napoli alta e la Napoli bassa, mettendo in rete<br />
i rispettivi utenti, ha significato poter contribuire a dar vita a<br />
un nuovo vero centro della Napoli d’Occidente.<br />
4<br />
5<br />
2. Il cantiere di Santa Maria<br />
degli Angeli<br />
3. La luce di Napoli raggiunge<br />
i binari<br />
4. Rendering della nuova<br />
piazza riqualificata<br />
5. Rendering del percorso<br />
elicoidale<br />
6. Il cortile cinematografico<br />
di Palazzo San Felice a Napoli<br />
7. Locandina di Passione,<br />
film musicale del 2010<br />
di John Turturro<br />
6<br />
Dalla tradizione della Napoli multi-piano al lavoro per<br />
rispettarla e insieme innovarla: come avete affrontato<br />
questa sfida, che è anche consistita nel costruire un<br />
“ponte” tra passato e futuro?<br />
Premetto che è stata una sfida anche di carattere sociale,<br />
perché stiamo parlando di “platee d’uso” molto diverse<br />
tra loro: dare vita a un’occasione di osmosi trasportistica<br />
come quella di Chiaia significa anche attivare un processo<br />
di rivisitazione urbana anche dal punto di vista sociale.<br />
Detto questo, dopo il primo, straordinario lavoro ingegneristico<br />
che ha individuato e preparato il punto dove<br />
realizzare la nuova stazione, il lavoro di noi architetti è<br />
partito essenzialmente da un grande buco che misurava<br />
25x25x43 metri e da una stratigrafia essenzialmente<br />
composta da tre tipi diversi di elementi materici: la terra,<br />
l’acqua e il tufo.<br />
Un trittico che ha senz’altro ispirato la nostra idea di colmare<br />
questo spazio urbano con tre elementi geometrici:<br />
il cilindro, il parallelepipedo e la semi-sfera. Questo partendo<br />
dal fatto che a mio avviso l’unico problema di noi<br />
architetti deve essere la bellezza, che nel caso di Chiaia<br />
si doveva tradurre nella sfida di portare a 44 metri di profondità<br />
il sole di Napoli.<br />
Sì, la scommessa è stata questa: far arrivare nel ventre<br />
della città, in tutte le stagioni dell’anno, un raggio di<br />
luce. L’abbiamo vinta proprio grazie alla geometria, tenendo<br />
presente, tra le altre, la lezione di Le Corbusier,<br />
per il quale tutta la bellezza della Storia, a partire da<br />
quella di Roma antica, era assimilabile proprio alle forme<br />
geometriche.<br />
Ai grandi elementi ne abbiamo poi aggiunti degli altri,<br />
per esempio la rampa elicoidale che riformula il percorso<br />
dell’antica rampa pre-spagnola o della scala, un elemen-<br />
7<br />
to totalmente urbano e non trasportistico. Quindi, il sistema<br />
di scale che portano alla stazione e quei vuoti che<br />
abbiamo voluto riempire con spazi costituiti da quadrati<br />
e sottoquadrati che da un lato si ispirano alla lanterna<br />
araba, dall’altro, più propriamente, ai cortili napoletani<br />
settecenteschi…<br />
Ci spieghi meglio quest’ultimo aspetto.<br />
Lo farò con una citazione cinematografica: il film Passione<br />
di John Turturro del 2010, che fa rivivere le canzoni<br />
della grande tradizione napoletana ambientandone<br />
alcune proprio nei cortili dei nostri palazzi storici. Le<br />
danzatrici che si affacciano dalle nicchie ci fanno capire<br />
che quel palazzo altro non è che uno spazio teatrale, e<br />
così abbiamo reso la stazione Chiaia, dove abbiamo affiancato<br />
il teatro al museo, inserendo lungo i livelli dei<br />
gruppi marmorei e dando vita a una vera e propria galleria<br />
d’arte. Ai binari, si arriverà dopo aver viaggiato nel<br />
patrimonio museale della città.<br />
E non abbiamo ancora parlato dell’apporto di Peter<br />
Greenway…<br />
Lo conosco da molti anni, ho già lavorato con lui per il padiglione<br />
dell’Expo di Shangai. Il suo contributo è stato incredibile,<br />
originalissimo.<br />
Il tema pittorico che ha suggerito è stato sì il viaggio dantesco<br />
agli inferi, caratterizzato dal passaggio tra tre temi<br />
coloristici, ma in questo caso il viaggiatore è la stessa mitologia,<br />
perché stiamo parlando di un percorso che va da<br />
Giove a Plutone.<br />
Infine: se dovesse definire la tipologia di opera che<br />
ha progettato per la metropolitana partenopea, come<br />
la descriverebbe?<br />
Certamente si tratta di una stazione, ma questo progetto,<br />
in particolare, non è definibile attraverso un dizionario costruttivo<br />
classico.<br />
Non si tratta di un edificio in senso stretto, non è soltanto<br />
un hub infrastrutturale. Ma è a tutti gli effetti un nuovo<br />
luogo urbano, che può diventare<br />
opera d’arte, caffè letterario, museo,<br />
centro per conferenze e insieme<br />
molte altre cose. Da parte<br />
mia posso dire di essere davvero<br />
orgoglioso di aver dato forma a<br />
un luogo al servizio della città, un<br />
centro nevralgico destinato a vivere<br />
e pulsare anche quando la metropolitana<br />
non transita. Sì, la stazione<br />
Chiaia del terzo millennio è<br />
un grande palazzo napoletano del<br />
Settecento e insieme un incredibile<br />
teatro urbano, che sorge dal passato<br />
ed è proiettato nel futuro.<br />
Il presente è questa collaborazione<br />
tra ingegneria, architettura e arte,<br />
di cui Napoli può andare fiera. nn<br />
Gallerie<br />
Gallerie<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
82<br />
83<br />
LS<br />
Lavorazioni Underground<br />
Risolvere i problemi<br />
grazie al know-how<br />
1<br />
2<br />
1, 2. Interventi nella galleria<br />
Verceia (Anas) in Valtellina<br />
3. Elia Stevanato, titolare<br />
di Stevanato Lavori<br />
e Prodotti Speciali<br />
4, 5. Applicazione di resine<br />
nella galleria Cernobbio,<br />
lungo la SS 340 (sempre<br />
statale Anas)<br />
zione di giunti (sia stradali sia aeroportuali),<br />
impermeabilizzazioni, sigillatura<br />
a caldo di pavimentazioni, ricostruzioni<br />
cementizie. Il filo conduttore di questo<br />
“universo” esecutivo: la tecnica. Parola<br />
chiave che, come sanno bene i lettori<br />
della nostra rivista, ne racchiude fondamentalmente<br />
altre due: l’innovazione<br />
(nei materiali e nelle attrezzature) e il<br />
know how, ovvero la competenza di chi<br />
fisicamente vive ogni giorno il cantiere.<br />
In altri termini, “le persone”, come<br />
ama sottolineare proprio Elia Stevanato,<br />
il quale tra l’altro sul proprio profilo LinkedIn,<br />
oltre a informazioni e foto dei lavori,<br />
posta regolarmente le foto dei suoi<br />
collaboratori con lo slogan “Stevanato,<br />
fatta da persone”. Un’iniziativa molto gradita, alla rete e<br />
soprattutto a quelli che sono di fatto i migliori testimonial<br />
aziendali possibili.<br />
Infrastrutture messe al sicuro<br />
Attiva da oltre 40 anni, Stevanato nell’ultimo decennio ha<br />
maturato una grande esperienza nel campo delle lavorazioni<br />
underground, aspetto di cui ci occuperemo in questa<br />
sede, rimandando a successivi approfondimenti l’illustrazione<br />
degli altri contesti di intervento. “In prevalenza<br />
- spiega Elia Stevanato a leStrade - ci occupiamo di iniezioni<br />
di resine funzionali a bloccare le infiltrazioni, sia accompagnando<br />
le imprese in nuove opere, sia in casi di<br />
manutenzioni profonde dell’infrastruttura. Ma eseguiamo<br />
anche iniezioni finalizzate a chiudere micro-crepe in superfici<br />
cementizie, tutti lavori particolari grazie ai quali ci<br />
siamo costruiti una certa nomea nel settore”.<br />
Sempre in galleria, tanto per fornire al lettore un quadro<br />
completo sugli interventi in carnet, Stevanato esegue<br />
anche scarifiche a secco di strutture cementizi, nonché<br />
idrodemolizioni con attrezzature robotizzate. Anche<br />
se la parte del leone la fanno proprio la gestione delle infiltrazioni<br />
e i consolidamenti, campi in cui l’azienda colla-<br />
3 bora con i principali operatori del settore,<br />
dall’ambito stradale (tra gli altri, con<br />
Anas) a quello delle metropolitane. Attualmente,<br />
soltanto per fare un esempio<br />
tra i molti possibili, le squadre di Stevanato<br />
sono operative nel cantiere della<br />
Galleria Verceia, lungo la SS 36 in Valtellina,<br />
dove Anas sta eseguendo una serie<br />
di interventi per il miglioramento del sistema<br />
di smaltimento delle acque meteoriche,<br />
nonché la verniciatura delle pareti.<br />
Nella bacheca aziendale, però, rientrano<br />
anche, come accennato, anche numerosi<br />
casi di iniezioni di contrasto alle infiltrazioni<br />
nell’ambito della realizzazione di<br />
nuove opere che prevedono grandi scavi:<br />
un’operazione cruciale, sia per la tutela<br />
di tutti coloro i quali lavorano in galleria, sia per la correttezza<br />
esecutiva degli interventi. “Scendendo ulteriormente<br />
nel dettaglio - aggiunge Elia Stevanato - nel tunnelling i<br />
servizi che effettuiamo sono i seguenti: iniezioni di resine<br />
poliuretaniche, iniezioni di resine acriliche, iniezioni di resine<br />
epossidiche, ricostruzione di cementi armati, idrodemolizione,<br />
trattamento superficiale con vernici. Il nostro<br />
valore aggiunto? La profonda conoscenza delle problematiche<br />
e soprattutto la ‘customizzazione’, perché ogni intervento<br />
ha la sua storia e le sue peculiarità, per questo, prima<br />
di iniziare il lavoro, riteniamo fondamentale effettuare<br />
gli adeguati sopralluoghi e portare a casa le informazioni<br />
necessarie alla scelta della soluzione tecnica più adatta,<br />
più opportuna”. Il riferimento è, essenzialmente, ai prodotti<br />
da impiegare, che Stevanato conosce, testa e impiega<br />
con riconosciuta cognizione di causa: “Merito, e torno<br />
ancora su un punto a cui tengo molto, della preparazione<br />
dei miei operatori, che conoscono bene questo mestiere”.<br />
Se le persone, con i loro know how, giocano un ruolo chiave<br />
in lavorazioni tanto specialistiche, un altro caposaldo<br />
per la buona riuscita del compito è sicuramente la tecnologia,<br />
in cui Stevanato continua a investire: “Oltre a poter<br />
disporre di una grande varietà di materiali, le nostre squa-<br />
Gallerie<br />
INIEZIONI PER BLOCCARE VENUTE D’ACQUA NELLE OPERE ESISTENTI<br />
O IN FASE DI REALIZZAZIONE. CONSOLIDAMENTI E RIPRISTINI DI CEMENTI<br />
E CALCESTRUZZI. SCARIFICHE E IDRODEMOLIZIONI. È DECISAMENTE AMPIO<br />
IL VENTAGLIO DI INTERVENTI PER IL SOTTERRANEO NEL CV DI STEVANATO,<br />
UN’AZIENDA CHE PUNTA FORTE SULLA CONOSCENZA PROFONDA DELLA<br />
MATERIA E SULLA SPECIALIZZAZIONE DEI SUOI OPERATORI.<br />
4<br />
5<br />
I<br />
riflettori di leStrade si accendono sulla Stevanato<br />
Prodotti e Lavori Speciali, un nome noto nel settore<br />
delle infrastrutture proprio in virtù di quello che<br />
viene ottimamente sintetizzato nella stessa ragione sociale<br />
di quest’azienda veneziana sul mercato dal 1979:<br />
l’alta specializzazione, sia per quanto riguarda le lavorazioni,<br />
sia per le soluzioni tecniche adottate. Parliamo al<br />
plurale, perché un punto di valore della company guidata<br />
da Elia Stevanato è proprio l’ampio ventaglio di interventi,<br />
eseguiti ed eseguibili, in molteplici contesti applicativi.<br />
Riassumiamone soltanto alcuni: infiltrazioni d’acqua, interventi<br />
su gallerie, sottopassi, ponti e viadotti, ricostru-<br />
Stefano Chiara<br />
Gallerie<br />
4/<strong>2021</strong>
84<br />
6<br />
6. Ancora un intervento<br />
di iniezione con resine<br />
in uno dei cantieri<br />
della metropolitana di Napoli<br />
7, 8. Lavorazioni di scarifica<br />
a secco<br />
9. Ripristino di piedritti<br />
NUOVO CARICATORE<br />
DYNAPAC MF2500CS<br />
IMIX<br />
10. Attività di ripristino in una<br />
galleria del Quadrilatero<br />
7 9<br />
10<br />
STAGE 1 MIXING<br />
induces flow from the cold region<br />
STAGE 2 MIXING<br />
brings flow back together<br />
8<br />
dre impiegano attrezzature altamente performanti, a partire<br />
delle pompe ad aria. In alcuni casi, le specifiche esigenze<br />
della lavorazione ci portano a progettare soluzioni<br />
fatte su misura, è stato questo il caso, per esempio, di una<br />
pistola per le iniezioni”.<br />
Evoluzione continua, dunque. Nella formazione, nella conoscenza<br />
dei materiali, nell’adattamento delle macchine.<br />
Accade lo stesso se vogliamo lo sguardo alle scarifiche a<br />
Gallerie<br />
secco con testate fresanti, altra lavorazione ad alta specializzazione<br />
(e delicatezza) in galleria, oppure alle idrodemolizioni,<br />
effettuate sempre di più con l’impiego di robot<br />
ad alte performance come quelli della linea Aquajet, che<br />
fa capo a Brokk. Ma di questo aspetto torneremo a parlare<br />
con maggior dovizia di particolare quando ci occuperemo<br />
di ponti, un altro campo di prova dove la specializzazione<br />
può essere davvero l’arma in più. nn<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
Il nuovo Caricatore Dynapac MF2500CS IMIX aggiunge alle già alte<br />
prestazioni qualitative del Caricatore standard una omogeneità del<br />
conglomerato bituminoso limitandone la segregazione, attraverso un<br />
sistema di coclee a 2 stadi, garantendo allo stesso tempo la corretta<br />
temperatura. Contattaci per saperne di più.<br />
DISPONIBILE PER IL NOLEGGIO! MACCHINA IN SAGOMA<br />
PER IL TRASPORTO!<br />
Dynapac Italia Srl - Bastioni di Porta Nuova 21 - 20121 Milano<br />
Tel 02 89041396 info.italy@dynapac.com www.dynapac.com
SCEGLI LA TUA STRADA<br />
LS<br />
MATERIALI<br />
&TECNOLOGIE<br />
MATERIALI<br />
n La strada maestra di ricerca e formazione<br />
n Tecniche di misura dello stato tensionale<br />
TECNOLOGIE&SISTEMI<br />
n Il Piave mormorò… La ciclabile è super-protetta<br />
n Primato olandese nelle strade digitali<br />
n Dalla road safety alle gallerie paramassi<br />
BITEMULSION<br />
Le nostre emulsioni bituminose sono il frutto della più avanzata ricerca tecnologica, soddisfano<br />
i più severi requisiti tecnici e le loro caratteristiche rispondono alle più esigenti richieste del<br />
mercato, offrendo quindi una libertà assoluta e senza compromessi.<br />
BITEM S.r.l<br />
41122 MODENA<br />
Via Dell’Industria, 81<br />
Tel. +39 059 285202<br />
Fax +39 059 2860310<br />
48015 CERVIA<br />
S.S. Adriatica km 169,440<br />
Tel. +39 0544 992564<br />
Fax +39 0544 999158<br />
www.bitemsrl.com
88<br />
89<br />
LS<br />
Conversazioni sul Buon Costruire<br />
La strada maestra<br />
di ricerca e formazione<br />
Aspettando Concretezza, proponiamo ancora<br />
una conversazione sul buon costruire. Dopo<br />
quella pubblicata in questa medesima rubrica<br />
sul numero di leStrade Ottobre e dedicata ai controlli<br />
di qualità, lo scorso marzo abbiamo avuto ancora<br />
una volta l’opportunità di ragionare di tecnica e opere<br />
infrastrutturali con i vertici dell’Istituto Italiano per il<br />
Calcestruzzo e con un esponente dell’Anas, l’ingegner<br />
Marcello De Marco, responsabile del Centro Sperimentale<br />
Stradale dell’azienda del gruppo FS Italiane. Con loro<br />
abbiamo parlato essenzialmente di ponti e viadotti,<br />
rimandando a una futura occasione di approfondimento<br />
maggiori dettagli sull’approccio della società delle strade<br />
a questa materia tanto cruciale. In questa sede vogliamo<br />
condividere con i lettori da un lato una dettagliata<br />
presentazione del noto Centro Anas per l’innovazione<br />
(vedi box), dall’altro alcune storie tecniche, attuali e<br />
passate, riguardanti in particolare opere in elevazione,<br />
ovvero proprio ponti e viadotti. Viaggeremo dunque<br />
dai collaudi del Ponte di Genova San Giorgio, sempre a<br />
cura di Anas, all’intervento da manuale della Provincia di<br />
Como, a Carimate, fino al leggendario “Ponte in 50 ore”,<br />
ovvero un crocevia strada-rotaia lungo la linea Milano-<br />
Venezia realizzato a tempo di record anche e soprattutto<br />
grazie all’impiego di diversi calcestruzzi speciali, formulati<br />
dall’Istituto Italiano per il Calcestruzzo, che hanno agito<br />
come un’invincibile squadra di calcio o come un’orchestra<br />
di musicisti sopraffini, scegliete voi la metafora che più vi<br />
aggrada. Infine, le ultime “Concretezza News”. I webinar<br />
formativi di prossima partenza, che si svolgeranno in<br />
collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri,<br />
hanno ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia,<br />
nonché l’autorizzazione ministeriale a erogare crediti<br />
formativi agli ingegneri.<br />
A cura di leStrade<br />
in collaborazione con<br />
Istituto Italiano<br />
per il Calcestruzzo<br />
Fondazione per la Ricerca<br />
e gli Studi sul Calcestruzzo<br />
FOCUS Buon Costruire<br />
Da Genova a Treviglio, storie di ponti<br />
controlli, grande ingegneria e alta qualità<br />
© Anas SpA<br />
Storie di ponti. Quello di Genova San Giorgio, per<br />
esempio, di cui Anas ha coordinato le fasi dei collaudi<br />
statici e tecnico-amministrativi, nonché della verifica<br />
di agibilità. Le prime sono state coordinate dall’ingegner<br />
Achille Devitofranceschi, supportato da una squadra di 20<br />
specialisti. Le seconde, dall’ingegner Nicola Prisco, presidente<br />
della Commissione tecnico-amministrativa, composta<br />
anche dagli ingegneri Andrea Simonini e Alessandro<br />
Medici. Dell’agibilità, infine, attività decisiva in quanto<br />
propedeutica all’apertura al traffico, si è preso cura l’ingegner<br />
Marcello De Marco, della Direzione Ingegneria e Verifiche,<br />
nonché responsabile del Centro Sperimentale Stradale<br />
di Cesano. Correva l’estate 2020, poche settimane<br />
dopo il primo lockdown. Un tempo in cui l’Anas stava già<br />
premendo l’acceleratore, tra le altre cose, sul potenziamento<br />
delle attività di ispezione delle grandi infrastrutture,<br />
quali ponti e viadotti, ma anche gallerie. Ne ha parlato<br />
a leStrade proprio l’ingegner De Marco nel corso di una<br />
conversazione tecnica, in videocall, a cui hanno partecipato<br />
anche i vertici dell’Istituto Italiano per il Calcestruzzo,<br />
Silvio Cocco e Valeria Campioni, sul tema della durabilità<br />
di materiali e opere costruttive: “Anas - ha detto De<br />
Marco - ha in gestione, tra le altre, anche due importanti<br />
opere d’arte firmate progettualmente dal professor Riccardo<br />
Morandi, il viadotto della Magliana sull’autostrada<br />
A91 Roma-Fiumicino e il viadotto Carpineto in Basilicata,<br />
lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Si tratta<br />
di due strutture, naturalmente, che stiamo monitorando<br />
con grande attenzione mettendo in campo le nostre metodologie<br />
ispettive migliori e strumenti di ultima generazione,<br />
di cui Anas si è dotata. Proprio lo scorso anno, per<br />
esempio, abbiamo acquistato ben tre mezzi tre by-bridge<br />
e numerose altre attrezzature funzionali alle ispezioni, che<br />
svolgiamo capillarmente su tutta la nostra rete in gestione,<br />
in cui la maggior parte dei viadotti, come è noto, sono<br />
in calcestruzzo precompresso con cavi postesi”.<br />
1. Un momento del collaudo del Ponte<br />
di Genova San Giorgio, era l’estate 2020<br />
Carimate, ricostruzione<br />
in un mese soltanto<br />
Storie di ponti. Come quello fortemente danneggiato a<br />
Carimate, lungo la SP Novedratese, in provincia di Como,<br />
esattamente due anni fa, ovvero poco prima della Pasqua<br />
2019. L’opera d’arte è stata messa in sicurezza e perfettamente<br />
ripristinata in appena 28 giorni, un record. A<br />
“batterlo” un team affiatato di tecnici e soluzioni, dai responsabili<br />
dell’amministrazione provinciale fino agli specialisti<br />
dell’Istituto Italiano per il Calcestruzzo, che ha fatto<br />
scendere in campo il calcestruzzo Aeternum CAL, a impermeabilità<br />
zero e ad alta durabilità: “Si è trattato - ha<br />
sottolineato il dirigente della Provincia di Como, ingegner<br />
2, 3 Due frame tratti da un videoservizio<br />
di Espansione TV sull’intervento da record<br />
di Carimate (in fig. 3 l’ingegner<br />
Bruno Tarantola, Provincia di Como)<br />
Materiali<br />
3<br />
Guarda il video<br />
Consulta<br />
il Rapporto<br />
Laboratorio Concretezza<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
2<br />
4/<strong>2021</strong>
90<br />
91<br />
LS<br />
4<br />
Ora 8<br />
Ora 9 Ora 11<br />
Ora 30<br />
Ora 32 Ora 33<br />
n Cordoli di fondazione<br />
n Sigillatura piede<br />
dei ritti<br />
n Sigillatura di giunti<br />
e articolazioni<br />
n Soletta<br />
5. Calcestruzzi speciali, distinti, su misura<br />
tivo sarebbe stato raggiungere i 250 kg di resistenza a<br />
compressione. All’ora 9 la prima betoniera (l’esecutore<br />
di questa lavorazione, ricordiamolo, è Imprese Pesenti)<br />
inizia il getto e il materiale penetra come si deve. “In quel<br />
caso - notano Cocco e Campioni - il calcestruzzo non doveva<br />
essere vibrato, in quanto era talmente accelerato<br />
che la vibrazione avrebbe potuto rompere i geli, rallentando<br />
la presa”. Le foto spiegano meglio di tante parole<br />
il buon esito di questo intervento nell’intervento: far sì<br />
che il calcestruzzo in ingresso non desse luogo a “gobbe”<br />
o “montagnole”, dando vita a una compenetrazione<br />
ideale (in fig. 4, ora 11, si notino ben “tre calcestruzzi”,<br />
quello fresco, quello che sta indurando e quello già indurito,<br />
con le relative consistenze).<br />
La prova del fuoco. Gli elementi prefabbricati, del peso<br />
di circa 16 ton ciascuno, vengono appoggiati sulla fondazione,<br />
anzi, per l’esattezza, su un dato di 6 cm di diametro<br />
collocato su di essa con funzione di regolazione<br />
successiva tramite chiave dinamometrica, per far sì che<br />
l’elemento raggiungesse la perfetta planarità. Ecco la ragione<br />
principale dell’obiettivo da raggiungere, in termini<br />
di resistenze, del calcestruzzo di fondazione: il dado non<br />
avrebbe dovuto affondare, cosa che infatti non è accaduta.<br />
Le gru a cavalletto, così, appoggiano i prefabbricati<br />
su dado e fondazione: il dato si serra correttamente<br />
e l’equilibrio è raggiunto. Occorre a questo punto, e qui<br />
entra ancora un gioco un calcestruzzo speciale, chiudere<br />
la base dell’elemento pompando materiale.<br />
Poco dopo 30 ore dall’avvio dei lavori, inizia il getto<br />
della soletta, con la terza tipologia di calcestruzzo formulato<br />
dall’Istituto. Si impiega un calcestruzzo ad altissima<br />
resistenza, ma, spiegano Cocco e Campioni,<br />
“leggermente espansivo, in modo tale che facesse da<br />
bloccaggio tra elemento ed elemento”. A seguire, l’impermeabilizzazione,<br />
la posta di ballast e traversine. Infine<br />
il collaudo. Infine? Non del tutto, perché appena un<br />
paio di giorni dopo gli specialisti di IIC hanno raccontato<br />
questa best practice, la prima di una lunga serie, a<br />
un convegno: “In quel caso avevamo studiato tre tipi<br />
di calcestruzzo di granulometria diversa, con tempi di<br />
presa diversa e distinta lavorabilità. Gli interventi più<br />
delicati: la lavorabilità del dado di fondazione e le cuciture<br />
degli elementi, sia alla base sia nella parte alta,<br />
dove andava utilizzato un calcestruzzo ad altissima resistenza<br />
con effetto espansivo, funzionale a bloccare i<br />
conci. Infine la soletta, che doveva prevedere lo stesso<br />
tipo di accelerazione della fondazione. Il fine ultimi<br />
di questi mix: lavorare tutti insieme allo stesso modo,<br />
per far quasi sembrare che l’opera fosse stata realizzata<br />
con un calcestruzzo unico”. nn<br />
Materiali<br />
Il Centro Sperimentale Stradale laboratorio dell’innovazione Anas<br />
Ora 38 Ora 40 Ora 44<br />
Bruno Tarantola - di un calcestruzzo a indurimento rapido<br />
e ad altrettanto rapida maturazione controllata: qualità<br />
davvero straordinarie che ci hanno permesso di gettare<br />
la soletta integrativa subito dopo il varo delle travi e<br />
procedere con l’impermeabilizzazione della soletta il giorno<br />
dopo il getto”.<br />
Di Aeternum ed Aeternum CAL ha parlato quindi lo stesso<br />
Silvio Cocco nel corso della citata conversazione IIC-<br />
Anas-leStrade: “Lo studio delle costruzioni di Roma Antica<br />
ci ha portato, ormai quasi vent’anni fa, a sintetizzare un<br />
compound di additivi, l’Aeternum, che conferisce al calcestruzzo<br />
un’elevatissima durabilità. È composto da serie di<br />
prodotti sintetici, tra loro collaborativi, che conferiscono al<br />
calcestruzzo un’impermeabilità zero, quindi molto oltre la<br />
norma, e danno la possibilità di lavorare un con rapporto<br />
acqua-cemento dello 0,30, facendo sì che il ritiro del calcestruzzo<br />
sia anch’esso praticamente zero. Sintetizzando<br />
al massimo, siamo riusciti a riprodurre una reazione pozzolanica<br />
tale da poter dar vita a un calcestruzzo dalla resistenza<br />
a cloruri e fosfati superiore a quello contenente cemento<br />
solfato-resistente. Il compound va dosato al 3% sul<br />
peso del cemento: consideriamo che se fossero impiegati<br />
gli additivi che lo compongono singolarmente, il costo aumenterebbe<br />
anche di 5-6 volte”. Il compound Aeternum,<br />
con queste caratteristiche, ha dato vita al calcestruzzo Aeternum<br />
CAL, dove a quanto già detto occorre aggiungere<br />
gli aspetti della progettazione estrema e del controllo capillare,<br />
fattori, insieme a quello della R&D, anch’essi determinanti<br />
per raggiungere l’obiettivo della qualità assoluta<br />
e, con esso, della durabilità. “Fattori quali l’impermeabilità<br />
assoluta, un rapporto acqua-cemento bassissimo, la compensazione<br />
dei ritiri - conclude Cocco - ci hanno permesso<br />
di controllare i tempi e i metodi di getto, nonché di presa.<br />
E di prevedere la durata del getto e insieme ad esso la lavorabilità.<br />
Oggi abbiamo il pieno controllo di tutto il ciclo”.<br />
Cls con il cronometro<br />
per il ponte in 50 ore<br />
Oggi, ma non da oggi. Già perché il lavoro sartoriale sui<br />
materiali dell’Istituto Italiano per il Calcestruzzo, non solo<br />
per quanto riguarda le pavimentazione industriali ma anche<br />
le infrastrutture di trasporto, vanta una lunga tradizione.<br />
È ancora nella storia e nella memoria di molti tecnici<br />
del settore, in particolare nell’ambito dell’engineering<br />
ferroviario, la best practice del “Ponte in 50 ore” realizzato<br />
a Treviglio lungo la linea RFI Milano-Venezia. Si è trattato<br />
del primo intervento di una lunga serie, che ha visto<br />
applicato il “Metodo Istituto Italiano per il Calcestruzzo”,<br />
consistente da un lato nella formulazione di mix design<br />
del tutto peculiari e dall’altro del controllo maniacale di<br />
ogni fase esecutiva, a partire dal trasporto del materiale.<br />
L’opera: un sottopasso costituito da elementi prefabbri-<br />
Laboratorio Concretezza<br />
4. Alcuni fotogrammi del film dell’esecuzione<br />
del “Ponte in 50 ore”, nell’ordine: betoniere<br />
pronte (ora 8), primo getto fondazione<br />
(ora 9), diverse consistenze ma senza gobbe<br />
(ora 11), posa elementi prefabbricati<br />
(ora 30), pompaggio calcestruzzo alla base<br />
(ora 32), cucitura avvenuta (ora 33),<br />
getti per cuciture parti superiori dell’elemento<br />
(ora 38), realizzazione della soletta (ora 40),<br />
avvio operazioni posa binario (ora 44)<br />
cati (Tensiter, ndr, ne abbiamo parlato più volte anche<br />
sulle pagine di leStrade) da posizionare sotto la linea ferroviaria<br />
per consentire il transito veicolare. La difficoltà,<br />
tipica del contesto rail: realizzare l’intervento a regola<br />
d’arte in tempi rapidissimi, ovvero sfruttando le limitatissime<br />
possibilità di interruzione d’esercizio. A conti<br />
fatti, l’impresa è stata compiuta in circa 50 ore. Ecco<br />
le prime fasi: taglio dei binari, asportazione dei medesimi,<br />
realizzazione dello scavo. Parallelamente si lavora<br />
agli impianti di betonaggio, si predispongono le autobetoniere,<br />
si formano adeguatamente gli autisti, si calcolano<br />
al secondo le tempistiche. Il primo calcestruzzo,<br />
molto particolare dato il basso rapporto acqua-cemento,<br />
è quello che avrebbe dovuto comporre le fondazioni<br />
degli elementi prefabbricati: a 2 ore e mezza l’obiet-<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
La punta di eccellenza nell’ambito dell’innovazione<br />
e della sperimentazione Anas (Gruppo FS Italiane)<br />
è rappresentata dal Centro Sperimentale Stradale<br />
di Cesano (CSS), il polo di riferimento scientifico,<br />
tecnico e di supporto a livello nazionale per tutte<br />
le attività concernenti la costruzione e la manutenzione<br />
delle infrastrutture viarie. Il Centro è inoltre il<br />
soggetto certificatore del rispetto delle norme tecniche<br />
e dei criteri di qualità nella realizzazione dei<br />
nuovi interventi. Il Centro è oggi impegnato sempre<br />
più nella ricerca di soluzioni innovative, con accresciuta<br />
sensibilità ai temi centrali della protezione<br />
dell’ambiente stradale e della sicurezza attiva<br />
e passiva delle infrastrutture viarie. In questo contesto<br />
partecipa anche a iniziative a livello internazionale.<br />
Il risultato di queste ricerche si esplica attraverso<br />
la messa a punto e la diffusione di norme<br />
tecniche prestazionali e linee guida nei diversi settori<br />
di interesse.<br />
Le attività sui materiali<br />
Rimandando alla sezione dedicata sul sito web<br />
dell’Anas stradeanas.it, limitiamoci in questa<br />
sede a una descrizione sintetica del Centro per<br />
quanto riguarda il solo aspetto dei materiali. Il<br />
Centro esegue prove e analisi su campioni di<br />
ogni tipo di materiale, per conto di Anas, amministrazioni<br />
e enti locali, privati. Le attività si svolgono<br />
nei seguenti laboratori: chimico, strutture,<br />
pavimentazioni, geotecnica, segnaletica.<br />
• Laboratorio chimico. È al servizio dei laboratori<br />
del Centro. Esegue le prove prescritte dalla<br />
normativa sui leganti idraulici, sulle pitture spartitraffico<br />
(segnaletica orizzontale), sulle materie<br />
plastiche (segnaletica complementare) e sulle<br />
terre (sostanze organiche). Con apparecchiature<br />
portatili, inoltre, esegue prove in situ per la<br />
segnaletica orizzontale (visibilità diurna, notturna<br />
e scivolosità).<br />
6. Il viadotto della Roma-Fiumicino progettato da Riccardo Morandi e<br />
monitorato, insieme ai manufatti di tutta la rete in gestione, dall’Anas<br />
© Wikipedia<br />
7. L’ingegner Marcello<br />
De Marco, responsabile<br />
del Centro<br />
Sperimentale Anas di<br />
Cesano<br />
• Laboratorio strutture. Esegue le prove prescritte<br />
dalla normativa sul conglomerato cementizio, sui<br />
leganti idraulici, sugli acciai e sulle barriere stradali.<br />
Il laboratorio esegue anche prove nei cantieri<br />
sulle opere di calcestruzzo e prove statiche e dinamiche<br />
non distruttive sulle opere d’arte.<br />
• Laboratorio pavimentazioni. Esegue le prove<br />
necessarie ad accertare la corrispondenza alle<br />
prescrizioni Anas dei conglomerati bituminosi<br />
e dei leganti idrocarburati (bitumi tradizionali<br />
modificati ed emulsioni), impiegati nella costruzione<br />
delle sovrastrutture stradali. Studia le<br />
nuove miscele con materiali innovativi.<br />
• Laboratorio geotecnica (Terre, Rocce, Geosintetici).<br />
Esegue prove per il controllo dei materiali<br />
posti in opera e per la redazione di capitolati<br />
ed elenchi prezzi. Ricerca nuove tecniche per la<br />
caratterizzazione e l’uso di materiali geotessili<br />
isotropi e anisotropi nelle diverse applicazioni<br />
stradali di filtrazione delle acque, armatura dei<br />
terreni e conglomerati bituminosi, impermeabilizzazione<br />
gallerie e impalcati di ponti e viadotti.<br />
Esegue prove per la caratterizzazione delle<br />
terre in sito (portanza statica e dinamica, densità,<br />
ecc.) e in laboratorio.<br />
• Laboratorio segnaletica. Misura i livelli di<br />
qualità della segnaletica verticale, in particolare<br />
della pellicola retroriflettente che costituisce<br />
il segnale stradale (coefficiente areico<br />
d’intensità luminosa o coefficiente di retro-riflessione;<br />
fattore di luminanza e coordinate cromatiche).<br />
Verifica la segnaletica orizzontale, con<br />
apparecchiature portatili (coefficiente di luminanza<br />
in condizioni di illuminazione diffusa; coefficiente<br />
di luminanza retroriflessa; fattore di luminanza<br />
e coordinate cromatiche).
92<br />
93<br />
LS<br />
Strutture in Calcestruzzo<br />
Tecniche di misura<br />
dello stato tensionale<br />
FOCUS SULLA CAROTA STRUMENTATA E SUL PROVINO TRONCO PIRAMIDALE,<br />
OVVERO DUE TECNICHE INNOVATIVE CHE CONSENTONO, OGGI, DI ACCRESCERE<br />
LA CONOSCENZA DELLO STATO TENSIONALE DELLE STRUTTURE IN<br />
CALCESTRUZZO, IN QUANTO SFRUTTANO IL RILASCIO TENSIONALE E LO RENDONO<br />
APPLICABILE ANCHE A ELEMENTI ARMATI COME LE TRAVI PRECOMPRESSE DA<br />
PONTE. DI SEGUITO, PRESENTIAMO I RISULTATI (DECISAMENTE SODDISFACENTI)<br />
DI UN PROGETTO DI RICERCA APPLICATIVA AD HOC.<br />
La conoscenza dello stato tensionale di un elemento<br />
strutturale è fondamentale per una corretta valutazione<br />
delle condizioni di lavoro, e quindi di sicurezza,<br />
di una struttura. La sua misura, di natura sperimentale,<br />
permette di migliorare la calibrazione del modello<br />
numerico, rendendo così più affidabili i risultati teorici. Se<br />
ci riferiamo, ad esempio, alla conoscenza delle sollecitazioni<br />
dei pilastri di fondazione di un edificio, dove il naturale<br />
assestamento nel tempo comporta un riallineamen-<br />
Materiali<br />
to dei carichi teorici, la conoscenza dello stato di tensione<br />
reale, confrontata con la resistenza ultima del materiale,<br />
permette di valutare il livello di sicurezza e lo spazio di sollecitazione<br />
ancora accettabile a fronte di eventi straordinari<br />
come quelli sismici [1] [2]. Capita spesso infatti che i<br />
risultati delle prove in laboratorio dei prelievi di carote di<br />
calcestruzzo forniscano valori scadenti, come 10-15 MPa,<br />
ma questo risultato, sia pur fuori norma, potrebbe essere<br />
compatibile a fronte di condizioni di lavoro in esercizio<br />
Settimo Martinello<br />
4 EMME Service SpA<br />
1. Infradosso di un impalcato<br />
1<br />
© atlantearchitetture.beniculturali.it<br />
2. Esecuzione di una carota<br />
su pilastro<br />
2<br />
dell’elemento strutturale molto bassi. Valori che appunto<br />
ci si prefigge di misurare direttamente nel punto di prelievo.<br />
La possibilità di misurare lo stato tensionale in esercizio<br />
è altrettanto interessante nel caso delle travi precompresse,<br />
dove i fenomeni di degrado possono ridurre, nel<br />
tempo, lo stato di precompressione all’intradosso e quindi<br />
produrre una condizione che comporta, attraverso i carichi<br />
di esercizio, uno stato tensionale di trazione con possibili<br />
fessurazioni. Quanto premesso rende l’idea dell’utilità<br />
di avere metodi sperimentali per la misura dello stato tensionale<br />
in esercizio sia di elementi strutturali fondamentali,<br />
come pilastri e travi di edifici, che di elementi in condizione<br />
di massima sollecitazione, come le mezzerie delle<br />
travi precompresse da ponte.<br />
In questo articolo, vengono presentate due innovative tecniche<br />
di misura dello stato tensionale: la Carota strumentata<br />
e il Provino tronco piramidale. Esse sfruttano la tecnica del<br />
rilascio tensionale, che era già nota, ma non aveva ad oggi<br />
una soluzione esecutiva affidabile e, nei casi come le travi da<br />
ponte, risultava impossibile da applicare a causa della quantità<br />
di armature presenti. Queste metodologie esecutive sono<br />
state sviluppate nel corso del 2020, all’interno di un progetto<br />
di ricerca che mirava ad individuare soluzioni per valutare le<br />
condizioni reali di conservazione dei viadotti delle autostrade.<br />
I risultati delle campagne di prova hanno dimostrato la<br />
validità della metodologia fornendo ai professionisti incaricati<br />
della valutazione della sicurezza delle opere uno strumento<br />
affidabile per la migliore validazione dei modelli numerici.<br />
Il rilascio tensionale<br />
La tecnica di rilascio tensionale, che è il punto di partenza delle<br />
due tecniche innovative qui presentate, è nota. Consiste nel<br />
misurare la deformazione ε relativa del calcestruzzo all’interno<br />
della circonferenza di taglio di una carota di prelievo. Si basa<br />
sulla teoria che lo stato tensionale Ơ preesistente provoca una<br />
variazione deformativa ε in proporzione al carico applicato ed<br />
al Modulo elastico E del materiale, attraverso la relazione di<br />
Hooke Ơ = E ε. Pertanto, nel momento in cui si esegue il carotaggio,<br />
man a mano che la carotatrice avanza, lo stato tensionale<br />
del provino si modifica andando infine ad annullarsi e<br />
producendo una deformazione di segno opposto a quella preesistente,<br />
appunto il rilascio tensionale. La misura della deformazione<br />
viene eseguita attraverso l’applicazione di estensimetri<br />
(strain gauges) posti sulla superficie, all’interno della<br />
circonferenza di taglio, nelle direzioni in cui si ritiene si sviluppi<br />
la sollecitazione. Questa operazione presentava due difficoltà<br />
che ne impedivano, sostanzialmente, l’utilizzo.<br />
• La prima difficoltà è legata al fatto che la misura di deformazione<br />
attraverso estensimetri è una misura molto delicata,<br />
con valori parametrici esigui, espressi in microVolt.<br />
Vanno considerate le numerose possibili anomalie prodotte<br />
dalle vibrazioni sul provino, dall’acqua impiegata per il taglio,<br />
ecc. Inoltre, la prova rileva il valore della Resistenza<br />
elettrica solo in due momenti, prima e dopo il taglio, esprimendo<br />
il rilascio tensionale come differenza tra questi due<br />
valori. Queste considerazioni rendevano il risultato di questa<br />
prova non affidabile, in particolare, nei casi in cui i valori<br />
risultano “allarmanti” e comportano decisioni drastiche.<br />
• La seconda difficoltà nasce dall’impossibilità di eseguire<br />
la prova nei punti di massima sollecitazione (come la mezzeria<br />
delle travi precompresse). Infatti, la presenza delle<br />
armature limita la scelta della posizione di carotaggio a<br />
zone con ridotta armatura e molto sensibili al danno strutturale<br />
che la carota provoca.<br />
Queste due difficoltà hanno relegato l’idea del rilascio tensionale<br />
a una semplice possibilità non trasformata in una<br />
reale tecnica diagnostica in sito. Difficoltà che sono oggi<br />
superate attraverso un sistema di acquisizione in continuo<br />
durante il prelievo delle carote, metodologia che prende<br />
il nome di Carota strumentata, e con la tecnica del prelievo<br />
di Provini tronco piramidali nel caso delle travi precompresse<br />
dove l’armatura è così densa che non permette<br />
il carotaggio.<br />
Fenomeni di degrado<br />
La precompressione si realizza mettendo in trazione cavi di<br />
acciaio appositamente inseriti nel getto. Rilasciando i cavi si<br />
trasferisce la compressione sul calcestruzzo. Poste le travi in<br />
essere queste subiscono una serie di fenomeni “naturali” che<br />
comportano una sensibile riduzione dello stato di compressione<br />
dell’intradosso. Al di là dell’applicazione dei pesi propri,<br />
che provoca un effetto di trazione all’intradosso, il fenomeno<br />
del ritiro comporta per sua natura una riduzione della<br />
precompressione che si sviluppa nell’arco di diversi mesi successivi<br />
al getto. Nel proseguo della vita dell’impalcato si manifestano<br />
fenomeni legati al processo di carbonatazione con<br />
conseguente ossidazione, e in alcuni casi corrosione, delle<br />
parti metalliche. Questo fenomeno degradante comporta<br />
una riduzione dell’aderenza tra armatura e calcestruzzo, distribuita<br />
o puntuale, producendo intrinsecamente una riduzione<br />
dello stato di precompressione. Nei lunghi periodi, decine<br />
di anni, si sviluppa anche il fenomeno del rilassamento<br />
dei cavi d’acciaio dovuto all’alto numero di oscillazioni subite.<br />
Oscillazioni che alternando diversi stati tensionali producono<br />
una riduzione dello stato di trazione dei cavi e di conseguenza<br />
di compressione del calcestruzzo. Per lo studio delle<br />
condizioni di degrado, generalmente individuate nella corrosione<br />
dei cavi o nella incompleta iniezione delle guaine,<br />
sono attualmente impiegate diverse tecnologie: tomografia<br />
ultrasonica, prove riflettometriche, radiografia, endoscopia<br />
[3]. Lo scopo di queste tipologie di indagine è quello di individuare<br />
l’entità e la posizione dei difetti, che costituiscono<br />
la causa che provoca la riduzione della precompressione. Le<br />
tecniche indicate sono esecutivamente complesse nel caso<br />
delle travi da ponte, sia per l’ampiezza delle superfici in studio<br />
sia per il fatto che spesso le travi sono accoppiate e quindi<br />
poco accessibili. Inoltre, offrono solo una stima dello stato<br />
di corrosione, difficilmente correlabile con la riduzione di<br />
precompressione provocata da tali fenomeni. Ecco che rilevare<br />
direttamente lo stato di precompressione, cioè valutare<br />
la conseguenza dei fenomeni di degrado, è un procedimento<br />
più affidabile in termini interpretativi.<br />
La tecnica del rilascio tensionale, una volta trovate le soluzioni<br />
pratiche che ne permettano l’impiego, si può considerare<br />
una soluzione ideale sia per l’importanza della risposta sia per<br />
il costo ridotto rispetto alle tecniche diagnostiche accennate.<br />
4/<strong>2021</strong><br />
Materiali
94<br />
95<br />
LS<br />
Sviluppo dello strumento di rilievo<br />
Il primo obiettivo del lavoro di ricerca è stato incentrato nel<br />
risolvere il primo dei due problemi fondamentali descritti in<br />
premessa: registrare i dati in continuo durante l’esecuzione<br />
della carota.<br />
È stato così sviluppato uno strumento di piccole dimensioni<br />
che ha la possibilità di alimentare estensimetri, memorizzare<br />
i dati, funzionare a batteria, non subire effetti a causa delle<br />
vibrazioni e soprattutto essere stagno. Il processo di sviluppo<br />
tecnologico ha visto la sperimentazione di diversi prototipi<br />
e il risultato finale denominato “Tensometer” offre tutte le<br />
caratteristiche richieste.<br />
Esternamente si presenta come un cilindro di diametro 70<br />
mm e altezza 100 mm. Dalla parte di fissaggio alla parete<br />
porta una guarnizione e dalla parte opposta una porta USB<br />
per il collegamento ad un’applicazione che consente di attivarlo,<br />
modificarne i parametri di lettura e scaricare i dati.<br />
Il Tensometer porta sul fronte di contatto con la parete due<br />
6<br />
3<br />
4<br />
morsetti a presa rapida per un facile collegamento ai cavi degli<br />
estensimetri. Due fori lungo lo spessore del contenitore<br />
cilindrico consentono l’introduzione di due viti che permettono<br />
il fissaggio tramite tasselli. Sulla testa porta un “tappo”<br />
svitabile, ma a tenuta stagna, che consente di aprire lo strumento<br />
e sostituire la batteria. Una seconda versione, denominata<br />
“Tensometer online”, gestisce la trasmissione dati in<br />
sistema telemetrico con mini-antenne ceramiche, consentendo<br />
di trasferire i dati in tempo reale pur rimanendo all’interno<br />
della carotatrice.<br />
La sperimentazione con carota<br />
strumentata<br />
Per una prima fase di studio sono stati predisposti 4 provini<br />
in calcestruzzo, di dimensioni 40 x 25 x 60 cm, con diverse<br />
caratteristiche di resistenza meccanica. I provini sono stati<br />
strumentati con 2 estensimetri affiancati in direzione verticale<br />
nel centro di entrambe le facce 40 x 60. Su una faccia,<br />
quella del carotaggio, è stato montato il Tensometer, mentre<br />
sull’altra faccia, i due estensimetri sono stati collegati ad<br />
un Datalogger di acquisizione dati. I provini sono stati posti<br />
a compressione sotto una pressa, portando la forza a 2.000<br />
kN, corrispondente ad una sollecitazione di 20 MPa. Tale forza<br />
ha prodotto deformazioni relative tra 800 e 1.000 µε. L’operazione<br />
è stata eseguita interrompendo l’avanzamento della<br />
carotatrice ogni 2 cm in modo da cogliere il momento del<br />
completo rilascio dello stato tensionale.<br />
Il grafico di fig. 5 evidenzia l’andamento deformativo del centro<br />
del provino attraverso la lettura dei due estensimetri frontali<br />
monitorati con il Tensometer. Si osserva la fase di carico<br />
prodotta dalla pressa, che provoca una deformazione relativa<br />
3. Montaggio del Tensometer<br />
4. Esecuzione di una carota<br />
su pilastro<br />
5. Andamento della<br />
deformazione relativa durante<br />
la fase di carotaggio<br />
5<br />
6. Sequenza esecutiva della<br />
prova in laboratorio<br />
7. Estrazione di una carota<br />
strumentata<br />
8. Deformazione relativa<br />
media rilevata<br />
8<br />
9. Campate a travi<br />
precompresse<br />
10. Direzione dei tagli<br />
11. Provino tronco piramidale<br />
12. Fase di taglio lato<br />
verticale<br />
13. Fase di taglio lato<br />
orizzontale<br />
7<br />
finale attorno ai 900 µε. L’inizio del carotaggio provoca, per<br />
effetto del rilascio, una rapida riduzione della deformazione<br />
che coi primi 2 cm di profondità è di circa il 40%. Il completo<br />
rilascio si sviluppa a circa 10 cm di profondità.<br />
Le prove eseguite sui diversi provini hanno mostrato come<br />
il rilascio completo tenda a mostrarsi a profondità maggiori<br />
man mano che aumenta la resistenza del materiale. Certamente<br />
l’estrazione della carota garantisce il completo rilascio<br />
tensionale. Nel caso di una prova in campo la misura della<br />
deformazione parte da un azzeramento iniziale dei valori di<br />
misura. Pertanto, nel caso di una struttura compressa, il rilascio<br />
prodotto dall’estrazione della carota produce una deformazione<br />
espansiva, dove la deformazione relativa risulta<br />
“positiva” (vedi fig. 8). Il valore rilevato dovrà essere pertanto<br />
invertito di segno.<br />
9 10 11<br />
Rilascio tensionale<br />
con provino tronco piramidale<br />
Come spiegato in premessa, non sempre è possibile estrarre<br />
una carota, sia per la densità delle armature presenti sia per<br />
non danneggiare eccessivamente la struttura in punti particolarmente<br />
sollecitati. Questa condizione si presenta spesso,<br />
ed in particolar modo, nel caso delle travi precompresse nella<br />
zona di mezzeria all’intradosso, dove la sollecitazione derivante<br />
dai carichi accidentali è massima. Per ovviare a questa<br />
difficoltà, si è proceduto ad una serie di prove di laboratorio<br />
per individuare una forma di provino estraibile che potesse<br />
limitarsi ad una profondità di pochi millimetri. La soluzione<br />
individuata, che ha fornito la migliore risposta nel garantire<br />
il completo rilascio e il minimo danneggiamento, è stata<br />
la forma del quadrato tronco piramidale. Dopo l’esecuzione<br />
dei tagli, il provino tronco piramidale infatti risulta collegato<br />
alla struttura per una piccola sezione e è quindi estraibile<br />
applicando un minimo sforzo. Lo spessore del provino risulta<br />
di circa 24 mm, fatto che rende possibile eseguire la prova<br />
12<br />
13<br />
Materiali<br />
Materiali<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
96<br />
97<br />
LS<br />
anche in presenza di armature purché, ovviamente, il copriferro<br />
sia adeguato. La tecnica esecutiva prevede l’applicazione<br />
sulla superficie della trave, nel punto di misura di interesse,<br />
di una coppia di estensimetri disposti in direzione<br />
orizzontale adiacenti l’uno all’altro.<br />
La fase successiva consiste nell’isolare una porzione dell’elemento<br />
strutturale mediante quattro tagli prodotti sui lati di<br />
un quadrato 60 x 60 mm.<br />
I tagli sono eseguiti con una direzione di 45° verso l’interno,<br />
figura 9, in modo da realizzare un elemento tronco-piramidale<br />
con una sezione di testa estremamente ridotta, tale da garantire<br />
il completo rilascio delle deformazioni incorporate. La<br />
deformazione, ε, misurata dagli estensimetri nella porzione<br />
isolata è uguale in segno contrario alla deformazione relativa<br />
derivante dalla precompressione e dai carichi permanenti.<br />
Sono state eseguite diverse prove in laboratorio, in una prima<br />
fase operando con un taglio manuale e successivamente<br />
attraverso una apparecchiatura elettro meccanica, denominata<br />
“Discovery”, che consente di effettuare tagli precisi,<br />
sempre alla distanza di 60 mm, perfettamente ortogonali ed<br />
a 45° verso l’interno.<br />
L’uso di una macchina si è dimostrato fondamentale per ottenere<br />
dei provini precisi e ripetibili. Lo studio si è sviluppato<br />
imponendo una compressione di 1.500 kN pari a 15 Mpa. Nel<br />
centro del punto di prova sono stati incollati 2 estensimetri<br />
affiancati in direzione verticale, collegati con un Datalogger<br />
installato nel Discovery che consente, attraverso un collegamento<br />
wireless, di seguire l’andamento, l’effetto del rilascio<br />
tensionale, e quindi della deformazione relativa, in tempo<br />
reale. I 4 tagli vengono eseguiti in successione lasciando 60<br />
secondi di tempo tra uno e l’altro per poter valutare l’effetto<br />
di ogni singolo taglio.<br />
In fig. 14 è possibile osservare l’evolversi della deformazione<br />
relativa di rilascio tensionale di una prova in laboratorio.<br />
La tecnica di prova di rilascio con provino tronco piramidale<br />
è stata ampliamente sperimentata su diverse travi precompresse<br />
di ponti autostradali eseguendo complessivamente oltre<br />
100 prove. Di seguito si riporta l’esempio di un Rapporto<br />
di prova ad indicare lo schema delle informazioni che sono<br />
necessarie per una corretta interpretazione dei risultati. La<br />
prova di rilascio sulla trave può essere eseguita sia lateralmente<br />
che all’intradosso.<br />
In ogni caso, se si utilizza il By-bridge è necessario tenere<br />
conto della riduzione della compressione provocata dal peso<br />
16<br />
15a<br />
14<br />
15b<br />
14. Andamento della<br />
deformazione relativa durante<br />
le quattro fasi di taglio<br />
15. Fasi esecutive di una<br />
prova di rilascio con provino<br />
tronco piramidale<br />
16. Rapporto di prova<br />
17. Prove di Pull-out in zona<br />
di rilascio<br />
18. Stampa in sito dei risultati<br />
del Pull-out<br />
19. Andamento della<br />
temperatura dei diversi<br />
componenti di una trave<br />
20. Linea di tendenza<br />
previsionale dello stato<br />
di compressione<br />
17<br />
18<br />
del mezzo sovrastante. Effetto che è valutabile attraverso<br />
una misura della deformazione relativa durante l’ingresso in<br />
campata del mezzo. Questo valore dovrà essere aggiunto a<br />
quello rilevato dalla prova di rilascio.<br />
Interpretazione dei risultati<br />
Chi opera nel settore dei controlli del materiale conosce la<br />
difficoltà interpretativa dei risultati ottenuti dalle prove sul<br />
calcestruzzo. Difficoltà che si presentano nella interpretazione<br />
dei risultati sia di laboratorio che delle prove in sito.<br />
Il calcestruzzo è un materiale disomogeneo, le cui caratteristiche<br />
possono cambiare sensibilmente anche in aree<br />
limitate. È per questo che le norme prevedono più misure<br />
e tecniche di elaborazione basate sulle medie per le prove<br />
di Resistenza sulle carote (o cubetti), Pull out, Sclerometro,<br />
ecc. Questa osservazione è la ragione per cui nella<br />
prova di rilascio si ritiene opportuno effettuare almeno<br />
due misure per singola direzione. In questo modo si ha<br />
una garanzia di affidabilità dei valori letti, in quanto ci si<br />
deve aspettare andamenti omogenei delle due curve rappresentative<br />
della deformazione. L’affidabilità del risultato<br />
della prova di rilascio è fondamentale, in quanto in taluni<br />
casi, il rilievo della sollecitazione su un elemento strutturale<br />
può rappresentare un fattore di allarme se il valore<br />
letto ha poca corrispondenza con l’atteso o un rapporto<br />
troppo piccolo rispetto alla sua Resistenza. Il passaggio<br />
da deformazione relativa a sollecitazione avviene attraverso<br />
il Modulo elastico. Valore che è stimabile attraverso<br />
la formula indicata nelle norme basata sulla Resistenza<br />
a compressione:<br />
È consigliabile effettuare delle prove di stima della resistenza<br />
del calcestruzzo in vicinanza al punto di esecuzione del<br />
rilascio. Sono particolarmente indicate le prove di Pull out,<br />
che provocano un danno limitato e che, tra le varie prove in<br />
situ sul calcestruzzo, rappresentano quelle più affidabili [3].<br />
Monitoraggio dello stato<br />
di precompressione<br />
La tecnica del rilascio tensionale con Provino tronco piramidale,<br />
che consente la misura dello stato di precompressione<br />
“attuale” delle travi precompresse dei ponti, apre la possibilità<br />
al Monitoraggio di questo parametro partendo appunto dal<br />
valore ottenuto dall’indagine in sito. Conosciuta la sollecitazione<br />
di compressione all’intradosso “attuale” è possibile monitorare<br />
l’andamento nel tempo della deformazione relativa<br />
utilizzando la stessa tipologia di strumenti, gli estensimetri.<br />
Posizionando gli estensimetri in prossimità delle zone dove<br />
è stata eseguita la prova di rilascio si potrà ottenere la variazione<br />
di questo parametro nel tempo, tenendo così sotto<br />
controllo i fenomeni di degrado che tendono a ridurre lo stato<br />
di precompressione. Tale metodologia di controllo è molto<br />
più semplice e meno costosa delle tecniche di monitoraggio<br />
dinamiche che vogliono comprendere lo stato tensionale attraverso<br />
la misura delle frequenze proprie [5]. Va sottolineato<br />
che la misura della deformazione relativa è influenzata dal<br />
comportamento termico della struttura. Le strutture, infatti,<br />
subiscono vari fenomeni deformativi conseguenti alla variazione<br />
di temperatura. Il più importante è la dilatazione termica<br />
del materiale, a cui si somma l’effetto “girasole” derivante<br />
dalle deformazioni differenziate provocate dell’irraggiamento<br />
19<br />
20<br />
Materiali<br />
Materiali<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
98<br />
21<br />
21. Fasi di installazione di un<br />
monitoraggio estensimetrico<br />
22. Immagine dei tecnici<br />
impegnati nella prima prova<br />
con provino tronco piramidale<br />
solare sulle singole superfici, e altri fenomeni minori, tra cui<br />
l’effetto di mutua sollecitazione provocata dal diverso coefficiente<br />
di dilatazione termica del calcestruzzo rispetto a quella<br />
dell’acciaio. Valori che variano tra 9 e 12 µε/°C. Inoltre,<br />
ovviamente, i valori monitorati sono influenzati degli effetti<br />
provocati dal transito dei mezzi. Per queste ragioni le tecniche<br />
di depurazione dei fattori di disturbo sono molteplici.<br />
Innanzitutto, la misura deve essere effettuata in prima mattina,<br />
quando si inverte l’andamento termico e si crea una zona<br />
temporale di stabilità termica. In questa fascia oraria, va intensificata<br />
la frequenza di misura e con appositi algoritmi si<br />
va a costruire la deformazione relativa depurata dagli effetti<br />
dinamici prodotti dal transito dei mezzi. L’obiettivo è quello di<br />
ricavare, a partire dai numerosi dati acquisiti, un solo singolo<br />
valore giornaliero per strumento. Infatti, tenuto conto che il<br />
fenomeno della riduzione di precompressione si sviluppa in<br />
periodi medio lunghi, si vogliono estrarre pochi dati, ma affidabili<br />
e di facile gestione.<br />
Avremo così a disposizione un grafico di più semplice lettura,<br />
che non necessita di particolari interpretazioni e che può essere<br />
gestito direttamente dagli operatori degli Enti concessionari.<br />
Ad oggi, nonostante le varie metodologie di depurazione utilizzate,<br />
non si è ancora in grado di depurate completamente<br />
gli effetti termici descritti. Si può ottenere però, attraverso<br />
le operazioni indicate, un andamento grafico poco alterato<br />
dagli effetti termici.<br />
Alterazione che si manifesta con un leggero andamento sinusoidale<br />
nell’arco di un anno. Questo risultato consente, dopo<br />
alcuni mesi dalla partenza del monitoraggio, di attivare una<br />
elaborazione basata sulla linea di tendenza che potrà fornirci<br />
una previsione nel lungo periodo sull’andamento della riduzione<br />
dello stato di precompressione. Linea di tendenza che<br />
andrà a migliorare di precisione nel tempo man a mano che<br />
si accumuleranno i dati giornalieri.<br />
Riguardo la conoscenza della deformazione assoluta di una<br />
trave, la variazione della freccia, sappiamo che tra deformazione<br />
relativa orizzontale e deformazione assoluta verticale<br />
esiste un rapporto ben identificato e legato, oltre che ai parametri<br />
meccanici e geometrici, ai vincoli. Genericamente il<br />
rapporto è espresso come f = R ε dove, nel caso del semplice<br />
appoggio e in condizione di carico distribuito,<br />
R =<br />
Materiali<br />
e dove y esprime la distanza dall’asse neutro.<br />
Sperimentalmente è possibile ricavare la correlazione tra deformazione<br />
relativa e freccia. Al momento dell’installazione<br />
degli strumenti di monitoraggio si può eseguire una prova di<br />
carico (anche a carichi ridotti, ma distribuiti, come ad esempio<br />
più automobili a simulare un carico distribuito) e rilevare<br />
contemporaneamente la freccia in mezzeria e la deformazione<br />
relativa indicata dagli estensimetri posti a monitoraggio. Conosciuto<br />
R, l’andamento di ε corrisponderà all’andamento di f.<br />
Conclusioni<br />
La possibilità di rendere operativa e funzionale la tecnica del<br />
rilascio tensionale apre una importante opportunità per chi<br />
ha il compito di valutare le condizioni di sicurezza delle opere.<br />
La Carota strumentata offre uno strumento fondamentale<br />
per la corretta valutazione della vulnerabilità sismica degli<br />
edifici e la tecnica del Provino tronco piramidale consente<br />
una verifica delle condizioni attuali delle strutture da ponte a<br />
campate composte da travi precompresse, aprendo la strada<br />
alla possibilità di monitoraggi semplici ed affidabili per il<br />
controllo nel tempo dell’evolversi del degrado. Questa tecnologia<br />
innovativa mette in luce l’importanza di affinare le tecniche<br />
di diagnostica strutturale. Un passo avanti importante<br />
che però non deve far dimenticare che il corretto studio di un<br />
edificio esistente passa, inderogabilmente, dalla costruzione<br />
di un modello numerico aderente, calibrato sulla base delle<br />
risultanze sperimentali, e la Carota strumentata, in questo<br />
senso può rappresentare un valido indicatore puntuale della<br />
affidabilità delle valutazioni teoriche. Lo stesso si può dire per<br />
i ponti. La strumentazione di monitoraggio o la possibilità di<br />
conoscere lo stato di sollecitazione attuale non può sostituire<br />
la fondamentale esecuzione di ispezioni visive sistematiche<br />
[6][7], che rimangono il fondamentale presidio per un<br />
sostanziale controllo della sicurezza delle infrastrutture. nn<br />
22<br />
Bibliografia<br />
[1] D. Acierno, G. Ciniglio,<br />
2010, Uni Federico II - Valutazione<br />
della resistenza a compressione<br />
del calcestruzzo.<br />
[2] European Standard and<br />
American Code, Ottobre 2017<br />
- Variation of in situ concrete<br />
strength.<br />
[3] G. Piscsalko, G.E. likins, B.<br />
White, Giugno 2013, International<br />
Bridge Conference - Current<br />
Practice and New Method.<br />
[4] S. Martinello, 4 Emme Service<br />
SpA, 2012 - Prove in sito.<br />
[5] S. Martinello, rivista Galileo,<br />
Giugno 2018 - Sulla efficacia<br />
del monitoraggio del comportamento<br />
dinamico dei ponti.<br />
[6] Ministero delle Infrastrutture<br />
e dei Trasporti, Febbraio<br />
2020 - Linee guida per la classificazione<br />
e gestione del rischio,<br />
la valutazione della sicurezza<br />
ed il monitoraggio dei ponti esistenti.<br />
[7] E. Giangreco, L. Jurina, E.<br />
Siviero, S. Tattoni, 2018, CIAS<br />
- Manuale valutazione dello stato<br />
dei ponti.<br />
Una gamma completa di compattatori e<br />
battipali, capaci di garantire efficacia nella<br />
compattazione, rapidità e sicurezza.<br />
Fresaceppi e trivelle, produzioni MADE IN ITALY della massima qualità.<br />
ATTREZZATURE<br />
MADE IN ITALY<br />
DELLA MASSIMA QUALITA<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
www.canginibenne.com
100<br />
101<br />
LS<br />
Parapetti e Staccionate<br />
Il Piave mormorò…<br />
La ciclabile<br />
è super-protetta<br />
Emilia Longoni<br />
LUNGO IL FASCINOSO PIAVE, NEL TREVIGIANO, CORTENSAFE HA PORTATO<br />
SULLE NUOVE PISTE CICLABILI DIECI CHILOMETRI COMPLESSIVI DI SOLUZIONI<br />
AD ALTA PROTEZIONE E INSIEME PREGIO NATURALISTICO. SI TRATTA DI UN<br />
PARAPETTO CON MONTANTE IN CORTEN E RETE IN ACCIAIO INOX E DI UNA<br />
STACCIONATA DI ULTIMA GENERAZIONE SEMPRE IN CORTEN E LEGNO DI LARICE,<br />
FATTI ENTRAMBI SU MISURA DELLO STRAORDINARIO CONTESTO.<br />
2<br />
Tecnologie&Sistemi<br />
1<br />
3<br />
4 5<br />
Tecnologie&Sistemi<br />
1. L’innovativo parapetto<br />
Cortensafe corre lungo<br />
il Piave<br />
2, 3. 4. Alcuni tratti protetti<br />
con il parapetto, a cui<br />
è stata aggiunta una rete<br />
in acciaio Inox<br />
5. Soluzione di chiusura<br />
in acciaio Corten<br />
che porta buoni frutti. Esperienza della<br />
materia - nel nostro caso soluzioni di protezione di<br />
L’esperienza<br />
infrastrutture ciclabili così come di percorsi pedonali<br />
- ma anche di un contesto di sviluppo del tutto peculiare,<br />
nello specifico quello generato alla fine del 2015 da un’iniziativa<br />
normativa della Regione Veneto che si è tradotta<br />
in un elenco di ben 23 interventi di nuova ciclabilità, di cui<br />
12 finanziati, inserita generalmente in contesti ad alto pregio<br />
paesaggistico. Di questa iniziativa ci siamo già occupati<br />
alla fine del 2017 nell’articolo “I parapetti d’acciaio del Veneto<br />
ciclabile”, leStrade 11/2017, in cui abbiamo raccontato<br />
l’esperienza di fornitura, per l’appunto, di Cortensafe a ben<br />
4 dei 12 siti d’opera che hanno beneficiato dei fondi regionali<br />
(la mappa normativa è la Delibera della Giunta guidata<br />
da Luca Zaia n. 2049 del 23 dicembre 2015). Ora, una volta<br />
messe in sicurezza (con dispositivi tra l’altro che destano<br />
ottimi riscontri anche per quanto riguarda la durabilità<br />
e il design) numerosi tratti delle piste ciclabili di Valpolicella<br />
(Dolcè), Lunga Via delle Dolomiti (Longarone), itinerario<br />
Agno-Guà (Valdagno) e Percorso delle Risorgive (San Giovanni<br />
Lupatoto), Cortensafe ha “chiuso il cerchio” portando<br />
le proprie soluzioni - in questo caso realizzate su misura<br />
- anche lungo il Piave, in provincia di Treviso, nell’ambito<br />
del progetto “La Piave - Paesaggi Percorsi Territori - Landscapes<br />
Community Nature trails”, a cura di Consorzio BIM<br />
Piave di Treviso. Una ciliegina sulla torta, insomma, anche<br />
in ragione di una serie di prodotti studiati ad hoc per questa<br />
infrastruttura, che andiamo a illustrare.<br />
Le soluzioni sviluppate<br />
Cortensafe, innanzitutto, ha sviluppato soluzioni funzionali<br />
(anche per quanto riguarda l’installazione) ed economicamente<br />
sostenibili, nonostante le peculiarità delle applicazioni<br />
anche in ragione delle aree tutelate in cui dovevano essere inserite.<br />
Dal punto di vista quantitativo, la fornitura si è tradotta<br />
in circa 5 km lineari, in tratti saltuari, di speciali parapetti<br />
in acciaio Corten integrati a una rete in acciaio Inox, nonché<br />
in altri 5 km circa di staccionata in acciaio Corten e legno di<br />
4/<strong>2021</strong>
102<br />
senti leggermente spostato in avanti (lo schema, suggeriscono<br />
da Cortensafe, è “ad ali di gabbiano”). “Si tratta di<br />
un parapetto costituito da un montante di forma circolare<br />
- nota Cracco - inserito in un corrimano non posizionato al<br />
centro del parapetto, secondo lo schema della nostra staccionata<br />
Snake, a cui si va ad aggiungere una rete in acciaio<br />
Inox ‘ispirata’ alla Stelvio HEC Grid, già presente nel catalogo<br />
Cortensafe. Questa soluzione da un lato si fonda su<br />
altre nostre esperienze di sviluppo, mentre dall’altro è totalmente<br />
customizzata: si tratta infatti di una novità assoluta”.<br />
Di due tipologie di altezze (1,30 e 1,50 m), il parapetto<br />
ha un montante infisso tramite profilo UNP con macchina<br />
battipalo nel terreno adiacente all’argine del Piave e presenta<br />
opportune predisposizioni per il passaggio delle funi<br />
in acciaio Inox a sostegno della rete forgiata con il medesimo<br />
materiale. “Stiamo parlando di un prodotto - aggiunge<br />
ancora Cracco - ad altissima protezione, che è stato opportuno<br />
andare a installare a protezione di quei punti del<br />
Piave caratterizzati da opere idrauliche con importanti portate<br />
idriche”.<br />
6. Staccionata con montante<br />
in acciaio Corten e tavole<br />
in legno di larice<br />
SOSTENIBILE<br />
ED EFFICIENTE<br />
6<br />
larice. Due soluzioni che progettualmente hanno sfruttato al<br />
meglio l’equilibrio di distinti materiali (non solo Corten, dunque),<br />
al fine di aumentare gli standard estetici e insieme quelli<br />
connessi a durabilità e minimizzazione delle manutenzioni.<br />
Ma approfondiamo nel dettaglio, con la collaborazione di Manuel<br />
Cracco di Cortensafe, entrambi i prodotti.<br />
Il parapetto<br />
La prima soluzione di cui ci occupiamo è un parapetto concepito<br />
per la massima protezione sia del ciclista, sia del pedone,<br />
grazie anche a una staffa ad hoc, per esempio, che<br />
fa sì che il corrimano non sia in asse con il palo ma si pre-<br />
La staccionata<br />
Lungo ulteriori 5 km, a tratti saltuari, ecco infine la staccionata<br />
di nuovissima concezione Cortensafe in acciaio Corten<br />
e legno, che riprende, nota Cracco, “la nostra Badia E3C<br />
Wood, ma anche in questo caso è totalmente customizzata”.<br />
L’effetto è decisamente suggestivo, come attestano anche<br />
le immagini che pubblichiamo in queste pagine: al montante<br />
in Corten vengono infatti intersecate tavole in legno di<br />
larice naturale tagliato fuori cuore. Proprio l’impiego di questa<br />
tipologia lignea è inoltre alla base, spiegano i suoi sviluppatori,<br />
dell’elevata durabilità del prodotto finale (per quanto<br />
riguarda quella del Corten, non abbiamo nulla da aggiungere…),<br />
di fatto raddoppiata rispetto a soluzioni standard. La<br />
staccionata è andata a proteggere e ornare strade ciclopedonali<br />
del Trevigiano, nell’area del Piave, che corrono per esempio<br />
lungo le golene. Tecnica e natura: ancora una volta un<br />
matrimonio di quelli che funzionano. nn<br />
7<br />
SOLUZIONI DI RICICLO SU MISURA<br />
L’uso dell’asfalto riciclato, o RAP, è oggi una necessità assoluta. In Ammann, vi offriamo soluzioni di<br />
riciclo su misura, compreso un elevato utilizzo di RAP. Per questo scopo, in prima linea c’è l’impianto di<br />
produzione di asfalto Ammann ABP HRT.<br />
Questo impianto è interamente dedicato al riciclo. Infatti, HRT sta per High Recycling Technology.<br />
L’impianto incorpora un alto grado di tecnologia ed innovazione, in particolare il processo di essiccazione in<br />
controcorrente del cilindro di riciclo RAH100.<br />
Basse emissioni<br />
Alta efficienza<br />
Riduzione dei danni al bitume<br />
• Riscaldamento indiretto<br />
• Bassa temperatura di scarico<br />
• Nessuna radiazione termica<br />
7. Armonia con la natura<br />
e durabilità: sono i due<br />
obiettivi raggiunti dalla nuova<br />
staccionata<br />
• Distribuzione omogenea del calore<br />
• Percentuali di riciclo fino al 100 %<br />
• Flessibilità della ricetta in quanto non è<br />
necessario surriscaldare i minerali<br />
• Temperature del RAP ottimale<br />
• Riscaldamento delicato del RAP<br />
Tecnologie&Sistemi<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
Ammann Italy S.r.l., Via dell’Industria, 1, 37012 Bussolengo<br />
Tel. + 39 045 676 4911, Fax + 39 045 670 1192, info.ait@ammann.com<br />
Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: www.ammann.com<br />
PMP-2785-00-IT | © Ammann Group
104<br />
105<br />
LS<br />
Innovazioni d’Europa<br />
Primato olandese<br />
nelle strade digitali<br />
1<br />
Grazia Crocco<br />
2 3<br />
2, 3. Segnaletica stradale<br />
digitale: una risorsa<br />
informativa preziosa anche<br />
per ciclisti e pedoni<br />
re entro il 2050, la cosiddetta Vision zero, come proposto<br />
dalla Commissione UE.<br />
Le prime valutazioni sulla sicurezza stradale dovranno essere<br />
effettuate entro il 2024. “Un importante passo avanti<br />
per la sicurezza dei nostri figli, con un occhio verso il futuro<br />
e verso il progresso tecnologico - ha dichiarato, in occasione<br />
dell’approvazione della nuova Direttiva da Parte del<br />
Parlamento europeo, l’eurodeputata Daniela Aiuto, proponente<br />
e relatrice della revisione legislativa -. È una Direttiva<br />
che guarda al futuro se pensiamo alle misure per la segnaletica<br />
e alla relativa interazione con veicoli equipaggiati con<br />
sistemi di assistenza automatica alla guida. Si tratta di un<br />
traguardo e al contempo un punto di partenza per un nuovo<br />
modo di concepire la sicurezza stradale”.<br />
Segnaletica e tecnologia<br />
Effettivamente nella direttiva c’è anche l’intento di armonizzare<br />
la segnaletica dei Paesi UE in modo che siano tutti facilmente<br />
riconoscibili dalle automobili e dall’uomo. In questo<br />
senso si stanno incamminando vari Paesi europei e alcuni<br />
si stanno ponendo all’avanguardia a livello internazionale. I<br />
Paesi Bassi sono, per esempio, il primo Paese al mondo ad<br />
aver creato un archivio digitale di tutti i segnali stradali nazionali.<br />
I dati della segnaletica (compreso il codice di indicazione<br />
e la posizione esatta) vengono memorizzati in formato<br />
digitale e poi resi disponibili come dati aperti. Questo<br />
tipo di sviluppo è stato commissionato dal Ministero delle<br />
Infrastrutture e della Gestione delle Acque. I dati sono stati<br />
collezionati dalla HR Group e saranno resi disponibili utilizzando<br />
la Nationale Databank Wegverkeersgegevens (National<br />
Road Traffic Database - NDW). Elaborando questi dati<br />
nelle applicazioni per il traffico o nei sistemi di navigazione,<br />
gli utenti della strada saranno così in grado di ricevere<br />
informazioni aggiornate sulla situazione del traffico sul loro<br />
percorso, comprese le zone di costruzione. Questa nuova<br />
tecnologia di segnaletica aiuterà le autorità stradali, i fornitori<br />
di servizi di informazione e gli utenti della strada, perché<br />
dati precisi e affidabili possono contribuire ad aumentare<br />
la sicurezza stradale. All’inizio questa sperimentazione<br />
riguardava i dati di tutta la segnaletica lungo le strade provinciali<br />
e principali e la segnaletica dei 130 maggiori comuni<br />
olandesi. Dopo l’estate, saranno inclusi anche i segnali di<br />
tutti i comuni più piccoli del Paese.<br />
Dati, aggiornare<br />
per migliorare<br />
L'NDW citato in precedenza è specializzato nel campo della<br />
raccolta dei dati sul traffico stradale. All’interno di esso circa<br />
19 autorità stanno collaborando alla raccolta, archiviazione<br />
e distribuzione dei dati sul traffico stradale. HR Group,<br />
specializzato in “oggetti” di traffico nello spazio pubblico,<br />
è l’organizzazione che si occupa della raccolta dei dati che<br />
manterrà aggionati per i prossimi due anni e forse più a lungo.<br />
Questo progetto garantirà elevati standard di sicurezza<br />
stradale, fornendo, in particolare, le informazioni aggiornate<br />
e corrette che possono essere comunicate agli utenti<br />
della strada sui limiti di velocità applicabili, i punti di carico<br />
e scarico, i divieti di sorpasso, le possibilità di parcheggio,<br />
i restringimenti stradali, ecc. Un contributo tecnologico<br />
importante per rendere le strade sempre più sicure. nn<br />
Tecnologie&Sistemi<br />
I PAESI BASSI DIGITALIZZANO TUTTI I SEGNALI STRADALI DELLA RETE<br />
NAZIONALE E DEI NETWORK DI OGNI COMUNE, DALLE METROPOLI AI PICCOLI<br />
PAESI, INSERENDO TUTTE LE INFORMAZIONI NEL SISTEMA NDW, NATIONAL<br />
ROAD TRAFFIC DATABASE. UNA FORMIDABILE RISORSA, PER TUTTI<br />
GLI STAKEHOLDER, NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA.<br />
La nuova direttiva europea sulla gestione della sicurezza<br />
delle infrastrutture stradali, che modifica la precedente<br />
Direttiva 2008/96/CE, attuata in Italia dal<br />
D.Lgs. 15/03/2011, n. 35, ha il principale obiettivo di ridurre<br />
l’incidentalità stradale attraverso una migliore progettazione<br />
e manutenzione di strade, gallerie e ponti. Essa garantisce<br />
un livello sistematicamente elevato di sicurezza stra-<br />
dale, estendendo l’ambito di applicazione alle autostrade e<br />
alle altre strade principali, oltre che a tutta la rete transeuropea<br />
di trasporto (TEN-T) e anche alle strade extraurbane,<br />
qualora siano state costruite utilizzando fondi UE. Queste<br />
nuove disposizioni puntano a conseguire gli obiettivi strategici<br />
di dimezzare il numero di vittime della strada, per avvicinarsi<br />
all’azzeramento degli incidenti mortali da consegui-<br />
1. Grande viabilità<br />
nei Paesi Bassi<br />
4. Si implementa<br />
ulteriormente il database<br />
nazionale sul traffico NDW<br />
4<br />
Tecnologie&Sistemi<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
106<br />
107<br />
LS<br />
Trasferimento Tecnologico<br />
Dalla road safety<br />
alle gallerie paramassi<br />
FOCUS SU UN SISTEMA BREVETTATO CHE SFRUTTA LA CAPACITÀ<br />
DISSIPATIVA DELL’ACCIAIO PER RISOLVERE ALCUNE CRITICITÀ<br />
NELL’AMBITO DELLA PROTEZIONE DELLE STRADE DALLA CADUTA<br />
MASSI. IL SISTEMA, COSTITUITO DA ELEMENTI COLLASSABILI<br />
CONTENUTI DA CAVI AD ALTA RESISTENZA, PUÒ ESSERE<br />
CONSIDERATO UNA VALIDA ALTERNATIVA AI TRADIZIONALI<br />
“CUSCINI” DEFORMABILI. CI SPIEGA TUTTO LO SPECIALISTA<br />
DI SMA CHE HA CURATO QUESTA INNOVAZIONE.<br />
2<br />
Trasferimento tecnologico: per esempio dalla sicurezza<br />
stradale alla sicurezza strutturale. Una buona, anzi<br />
un’ottima pratica che da tempo viene esercitata, per<br />
precisa scelta e cultura aziendale, a casa di SMA Road Safety,<br />
azienda che i lettori di leStrade e più in generale gli<br />
operatori delle infrastrutture hanno imparato a conoscere<br />
molto bene per una notevole serie di tecnologie innovative,<br />
dagli attenuatori d’urto ai varchi amovibili, fino alle “smart<br />
barrier” di ultima generazione. Guardando allo specifico dei<br />
materiali impiegati, uno dei fulcri dell’esperienza e del know<br />
how di SMA è senz’altro legato alla conoscenza e all’impiego<br />
dell’acciaio. Ed è proprio da qui che può partire questa<br />
storia di dialogo, scambio, trasferimento per l’appunto tra<br />
chi, all’interno dell’azienda di Marcianise (Caserta), si occupa<br />
di ricerca, sviluppo e innovazione. La notizia,<br />
volendo anticiparla, è questa: il laboratorio SMA<br />
ha dato vita, testandolo debitamente, a un innovativo<br />
sistema di dissipazione energetica - in acciaio<br />
- per gallerie paramassi che consente di superare<br />
una serie di criticità, note alla letteratura tecnica<br />
sulla materia, nel contesto della protezione delle infrastrutture<br />
stradali dai fenomeni di caduta massi.<br />
Di questo progetto specifico si è occupato l’ingegner<br />
Danilo Di Giacinto, R&D Specialist di SMA Road Safety<br />
(che, a proposito di sinergie, può contare anche<br />
su quelle attivabili nell’ambito del Gruppo<br />
Industry AMS fondato da Pasquale Impero).<br />
L’abbiamo intervistato.<br />
Stefano Chiara<br />
1<br />
3<br />
3. Materiale granulare,<br />
naturale o processato,<br />
utilizzato per la costituzione<br />
dello strato deformabile:<br />
2a sabbia, ghiaia e pietrisco;<br />
2b argilla espansa; 2c vetro<br />
cellulare<br />
4. Amplificazione dinamica<br />
delle azioni caratteristiche<br />
associate a un evento<br />
di caduta massi<br />
su galleria artificiale<br />
(Fonte Labiouse et al.)<br />
5. Sistema modulare<br />
SMA Road Safety<br />
per gallerie paramassi:<br />
prova sperimentale<br />
in scala reale<br />
2a 2b 2c<br />
Ingegner Di Giacinto, partiamo dall’“idea” che ha originato<br />
questo progetto di ricerca.<br />
In SMA Road Safety crediamo molto nel principio del trasferimento<br />
tecnologico tra le soluzioni tecniche che andiamo a<br />
sviluppare: da tempo, tra i vari settori, sussiste una trasversalità<br />
che è foriera di nuovi spunti progettuali e costruttivi.<br />
Nel caso specifico questo approccio vi ha portati, partendo<br />
dalla vostra consolidata esperienza nell’ambi-<br />
4<br />
to dello sviluppo di dispositivi di ritenuta stradale,<br />
che mettono al centro dell’azione progettuale proprio<br />
il principio di assorbimento dell’energia, a lavorare<br />
sulle protezioni delle gallerie paramassi, anch’esse,<br />
del resto, opere realizzate per assicurare determinati<br />
standard di sicurezza passiva alla strada sottostante.<br />
Proprio così. Le gallerie paramassi sono strutture, poste a<br />
protezione di tratti limitati dell’infrastruttura stradale, di tipo<br />
passivo. Non agiscono, cioè, direttamente sulla causa della<br />
caduta dei massi. Sono costituite da un impalcato, in genere<br />
in calcestruzzo armato, sostenuto da elementi verticali.<br />
Sulla sommità dell’impalcato viene quindi collocato uno<br />
strato ammortizzante, il cosiddetto “cuscino”, che serve proprio<br />
a mitigare gli effetti di un impatto diretto sulla struttura.<br />
te riconosciuti alcuni limiti alle soluzioni tradizionali. Diversi<br />
studi sperimentali, per esempio, hanno dimostrato che a<br />
causa di fenomeni dinamici interni allo stesso strato deformabile,<br />
l’azione trasmessa all’impalcato, in caso di caduta<br />
massi, può essere anche maggiore di quella d’impatto, con<br />
incrementi compresi tra il 50 e il 100%. In più, va aggiunto<br />
che le caratteristiche del materiale dello strato deformabile<br />
non sono sempre stabili: i fenomeni di gelo-disgelo possono<br />
aumentarne la rigidezza e, quindi, l’azione di impatto, che<br />
a questa variabilità dello strato deformabile aggiunge anche<br />
quella delle caratteristiche del blocco impattante (dalla<br />
massa alla velocità), ovvero del masso, mutevoli nel tempo.<br />
Ci può descrivere il sistema SMA? E come migliorerebbe<br />
la situazione, a vostro avviso, attraverso la sua<br />
adozione?<br />
Si tratta di un sistema modulare coperto da brevetto che proponiamo<br />
proprio come alternativa progettuale rispetto alle<br />
soluzioni tradizionali impiegate per dare corpo allo strato deformabile<br />
delle gallerie paramassi. È costituito da un insieme<br />
5<br />
Tecnologie&Sistemi<br />
1. Il sistema brevettato<br />
SMA Road Safety:<br />
modellazione FEM<br />
2. Galleria paramassi:<br />
foto e schema. Fonte:<br />
Delhomme et al., 2005<br />
Dunque voi vi siete occupati proprio del “cuscino”, è<br />
corretto? Partendo da che tipo di stato di fatto?<br />
Storicamente questi strati ammortizzanti sono realizzati in<br />
materiale granulare naturale. Alcune innovazioni più recenti<br />
hanno puntato sull’utilizzo di materiali granulari più leggeri,<br />
processati industrialmente: penso all’argilla espansa o al<br />
vetro cellulare. Questi materiali permettono di ridurre il carico<br />
permanente non strutturale sull’impalcato e, quindi, di<br />
aumentare lo spessore del cuscino riducendo le azioni associate<br />
all’impatto. In generale, però, vengono comunemen-<br />
Tecnologie&Sistemi<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
108<br />
di elementi collassabili assialmente contenuti da cavi ad alta<br />
resistenza. A loro volta, questi elementi tubolari sono costituiti<br />
da un insieme di elementi dissipativi, i cosiddetti crashbox,<br />
saldati l’uno all’altro. Le prestazioni del sistema sono state<br />
valutate attraverso analisi agli elementi finiti, corroborate<br />
da prove sperimentali in scala reale, variando parametri quali<br />
l’altezza di caduta libera, la massa del blocco impattante,<br />
il numero di elementi dissipativi, l’inclinazione dell’impatto.<br />
Passando alla seconda parte della sua domanda, posso dirle<br />
che abbiamo effettuato un confronto del nostro sistema,<br />
in termini di forza d’impatto e peso proprio per unità di superficie,<br />
con le opzioni esistenti più diffuse. Per l’esattezza,<br />
è stato considerato l’impatto di un blocco di 4 ton in caduta<br />
libera verticale da 7,5 m, corrispondente a un’energia cinetica<br />
all’impatto pari a 300 kJ. I dati di confronto sono stati<br />
estratti dalla letteratura, per quanto riguarda le soluzioni sistema<br />
sandwitch TLAS, ghiaia e vetro cellulare, oppure calcolati<br />
mediante formulazioni empiriche (nel caso della sabbia).<br />
6. Performance del sistema<br />
modulare SMA vs. alcuni<br />
sistemi esistenti<br />
Quali risultati avete ottenuto?<br />
La soluzione modulare SMA, oltre a essere la più leggera, ha<br />
consentito di raggiungere una riduzione della forza d’impatto<br />
del 72%, 62% e 60% rispettivamente rispetto alla sabbia<br />
sciolta, al vetro cellulare e al sistema sandwich TLAS. Ma potrei<br />
suggerire ulteriori punti di valore di questa innovazione.<br />
Per esempio?<br />
Per esempio, l’assenza di amplificazione dinamica tra la forza<br />
d’impatto e la forza trasmessa. La forza d’impatto risulta<br />
infatti indipendente dalle caratteristiche del blocco impattante.<br />
Di conseguenza, il sistema può essere dimensionato<br />
in base ai parametri richiesti dalla committenza in termini<br />
di forza trasmessa (in presenza di vincolo sulla capacità<br />
della struttura della galleria) o energia dissipata (requisito<br />
geologico). Le prestazioni di questo “cuscino” d’acciaio, poi,<br />
risultano stabili nel tempo, mentre la sua industrializzazione<br />
consente di tutelarne al meglio la qualità.<br />
6<br />
Può aggiungere ancora qualche considerazione sul<br />
piano delle verifiche del sistema?<br />
Il nostro dispositivo si basa su dati certificati che vanno a costituire<br />
una dichiarazione di prestazione. Conosciamo le caratteristiche<br />
del sistema e tutte le informazioni sulla forza trasmessa,<br />
un dato cruciale per il progettista, che valute la forza<br />
di impatto attraverso formule derivate da dati sperimentali. Nel<br />
caso specifico delle gallerie paramassi non esiste una norma<br />
nazionale, ma si fa riferimento alle normative svizzera o giapponese,<br />
basate sulla meccanica del contatto di Hertz, che implica<br />
il calcolo della forze di impatto e di trasmissione. Come le<br />
dicevamo prima, però, le variabilità sono una costante, mentre<br />
con il nostro sistema formiamo dei dati precisi e univoci.<br />
Il “cuscino” SMA può essere impiegato indifferentemente<br />
per nuove opere o per strutture esistenti?<br />
Certamente. Considerando poi che molte di queste infrastrutture<br />
sono state progettate diversi decenni fa, anche in<br />
questo campo l’attenzione manutentiva dei gestori, in tutta<br />
Europa, si sta alzando.<br />
L’avete già applicato?<br />
Non ancora in un contesto di gallerie paramassi, ma in altre<br />
situazioni, in contesti industriali, che richiedessero particolari<br />
standard di sicurezza passiva. nn<br />
7 8<br />
7, 8. Trasferimento<br />
tecnologico SMA Road Safety:<br />
dal know how in materia<br />
di dispositivi di ritenuta<br />
a un nuovo cuscino<br />
d’acciaio a protezione<br />
delle gallerie paramassi<br />
(in fig. 8 esecuzione<br />
della prova sperimentale)<br />
Tecnologie&Sistemi<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade
LS<br />
15 th - 17 th June <strong>2021</strong><br />
MACCHINE<br />
ASPHALT 4.0 FOR FUTURE MOBILITY<br />
&ATTREZZATURE<br />
MACCHINE<br />
n Versatile, precisa e con radiocomando<br />
n Protezioni e prestazioni<br />
ATTREZZATURE<br />
n Qualità al servizio della gestione viaria<br />
CHECK THE UPDATES AND REGISTER<br />
FOR THE VIRTUAL CONGRESS!<br />
www.eecongress<strong>2021</strong>.org<br />
#eecongress<strong>2021</strong>
112<br />
113<br />
LS<br />
1, 2. La nuova finitrice<br />
Dynapac F1250CS<br />
impegnata in una stesa<br />
urbana in Puglia<br />
3. Particolare del banco<br />
Macchine<br />
1 2<br />
3<br />
Finitrici Compatte<br />
4. Novità assoluta:<br />
il radiocomando<br />
4<br />
La nuova F1250CS<br />
Versatile, precisa<br />
e con radiocomando<br />
Peso<br />
Larghezza di base<br />
Larghezza max di lavoro<br />
Larghezza min di lavoro con riduttori<br />
7 ton<br />
1,20 m<br />
3,50 m<br />
0,30 m<br />
Capacità di stesa 300 m 3 /h<br />
Motore<br />
Deutz TD2.9 L4<br />
Emissioni Tier 3/Tier 4<br />
Capacità tramoggia<br />
Diametro coclea<br />
5,5 ton<br />
320 mm<br />
ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA DYNAPAC F1250CS, UNA FINITRICE COMPATTA<br />
DOTATA DI UN BANCO AD ALTE PRESTAZIONI CHE SI CARATTERIZZA<br />
PER L’ELEVATA VERSATILITÀ, OLTRE CHE PER UNA SERIE DI DOTAZIONI<br />
TECNOLOGICHE DI GRANDE INTERESSE. TRA LE ALTRE, IL RADIOCOMANDO<br />
CHE AUMENTA SICUREZZA, PRECISIONE E COMFORT PER GLI OPERATORI. NE<br />
ABBIAMO PARLATO CON ANDREA MONTECRISTO, DI EDILSTRADE, CHE L’HA GIÀ<br />
TESTATA SUL CAMPO. CON SODDISFAZIONE.<br />
Una finitrice compatta, ma estremamente versatile.<br />
Un condensato di storica affidabilità e allo stesso<br />
tempo di alta tecnologia. Dynapac (gruppo Fayat)<br />
cala l’asso e porta sulle nostre strade la nuova F1250CS,<br />
una cingolata che, abbinata al banco Dynapac V2400TV-<br />
TVE (con potente centralina da 55 kW a regolazione continua<br />
del numero di giri), sta già riscuotendo un forte apprezzamento<br />
da parte dei nostri operatori, impegnati in lavori<br />
intensi e vari, dalle strettoie alle grandi viabilità. La versatilità<br />
di cui si diceva riguarda sia i contesti applicativi, sia naturalmente<br />
le larghezze di stesa, che con le estensioni arrivano<br />
anche fino a 3,5 m. Se invece andiamo a guardare le<br />
sue performance nello stretto, possiamo anticipare che i restringimenti<br />
- anche fino a 30 cm - sono facili e rapidi, per<br />
la piena soddisfazione dei titolari d’impresa, che possono<br />
così premere l’acceleratore della produttività. Rimandando<br />
un approfondimento specifico su questo aspetto a qualche<br />
riga più avanti, possiamo qui sottolineare il punto di valore<br />
della precisione di questa nuova paver, di fronte a ogni<br />
situazione di cantiere. A conseguirla anche un’innovazione<br />
Fabrizio Apostolo<br />
unica: la possibilità di manovrare la macchina attraverso il<br />
radiocomando RC 360, un “giocattolo” tech dai molteplici<br />
vantaggi. La distanza, infatti, consente da un lato all’operatore<br />
di muoversi in sicurezza, mentre dall’altro ne favorisce<br />
la visibilità, con evidenti benefici per la qualità finale della<br />
lavorazione. “La combinazione tra le dimensioni compatte,<br />
il banco ad alte prestazioni e la sua robustezza - notano da<br />
Dynapac Italia - fanno della F1250CS un perfetto strumento<br />
di lavoro per svariate applicazioni. La Dynapac F1250CS, per<br />
esempio, ha la possibilità di asfaltare al di sotto della quota<br />
zero. Questo permette alla finitrice di uscire da uno scavo di<br />
fresatura, lasciando la quota del banco sempre al livello zero,<br />
senza dunque creare uno scalino e rendere necessario il riposizionamento<br />
della finitrice. È ideale, inoltre, per la pavimentazione<br />
in luoghi stretti, dalle piste ciclabili alle trincee,<br />
ai marciapiedi”. Questo solo per fornire al lettore una prima<br />
fotografia di questa macchina, che tra le altre cose è dotata<br />
di un motore a 4 cilindri da 54 kW Deutz di ultima generazione<br />
e dispone di una serie di dispositivi di illuminazione che la<br />
rendono ideale anche per lavorazioni in notturna. Per ulteriori<br />
accattivanti dettagli (e ce ne sono) rimandiamo alla documentazione<br />
e a tutti gli approfondimenti del caso che può<br />
fornire Dynapac Italia. In questa sede, invece, abbiamo ritenuto<br />
di interesse per il lettore andare ad ascoltare la voce di<br />
un imprenditore che ha già inserito la Dynapac F1250 nella<br />
sua flotta e che l’ha già anche ampiamente testata sul campo,<br />
persino con l’innovativo radiocomando. La testimonianza,<br />
per noi preziosa, è quella di Andrea Montecristo, che guida<br />
insieme al fratello Vincenzo e al figlio Mirko la Edilstrade di<br />
Montecristo, sede a Ruvo di Puglia, provincia di Bari.<br />
Di cosa si occupa, nel dettaglio, la vostra impresa?<br />
Ci occupiamo di posa di cavi per le telecomunicazioni, per i<br />
principali operatori del settore (da Telecom a Vodafone a Fastweb):<br />
effettuiamo tutte le lavorazioni del caso, dallo sca-<br />
Macchine<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
114<br />
115<br />
LS<br />
5 6<br />
7 8<br />
5, 6. La macchina compatta<br />
nella sede Edilstrade<br />
di Montecristo, a Ruvo<br />
di Puglia<br />
7, 8. Lavorazioni nello spazio<br />
stretto a Corato, provincia<br />
di Bari<br />
9. La squadra di Edilstrade<br />
10. Andrea Montecristo<br />
(a sinistra) a 13 anni<br />
11. L’effigie Ursus Peroni<br />
10<br />
Dove operate, territorialmente?<br />
Per lo più in Puglia, dove abbiamo molto lavoro. Avendo seminato<br />
sempre bene e lavorando con gli uomini e le macchine<br />
giuste, abbiamo una buona nomea nel settore.<br />
A proposito di macchine, una vostra primizia in flotta è<br />
proprio la nuova Dynapac F1250CS. Come l’ha conosciuta?<br />
Abbiamo conosciuto questa macchina a seguito di una nostra<br />
ricerca funzionale a trovare un mezzo idoneo per effettuare<br />
ripristini in spazi stretti nell’ambito di lavorazioni Open<br />
Fibra. In precedenza, per questo genere di lavori impiegavamo<br />
una macchina più grande, di un’altra casa, in cui però<br />
attivare i restringimenti del banco diventava un’operazione<br />
piuttosto complessa, con conseguente rallentamento delle<br />
produzioni. Premetto che stavamo cercando una macchina<br />
nuova, non usata, perché con le macchine credo che sia meglio<br />
partire con il piede giusto e che a “usarle” siamo e saremo<br />
noi. Dalla Dynapac mi hanno proposto questa macchina,<br />
che ho voluto per prima cosa vedere, toccare con mano. La<br />
prima sensazione è già stata ottima.<br />
Attrezzature<br />
vo ai ripristini stradali. Parallelamente, passando dal settore<br />
privato a quello pubblico, effettuiamo per lo più manutenzioni<br />
per i comuni, dalle strade alle piazze. Oggi sono questi i lavori<br />
che ci vedono maggiormente impegnati.<br />
Come ha iniziato questo mestiere?<br />
Ho cominciato all’età di 13 anni, ingrassando i camion di mio<br />
padre, che era attivo nel settore agricolo, ma anche in quello<br />
degli sbancamenti e degli scavi per costruzioni. Per anni<br />
la nostra azienda di famiglia è stata impegnata in quel genere<br />
di attività, successivamente abbiamo puntato di più,<br />
come dicevo, su telecomunicazioni e manutenzioni. In ambito<br />
strettamente stradale, il mio primo incontro con un rullo<br />
è avvenuto sempre quando ero ragazzino: si trattava di un<br />
Ursus Peroni, una casa “mitica”. Pensi che un mio amico ne<br />
possiede ancora un modello, da collezione, e per farmi felice<br />
recentemente mi ha regalato la sua targa con il marchio.<br />
9<br />
11<br />
Su cosa puntate principalmente<br />
per raggiungere i vostri<br />
obiettivi aziendali?<br />
Sulla competenza del personale<br />
e sull’efficienza dei mezzi d’opera.<br />
Per quanto riguarda le manutenzioni<br />
e i ripristini, per esempio,<br />
abbiamo escavatori, frese, finitrici, rulli,<br />
piastre vibranti. Tutto ciò che serve, insomma,<br />
per realizzare un manto stradale perfetto, dalle planarità a regola<br />
d’arte. Questa attenzione alla qualità dei manti è fondamentale<br />
anche quando dobbiamo chiudere gli scavi dopo la<br />
posa di fibra ottica, per esempio. Pensi che da anni, per quanto<br />
riguarda questo aspetto, abbiamo anche un’assicurazione,<br />
ma non abbiamo mai dovuto attivarla. Dicevo della competenza:<br />
per noi è un aspetto fondamentale. Pensi che abbiamo<br />
con noi alcuni operai specializzati e adeguatamente formati<br />
che, come dico sempre, hanno gli occhi che sono meglio<br />
di un georadar…<br />
Il banco: prestazioni, temperatura ideale<br />
e facilità d’uso anche nello stretto<br />
Il nuovo banco ad alte prestazioni Dynapac V2400, cuore della finitrice compatta<br />
in flotta alla Edilstrade di Montecristo, può essere riscaldato a gas o elettricamente.<br />
Grazie alle molteplici regolazioni, come l’angolo d’attacco e le piastre profonde,<br />
il banco offre un’eccellente pre-compattazione e una superficie liscia anche<br />
con strati spessi. Il kit per le riduzioni di stesa può essere montato sul banco<br />
senza smontarne altre parti. Con questo kit, la F1250CS può essere così utilizzata<br />
per asfaltare tracce e/o piste strette. La temperatura del banco viene infine<br />
regolata dal display presente sul cruscotto. Essendo il dispositivo dotato<br />
di termostato auto-regolante, la temperatura sarà sempre costante, ma con il<br />
minimo spreco di energia.<br />
Siete riusciti ad aumentare la produzione? Il flusso di<br />
lavoro è migliorato?<br />
Certamente. Il nuovo banco della macchina favorisce sia i restringimenti,<br />
sia gli allargamenti, rendendola così molto versatile.<br />
Ora riusciamo a pavimentare su larghezze di 60 cm senza<br />
intoppi, con fluidità. Tecnicamente, è tutta un’altra cosa. E pensi<br />
anche che ora la squadra può essere composta anche da due<br />
soli addetti, al posto dei quattro che ci volevano in precedenza.<br />
Vendiamo alla ciliegina sulla torta: il radiocomando…<br />
Si tratta di una novità assoluta, che anche in questo caso,<br />
però, abbiamo voluto valutare al meglio, effettuando delle<br />
prove nel nostro piazzale, perché avevamo già esperienza<br />
di radiocomandi per gru, ma non siamo sempre stati del<br />
tutto soddisfatti dai livelli di precisione, che invece nelle stese<br />
sono fondamentali. Devo dire che anche questo optional<br />
ci ha lasciati molto soddisfatti: gli operatori possono svolgere<br />
in piena sicurezza tutte le funzioni affidate al cruscotto,<br />
dall’avanzamento al controllo degli spessori, e con un’estrema<br />
precisione. Abbiamo già superato le 100 ore di lavoro con<br />
questa modalità e devo dire che il risultato è stato sempre<br />
buono. Soprattutto per chi lavora negli spazi stretti, la possibilità<br />
di allontanarsi dalla macchina è un fattore a sicuro valore<br />
aggiunto, non solo sul piano della safety, ma anche su<br />
quello dell’accuratezza della lavorazione. Con il radiocomando<br />
si può lavorare fino a 10 metri di distanza dalla macchina,<br />
esattamente come si fosse in pancia. Migliora la sicurezza,<br />
anche in funzione dei controlli di legge, migliora la visibilità e<br />
soprattutto migliora il confort delle squadre, che possono finalmente<br />
operare lontano dai fumi d’asfalto.<br />
Congediamo Montecristo, che, come ultimo gesto, va alla ricerca<br />
di due immagini per lui davvero significative: Andrea<br />
a 13 anni con il camion del padre e l’effigie dell’Ursus Peroni.<br />
Pubblicarle ci sembra doveroso, per ringraziarlo, per far entrare<br />
ancora di più il lettore in questa bella storia di esperienza<br />
e, insieme, di attenzione all’innovazione. nn<br />
Macchine<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
116<br />
117<br />
LS<br />
1<br />
Lavorazioni Underground<br />
Protezioni e prestazioni<br />
1, 2, 3, 4. La novità Epiroc<br />
boomer M20, un modello che<br />
si caratterizza, tra le altre<br />
cose, per l’elevato tasso<br />
di protezione dei sistemi<br />
idraulici e della sensoristica<br />
razione con i principali clienti ed è il risultato di un’ampia ricerca<br />
e di test in ambiente reale. È la scelta perfetta per le miniere<br />
e per i contractors che vogliono superare la concorrenza grazie<br />
all’innovazione”, afferma Niklas Berggren, Global Product Manager<br />
Face Drilling Equipment di Epiroc.<br />
Funzioni automatizzate<br />
L’alta precisione e le prestazioni sono assicurate dalle funzioni di<br />
automazione a bordo, alle capacità di accesso ai dati di perforazione<br />
da remoto e ai piani di volata digitali che offrono maggiore<br />
affidabilità e qualità dell’intero ciclo di perforazione. Utilizzando<br />
l’High Performance Development, il Boomer M20 permette all’operatore<br />
impostare e modificare i piani di volata direttamente<br />
al fronte, eliminando la necessità di intervenire dall’ufficio. “Con<br />
la gestione digitale dei piani di volata, lo sfondo sarà maggiore,<br />
più preciso e con meno sovrascavi. Abbiamo visto un risparmio<br />
3<br />
totale sui costi fino al 25% e un aumento della produttività fino<br />
al 40%”, dice ancora Berggren.<br />
Ambiente di lavoro più sicuro<br />
Il Boomer M20 è stato progettato pensando alla sicurezza; grazie<br />
a diverse caratteristiche, la macchina offre un ambiente di<br />
lavoro sicuro ed ergonomico per gli operatori. “La sicurezza è<br />
stata fondamentale sin dal primo giorno. È la nostra massima<br />
priorità e con questo carro di perforazione abbiamo fatto grandi<br />
sforzi per migliorare la sicurezza degli operatori”, nota Berggren.<br />
Grazie alle capacità di gestione da remoto, gli operatori<br />
possono perforare da una distanza di sicurezza, lontana dalle<br />
aree pericolose sul fronte della galleria e mantenere la produzione<br />
anche durante i cambi di turno. Grazie ai joystick multifunzionali,<br />
gli operatori possono tenere gli occhi sul lavoro in<br />
ogni momento. La cabina, unica nel suo genere, è progettata<br />
per offrire una visibilità ottimale e, grazie a speciali materiali,<br />
una sensibile riduzione del rumore e delle vibrazioni, il livello di<br />
rumorosità è mantenuto a soli 65 dB. La piattaforma di servizio<br />
è sicura rappresentando un altro grande vantaggio evitando<br />
qualsiasi operazione in prossimità del fronte in condizioni di<br />
roccia non sostenuta.<br />
L’opzione elettrica<br />
Epiroc continua a sostenere l’elettrificazione nelle miniere sotterranee<br />
e il nuovo Boomer M20 può essere fornito con alimentazione<br />
elettrica a batteria. Un Boomer M20 alimentato a batteria<br />
porta ulteriori vantaggi in termini di salute, manutenzione,<br />
ventilazione e raffreddamento.<br />
“Con il caricabatterie a bordo, l’operatore non ha bisogno di<br />
pianificare la ricarica, poiché questa avviene automaticamente<br />
durante la connessione alla rete in fase di perforazione. Grazie<br />
alla batteria ad alta capacità, il Boomer M20 ha una notevole<br />
autonomia per gli spostamenti non inficiando lo svolgimento<br />
dei turni di lavoro”, conclude Berggren. nn<br />
Macchine<br />
EPIROC LANCIA SUL MERCATO UNA NUOVA GENERAZIONE DI CARRI DI PERFORAZIONE<br />
DA GALLERIA: IL BOOMER M20, LA PRIMO MODELLO DEL GENERE AL MONDO<br />
CON IDRAULICA E SENSORI PROTETTI A GARANZIA DI UNA MASSIMIZZAZIONE<br />
DELLE ATTIVITÀ E UNA MINIMIZZAZIONE DEI FERMI MACCHINA. TRA GLI ALTRI<br />
PUNTI DI VALORE, L’ALTA PRECISIONE GARANTITA DALL’AUTOMAZIONE.<br />
2<br />
4<br />
Con idraulica, elettronica e sensori protetti il nuovo Boomer<br />
Epiroc M20 è progettato per ridurre al minimo gli interventi<br />
di manutenzione non programmati e per massimizzare<br />
i tempi di attività e le prestazioni. Si tratta, spiegano da<br />
Epiroc, della nuova generazione nel settore minerario sottorraneo:<br />
una parte impegnativa del lavoro in sotterraneo è l’usura<br />
quotidiana dei tubi idraulici. Il distacco e la caduta e detriti e<br />
la continua usura dovuta al contatto con il suolo e le pareti della<br />
galleria richiedono costanti sostituzione dei tubi. Il design del<br />
braccio del Boomer M20 con l’idraulica posta all’interno riduce<br />
al minimo i fermi-macchina per la sostituzione dei tubi idraulici,<br />
mantenendo la macchina in funzione anche nelle condizioni<br />
più difficili. “Il Boomer M20 è stato sviluppato in stretta collabo-<br />
Macchine<br />
Mauro Armelloni<br />
Una nuova prospettiva<br />
Per sottolineare maggiormente i punti di fornza dell’innovazione,<br />
Epiroc ha realizzato uno suggestivo video promozionale, con uno<br />
sfondo scenico di grande impatto. Il Boomer M20 è in equilibrio<br />
sui suoi innovativi e robusti bracci, sulla cima di una montagna. Il<br />
Presidente e CEO di Epiroc, Helena Hedblom, ha presentato personalmente<br />
il nuovo boomer nel video della campagna.<br />
“Siamo qui per il brivido di risolvere problemi reali. Per lo spirito<br />
di avventura e l’energia che si prova quando si affrontano nuove<br />
prospettive. Il Boomer M20 è un altro grande esempio di come<br />
facciamo la differenza attraverso l’innovazione”, ha detto Hedblom.<br />
Per saperne di più: www.epiroc.com/it-it/campaigns/<br />
boomer-m20-launch<br />
5. Un frame del video promozionale<br />
4/<strong>2021</strong>
118<br />
119<br />
LS<br />
1<br />
3<br />
Attrezzature<br />
2<br />
Manutenzione Stradale<br />
Qualità al servizio<br />
della gestione viaria<br />
Mauro Armelloni<br />
FOCUS SULLE SOLUZIONI CANGINI SVILUPPATE PER SEMPLIFICARE IL LAVORO,<br />
MIGLIORANDONE LE CONDIZIONI, DEI MANUTENTORI STRADALI:<br />
DALLE SPAZZATRICI PER GRANDI SUPERFICI ALLE SOLUZIONI PER PULIZIE<br />
DIFFICILI. IL FILO CONDUTTORE: L’ATTENZIONE AL DETTAGLIO, CHE FA LA<br />
QUALITÀ, E LA “USER EXPERIENCE”.<br />
Qualità in ogni minimo dettaglio. È questo un requisito<br />
fondamentale per Cangini Benne, azienda che da<br />
sempre lavora con dedizione per portare sul mercato<br />
prodotti, per l’appunto, di alta qualità che rispecchino al meglio<br />
le specifiche standard e le richieste dei clienti: “La qualità<br />
- aggiungono ancora da Cangini - assume un valore importante<br />
quando l’obiettivo è quello di soddisfare le aspettative degli<br />
utilizzatori”. Ma per l’azienda romagnola il concetto di qualità<br />
va inteso anche in senso evolutivo, non statico ma dinamico,<br />
ovvero come miglioramento continuo di ogni singolo prodotto<br />
in termini di innovazione e prestazione. Per questa ragione,<br />
l’azienda investe in maniera considerevole sul proprio reparto<br />
di ricerca e sviluppo, pronto a perfezionare ogni particolare<br />
progettuale e costruttivo al fine di rendere sempre migliore<br />
la “user experience” degli specialisti di infrastrutture e costruzioni<br />
con le attrezzature Cangini Benne.<br />
Pulizia ideale<br />
La manutenzione stradale è un ambito che in passato ha spesso<br />
assunto poco rilievo (fortunatamente il trend sta mutando),<br />
ma che considerevolmente importante, per non dire cruciale.<br />
In tutti i suoi aspetti. Durante i lavori stradali, per esempio, si<br />
1. Massima pulizia in ogni<br />
angolo della strada grazie<br />
alle attrezzature specifiche<br />
Cangini<br />
2. Modello per grandi<br />
superfici<br />
3. La gamma si caratterizza<br />
per varietà di soluzioni, tutte<br />
di alta qualità e funzionalità<br />
4. Spazzolone per escavatore<br />
producono grandi quantità di polveri, detriti e residui sui quali<br />
bisogna “agire”, per evitare che questi si depositino sul fondo<br />
stradale e che, soprattutto, si diffondano nell’aria. Per questo<br />
scopo occorrono strumenti attentamente studiati per operare<br />
in ambienti anche difficili, come quelli molto polverosi e umidi<br />
tipici delle cantirizzazioni. A questo proposito, la gamma di<br />
spazzatrici e rulli Cangini è risultata e risulta la scelta ideale.<br />
In generale gli interventi di routine per la pulizia delle strade e<br />
la loro manutenzione, finalizzati a garantirne una migliore viabilità,<br />
saranno ancora di più rapida esecuzione e dal risultato<br />
professionale proprio grazie all’ausilio della gamma di prodotti<br />
Cangini interamente dedicata al settore stradale. Pulizie “difficili”<br />
e in ambienti impegnativi non saranno più un problema.<br />
La linea dedicata di prodotti è infatti pensata per ogni specifica<br />
esigenza d’impiego e applicazione, dai piazzali e ambienti<br />
chiusi fino allo sgombero delle strade dalla neve. Si tratta di<br />
molteplici attrezzature che si contraddistinguono per grande<br />
mobilità e agilità, al fine di favorire elevate prestazioni sempre<br />
in sicurezza, anche nelle condizioni più complesse, con l’obiettivo<br />
di offrire al mercato le migliori soluzioni per la pulizia<br />
in ambito industriale e urbano.<br />
Abbattimento polveri<br />
Il continuo studio e propensione al miglioramento ha portato<br />
l’azienda a rivoluzionare alcune delle sue attrezzature<br />
per proporre così al mercato prodotti innovativi quali la nuova<br />
spazzatrice Easy Sweepy, che viene affiancata agli altri<br />
prodotti della stessa gamma, tra cui il rullo spazzolone, la<br />
spazzatrice SPZ e la spazzola All Duster. Insieme, queste soluzioni<br />
possono far sì che il “cleaning” delle strade sia in concomitanza<br />
di interventi di manutenzione, sia nella gestione<br />
ordinaria, non sia più un problema. Le spazzole di queste<br />
attrezzature Cangini possono essere predisposte in acciaio,<br />
PPL o materiale misto acciaio/PPL. La nuova Easy Sweepy,<br />
da parte sua, presenta diversi accessori che la rendono<br />
particolarmente adatta per la pulizia di grandi superfici,<br />
pavimentazioni industriali e strade che richiedono un’attenzione<br />
di alto livello. Con il suo impianto abbattimento polveri,<br />
l’attrezzatura permette di abbattere le polveri generate<br />
durante la lavorazione. Inoltre, il nuovo sistema flottante<br />
4<br />
permette alla spazzatrice di aderire meglio al terreno e di<br />
tenere una maggiore velocità di avanzamento.<br />
Innovazioni continue<br />
Piccola ma potente: è il caso della spazzola All Duster, disponibile<br />
in versione per attacco frontale, ideale per il diserbo e per<br />
la pulizia profonda di cordoli, marciapiedi e asfalti. È caratterizzata<br />
da un’ottima manovrabilità dettata dalla sua possibile inclinazione<br />
meccanica. È dotata, inoltre, di paratie di protezione<br />
per evitare che il materiale raccolto venga disperso. La spazzola<br />
può essere posizionata sia a destra sia a sinistra, per poter pulire<br />
entrambi i lati della strada. Inoltre lo snodo e il flottante le<br />
permettono di seguire l’andamento del terreno, mentre la sua<br />
durata è garantita dalla ruota pivotabile che consente di impostare<br />
l’altezza dei lavori. Estremamente performante, la spazzatrice<br />
SPZ Cangini è invece indicata per i lavori più gravosi grazie<br />
al rullo regolabile e al robusto telaio. Una sua ulteriore particolarità<br />
è la capienza della vasca di raccolta che la rende capace di<br />
raccogliere grande quantità di ghiaia e polvere da aree estese.<br />
Tra i suoi accessori anche i nebulizzatori interni ed esterni, che<br />
permettono di abbattere le polveri sollevate durante l’operazione<br />
di pulizia. In caso di superfici dove non si considera necessaria<br />
la raccolta del materiale, come per esempio nella rimozione<br />
di neve da grandi piazzali, il rullo spazzolone è infine l’attrezzatura<br />
ideale. Il rullo è dotato di un auto-livellamento orizzontale<br />
di +-10° e angolazione idraulica di +-30°. Il dispositivo è disponibile<br />
anche per applicazione su braccio escavatore. Per saperne<br />
di più: canginibenne.com nn<br />
Attrezzature<br />
4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
leStrade<br />
LS<br />
Aeroporti Autostrade Ferrovie<br />
MAGGIO <strong>2021</strong><br />
Aeroporti Autostrade Ferrovie<br />
Casa Editrice la fiaccola srl<br />
PAGINE<br />
LS<br />
SPECIALE<br />
con<br />
INFRASTRUTTURE VIARIE<br />
Lo speciale raddoppia<br />
Il numero “Road” per<br />
eccellenza dell’annata<br />
editoriale, visto il successo<br />
della terza edizione<br />
dell’ultimo dicembre, nel<br />
<strong>2021</strong> raddoppia.<br />
Maggio tutto stradale<br />
Oltre all’edizione di<br />
Dicembre <strong>2021</strong> - già<br />
confermata - sarà “tutto<br />
stradale” anche il numero<br />
di Maggio di leStrade, di<br />
prossima uscita.<br />
Insieme ai gestori<br />
Il numero speciale<br />
sarà realizzato con la<br />
collaborazione dell’Anas<br />
e delle concessionarie<br />
autostradali italiane ed<br />
europee, nonché dell’IRF.<br />
Dossier Innovatori<br />
Punti forti: interviste<br />
esclusive, le voci degli<br />
specialisti, le opere in corso<br />
e il dossier Gli Innovatori-<br />
Speciale Strade in italiano<br />
e inglese.<br />
I grandi temi<br />
Dal monitoraggio di ponti<br />
e gallerie alle tecnologie<br />
di ispezione con droni,<br />
dalle ultime frontiere della<br />
manutenzione alle nuove<br />
opere stradali.<br />
Digital roads<br />
Numerosi contenuti del<br />
numero saranno, come<br />
di consueto, diffusi anche<br />
sul nostro sito Internet<br />
www.lestradeweb.it<br />
e su LinkedIn.<br />
ASSOCIATIVE<br />
n Modifiche al<br />
Codice della Strada<br />
n La forza<br />
della gestione<br />
n Elettrificazione<br />
per la transizione ecologica<br />
n Canone unico<br />
n Conoscenza<br />
per la ripresa<br />
n Tre mosse per digitalizzare<br />
la logistica<br />
Associazione Italiana<br />
della Telematica<br />
per i Trasporti e la Sicurezza<br />
La rivista leStrade, che con i suoi 123 anni di storia è il magazine sulle infrastrutture più longevo<br />
d’Europa, continua a puntare sull’approfondimento di qualità proponendo ai suoi lettori un numero<br />
unico che racconterà gli ultimi trend del settore delle infrastrutture viarie, in collaborazione con<br />
istituzioni, gestori, progettisti, imprese e specialisti del nostro settore.<br />
Per maggiori informazioni<br />
marketing@fiaccola.it - tel. 02.89421350
122<br />
Modifiche al Codice della Strada<br />
Incontro di approfondimento culturale sul web con il direttore del Centro Studi e Ricerche<br />
123<br />
LS<br />
La forza della gestione<br />
Puntiamo, con il “Recovery”, alle reti da migliorare e ai territori da mettere in sicurezza<br />
AIIT Associazione Italiana<br />
per l’ingegneria<br />
del Traffico e dei Trasporti<br />
Via Solferino, 32<br />
00185 Roma<br />
Tel. 06.58330779<br />
segreteria@aiit.it<br />
www.aiit.it<br />
A cura della<br />
Segreteria AIIT<br />
Modifiche al Codice della<br />
Strada introdotte dalla L. n.<br />
120/2020, hanno indotto<br />
AIIT a programmare un incontro di<br />
approfondimento che si è svolto il 9<br />
marzo scorso in modalità “a distanza”<br />
ed è stato aperto a tutti i soci e,<br />
in generale, ai tecnici del settore<br />
interessati alla materia. L’evento -<br />
che costituisce oramai un format di<br />
meeting culturale, molto impiegato<br />
da AIIT (AperAIITivo-Web) - è<br />
consistito in un excursus generale<br />
sulle principali novità del Codice e in<br />
un approfondimento, con dibattito<br />
finale, condotto dal Direttore del<br />
Centro Studi e Ricerche di AIIT, prof.<br />
Giuseppe Cantisani. Il prof. Cantisani,<br />
in particolare, ha evidenziato come,<br />
con la conversione del decreto<br />
“semplificazioni”, sia stata, di fatto,<br />
introdotta una “miniriforma” del<br />
Codice della Strada, disseminata, nella<br />
norma, in maniera poco organica, tra<br />
le “semplificazioni procedimentali”<br />
di cui al Capo I del Titolo II, le<br />
disposizioni in materia di “cittadinanza<br />
digitale e accesso ai servizi digitali<br />
della pubblica amministrazione”<br />
di cui al Capo I del Titolo III, le<br />
“semplificazioni in materia di attività<br />
di impresa e investimenti pubblici” e<br />
le “semplificazioni in materia di green<br />
economy” di cui ai Capi I e III del<br />
Titolo IV. In particolare, oltre ad alcuni<br />
“aggiustamenti” riguardanti le misure<br />
di contrasto a varie pratiche scorrette<br />
(es. veicoli con targa estera) e<br />
modifiche a procedure amministrative<br />
(abrogazione del cd. Ricorso<br />
gerarchico al Ministero), le novità di<br />
maggiore interesse del Codice, per<br />
l’ambito strettamente “tecnico” hanno<br />
riguardato le modifiche all’art. 2,<br />
all’art. 3, all’art. 7, al 12-bis, al 27, al<br />
37, al 75, al 148, al 148, ecc. L’analisi<br />
condotta dal prof. Cantisani ha preso<br />
le mosse dalle modifiche riportate ai<br />
seguenti articoli del Codice:<br />
• Il comma 3 dell’art. 2, con la nuova<br />
voce di classificazione di “strada<br />
urbana ciclabile” (lett. e-bis), definita<br />
come strada interna a un centro<br />
abitato, a unica carreggiata, con<br />
banchine pavimentate e marciapiedi,<br />
con limite di velocità fino a 30 km/h,<br />
priorità ai velocipedi che godono<br />
anche di precedenza nei confronti<br />
degli altri veicoli (nuovo comma 4-bis<br />
dell’art. 145);<br />
• L’art. 3, dove, in particolare, viene<br />
sostituito integralmente il punto<br />
12-bis) che novella la definizione di<br />
“corsia ciclabile” e viene aggiunto<br />
il nuovo comma 12-ter), recante la<br />
definizione di “corsia ciclabile per<br />
doppio senso ciclabile”;<br />
• I commi 9 e 9-ter dell’art. 182, ove<br />
si stabiliscono gli spazi dove devono<br />
transitare i velocipedi e la possibile<br />
presenza sulla soglia dell’intersezione<br />
della “casa avanzata”.<br />
Mentre, sul primo aspetto, l’analisi<br />
ha evidenziato alcuni elementi<br />
di incoerenza con le previsioni<br />
dell’attuale normativa tecnica<br />
(DM 5/11/2001), sull’aspetto<br />
legato all’introduzione della cd.<br />
corsia ciclabile, l’approfondimento<br />
dell’incontro ha evidenziato numerosi<br />
aspetti critici di ordine applicativo.<br />
In particolare, l’art. 12-bis) reca la<br />
seguente definizione di corsia ciclabile:<br />
“Parte longitudinale della carreggiata,<br />
posta di norma a destra, delimitata<br />
mediante una striscia bianca,<br />
continua o discontinua, destinata alla<br />
circolazione sulle strade dei velocipedi<br />
nello stesso senso di marcia degli altri<br />
veicoli e contraddistinta dal simbolo<br />
del velocipede. La corsia ciclabile può<br />
essere impegnata, per brevi tratti,<br />
da altri veicoli se le dimensioni della<br />
carreggiata non ne consentono l’uso<br />
esclusivo ai velocipedi; in tal caso<br />
essa è parte della corsia veicolare<br />
e deve essere delimitata da strisce<br />
bianche discontinue. La corsia ciclabile<br />
può essere impegnata da altri veicoli<br />
anche quando sono presenti fermate<br />
del trasporto pubblico collettivo<br />
e risulta sovrapposta alle strisce<br />
di delimitazione di fermata di cui<br />
all’articolo 151 del regolamento di<br />
cui al decreto del Presidente della<br />
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.<br />
La corsia ciclabile si intende valicabile,<br />
limitatamente allo spazio necessario<br />
per consentire ai veicoli, diversi dai<br />
velocipedi, di effettuare la sosta o la<br />
fermata nei casi in cui vi sia fascia di<br />
sosta veicolare laterale, con qualsiasi<br />
giacitura”. Si tratta evidentemente<br />
di una definizione che non contiene<br />
riferimenti tecnici adeguati a<br />
comprendere quando e dove realizzare<br />
tali interventi e, ancora, quali<br />
dimensioni assumere a riferimento,<br />
quale geometria plano-altimetrica<br />
dover rispettare, ecc. Analoghe<br />
considerazioni valgono per l’art. 12-ter<br />
che introduce la Corsia ciclabile per<br />
doppio senso ciclabile. L’ulteriore<br />
approfondimento del webinar di<br />
AIIT ha riguardato la modifica al<br />
Codice per la parte relativa alla cd.<br />
“Casa Avanzata” (co. 9-ter dell’art.<br />
182), che, pur definita con qualche<br />
elemento dimensionale in più, rispetto<br />
alle corsie ciclabili, richiederebbe<br />
approfondimenti tecnici utili a meglio<br />
individuarne gli ambiti applicativi.<br />
Al termine dell’analisi condotta<br />
dal prof. Cantisani, numerose<br />
considerazioni e osservazioni dei<br />
partecipanti hanno evidenziato come<br />
le modifiche normative introdotte<br />
richiedano, ad oggi, un impegno di<br />
regolamentazione atto a guidare con<br />
maggiore sistematicità e organicità<br />
non solo la progettazione, ma<br />
anche le scelte inerenti a soluzioni<br />
compatibili e sicure e in grado di<br />
uniformare l’operato delle singole<br />
municipalità. In proposito, AIIT ha<br />
già da tempo attivato un apposito<br />
Tavolo tecnico che ha prodotto<br />
un interessante documento sul<br />
“Ridisegno degli spazi urbani” la<br />
cui diffusione - ad accesso libero -<br />
è programmata a partire dalla fine<br />
del mese di <strong>aprile</strong>. Si tratta di un<br />
documento nato nella prospettiva di<br />
1<br />
1. Esempio di corsia ciclabile<br />
unidirezionale<br />
2<br />
2. Esempio di realizzazione<br />
non coordinata di corsia ciclabile<br />
per doppio senso di marcia<br />
fornire ai tecnici e agli amministratori<br />
che operano nelle varie realtà<br />
urbane in Italia riferimenti tecnici e<br />
applicativi atti a indirizzare scelte di<br />
intervento e realizzazioni tecniche,<br />
anche alla luce di esperienze di<br />
studio e sperimentazioni sviluppate<br />
in altri paesi. nn<br />
AISES<br />
Associazione Italiana Segnaletica<br />
e Sicurezza<br />
P.zza Cola di Rienzo, 80/a<br />
00192 Roma<br />
Tel 06.45476588 - Fax 06.45476677<br />
E-mail: presidenza@aises.it<br />
www.aises.it<br />
Gabriella Gherardi<br />
Presidente AISES<br />
Ci spiace osservare che nelle<br />
varie versioni del Recovery<br />
Plan, in continua evoluzione,<br />
non ci si soffermi mai sulla gestione:<br />
peccato, perché, a nostro avviso,<br />
la partita si gioca tutta qui nella<br />
gestione delle imprese esistenti,<br />
del territorio reale e dei suoi grandi<br />
rischi (sismico e idrogeologico), delle<br />
strade e dell’immenso patrimonio<br />
paesaggistico e dei beni culturali del<br />
nostro Paese.<br />
A che cosa, se non alla gestione, si<br />
pensa di imprimere l’orientamento,<br />
richiesto dalla UE, all’innovazione<br />
tecnologica, alla digitalizzazione e<br />
alla difesa ambientale necessario per<br />
ottenere gli ambiti finanziamenti?<br />
Non credo che la congerie dei vari<br />
progetti che compongono la proposta<br />
in bozza del Recovery Plan pensi di<br />
costruire tutto nuovo di zecca, magari<br />
tramite stimoli di fantastiche start<br />
up o grandi società di consulenza dai<br />
nomi rigorosamente in inglese, anche<br />
se con sede a Bari, o che tutta la<br />
ripresa si giochi sul completamento<br />
dei grandi lavori rimasti da anni<br />
incompiuti o nella mente dei nostri<br />
governanti come l’ormai mitologico<br />
ponte di Messina.<br />
Se questo non sarà, come è<br />
probabile che sia, la strumentazione<br />
del Recovery dovrà giocarsi<br />
prevalentemente entro il campo di<br />
gioco della gestione dell’esistente.<br />
Ovviamente noi ci riferiamo a quanto<br />
a nostre mani (strade, territorio,<br />
grandi rischi) estendibile ai campi di<br />
rappresentanza delle altre categorie<br />
federate (imprese di manutenzione<br />
specialistiche, dei beni culturali, dei<br />
servizi speciali, ecc.) e non a tutto il<br />
resto dell’economia del Paese.<br />
Insomma, tirando le somme, la<br />
ripresa produttiva si svolge:<br />
• su uno Stato centrale che dà le<br />
carte,<br />
• sugli enti locali che le giocano nel<br />
territorio,<br />
• sugli imprenditori che vogliono<br />
scendere in gioco (non tutti sono<br />
disposti),<br />
• sui processi gestionali che danno<br />
1, 2. Strade e territorio,<br />
ma anche ferrovie e, più<br />
in generale, le opere esistenti:<br />
un patrimonio che la regia<br />
del Recovery Plan dovrebbe<br />
mettere al centro dell’attenzione,<br />
per trascinare - per davvero -<br />
il Paese fuori dalle secche<br />
le regole del gioco in tutti i settori<br />
all’interno dei quali inserire le nuove<br />
ispirazioni europee per le quali la<br />
Comunità è disposta a farci credito e<br />
sussidio per oltre 200 mld in 4 anni.<br />
Guai a noi se dovessimo perdere<br />
di vista questo obiettivo, perché<br />
potremmo rischiare di indirizzare<br />
queste ingenti risorse verso cose<br />
che, allo stato, non esistono e<br />
che dobbiamo costruire a nuovo,<br />
seguendo motivazioni non già<br />
pragmatiche ma dettate dall’orgoglio<br />
di piccole patrie o, peggio, sull’altare<br />
di ideologie fumose cui, spesso,<br />
sottendono interessi di parte, non<br />
sempre nominabili.<br />
Dobbiamo, al contrario, rinforzare<br />
le gestioni, tutte le gestioni,<br />
arricchendole dei nuovi obiettivi<br />
che ci siamo concordemente<br />
dati in Europa che sono la difesa<br />
dell’ambiente, particolarmente<br />
dai grandi rischi naturali che<br />
affliggono il nostro Paese (sismico<br />
e idrogeologico), dell’innovazione<br />
tecnologica di cui le nostre imprese<br />
e il nostro territorio hanno un grande<br />
bisogno; di un’informalizzazione<br />
dei processi gestionali volta alla<br />
semplificazione e alla riduzione<br />
dei tempi di risposta fino al<br />
raggiungimento del tempo reale.<br />
Ciò facendo, può darsi che la forza<br />
della gestione, adeguatamente<br />
rifinanziata e rinnovata nei contenuti,<br />
possa trainare il Paese fuori dalle<br />
secche.<br />
Su tutto questo facciamo una grossa<br />
puntata, forse l’unica al momento<br />
possibile davvero, sperando che<br />
il nuovo, quello autentico, nasca<br />
all’interno di questo percorso, strada<br />
facendo, spontaneamente. nn<br />
AssociAzione AiiT<br />
AssociAzione Aises<br />
12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />
4/<strong>2021</strong>
124<br />
125 LS<br />
Elettrificazione per la transizione ecologica<br />
Intervista a Giuseppe Ghilardi, Consigliere Settore Elettrificazione ANIE Assifer<br />
Canone unico<br />
Semplificazione o vessazione? Ecco il punto di vista di AIFIL<br />
ASSIFER<br />
Associazione Industrie Ferroviarie<br />
Federazione ANIE - Confindustria<br />
Viale Vincenzo Lancetti, 43<br />
20158 Milano<br />
Tel. 02.3264303 / 249<br />
E-mail assifer@anie.it<br />
www.assifer.anie.it - www.anie.it<br />
Ufficio Comunicazione<br />
ANIE ASSIFER<br />
la nostra società e<br />
i nostri cittadini stanno<br />
“Oggi<br />
ancora soffrendo le<br />
conseguenze ed i condizionamenti<br />
della situazione pandemica che ha<br />
investito il pianeta. Resistiamo,<br />
ci adattiamo e guardiamo avanti<br />
cercando una progettualità che ci<br />
permetta di uscirne migliori di come ci<br />
siamo entrati. Nel mondo dei trasporti,<br />
come Unione Europea e come Paese<br />
ci proponiamo di creare un sistema<br />
sostenibile, smart e flessibile che<br />
agevoli i cambiamenti fondamentali a<br />
favore del New Green Deal. A questo<br />
proposito risulta impossibile non<br />
associare immediatamente il concetto<br />
di “elettrificazione” come fattore<br />
chiave per il successo di un nuovo<br />
modo di fare trasporti.”<br />
Ne abbiamo parlato con Giuseppe<br />
Ghilardi, Consigliere Settore<br />
Elettrificazione ANIE ASSIFER, che<br />
rappresenta le imprese costruttrici<br />
operanti in Italia nel settore del<br />
trasporto ferroviario e del trasporto<br />
pubblico.<br />
Green Deal e Mobilità Sostenibile<br />
sono un binomio obbligato in tutte<br />
le politiche del vecchio continente.<br />
Come renderli una realtà sul<br />
nostro territorio?<br />
Pragmatismo con ricerca di effetti<br />
immediati sul territorio e sul clima<br />
è ciò di cui abbiamo bisogno e<br />
l’elettrificazione massiccia è lo<br />
strumento più efficace per svoltare<br />
1. L’ingegner Giuseppe Ghilardi<br />
davvero. La trazione elettrica fornisce<br />
vantaggi nelle prestazioni, nell’uso<br />
dell’energia di cui disponiamo e nella<br />
riduzione dell’inquinamento da gas di<br />
scarico e da rumore. L’idrogeno sta<br />
godendo di grande visibilità mediatica<br />
e di investimenti da parte dell’industria<br />
dei trasporti ed è innegabile che in<br />
un futuro potrà dare un contributo<br />
importante alla decarbonizzazione.<br />
Se però vogliamo attuare interventi<br />
davvero in grado di dare oggi un<br />
forte impulso verso la Transizione<br />
Ecologica, l’elettrificazione è lo<br />
strumento a cui dobbiamo rivolgerci.<br />
È oramai chiaro e lo certificano anche<br />
i progetti di mobilità sostenibile che<br />
arrivano dalle nostre città, dai piani<br />
integrati regionali e dai grandi progetti<br />
ferroviari da finanziare con il Next<br />
Generation EU. Lo vediamo a tutto<br />
campo, con iniziative anche in Italia<br />
per la sperimentazione di autostrade<br />
elettriche a beneficio del traffico<br />
pesante. Tecnologie di elettrificazione<br />
efficaci per ogni contesto, dall’alta<br />
velocità alla mobilità urbana, ci<br />
permettono di proporre soluzioni<br />
che rispettino anche gli aspetti visivi<br />
e la specificità dei contesti urbani.<br />
Dobbiamo solo stare attenti a non farci<br />
disorientare da chi propone ricette<br />
radicali che vorrebbero spazzare<br />
via completamente pali e fili dalle<br />
nostre città… se l’impianto fisso<br />
è la soluzione che maggiormente<br />
garantisce il risultato, ripeto,<br />
dobbiamo essere pragmatici: efficacia,<br />
1<br />
disponibilità del servizio e sostenibilità<br />
complessiva non devono mai essere<br />
messi da parte.<br />
L’elettrificazione di infrastrutture<br />
per i trasporti non è però una<br />
novità tecnologica, c’è chi la<br />
considera ormai una commodity.<br />
Cosa ne pensa ASSIFER in<br />
proposito.<br />
Quando ci muoviamo di fianco<br />
a una ferrovia, a un tram o una<br />
filovia, riconosciamo facilmente se<br />
il committente ha affidato il lavoro<br />
pensando che l’elettrificazione è un<br />
lavoro che può essere realizzato<br />
da chiunque. Riprendo quanto<br />
sottolineato in un precedente<br />
articolo su queste pagine - l’asset<br />
principale delle nostre aziende<br />
associate è la competenza delle<br />
persone che ci lavorano. Un knowhow<br />
altamente specializzato,<br />
costruito con investimenti continui<br />
e che si materializza in proposizione<br />
di soluzioni tecniche innovative,<br />
logistica su misura, precisione nella<br />
pianificazione e nell’esecuzione.<br />
Partendo ovviamente dal rispetto della<br />
sicurezza dei lavoratori e del mondo<br />
che c’è attorno. Trovo altamente<br />
stimolante il lavoro che si sta portando<br />
avanti per sviluppare soluzioni<br />
tecnologiche mirate ad aumentare<br />
i livelli di affidabilità, sicurezza e<br />
disponibilità delle nostre infrastrutture.<br />
Penso all’interazione tra mondo<br />
industriale e il mondo accademico<br />
come succede al Politecnico di Milano,<br />
dove sul tavolo ci sono numerosi<br />
progetti, dall’efficientamento<br />
energetico, all’impiego di nuovi<br />
materiali, alla diagnostica avanzata.<br />
Così come interessante sarà l’adozione<br />
del BIM per la progettazione e<br />
realizzazione degli impianti con<br />
le enormi potenzialità che questa<br />
metodologia offre. Tutte attività<br />
che rappresentano un investimento<br />
indispensabile per garantire davvero<br />
la transizione ecologica, ed è difficile<br />
ottenerle dal tessuto industriale se si<br />
pensa che l’elettrificazione si possa<br />
acquistare come fosse una commodity.<br />
Del resto, durante l’esecuzione dei<br />
contratti i nostri clienti riconoscono<br />
sempre la competenza e la capacità<br />
propositiva delle aziende. In alcuni casi<br />
dovrebbero forse essere più esigenti<br />
nella selezione dell’appaltatore.<br />
Modelli di acquisto differenti che<br />
permettano rapidità di intervento<br />
ma anche premialità per gli attori<br />
in grado di proporre maggiore<br />
qualità e certezza nei risultati. Il<br />
mondo delle costruzioni lo ripete<br />
ormai da tempo.<br />
In questo momento il mondo intero<br />
si è reso conto che la progettualità<br />
sulle infrastrutture è uno strumento<br />
importante per rimettere in moto<br />
l’economia e, per vincere la sfida del<br />
rilancio, è evidente la necessità di<br />
ripensare al modello di engagement<br />
tra committenza ed imprese<br />
esecutrici.<br />
Che serva semplificazione burocratica<br />
ne siamo convinti tutti. Che si debba<br />
rinnovare un patto fatto di fiducia e<br />
cooperazione a superare diffidenze<br />
e contrapposizioni è altrettanto<br />
importante per raggiungere l’obiettivo<br />
comune. In generale però, e ancor<br />
di più se parliamo di elettrificazione,<br />
quando si affida un contratto non<br />
si deve dimenticare di pretendere<br />
garanzie adeguate a chi eseguirà<br />
il lavoro, in termini di know-how<br />
specialistico per ogni sezione<br />
dell’opera da eseguire. Anche e<br />
specialmente quando la committenza<br />
ricorre a contrattisti generali per<br />
affidare grandi progetti. nn<br />
2. Infrastrutture<br />
ferroviarie<br />
FINCO<br />
Federazione Industrie Prodotti<br />
Impianti Servizi ed Opere Specialistiche<br />
per le Costruzioni<br />
Via Brenta, 13<br />
00198 Roma<br />
Tel 06.8555203<br />
Fax: 06.8559860<br />
E-mail: finco@fincoweb.org<br />
www.fincoweb.org<br />
Alfio Bonaventura<br />
Presidente AIFIL<br />
Associazione Italiana<br />
Fabbricanti Insegne Luminose<br />
Federata Finco<br />
D<br />
al 1° gennaio <strong>2021</strong> è<br />
entrato in vigore il<br />
cosiddetto canone unico<br />
(art. 1, commi da 816 a 847, L.<br />
160/2019). Si tratta di un canone<br />
che sostituisce Cosap, ICP, Cimp,<br />
Tosap e Canone non ricognitorio.<br />
Nelle intenzioni del Legislatore il<br />
canone avrebbe dovuto avere<br />
effetti positivi semplificando il<br />
sistema. Tuttavia, non è ciò che<br />
in realtà è avvenuto e sta<br />
avvenendo! Gli Enti locali<br />
chiamati a deliberare i nuovi<br />
regolamenti e le tariffe si sono<br />
trovati nella difficoltà di dover<br />
disciplinare, sotto un’unica<br />
fattispecie, categorie tributarie<br />
diverse che non sono in realtà<br />
unificabili poiché i loro<br />
presupposti sono diversi.<br />
Ma aldilà degli aspetti giuridici,<br />
ciò che è davvero grave è il fatto<br />
che la Legge istitutiva non<br />
prevede un tetto massimo alle<br />
tariffe con la conseguenza che il<br />
canone unico, rispetto alle<br />
precedenti imposizioni (ICP,<br />
COSAP, ecc…), si è tramutato in<br />
un onere a carico del<br />
contribuente locale maggiorato<br />
rispetto al 2020 e ciò nonostante<br />
nella Legge si parli di parità di<br />
gettito.<br />
Clamorosi sono ad esempio i casi<br />
della Città Metropolitana di<br />
Milano, della Provincia di Monza e<br />
della Brianza e del Comune di<br />
Cavenago che, oltrepassando<br />
ogni ragionevole buon senso, ha<br />
applicato una tariffa pari al 500%<br />
di quella del 2020.<br />
E ciò in un momento di grave<br />
crisi economica, come quella che<br />
stiamo vivendo a causa della<br />
pandemia, aumentando la<br />
pressione fiscale a livello locale<br />
(comunale e provinciale) con<br />
ricadute dirette sui commercianti,<br />
sulle attività di impresa e, in<br />
generale, su coloro che<br />
espongono semplicemente la<br />
propria insegna di esercizio al<br />
fine di identificare la propria<br />
sede.<br />
Quanto sopra sta avvenendo<br />
sostanzialmente all’insaputa degli<br />
esercenti in quanto i conti<br />
saranno loro presentati dai<br />
Comuni e dalle Province da Aprile<br />
<strong>2021</strong> con un effetto devastante.<br />
È appena il caso di notare che<br />
l’aumento della pressione fiscale<br />
locale stride anche con quanto ha<br />
dichiarato il Presidente del<br />
Consiglio Draghi durante la<br />
conferenza stampa del 19 marzo<br />
<strong>2021</strong> sul Dl sostegno: “Dobbiamo<br />
chiederci di cosa ci sia bisogno<br />
quest’anno. Bisogna<br />
accompagnare le imprese nel<br />
percorso di uscita dalla<br />
recessione. Questo è un anno in<br />
cui non si chiedono soldi ma si<br />
danno soldi. Verrà in un altro<br />
tempo il momento di pensare al<br />
debito pubblico”.<br />
È paradossale, peraltro, che<br />
proprio quelle attività che hanno<br />
subito l’imposizione della chiusura<br />
(ristoranti, bar, pasticcerie, etc..)<br />
e quelle che indirettamente a<br />
causa della emergenza sanitaria<br />
hanno subito un grave danno<br />
economico (alberghi, strutture<br />
ricettive, ecc..) debbano essere<br />
ulteriormente penalizzate con un<br />
incremento del Canone unico.nn<br />
AssociAzione Anie/AssiFeR<br />
Federazione FinCo<br />
4/<strong>2021</strong>
126<br />
Conoscenza per la ripresa<br />
Una nuova banca dati e informazioni su Covid-19 e settore dei trasporti<br />
Tre mosse per digitalizzare la logistica<br />
Ovvero: e-CMR, dati condivisi e sportello unico: intervista a Clara Ricozzi (OITA)<br />
127<br />
LS<br />
International Road<br />
Federation (IRF)<br />
2 Chemin de Blandonnet<br />
CH-1214 Vernier (Geneva)<br />
Tel. +41-22-306 0260<br />
E-mail: info@irfnet.ch<br />
www.irfnet.ch<br />
Susanna Zammataro<br />
Direttore Generale<br />
IRF<br />
Un nuovo e completo centro di<br />
risorse di conoscenza su Covid-<br />
19 e Trasporti è stato lanciato<br />
il 4 marzo dall’International Road<br />
Federation (IRF) (Ginevra, Svizzera)<br />
grazie a una sovvenzione del Covid-<br />
19 Response & Recovery Transport<br />
Research Fund (2020) gestito dal High<br />
Volume Transport Programme (HVT)<br />
con fondi UK Aid. Il nuovo repository<br />
è ospitato nel portale Global Transport<br />
Knowledge Partnership (gTKP) e ha<br />
l’obiettivo di accelerare l’accesso -<br />
soprattutto per i paesi a basso reddito<br />
- alla conoscenza, all’esperienza, alle<br />
risorse di apprendimento e alle buone<br />
pratiche su COVID-19 e Trasporti. “Pur<br />
affrontando l’emergenza che Covid-<br />
19 ha creato, questa trasformazione<br />
del portale gTKP consentirà anche<br />
di sostenere gli sforzi per un’agenda<br />
post-Covid trasformativa del settore<br />
trasporti. Questo, garantendo che<br />
l’accesso alla conoscenza creata<br />
all’interno di altri programmi e iniziative<br />
pertinenti (ReCAP, HVT e UNRSC) sia<br />
reso effettivamente fruibile così come<br />
le conoscenze utilizzate per informare<br />
le decisioni che daranno forma alla<br />
ripresa”, ha affermato Susanna<br />
Zammataro, Direttore Generale dell’IRF,<br />
presentando il repository in un webinar<br />
dedicato ospitato dall’IRF il 4 marzo.<br />
“Covid-19 ha esposto molte aree<br />
critiche della ricerca richiesta in ambito<br />
trasportistico, come le emissioni del<br />
sistema dei trasporti e la modellazione<br />
ambientale, il controllo delle infezioni<br />
sui sistemi di trasporto, la domanda di<br />
trasporto post-Covid-19, la sicurezza<br />
alimentare e la resilienza dei sistemi di<br />
trasporto, ecc. Questa è un’opportunità<br />
per lavorare ancora più insieme come<br />
una rete globale con una visione<br />
comune e di consentire la mobilità<br />
sostenibile per tutti”, ha commentato<br />
Bernard Obika, leader del team HVT.<br />
Il portale gTKP presenta una vasta<br />
gamma di casi di studio, documenti<br />
di ricerca, pubblicazioni, rapporti,<br />
presentazioni e altro, tutti organizzati<br />
attorno a 5 sezioni chiave: Covid-<br />
19, High Volume Transport, Sicurezza<br />
stradale, Strade rurali, archivi gTKP.<br />
Funziona come una libreria online<br />
gratuita e una porta per accedere ad<br />
altri repository e risorse rilevanti. Gli<br />
utenti e le altre organizzazioni sono<br />
attivamente incoraggiati a migliorare<br />
sia il dinamismo che l’interattività<br />
del portale apportando le proprie<br />
conoscenze ed esperienze sotto forma<br />
di nuovi rapporti, articoli, casi di studio,<br />
documenti di ricerca, pubblicazioni e<br />
altro ancora. “Mentre procediamo in<br />
questo viaggio, accogliamo con favore<br />
commenti e suggerimenti continui<br />
su come continuare a migliorare il<br />
contenuto e la portata del portale per<br />
soddisfare le esigenze in continua<br />
evoluzione. Inoltre, accogliamo con<br />
favore l’opportunità di lavorare con<br />
molte altre organizzazioni nel settore dei<br />
trasporti e non solo per rendere gTKP<br />
uno sforzo congiunto e una piattaforma<br />
condivisa - ha continuato il Direttore<br />
Generale dell’IRF -. La condivisione<br />
delle conoscenze è fondamentale per<br />
il progresso nel settore dei trasporti.<br />
Insieme possiamo costruire un<br />
servizio che contribuisca in modo<br />
determinante al raggiungimento di<br />
questo fondamentale obiettivo globale”.<br />
Il repository Covid-19 è accessibile sul<br />
sito web di Global Transport Knowledge<br />
Partnership: gtkp.com. nn<br />
Nuovo materiale per strade più resilienti<br />
L’IRF Ginevra, in collaborazione<br />
con l’Università di<br />
Birmingham (UoB), l’Università<br />
di Auckland (UoA) e<br />
l’Università Putra Malaysia<br />
(UPM), il 15 <strong>aprile</strong> ha partecipato<br />
al 2° Webinar CRI-<br />
SPS dal tema “Fiber Mastic<br />
Asphalt Technology - Un<br />
nuovo materiale per strade<br />
più resilienti”. Alcuni tipi<br />
di pavimentazione stradale<br />
flessibile possono subire danni da fatica a causa di sovraccarico, cattiva<br />
costruzione o drenaggio inadeguato. Tali danni possono provocare crepe<br />
da fatica e solchi che portano alla formazione di buche e livelli inaccettabili<br />
di asperità della strada. Ciò richiede una maggiore manutenzione<br />
e costi di utilizzo della strada. Un’innovativa tecnologia Fiber Mastic<br />
Asphalt (FMA) è stata sviluppata presso l’Università Putra Malaysia (UPM)<br />
negli ultimi 25 anni per affrontare questi problemi sulle strade della Malesia.<br />
L’ingrediente principale di FMA, la fibra di cellulosa, è prodotto dalle<br />
bucce vuote del frutto degli alberi di palma da olio. Una valutazione delle<br />
strade in servizio costruite utilizzando FMA ha mostrato ottimi risultati aumentando<br />
la durata delle pavimentazioni stradali basate su FMA fino a 10<br />
anni rispetto a quelle costruite con materiali convenzionali. irfnet.ch<br />
Manifesto sulla mobilità connessa e autonoma<br />
L’IRF Ginevra ha pubblicato l’11<br />
marzo il “Manifesto della mobilità<br />
connessa e autonoma” con l’obiettivo<br />
di fornire spunti di riflessione<br />
su come prepararsi in modo<br />
proattivo alla rivoluzione della mobilità<br />
che i veicoli connessi e autonomi<br />
(CAV ) portano al settore della<br />
mobilità e dei trasporti. L’IRF ha<br />
lanciato il Connected and Autonomous<br />
Mobility Committee (CAMC)<br />
per rispondere alle grande sfida<br />
che il settore si trova ad affrontare.<br />
Il Comitato a guida IRF, in collaborazione<br />
con la European Union<br />
Road Federation (ERF) e l’Associazione<br />
europea degli operatori delle<br />
infrastrutture stradali a pedaggio<br />
(ASECAP), mira a costruire una visione<br />
condivisa che guiderà il prossimo<br />
periodo di transizione dove<br />
uno scenario di traffico misto - ovvero<br />
veicoli convenzionali e autonomi<br />
- sarà prevalente. Il Manifesto<br />
riassume una prima riflessione<br />
sulle principali sfide identificate dai<br />
tre gruppi di lavoro che guidano il<br />
lavoro del Comitato per la mobilità<br />
connessa e autonoma (CAMC)<br />
dell’IRF: quadro normativo, lavoro<br />
futuro e bisogni sociali e innovazioni<br />
tecnologiche. irfnet.ch<br />
Associazione Italiana<br />
della Telematica<br />
per i Trasporti e la Sicurezza<br />
TTS Italia<br />
Associazione Italiana della Telematica<br />
per i Trasporti e la Sicurezza<br />
Via Flaminia, 388<br />
00196 Roma<br />
E-mail laura.franchi@ttsitalia.it<br />
www.ttsitalia.it<br />
Laura Franchi<br />
1<br />
1. Clara Ricozzi<br />
Pensare alla grande, passare<br />
dalle parole ai fatti e agire<br />
in fretta. Sono questi<br />
gli input emersi dal webinar<br />
su “Le applicazioni ITS per<br />
l’efficientamento della logistica”<br />
organizzato da TTS Italia il 24<br />
marzo allo scopo di presentare<br />
il documento redatto dal gruppo<br />
di lavoro sulla digitalizzazione<br />
della logistica. Un documento che<br />
arriva in un momento cruciale<br />
per la logistica, messa sotto<br />
i riflettori dalla pandemia, al<br />
centro di grandi trasformazioni<br />
dovute al cambiamento dei<br />
bisogni, esplorata da molte<br />
start up, ora più che mai sente<br />
il bisogno di fare il salto verso<br />
la digitalizzazione e la smart<br />
logistics. TTS Italia ha intervistato<br />
Clara Ricozzi, presidente di OITA,<br />
vicepresidente del Freight Leaders<br />
Council e coordinatrice del gruppo<br />
di lavoro di TTS Italia che indica<br />
le priorità per il settore: e-CMR,<br />
dati condivisi e sportello unico.<br />
Lei ha coordinato il gruppo<br />
di lavoro di TTS Italia<br />
sull’efficientamento della<br />
logistica. Che tipo di lavoro<br />
avete fatto?<br />
Il punto di partenza sono state<br />
le Linee guida redatte nel 2019<br />
da TTS Italia per la smart<br />
moility. In quel documento<br />
si indicava anche la logistica<br />
tra settori da affrontare con<br />
carattere di priorità. Il gruppo<br />
di lavoro, avviato alla fine del<br />
2019, ha messo in rete prima<br />
in presenza poi con scambi in<br />
modalità telematica una grande<br />
molteplicità di soggetti, soci<br />
di TTS Italia, stakeholders<br />
del settore e rappresentanti<br />
istituzionali con lo scopo di<br />
proporre iniziative concrete per<br />
dare efficienza alla logistica<br />
attraverso un uso massiccio di<br />
ITS e tecnologie. Siamo partiti<br />
anche analizzando la normativa<br />
esistente in particolare alla<br />
luce del nuovo Regolamento Ue<br />
1056/2020 pubblicato in Gazzetta<br />
lo scorso luglio. Un provvedimento<br />
che sarà operativo nel prossimo<br />
futuro e che pone le basi per<br />
la condivisione dei dati del<br />
trasporto. Abbiamo poi analizzato<br />
le diverse criticità esistenti e<br />
indicato in un documento alcune<br />
proposte operative che vanno ad<br />
inserirsi anche nel ragionamento<br />
che stiamo facendo come sistema<br />
Paese sul PNRR (Piano Nazionale<br />
di Ripresa e Resilienza).<br />
La pandemia ha acceso un faro<br />
sulla logistica, mettendone in<br />
evidenza le criticità, ma anche<br />
la centralità…<br />
Certo. Il gruppo di lavoro<br />
vuole esprimere questo:<br />
concentriamoci su un settore<br />
basilare per l’economia nazionale,<br />
individuando e cercando di<br />
risolverne le criticità per renderlo<br />
più efficiente. Secondo alcune<br />
stime, oggi le inefficienze della<br />
logistica equivalgono a 70<br />
miliardi di euro annui, dei quali<br />
oltre 30 miliardi attribuibili a<br />
oneri burocratici e ritardi nella<br />
digitalizzazione. Una situazione<br />
che rischia di aggravarsi<br />
ulteriormente in vista di<br />
emergenze e crisi di vario genere.<br />
Nel documento si parla di<br />
nuova logistica. Che cosa vuol<br />
dire?<br />
La nuova logistica è il modello che<br />
nasce dallo sviluppo di sistemi<br />
intelligenti e digitalizzazione.<br />
Una supply chain protagonista<br />
dell’economia in grado di<br />
fluidificarne i flussi e garantirne la<br />
sicurezza.<br />
Per raggiungere questo obiettivo<br />
il documento indica delle priorità,<br />
tra cui la digitalizzazione dei<br />
documenti e delle certificazioni,<br />
l’interoperabilità della PLN con gli<br />
ITS già in uso presso le aziende,<br />
la realizzazione di aree di sosta<br />
sicure per i mezzi pesanti, misure<br />
per favorire lo sviluppo delle<br />
smart roads, del platooning, della<br />
blockchain, per contenere i viaggi<br />
a vuoto, per sostener la logistica<br />
collaborativa, l’organizzazione<br />
dell’ultimo miglio e della logistica<br />
urbana e interventi mirati alla<br />
sicurezza delle aree di sosta.<br />
Sempre nel documento emerge<br />
la richiesta di un soggetto unico<br />
nazionale a sostegno della<br />
logistica.<br />
Ci può spiegare meglio?<br />
Questa richiesta emerge<br />
dall’analisi del Piano di azione<br />
nazionale sui sistemi intelligenti<br />
di trasporto (ITS) e dalla<br />
constatazione che le competenze<br />
sulla sua attuazione sono<br />
in capo a diverse strutture<br />
amministrative. Così l’idea di un<br />
soggetto unico a livello nazionale<br />
- sul modello di un’agenzia<br />
- potrebbe considerarsi una<br />
soluzione per accelerare il lavoro<br />
su questo fronte, per avere<br />
un’unità di scelte che finora è<br />
mancata e che in questo momento<br />
diventa ancora più importante in<br />
vista del PNRR che mette al primo<br />
punto proprio la digitalizzazione.<br />
Potrebbe anche essere una<br />
struttura interna al MIMS<br />
(Ministero delle Infrastrutture e<br />
della Mobilità sostenibili, ndr) con<br />
l’obiettivo di coordinare le altre<br />
amministrazioni coinvolte.<br />
Quale ruolo è auspicabile per<br />
la PLN?<br />
La Piattaforma Nazionale Logistica<br />
dovrebbe favorire con maggiore<br />
convinzione l’interoperabilità fra<br />
i servizi logistici e le piattaforme<br />
già in uso. Per fare questo<br />
occorre semplificare i processi di<br />
comunicazione tra i nodi logistici e<br />
attivare funzionalità che facilitino<br />
l’accesso e/o la prenotazione dei<br />
mezzi nei porti, interporti, hub e<br />
strutture operative.<br />
Ci può indicare due, massimo<br />
tre misure urgenti da mettere<br />
in campo?<br />
Sono quelle già inserite nel<br />
PNRR, ovvero la semplificazione e<br />
smaterializzazione dei documenti<br />
di viaggio con il recepimento<br />
della normativa per la CMR<br />
elettronica. Per mettere in pratica<br />
questo punto occorre una legge<br />
che recepisca la convenzione<br />
internazionale e detti i tempi per<br />
l’adeguamento delle aziende alle<br />
nuove regole. Un’altra misura è la<br />
condivisione dei dati in attuazione<br />
del regolamento europeo: avere<br />
dati uniformi a disposizione<br />
consente di procedere a passo<br />
spedito verso la digitalizzazione<br />
del settore. Infine, lo sportello<br />
unico doganale, ormai al<br />
palo da diversi anni, direi<br />
immotivatamente, rappresentano<br />
strumento utilissimo per le<br />
aziende. Si tratta anche qui di<br />
dare seguito a un provvedimento<br />
amministrativo per attuarlo<br />
completamente. Sono piccoli passi<br />
che però porterebbero a grandi<br />
conquiste!<br />
https://www.ttsitalia.it/<br />
newsletter/30_marzo_<strong>2021</strong>.<br />
html nn<br />
Federazione irF<br />
AssociAzione TTs iTALiA<br />
4/<strong>2021</strong>
Speciale Ponti&Viadotti<br />
leStrade<br />
LS<br />
Aeroporti Autostrade Ferrovie<br />
N. 1566/ 1563/ 1562/ 412 11 APRILE DICEMBRE NOVEMBRE <strong>2021</strong>2020<br />
Aeroporti Autostrade Ferrovie<br />
Casa Editrice la fiaccola srl<br />
Speciale Gallerie<br />
LE STRADE<br />
STRADE MONOGRAFICO<br />
GALLERIE MACCHINE<br />
Barriere Numero dedicato made in Italy<br />
sul alle mercato reti stradali francese<br />
INTERVISTE<br />
In esclusiva Anas<br />
e Commissione UE<br />
SPECIALISTI<br />
Norme, sicurezza<br />
e alta tecnologia<br />
Le opere ferroviarie<br />
della nostra Penisola<br />
Arriva la finitrice<br />
con il radiocomando<br />
(n. 1562) 1563) 1566) - Anno CXXIII - - N° 11 12 4 Aprile Novembre Dicembre <strong>2021</strong> 2020<br />
GALLERIE<br />
Gli avanzamenti<br />
dei trafori alpini<br />
ROAD SAFETY<br />
Come proteggere<br />
Mapeshield<br />
gli ostacoli fissi<br />
®<br />
00_00_COVER LS 4.indd 1<br />
13/04/21<br />
ENGLISH VERSION<br />
00_00_COVER_11_2020 LS ANAS 4.indd OK.indd OK.indd 1 1 1 25/11/20 18/12/20 13/04/21 12:20 11:43<br />
16:48<br />
OGNI mESE<br />
• Interviste • Autostrade • Strade • Infrastrutture & Mobilità<br />
• Manutenzione & Innovazione • Ponti & Viadotti • Gallerie<br />
• Parcheggi • Materiali & Tecnologie • Macchine & Attrezzature<br />
Dossier periodici in lingua inglese<br />
abbonamenti@fiaccola.it<br />
Abbonamento annuo €100,00 *<br />
10 numeri + versione online www.lestradeweb.it<br />
*(IVA assolta dall’editore)<br />
www.lestradeweb.it<br />
Casa Editrice la fiaccola srl<br />
Via Conca del Naviglio, 37 | 20123 Milano | Tel. 02 89421350 | fax 02 89421484 | www.fiaccola.it
IL FUTURO DELLA SICUREZZA STRADALE<br />
VISIBILITÀ<br />
ILLUMINAZIONE INNOVATIVA DELLA STRADA<br />
La strada è illuminata in modo rivoluzionario, delineandola perfettamente dalla banchina<br />
a metà della corsia con un fascio luminoso molto potente, che si attenua verso il centro<br />
della carreggiata. Trattasi di illuminazione longitudinale a intensità regolabile anche da<br />
remoto, nel rispetto delle normative vigenti.<br />
www.guardled.it