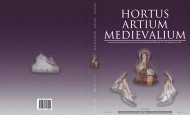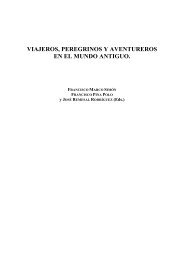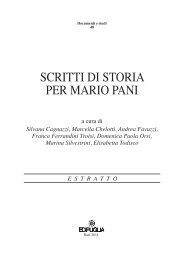VAGNARI - Archeologia.unifg.it - Università degli Studi di Foggia
VAGNARI - Archeologia.unifg.it - Università degli Studi di Foggia
VAGNARI - Archeologia.unifg.it - Università degli Studi di Foggia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
XII. Vagnari nel contesto dei paesaggi rurali dell’Apulia romana e tardoantica<br />
ticolarmente preziose in particolare a segu<strong>it</strong>o del <strong>di</strong>rottamento<br />
del grano egiziano verso Costantinopoli e più<br />
tar<strong>di</strong> della perd<strong>it</strong>a del controllo dell’Africa in mano ai<br />
Vandali 41 .<br />
Un ruolo fondamentale nella definizione del paesaggio<br />
rurale tardoantico (soprattutto nel V-VI secolo)<br />
va attribu<strong>it</strong>o alle chiese e ai cim<strong>it</strong>eri, spesso unica traccia<br />
<strong>di</strong> ab<strong>it</strong>ati minori, <strong>di</strong>fficili da in<strong>di</strong>viduare nel corso<br />
delle ricognizioni e raramente oggetto <strong>di</strong> scavi non lim<strong>it</strong>ati<br />
esclusivamente all’indagine dell’e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong><br />
culto 42 . I tanti esempi noti, pur con i lim<strong>it</strong>i <strong>di</strong> una conoscenza<br />
ancora ampiamente lacunosa e nonostante le<br />
specific<strong>it</strong>à dei singoli casi (chiese private, chiese battesimali,<br />
chiese episcopali, monasteri, ecc.), propongono<br />
una serie <strong>di</strong> considerazioni che è possibile così<br />
schematizzare: le <strong>di</strong>ffusione delle chiese rurali riguardò<br />
in particolare il V e VI secolo, che cost<strong>it</strong>uirono<br />
il momento centrale della cristianizzazione delle campagne;<br />
alcune chiese restarono in v<strong>it</strong>a sicuramente non<br />
oltre il VII secolo, mentre per altre è documentata o<br />
ipotizzabile una prosecuzione nei secoli successivi; la<br />
geografia <strong>degli</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> culto era strettamente legata<br />
non solo alla viabil<strong>it</strong>à ma anche alle geografia delle<br />
ville e dei vici tardoantichi; non sempre, però, risulta<br />
chiaro se la chiesa si sia installata nei pressi <strong>di</strong> una<br />
villa ancora attiva o in un e<strong>di</strong>ficio ormai abbandonato<br />
e in <strong>di</strong>suso; in questi ultimi casi spesso sono i cim<strong>it</strong>eri<br />
ad attestare forme <strong>di</strong> riuso delle strutture preesistenti;<br />
le chiese associavano alle attiv<strong>it</strong>à religiose altre funzioni,<br />
in quanto centri <strong>di</strong> aggregazione, <strong>di</strong> commercio<br />
e <strong>di</strong> scambio, <strong>di</strong> pagamento dei canoni e delle tasse, e<br />
<strong>di</strong> assistenza.<br />
È una peculiar<strong>it</strong>à del processo <strong>di</strong> cristianizzazione,<br />
in particolare nei terr<strong>it</strong>ori centro-meri<strong>di</strong>onali, la presenza<br />
<strong>di</strong> un certo numero <strong>di</strong> vici promossi a sede episcopale,<br />
secondo un processo frequente nella prassi,<br />
anche se fortemente contrastato dai vertici della gerarchia<br />
ecclesiastica 43 . Ben due casi riguardano la Puglia<br />
settentrionale: Trani e San Giusto. I vescovi rurali,<br />
spesso erroneamente confusi con i corepiscopi, erano<br />
dotati <strong>di</strong> pieni poteri, partecipavano a concili, ne sottoscrivevano<br />
gli atti, ricevevano missive papali ed inca-<br />
41 In generale cfr. Volpe 1996, 147-196; Arthur 2004.<br />
42 Si rinvia a Volpe, Favia, Giuliani 1999 e 2003; Volpe 2008b<br />
e 2009; in generale si veda Cantino Wataghin, Fiocchi Nicolai,<br />
Volpe 2007.<br />
richi per la soluzione <strong>di</strong> problemi riguardanti altre <strong>di</strong>ocesi,<br />
ecc., pur essendo inse<strong>di</strong>ati in ab<strong>it</strong>ati rurali. Il concetto<br />
<strong>di</strong> rurale è, dunque, legato al tipo <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento<br />
nel quale il vescovo eserc<strong>it</strong>ava le proprie funzioni, cioè<br />
generalmente in ‘agglomerati secondari’, o meglio in<br />
‘inse<strong>di</strong>amenti non urbani’, privi dunque dello status <strong>di</strong><br />
civ<strong>it</strong>as. All’interno <strong>di</strong> questa definizione possono trovare<br />
spazio realtà alquanto articolate, come vici, scali<br />
mar<strong>it</strong>timi e stazioni <strong>di</strong> posta (mansiones), inse<strong>di</strong>amenti<br />
<strong>di</strong> tipo precario o stagionale legati ad esempio a nun<strong>di</strong>nae<br />
o sorti intorno a santuari, accampamenti mil<strong>it</strong>ari,<br />
castra/castella 44 .<br />
Il fenomeno appare eccezionale nell’Italia Annonaria,<br />
mentre risulta molto più esteso in area centro-meri<strong>di</strong>onale.<br />
È particolarmente significativa, in alcuni<br />
casi, l’evoluzione urbana del vicus. Esemplare <strong>di</strong> questo<br />
processo è il caso <strong>di</strong> Trani, un villaggio portuale del<br />
terr<strong>it</strong>orio <strong>di</strong> Canusium, documentato per la prima volta<br />
dalla Tabula Peutigeriana e assurto al rango <strong>di</strong> <strong>di</strong>ocesi<br />
tra V e VI secolo in segu<strong>it</strong>o ad una gemmazione dalla<br />
<strong>di</strong>ocesi canosina, <strong>di</strong> cui faceva originariamente parte:<br />
Eutychius episcopus Tranensis sottoscrisse i concili romani<br />
del 501-2.<br />
Se in alcuni casi il vicus conobbe una trasformazione<br />
urbana, la breve durata, con il conseguente abbandono<br />
nel corso dell’Altome<strong>di</strong>oevo, <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>ocesi<br />
rurali <strong>di</strong>mostra, però, come l’iniziativa vescovile, pur<br />
cost<strong>it</strong>uendo un decisivo fattore <strong>di</strong> sviluppo, non potesse<br />
essere sufficiente, in mancanza <strong>di</strong> altri fattori (in particolare<br />
legati alla collocazione lungo gran<strong>di</strong> arterie viarie<br />
e in s<strong>it</strong>i portuali), a garantire sempre e comunque<br />
un’evoluzione in senso urbano. La maggiore <strong>di</strong>ffusione<br />
delle <strong>di</strong>ocesi rurali nelle regioni centro-meri<strong>di</strong>onali è<br />
verosimilmente da spiegare sia con l’affermazione in<br />
queste aree del sistema vicano, sia con la particolare<br />
v<strong>it</strong>al<strong>it</strong>à dell’economia agraria <strong>di</strong> tali terr<strong>it</strong>ori durante<br />
l’età tardoantica. Frequente risulta l’associazione tra le<br />
se<strong>di</strong> episcopali sorte in campagna e la presenza <strong>di</strong><br />
ampie proprietà imperiali 45 , spesso trasfer<strong>it</strong>e al patrimonio<br />
ecclesiastico e a volte organizzate nella forma<br />
della massa fundorum 46 . Tale associazione con la proprietà<br />
imperiale sembra particolarmente significativa<br />
43 Si veda ampiamente Volpe 2008b.<br />
44 Cantino Wataghin, Fiocchi Nicolai, Volpe 2007.<br />
45 De Fino 2005a.<br />
46 Vera 1999b e 2001.<br />
<strong>VAGNARI</strong>. Il villaggio, lʼartigianato, la proprietà imperiale - © 2011 · E<strong>di</strong>puglia s.r.l. - www.e<strong>di</strong>puglia.<strong>it</strong><br />
355