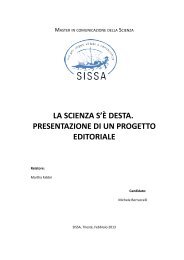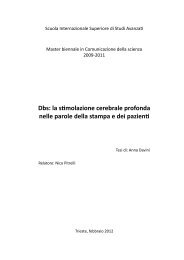La comunicazione scientifica nei conflitti ambientali. Casi a ...
La comunicazione scientifica nei conflitti ambientali. Casi a ...
La comunicazione scientifica nei conflitti ambientali. Casi a ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
comunità (Bobbio, 2011). Un fenomeno che ha origine nella perdita di fiducia<br />
nelle istituzioni e nella politica (Sintomer e Allegretti, 2009), e nella loro capacità<br />
di gestione delle problematiche <strong>ambientali</strong>, che rappresenta uno dei “principali<br />
antecedenti del conflitto” (Petts, 1995). Una profonda crisi della legittimità politica<br />
che ha portata mondiale: secondo un sondaggio realizzato dai servizi<br />
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), due terzi degli abitanti del<br />
pianeta non si sentono rappresentati dai loro governanti (Castells, 2007).<br />
Conflitto, quindi, particolarmente legato al capitale di fiducia <strong>nei</strong> confronti delle<br />
istituzioni. Fiducia ulteriormente minata dalla sempre maggiore frammentazione<br />
della scienza, dalla moltiplicazione delle realtà scientifiche (il nucleare è pulito?<br />
Uno scienziato ti dirà di sì, un altro no. Chi ha ragione?), come si vedrà <strong>nei</strong> casi<br />
studio che seguono. <strong>La</strong> gestione delle questioni <strong>ambientali</strong> non è più quindi<br />
delegabile a un sapere esperto, poiché non vi sono più soggetti univocamente<br />
capaci di verità pre-istituita, il cui statuto sia certo da un lato – la scienza moderna<br />
che appariva univoca - e verificabile dall’altro - la rappresentanza politica, che<br />
appariva razionale 3 .<br />
Davanti ad istituzioni che presentano opere o politiche come decisive e<br />
imprescindibili per lo sviluppo (spesso attraverso processi decisionali top-down,<br />
fortemente centralizzati, poco attrezzati all’ascolto delle comunità locali), come ad<br />
esempio gli impianti di incenerimento dei rifiuti, nuovi soggetti rispondono (e si<br />
oppongono) dando vita a nuovi processi di “apprendimento collettivo”, parlando<br />
di rischio e di pericolosità per la salute. Allo scopo, i movimenti si appoggiano<br />
sempre più alla conoscenza e all’expertise tecno-<strong>scientifica</strong> ufficiale per porsi sullo<br />
stesso piano di autorevolezza <strong>scientifica</strong> delle argomentazioni delle istituzioni, e<br />
affrancarsi dallo stigma Nimby (Pellizzoni, 2011). Viene così a cadere il monopolio<br />
sull’expertise da parte delle organizzazioni politiche e le istituzioni, che al<br />
contrario diventa una risorsa a livello di movimenti di base.<br />
<strong>La</strong> capacità di produrre contro-expertise consente ai movimenti di legittimarsi agli<br />
occhi dell’opinione pubblica come portatori d’interessi non (solo) particolaristici e<br />
di progettualità alternativa (Trom, 1999; Rootes, 2007). Allo stesso tempo, però,<br />
ne consegue che il conflitto originario tra proponenti e popolazione locale si<br />
3 <strong>La</strong> scienza, tradizionale apparato di legittimazione razionalista negli ultimi due secoli,<br />
comincia a vacillare: ciò essenzialmente perché quasi sempre le distanze tra cause ed effetti<br />
finiscono per essere notevoli, e quindi difficilmente “coglibili” da parte degli esperti stessi, i<br />
quali non a caso si dividono in scuole di pensiero diverse e contrapposte, producendo un<br />
ulteriore “effetto di spaesamento” da parte dell’opinione pubblica (Giddens, 2000).<br />
9