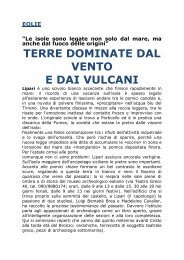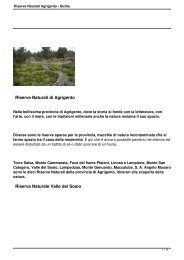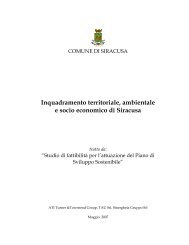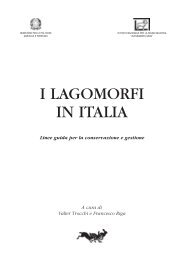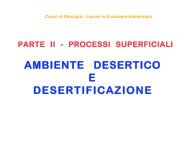You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
“La tigre e la neve”<br />
La storia di un amore non ricambiato.<br />
Attorno: la guerra in Iraq<br />
Cinema e Spettacolo<br />
Dicembre 20<strong>05</strong><br />
L’ultimo gioiello di Roberto Benigni:<br />
“La tigre e la neve”, un film sull’amore e<br />
sulla poesia che ha sullo sfondo la guerra<br />
irachena.<br />
Attilio (Roberto Benigni) è un poeta<br />
italiano, padre di due adolescenti ed innamorato<br />
di una donna Vittoria (Nicoletta<br />
Braschi), che, però, non lo ricambia. Per<br />
lei, ferita a Baghdad, il caro Attilio si muoverà<br />
in situazioni esilaranti e superlativi<br />
per aiutarla a trovare una medicina in grado<br />
di ridurre l’edera cerebrale che la sta<br />
uccidendo. Così, anche lui si recherà a Baghdad<br />
e qui incontrerà l’amico poeta arabo<br />
Jean Reno, che dall’Europa torna in Iraq<br />
durante la guerra.<br />
Siamo nella primavera del 2003, in Iraq,<br />
all’inizio del conflitto. E qui il povero Attilio<br />
che non conosce una parola di arabo,<br />
combatterà la sua guerra personale in una<br />
terra dilaniata dall’orrore, armato solo della<br />
sua poesia. Nonostante il film possa<br />
sembrare ripetitivo e troppo dolciastro nella sua struttura narrativa e nella messinscena,<br />
non si può nascondere il talento di Benigni attore che tra una sventura e l’altra ci regala<br />
momenti di una comicità sublime che rimarranno nell’immaginario collettivo: come, quando<br />
saltella su di un campo minato come se fosse un canguro per inseguire la sua amata, o<br />
quando dialoga col dromedario.<br />
Non si può definire La tigre e la neve un film sulla guerra irachena, anche se è ambientato<br />
in questo contesto, ma sulla poesia e sull’amore che tutto vince, anche ciò che può sembrare<br />
impossibile, come la malattia di Vittoria. Pensiamo alla scena sulla lezione tenuta dal<br />
professore Attilio e alle diverse citazioni letterarie o al sogno dei quattro poeti: Borges,<br />
Montale, Ungaretti, Yourcenar. Qui la guerra è solo evocata, è proprio l’amore che spinge<br />
e prende il sopravvento, la voglia di vivere, nonostante la vita sia disperata. È Benigni<br />
stesso che sottolinea che la forza del suo film è nel sentimento e gli iracheni e gli americani<br />
sono solo sullo sfondo. I posti di blocco in cui si imbatte Attilio sono di marines americani,<br />
visti con gli occhi di un poeta:<br />
“Sono ragazzi, verso di loro non esprimo giudizi, ma mostro la mia pietas”.<br />
Sulla scia di questo amore universale, Benigni si muove tra i sogni di Fellini e la comicità<br />
di Chaplin. In sogno con mutandoni, calzini e canottiera, Attilio porterà la sua amata<br />
Vittoria all’altare sulle struggenti note di You can never hold back spring cantata live da<br />
Tom Waits; in un prato circondato da antiche mura romane davanti a una platea in cui si<br />
riconoscono i quattro poeti.<br />
“Il sublime –afferma Benigni- deve sempre essere sorvegliato dal comico. Se dovessi<br />
vergognosamente indicare un modello a cui mi sono ispirato inopinatamente per questo<br />
film è il maestro Chaplin di Luci della città. Qui il protagonista fa la sua guerra per una<br />
donna in coma, lì Chaplin la fa per una ragazza cieca. E sulla scena finale ho quasi copiato<br />
l’inquadratura. È un tributo pagato al Maestro<br />
La stagione autunnale consacra le sue migliori<br />
fiction, quando ci propone storie e fatti importanti<br />
per le generazioni future. Come nel il caso di Mediaset<br />
che ci ha raccontato la storia di Nicola Sacco<br />
e Bartolomeo Vanzetti: l’ingiusta condanna di due<br />
immigrati italiani giustiziati innocenti sulla sedia<br />
elettrica americana. Fiction per la regia di Fabrizio<br />
Costa, con Sergio Rubini nel ruolo di Sacco, Ennio<br />
Fantastichini in quello di Vanzetti ed Anita Caprioli<br />
in quello di Rosina, moglie di Sacco. Mai<br />
come oggi, raccontare quella vicenda è così di attualità:<br />
illegalità, sopraffazione, sfruttamento dei<br />
più deboli, libertà d’espressione sono temi più che<br />
mai attuali perché viviamo in un secolo di ingiustizie.<br />
Siamo ai primi del Novecento, l’arrivo in America<br />
(terra di libertà, democrazia e lavoro) della<br />
povera gente pronta ad abbandonare le proprie<br />
radici e i propri affetti, per rimettersi in gioco e<br />
ripartire da zero; come Nicola Sacco, ciabattino<br />
che credeva nella famiglia e Bartolomeo Vanzetti<br />
idealista anarchico. Ad accoglierli nel quartiere italiano<br />
don Mario, la sua bontà e la sua saggezza, la<br />
casa del suo Signore aperta a tutti, anche agli anarchici,<br />
perché cambiare il mondo è giusto se esso è<br />
ingiusto. Lo sguardo di Sacco è intimidito, ma anche<br />
affascinato; così il regista lo mostra e lo segue<br />
con la sua macchina da presa (mdp), mentre percorre<br />
il suo cammino e stanza dopo stanza scoprirà<br />
il bel volto della sua Rosina, che danza sulle tristi<br />
note di Giselle, amore disperato ma intenso come<br />
sarà il suo. Se l’amore e la solidarietà traspaiono dal<br />
quartiere italiano, dall’altra parte, il regista analizza<br />
la corruzione del potere razzista e sopraffattore,<br />
che ha il solo compito di denigrare e soggiogare la<br />
povera gente che emigra in cerca di fortuna.<br />
Pertanto il potere della stampa, cioè l’informazione<br />
venduta, serve il potere, occultando la verità;<br />
mentre il Vanzetti sottolinea come solo la cultura,<br />
intesa come istruzione, può sconfiggere quei padroni<br />
dei cantieri che hanno un solo compito: quello<br />
di sfruttare i poveri immigrati. Da qui parte la<br />
rivoluzione, quella fatta di parole, che annuncia:<br />
libertà e democrazia. “Se l’America è un paese<br />
libero, dov’è la libertà e la democrazia quando manca<br />
la dignità umana?” E’ questa la dignità che don<br />
Mario predica nell’omelia per la morte del padre di<br />
Rosina, avvenuta durante il lavoro; dove in alto il<br />
regista illumina il Cristo in croce, metafora dello<br />
sfruttamento di questa gente, costretta a lavorare<br />
in condizioni disastrose e massacranti.<br />
”.<br />
R. R. C.<br />
Vanzetti invoca lo sciopero, la lotta per cambiare<br />
il sistema: una lotta pacifica fatta solo di parole<br />
e non di azioni violente: “Pianterò un albero e<br />
renderò universali le città… Per te democrazia,<br />
mia donna, per te faccio vibrare questi canti”. Ma<br />
al cantiere non c’è posto per gli anarchici e il sindacato:<br />
Saccho è licenziato. Si è licenziati e messi a<br />
morte se si è contro il potere del governatore e delle<br />
sue idee, non importa se nel corteo ci sono donne<br />
e bambini; bisogna fermarli e se è necessario ammazzarli<br />
tutti. Si vuole impedire un futuro migliore<br />
alle nuove generazioni; infatti Rosina, durante la<br />
manifestazione contro la guerra, perderà la sua seconda<br />
gravidanza.<br />
Tre maggio 1920, Sacco e Vanzetti vengono<br />
arrestati per rapina e duplice omicidio; inizia la<br />
loro discesa. Il regista nella seconda parte del film,<br />
la più intensa, evidenzia ancor più il contrasto tra<br />
bene e male, tra verità e menzogna e il processo, col<br />
suo tragico finale, diventa simbolo di libertà e giustizia.<br />
Il merito di Fabrizio Costa è di averci regalato<br />
una vicenda umana filmata nei minimi dettagli,<br />
dove l’aula del processo diventa luogo di razzismo<br />
e malvagità; mentre il posto degli imputati, il più<br />
pulito e sincero. Sacco e Vanzetti sono due animecristo<br />
e la loro integrità e purezza non sarà scalfita<br />
neanche quando il potere, sopraffatto dalla verità<br />
di mezzo mondo, proporrà la grazia solo al Vanzetti,<br />
il quale risponderà: «Io Nicola non lo lascio».<br />
La solidarietà tra i compagni di cella, il suono dei<br />
cucchiai sui cancelli, è una delle scene più emozionanti<br />
del film, e da qui in poi il film è un climax<br />
ascendente di rabbia, tristezza e amarezza, che ci<br />
porterà fino a quel 23 agosto del 1927 su una sedia<br />
elettrica. E che tono alto, dignitoso e sublime le sue<br />
ultime parole davanti al giudice, la corte, i presenti<br />
in aula: “Sono colpevole di essere un radicale, un<br />
italiano, un anarchico, un socialista, uno vicino agli<br />
uomini. Mi avete tolto l’amore e la voglia di sognare.<br />
Grido la mia protesta contro l’ingiustizia; insegno<br />
agli uomini di avere dignità, a far capire loro i<br />
doveri ed anche i diritti. Ci rivedremo in un’altra<br />
vita, migliore di questa”. Ancora oggi, purtroppo,<br />
la cronaca si ripete: il regista ha voluto raccontare<br />
questa storia anche per far capire meglio il tema<br />
dell’immigrazione, in un paese come il nostro in<br />
cui c’è un alto numero di immigrati.<br />
Adesso stiamo diventando sempre meno tolleranti<br />
davanti a questa povera gente che è vista<br />
come il nemico che vuole toglierci il lavoro, ma che<br />
è solo un gruppo disperato in cerca di fortuna,<br />
come lo erano Sacca e Vanzetti. Forse se si racconta<br />
una storia di due italiani immigrati e disprezzati<br />
riusciremo a capire meglio quello stato di cose e ad<br />
immedesimarci di più per riuscire a non disprezzare<br />
ma ad aiutare chi è meno sfortunato di noi. Questo<br />
è il messaggio positivo della fiction: nel mondo<br />
c’è posto per tutti.<br />
Nel 1977 Nike (Nicola Sacco) e Bart (Bartolomeo<br />
Vanzetti) sono stati riabilitati da quell’accusa<br />
ingiusta.<br />
Rocco Roberto Cacciatore<br />
Ogni volta che si parla di Torino, mi<br />
dicono che è una città fredda e grigia,<br />
provinciale. Che non ha tanto da proporre<br />
ai suoi cittadini, figuriamoci ad un<br />
ospite.<br />
Rispondo sempre che non è proprio<br />
come si dice. Certo oggi Torino è<br />
tutto un cantiere che si prepara alle Olimpiadi<br />
del 2006, ma la capitale italiana<br />
dell’arte contemporanea esprime una<br />
realtà tutt’altra che grigia. Anzi, è una<br />
città dove regna il verde; dove principalmente<br />
regna -insieme alla Fiat- il Cinema<br />
con il suo Museo, la strepitosa ambientazione<br />
della Mole Antonelliana, dove si<br />
è svolta la serata di chiusura del 23°<br />
Film festival.<br />
Al “Torino Film Festival” manca però<br />
la mondanità. Mancano i nomi famosi<br />
del grande schermo hollywoodiano e non<br />
si sfoggiano i vestiti di gala come a Cannes,<br />
Venezia, Los Angeles…<br />
I riflettori abbaglianti non vengono<br />
puntati su vincitori e conduttori di fama<br />
mondiale. La sala del vecchio cinema<br />
“Lux”, il più vecchio di Torino, è rimasta<br />
uguale nella serata di consegna dei premi.<br />
Durante i giorni del festival potevi<br />
avvicinarti liberamente al personaggio<br />
che ti interessava e discutere con lui del<br />
suo lavoro, dei suoi progetti e scambiare<br />
tutte le idee… È tutto cosi compatto<br />
e normale. Motivo per il quale amo i<br />
festival di questo genere: non sono dispersivi<br />
e frenetici; sono fatti su misura<br />
“Sacco e Vanzetti” di Fabrizio Costa<br />
Una storia di ieri per capire tante storie di oggi<br />
23esimo Film Festival<br />
A Torino, niente riflettori su vincitori e conduttori di fama mondiale<br />
per gente comune. Ovvio per gente che<br />
ama il cinema.<br />
Certo che i cinefili hanno avuto chi<br />
incontrare: Claude Chabrol, Walter Hill,<br />
Alfred Green, Amir Naderi, i “nuovi”<br />
Lav Diaz e Lodge Kerrigan, il siciliano<br />
Vittorio de Seta al quale è andato il premio<br />
Cipputi alla carriera. E, infine, Isabella<br />
Rossellini che ha presentato il film<br />
“Mio Padre ha 100 anni”. Tutto suo<br />
dalla sceneggiatura alla ripresa, al montaggio.<br />
Una “lettera d’amore” di 15 minuti<br />
dedicata al Padre come lo ricorda lei.<br />
Su come è nata l’idea e sulla sua famiglia,<br />
Isabella ne parla volentieri in un in-<br />
Via Molinari, 4 - C.da Pezzamandra - Misterbianco (CT)<br />
contro stampa durante il suo soggiorno<br />
torinese. Lei, donna immagine della eleganza<br />
femminile, si presenta vestita con<br />
un abito maschile “perché è più comodo”,<br />
risponde.<br />
INCONTRO CON<br />
ISABELLA ROSSELLINI<br />
My Dad is 100 Years Old<br />
Genesi del film. - Nel 2006 mio<br />
padre compirebbe 100 anni. Ho pensato<br />
molto a cosa fare: restrospettive, articoli,<br />
libri. Poi mi sono detta: «e se non<br />
succede nulla?» Allora ho deciso per il<br />
film, una cosa mia, che posso fare solo<br />
io, non il solito documentario con le immagini<br />
di repertorio, ma un film interno,<br />
basato sulle cose che avevo in<br />
testa.<br />
I personaggi.<br />
- Ho cercato di<br />
dialogare con persone<br />
che avevano<br />
idee sul cinema diverse<br />
da mio padre.<br />
Alfred Hitchcock;<br />
il produttore<br />
David<br />
O. Selznick, che<br />
aveva un contratto<br />
con mia<br />
madre, pur non<br />
avendo mai lavorato<br />
con mio padre co-<br />
nosceva tutti i suoi film; Federico Fellini,<br />
grande amico di papà per cui ha scritto<br />
molto; Charlie Chaplin di cui papà<br />
aveva una foto sul comodino e che nel<br />
film appare come un angelo.<br />
Mettersi in gioco come attrice. -<br />
All’inizio avevo disegnato il copione per<br />
far capire a Maddin cosa volevo. È stato<br />
lui a darmi l’idea di interpretare tutti i<br />
personaggi perchè solo io sapevo quello<br />
che volevo, solo io sapevo cosa avevo in<br />
testa. Così ho provato e direi che ha funzionato:<br />
in particolare mi è piaciuto il<br />
mio Selznick, molto virile.<br />
Mio padre non voleva che facessimo<br />
gli attori, per questo l’ho fatto solo dopo<br />
la sua morte. Il primo film che ho interpretato,<br />
dopo Il Papocchio in cui facevo<br />
me stessa, è stato Il prato (1979) dei<br />
fratelli Taviani: mi ricordo un grande conflitto<br />
interiore perchè papà aveva molta<br />
stima di loro e aveva premiato a Cannes<br />
il loro Padre, padrone. Quindi da una<br />
parte io volevo fare il film con i Taviani,<br />
ma dall’altra era come andare contro i<br />
voleri di mio padre. Fu mia madre che un<br />
giorno mi disse: «Tuo padre faceva i film<br />
con i non-attori, quindi anche tu puoi<br />
fare la non-attrice».<br />
La scelta di Guy Maddin. - Tre anni<br />
fa abbiamo fatto insieme il film The Saddest<br />
Music in the World, che presto uscirà<br />
in Italia. Guy vive in un piccolo paesino<br />
sperduto ma ricco di arte. Quando<br />
mi ha mandato il suo film The Heart of<br />
the World sono rimasta letteralmente incantata:<br />
i suoi film sono “rovinati”, sembrano<br />
disintegrarsi, la sua è un’estetica<br />
della fragilità alla Méliès.<br />
Il Sundance Film Festival ha comprato<br />
My Dad is 100 Years Old e volevano<br />
proiettare anche Roma città aperta<br />
perchè da 18 anni non si vede in America.<br />
Originariamente il mio film era pensato<br />
per l’America e avevo in mente di<br />
fare una retrospettiva nelle Università<br />
per far conoscere agli americani l’opera<br />
di mio padre. Maddin è molto popolare<br />
tra i giovanissimi per cui l’ho usato un<br />
po’ come esca e lui si è prestato molto<br />
volentieri.<br />
La grande pancia. - Papà diceva<br />
sempre che invidiava le donne, che avrebbe<br />
voluto vivere la gravidanza e allattare<br />
i suoi figli. Io da bambina era convinta<br />
che fosse incinto perchè credevo potesse<br />
fare tutto. Papà stava sempre a letto,<br />
lo vedevamo spesso in pigiama e io abbracciavo<br />
il suo grande pancione: per<br />
questo nel film ho usato questa immagine<br />
buffa. I film di papà sono dei grandi<br />
drammi, strappano le lacrime: io ho voluto<br />
fare dell’umorismo per ritrovare la<br />
mia voce.<br />
Ingrid Bergman. - La frase secondo<br />
cui la carriera di mia madre sarebbe<br />
stata rovinata da Rossellini compare in<br />
un libro di Hitchcock. In realtà mia madre<br />
diceva di essere stata lei a rovinare la<br />
carriera di papà. I film che hanno fatto<br />
11<br />
insieme all’epoca non avevano avuto<br />
grande successo, solo ora cominciano a<br />
essere rivalutati.<br />
Roberto Rossellini e la sua famiglia.<br />
- Pur abitando quasi tutti in posti<br />
diversi siamo molto in contatto. Siamo 6<br />
fratelli: Renzo, si occupa di cinema, Roberto<br />
è un pittore, mia sorella gemella<br />
insegna all’Università, Raffaella si è convertita<br />
all’Islam ed è sposata con un<br />
musulmano: Gill che è paraplegico. Ho<br />
adottato un figlio, Roberto, che è nero<br />
con gli occhi blu: mio padre sarebbe stato<br />
felicissimo di lui.<br />
È difficile dire cosa mio padre mi abbia<br />
insegnato, papà era unico. Anche<br />
quando ero in terapia mi chiedevano di<br />
raccontare il rapporto con mio padre ma<br />
io non potevo spiegarlo e dicevo che se<br />
avessero conosciuto Rossellini avrebbero<br />
avuto anche loro il complesso di Elettra.<br />
La cosa più sorprendente è stata<br />
imparare tutto ciò che mio papà non mi<br />
aveva insegnato: ad esempio, ho sposato<br />
Martin Scorsese e poi David Lynch<br />
ed entrambi parlavano continuamente di<br />
cinema. Io pensavo avessero sempre dei<br />
problemi di lavoro e invece ho scoperto<br />
che i cineasti parlano di cinema. Mio<br />
padre invece ne parlava raramente.<br />
Stromboli, terra di Dio. - L’ho scelta<br />
perchè è da lì che sono nata. Se non ci<br />
fosse stata Stromboli, terra di Dio non<br />
sarei mai venuta al mondo.<br />
Silvia Ivanova