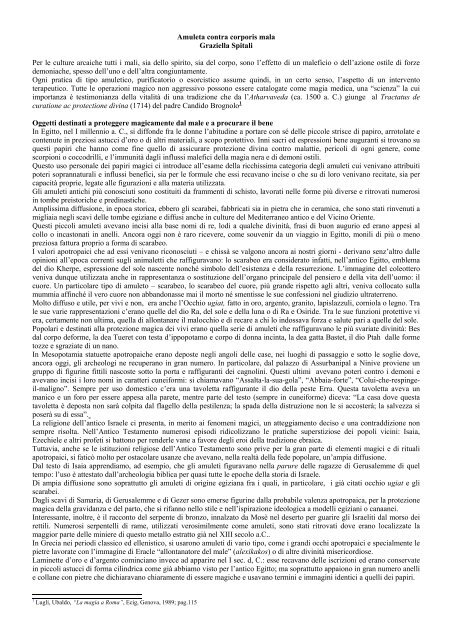Amuleta contra corporis mala Graziella Spitali Per le culture ...
Amuleta contra corporis mala Graziella Spitali Per le culture ...
Amuleta contra corporis mala Graziella Spitali Per le culture ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Amu<strong>le</strong>ta</strong> <strong>contra</strong> <strong>corporis</strong> <strong>mala</strong><br />
<strong>Graziella</strong> <strong>Spitali</strong><br />
<strong>Per</strong> <strong>le</strong> <strong>culture</strong> arcaiche tutti i mali, sia dello spirito, sia del corpo, sono l’effetto di un ma<strong>le</strong>ficio o dell’azione osti<strong>le</strong> di forze<br />
demoniache, spesso dell’uno e dell’altra congiuntamente.<br />
Ogni pratica di tipo amu<strong>le</strong>tico, purificatorio o esorcistico assume quindi, in un certo senso, l’aspetto di un intervento<br />
terapeutico. Tutte <strong>le</strong> operazioni magico non aggressivo possono essere catalogate come magia medica, una “scienza” la cui<br />
importanza è testimonianza della vitalità di una tradizione che da l’Atharvaveda (ca. 1500 a. C.) giunge al Tractatus de<br />
curatione ac protectione divina (1714) del padre Candido Brognolo 1<br />
Oggetti destinati a proteggere magicamente dal ma<strong>le</strong> e a procurare il bene<br />
In Egitto, nel I mil<strong>le</strong>nnio a. C., si diffonde fra <strong>le</strong> donne l’abitudine a portare con sé del<strong>le</strong> picco<strong>le</strong> strisce di papiro, arrotolate e<br />
contenute in preziosi astucci d’oro o di altri materiali, a scopo protettivo. Inni sacri ed espressioni bene auguranti si trovano su<br />
questi papiri che hanno come fine quello di assicurare protezione divina contro <strong>mala</strong>ttie, pericoli di ogni genere, come<br />
scorpioni o coccodrilli, e l’immunità dagli influssi ma<strong>le</strong>fici della magia nera e di demoni ostili.<br />
Questo uso persona<strong>le</strong> dei papiri magici ci introduce all’esame della ricchissima categoria degli amu<strong>le</strong>ti cui venivano attribuiti<br />
poteri soprannaturali e influssi benefici, sia per <strong>le</strong> formu<strong>le</strong> che essi recavano incise o che su di loro venivano recitate, sia per<br />
capacità proprie, <strong>le</strong>gate al<strong>le</strong> figurazioni e alla materia utilizzata.<br />
Gli amu<strong>le</strong>ti antichi più conosciuti sono costituiti da frammenti di schisto, lavorati nel<strong>le</strong> forme più diverse e ritrovati numerosi<br />
in tombe preistoriche e predinastiche.<br />
Amplissima diffusione, in epoca storica, ebbero gli scarabei, fabbricati sia in pietra che in ceramica, che sono stati rinvenuti a<br />
migliaia negli scavi del<strong>le</strong> tombe egiziane e diffusi anche in <strong>culture</strong> del Mediterraneo antico e del Vicino Oriente.<br />
Questi piccoli amu<strong>le</strong>ti avevano incisi alla base nomi di re, lodi a qualche divinità, frasi di buon augurio ed erano appesi al<br />
collo o incastonati in anelli. Ancora oggi non è raro ricevere, come souvenir da un viaggio in Egitto, monili di più o meno<br />
preziosa fattura proprio a forma di scarabeo.<br />
I valori apotropaici che ad essi venivano riconosciuti – e chissà se valgono ancora ai nostri giorni - derivano senz’altro dal<strong>le</strong><br />
opinioni all’epoca correnti sugli anima<strong>le</strong>tti che raffiguravano: lo scarabeo era considerato infatti, nell’antico Egitto, emb<strong>le</strong>ma<br />
del dio Kherpe, espressione del so<strong>le</strong> nascente nonché simbolo dell’esistenza e della resurrezione. L’immagine del co<strong>le</strong>ottero<br />
veniva dunque utilizzata anche in rappresentanza o sostituzione dell’organo principa<strong>le</strong> del pensiero e della vita dell’uomo: il<br />
cuore. Un particolare tipo di amu<strong>le</strong>to – scarabeo, lo scarabeo del cuore, più grande rispetto agli altri, veniva collocato sulla<br />
mummia affinché il vero cuore non abbandonasse mai il morto né smentisse <strong>le</strong> sue confessioni nel giudizio ultraterreno.<br />
Molto diffuso e uti<strong>le</strong>, per vivi e non, era anche l’Occhio ugiat, fatto in oro, argento, granito, lapislazzuli, corniola o <strong>le</strong>gno. Tra<br />
<strong>le</strong> sue varie rappresentazioni c’erano quel<strong>le</strong> del dio Ra, del so<strong>le</strong> e della luna o di Ra e Osiride. Tra <strong>le</strong> sue funzioni protettive vi<br />
era, certamente non ultima, quella di allontanare il malocchio e di recare a chi lo indossava forza e salute pari a quel<strong>le</strong> del so<strong>le</strong>.<br />
Popolari e destinati alla protezione magica dei vivi erano quella serie di amu<strong>le</strong>ti che raffiguravano <strong>le</strong> più svariate divinità: Bes<br />
dal corpo deforme, la dea Tueret con testa d’ippopotamo e corpo di donna incinta, la dea gatta Bastet, il dio Ptah dal<strong>le</strong> forme<br />
tozze e sgraziate di un nano.<br />
In Mesopotamia statuette apotropaiche erano deposte negli angoli del<strong>le</strong> case, nei luoghi di passaggio e sotto <strong>le</strong> soglie dove,<br />
ancora oggi, gli archeologi ne recuperano in gran numero. In particolare, dal palazzo di Assurbanipal a Ninive proviene un<br />
gruppo di figurine fittili nascoste sotto la porta e raffiguranti dei cagnolini. Questi ultimi avevano poteri contro i demoni e<br />
avevano incisi i loro nomi in caratteri cuneiformi: si chiamavano “Assalta-la-sua-gola”, “Abbaia-forte”, “Colui-che-respingeil-maligno”.<br />
Sempre per uso domestico c’era una tavo<strong>le</strong>tta raffigurante il dio della peste Erra. Questa tavo<strong>le</strong>tta aveva un<br />
manico e un foro per essere appesa alla parete, mentre parte del testo (sempre in cuneiforme) diceva: “La casa dove questa<br />
tavo<strong>le</strong>tta è deposta non sarà colpita dal flagello della pesti<strong>le</strong>nza; la spada della distruzione non <strong>le</strong> si accosterà; la salvezza si<br />
poserà su di essa”.<br />
La religione dell’antico Israe<strong>le</strong> ci presenta, in merito ai fenomeni magici, un atteggiamento deciso e una <strong>contra</strong>ddizione non<br />
sempre risolta. Nell’Antico Testamento numerosi episodi ridicolizzano <strong>le</strong> pratiche superstiziose dei popoli vicini: Isaia,<br />
Ezechie<strong>le</strong> e altri profeti si battono per render<strong>le</strong> vane a favore degli eroi della tradizione ebraica.<br />
Tuttavia, anche se <strong>le</strong> istituzioni religiose dell’Antico Testamento sono prive per la gran parte di e<strong>le</strong>menti magici e di rituali<br />
apotropaici, si faticò molto per ostacolare usanze che avevano, nella realtà della fede popolare, un’ampia diffusione.<br />
Dal testo di Isaia apprendiamo, ad esempio, che gli amu<strong>le</strong>ti figuravano nella parure del<strong>le</strong> ragazze di Gerusa<strong>le</strong>mme di quel<br />
tempo: l’uso è attestato dall’archeologia biblica per quasi tutte <strong>le</strong> epoche della storia di Israe<strong>le</strong>.<br />
Di ampia diffusione sono soprattutto gli amu<strong>le</strong>ti di origine egiziana fra i quali, in particolare, i già citati occhio ugiat e gli<br />
scarabei.<br />
Dagli scavi di Samaria, di Gerusa<strong>le</strong>mme e di Gezer sono emerse figurine dalla probabi<strong>le</strong> va<strong>le</strong>nza apotropaica, per la protezione<br />
magica della gravidanza e del parto, che si rifanno nello sti<strong>le</strong> e nell’ispirazione ideologica a modelli egiziani o canaanei.<br />
Interessante, inoltre, è il racconto del serpente di bronzo, innalzato da Mosè nel deserto per guarire gli Israeliti dal morso dei<br />
rettili. Numerosi serpentelli di rame, utilizzati verosimilmente come amu<strong>le</strong>ti, sono stati ritrovati dove erano localizzate la<br />
maggior parte del<strong>le</strong> miniere di questo metallo estratto già nel XIII secolo a.C..<br />
In Grecia nei periodi classico ed el<strong>le</strong>nistico, si usarono amu<strong>le</strong>ti di vario tipo, come i grandi occhi apotropaici e specialmente <strong>le</strong><br />
pietre lavorate con l’immagine di Erac<strong>le</strong> “allontanatore del ma<strong>le</strong>” (a<strong>le</strong>xikakos) o di altre divinità misericordiose.<br />
Laminette d’oro e d’argento cominciano invece ad apparire nel I sec. d, C.: esse recavano del<strong>le</strong> iscrizioni ed erano conservate<br />
in piccoli astucci di forma cilindrica come già abbiamo visto per l’antico Egitto; ma soprattutto appaiono in gran numero anelli<br />
e collane con pietre che dichiaravano chiaramente di essere magiche e usavano termini e immagini identici a quelli dei papiri.<br />
1 Lugli, Ubaldo, “La magia a Roma”, Ecig, Genova, 1989; pag.115
<strong>Per</strong> queste pietre in particolare è stata adottata la definizione di “gemme gnostiche”, con riferimento ad e<strong>le</strong>menti dottrinari<br />
dello gnosticismo, o quella più appropriata di “gemme di Abrasax”, dal termine più frequentemente inciso su tali pietre.<br />
La lingua del<strong>le</strong> iscrizioni era il greco, usato anche per trascrivere vocaboli di lingue semitiche o incomprensibili. Non è raro<br />
trovare incise sul<strong>le</strong> gemme formu<strong>le</strong> attestate dai papiri; e accade che un papiro descriva un’incisione che è poi giunta fino a<br />
noi.<br />
Un largo pubblico di utenti faceva uso di queste gemme. <strong>Per</strong> questo motivo esse erano realizzate in materia<strong>le</strong> semiprezioso o di<br />
uso comune (diaspro, ematite, perfino ciottoli) ed erano di manifattura non certo di lusso.<br />
La scelta doveva dunque avvenire sulla base di valutazioni che prescindevano dal valore vena<strong>le</strong> del<strong>le</strong> pietre e si riferivano<br />
piuttosto alla loro efficacia come talismani.<br />
Si conoscono in effetti gemme rivolte contro <strong>le</strong> emorragie, la febbre, la sciatica, il mal di reni, i dolori allo stomaco, l’aborto, i<br />
<strong>mala</strong>nni dell’utero e degli occhi; altre gemme recano incantesimi d’amore o esprimono professioni di fede, con acclamazioni<br />
ed epiteti divini; altre ancora si propongono come amu<strong>le</strong>ti contro mali invisibili ed esseri demoniaci.<br />
Spesso <strong>le</strong> gemme, come già i papiri, recavano iscrizioni parzialmente o totalmente incomprensibili, con <strong>le</strong>ttere isolate o in<br />
serie, combinazioni vocaliche, anagrammi e formu<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggibili nei due sensi, come, ad esempio thobarraboth<br />
(QOBARRABOQ) e, più di frequente ablanathanalba (ABLANAQANALBA).<br />
Altre volte, <strong>le</strong> virtù apotropaiche dell’amu<strong>le</strong>to sono <strong>le</strong>gate alla raffigurazione dell’oggetto da proteggere, dell’essere<br />
sovrumano da supplicare, degli eventi mitici da evocare all’occorrenza.<br />
Troviamo così amu<strong>le</strong>ti con la Gorgone decapitata contro la podagra, Ares guardiano contro i mali del fegato e dell’utero, lo<br />
scorpione contro il suo stesso ve<strong>le</strong>no, la lucertola per <strong>le</strong> affezioni degli occhi.<br />
Anche in campo <strong>le</strong>tterario abbiamo un esempio interessante. Nel II secolo d.C. circola, infatti, un trattato, il Ciranide, che<br />
consisterebbe di opere parte di Arpocrate di A<strong>le</strong>ssandria, lo scrittore di cose mediche e astrologiche, e parte di Cirano, re di<br />
<strong>Per</strong>sia 2 . Il corpo del trattato consiste di quattro libri che si occupano dei poteri magici e curativi di pietre, piante e animali,<br />
ordinati secondo <strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere dell’alfabeto greco. Il primo capitolo tra <strong>le</strong> altre voci annovera: ampelós (la vite), aquila (l’uccello),<br />
aetítis (“etite”, una pietra del colore dell’aquila) e aquila (“l’aquila di mare”, cioè la razza).<br />
Ciascun “e<strong>le</strong>mento” possiede meravigliose virtù che ingegnosamente li mettono in rapporto l’uno con l’altro: dalla vite si trae<br />
il vino e la sua radice cura l’epi<strong>le</strong>ssia e l’ubriachezza; la pietra trovata nella testa della razza previene l’ubriachezza, a<br />
prescindere dalla quantità di vino bevuto; disegnando la figura di un’aquila su un’etite e piazzando la pietra con una piuma<br />
dello stesso uccello presso la porta, questa impedirà a tutti i mali di entrare in casa. Secondo il Ciranide, ogni oggetto ed essere<br />
possiedono virtù magiche e perfino l’orso selvatico ha meravigliose proprietà: il suo teschio cura il mal di testa, l’occhio <strong>le</strong><br />
<strong>mala</strong>ttie dell’occhio umano, l’orecchio quel<strong>le</strong> dell’orecchio, mentre i suoi denti sono un amu<strong>le</strong>to che favorisce la dentizione<br />
nei bambini.<br />
Nel V secolo d. C. cominciano ad apparire in abbondanza gemme che si rifanno a modelli e concezioni giudaico cristiane:<br />
l’immagine del re Salomone, prototipo del Cristo, nel<strong>le</strong> vesti di un cavaliere che uccide con la lancia un demone femmini<strong>le</strong><br />
oppure associato al malocchio; il nome e la figura di Gesù Cristo sulla croce accanto a simboli e iscrizioni magiche; la<br />
Gorgone unita a un arcangelo o alla Madonna.<br />
Pensieri diffusi<br />
In un’aura cultura<strong>le</strong> dove la confusione tra natura<strong>le</strong> e soprannatura<strong>le</strong> era così marcata, i literati latini, che già provenivano da<br />
un ambiente in cui l’intrusione del soprannatura<strong>le</strong> nel quotidiano era riconosciuta, temuta, ricercata e istituzionalizzata,<br />
dispongono di scarsi strumenti critici per operare quella separazione che i magistri el<strong>le</strong>nistici ignoravano nel<strong>le</strong> loro opere. Nel<br />
momento in cui Roma diventa partecipe della cultura el<strong>le</strong>nistica vengono scoperte e sfruttate <strong>le</strong> “proprietà occulte” di alcune<br />
sostanze minerali, vegetali e animali.<br />
Quello di “proprietà occulta” si configura, d’altronde, come un concetto estremamente ambiguo, destinato ad ostacolare il<br />
progresso del<strong>le</strong> scienze sino al XVII sec..<br />
E’ notevo<strong>le</strong> che Ga<strong>le</strong>no, il grande medico vissuto alla corte di Marco Aurelio, pur respingendo energicamente qualsiasi pratica<br />
di tipo magico, abbia fede nel<strong>le</strong> “virtù occulte” di talune sostanze 3<br />
Se poi alcune eccezioni vi furono, quali il De medicina di Aulo Cornelio Celso, esse però rimasero voci clamantes in deserto e<br />
il conflitto epistemologico tra scienza e magia deve piuttosto essere ricercato in quei testi che furono opera di uomini più<br />
“aderenti” al loro tempo (aderenza che possiamo misurare dal successo di pubblico del<strong>le</strong> loro opere). Nessuna opera meglio<br />
della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio ci può fornire un compendio del pensiero e dell’atteggiamento romano di fronte<br />
alla natura e alla vita umana 4 .<br />
Con i trentasette libri che compongono la sua “enciclopedia” del sapere natura<strong>le</strong>, Plinio ci porge il più notevo<strong>le</strong> esempio di<br />
ec<strong>le</strong>ttismo romano. Da un punto di vista genera<strong>le</strong>, Plinio, preoccupato di raccogliere tutto lo scibi<strong>le</strong> del suo tempo sulla natura<br />
- sui minerali, sugli animali, sul<strong>le</strong> piante - non perse mai di vista l’uomo e <strong>le</strong> necessità contingenti.<br />
Plinio non era uno scienziato né un filosofo: anzi, dal punto di vista della storia cultura<strong>le</strong>, uno dei suoi pregi sta proprio nel<br />
metterci a disposizione schemi di pensiero pre-scientifici e di fornirci una rappresentazione del mondo antico dal punto di vista<br />
di una persona colta, non da quello di uno specialista o di un filosofo che debbono portare avanti e difendere la loro particolare<br />
concezione. Questo significa che la sua enciclopedia si può ritenere ragionevolmente rappresentativa della cultura romana<br />
dell’epoca: la presenza di e<strong>le</strong>menti non scientifici o folklorici, <strong>contra</strong>pposta alla sostanzia<strong>le</strong> correttezza del<strong>le</strong> altre<br />
2 Cfr. John Scarborough, “The Cyranides and Dioscorides: a possib<strong>le</strong> common source”, in I. Merkel e A. G. Debus (a cura di), Hermeticism and the<br />
Renaissance, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, pagg. 79-112.<br />
3 Lugli, U., op. cit., pag.68<br />
4 Cfr. Robert Lenob<strong>le</strong>, Storie dell’idea di natura, op. cit., pagg. 169-251; e Michel Beagon, Roman Nature,<br />
Cambridge University Press, Cambridge, 1992, passim.
informazioni, è indice non tanto dello scarso discernimento persona<strong>le</strong> di Plinio, quanto dell’assenza di un canone scientifico<br />
consolidato nel mondo cultura<strong>le</strong> romano (ed el<strong>le</strong>nistico).<br />
Non e’vero ma…Plinio ci crede!<br />
Abbiamo detto che gli amu<strong>le</strong>ti sono oggetti portati a scopi magici per proteggere il possessore contro i sorti<strong>le</strong>gi, il malocchio,<br />
la <strong>mala</strong>ttia o altro.<br />
Ma anche <strong>le</strong> case, <strong>le</strong> mura, <strong>le</strong> città venivano protette nello stesso modo: …dicono che la testa di lupo seccata neutralizza i<br />
ma<strong>le</strong>fici e per questo motivo la inchiodano al<strong>le</strong> porte del<strong>le</strong> case di campagna 5 o anche …che il fie<strong>le</strong> di cane maschio nero<br />
funge da amu<strong>le</strong>to, facendo con esso fumigazioni e purificazioni per tutta la casa, contro ogni ma<strong>le</strong>ficio, oppure il sangue di<br />
cane, cospargendone <strong>le</strong> pareti, e interrando il suo membro genita<strong>le</strong> sotto l’uscio di casa 6 .<br />
E infine si dice che i ma<strong>le</strong>fici non possano penetrare o almeno non possano nuocere se si applica una stella marina con<br />
sangue di volpe e la si appende allo stipite superiore o a un chiodo di bronzo della porta 7 .<br />
Abbiamo anche visto come si potessero usare per gli amu<strong>le</strong>ti i materiali più diversi, pietre, metalli, piante, animali, dal<br />
momento che si riteneva che tutte <strong>le</strong> sostanze possedessero qualche virtù magica.<br />
… Un ferro di cavallo, venuto via dallo zoccolo, come spesso capita, se lo si raccoglie e lo si conserva da qualche parte,<br />
farebbe passare il singhiozzo nel momento stesso in cui torna in mente dove l’abbiamo riposto 8 . Come è ben noto a tutti l’uso<br />
di conservare un ferro di cavallo nella propria casa come portafortuna è sopravvissuto fino ai giorni nostri.<br />
E’ interessante vedere la professione di fede negli amu<strong>le</strong>ti quando la <strong>mala</strong>ttia è ribel<strong>le</strong> al<strong>le</strong> cure della medicina ufficia<strong>le</strong>: nel<strong>le</strong><br />
febbri quartane la medicina clinica 9 non funziona quasi per nulla. <strong>Per</strong> questo indicheremo parecchi rimedi magici, e in primo<br />
luogo quelli che ordinano come amu<strong>le</strong>ti: la polvere in cui si sia rigirato uno sparviero, posta in un pannolino appeso con un<br />
filo rosso; il dente più lungo d’un cane nero. Chiamano pseudosphex la vespa che vola isolata; la catturano con la mano<br />
sinistra e la <strong>le</strong>gano sotto il collo, altri invece usano quella che in quell’anno è stata vista per prima 10 .<br />
Contro la congiuntivite affermano poi che chi porta una lingua di volpe in un braccia<strong>le</strong>tto non soffrirà mai di questa<br />
<strong>mala</strong>ttia 11 .<br />
Un’altra superstizione guaritoria è l’immagine di simpatia e antipatia del<strong>le</strong> forze attraverso il cosmo: stel<strong>le</strong>, terra, bestie, piante<br />
e minerali sono forze corrispondenti che si influenzano reciprocamente attraverso attrazione e repulsione 12 .<br />
… la pietra aetite che si trova nel nido dell’aquila protegge il feto da ogni pericolo d’aborto. Una penna d’avvoltoio messa<br />
sotto i piedi aiuta <strong>le</strong> partorienti 13 .<br />
…Stupefacente è anche ciò che si trova a proposito della torpedine: se viene catturata quando la luna è nella Bilancia e viene<br />
conservata all’aperto per tre giorni, ogni volta che si porta a una donna rende i parti facili. Si pensa che anche l’acu<strong>le</strong>o della<br />
pastinaca aiuti il parto, <strong>le</strong>gato come amu<strong>le</strong>to all’ombelico, purché sia stato tolto alla pastinaca viva e questa sia stata buttata<br />
in mare 14 .<br />
…la …lingua [ del cama<strong>le</strong>onte], portata addosso come amu<strong>le</strong>to, allontana i pericoli del parto […]. Il suo piede anteriore<br />
destro, <strong>le</strong>gato al braccio sinistro con pel<strong>le</strong> di iena, ha potere contro i furti ed i terrori notturni ... 15<br />
Riguardo a un piccolo pesciolino chiamato remora, fra i Greci alcuni riferiscono che usandolo come amu<strong>le</strong>to vengono<br />
trattenuti fino al compimento i feti che tendono a scivolare e a uscire … altri che, conservato nel sa<strong>le</strong> e portato addosso come<br />
amu<strong>le</strong>to, agevola il parto al<strong>le</strong> donne gravide e per questo viene chiamato, con altro nome, odinolytes 16 .<br />
Plinio afferma che simpatia e antipatia dominano la natura; dalla sua osservazione l’uomo può trovare, facilmente, la medicina<br />
adatta a ogni <strong>mala</strong>ttia.<br />
E sempre riguardo la possibilità di successo del<strong>le</strong> cure simpatiche, Plinio confida anche nella signatura rerum, cioè nei<br />
caratteri esterni – forma, colore, sapore – attraverso i quali piante, animali o altro richiamano l’attenzione dell’osservatore e lo<br />
orientano circa il loro uso terapeutico 17 .<br />
Una coppia di cimici attaccata come amu<strong>le</strong>to al braccio sinistro in un batuffolo di lana rubata a un pastore combatte la<br />
febbre notturna, ravvolta in un panno rosso vivo <strong>le</strong> febbri diurne 18 .<br />
E’ chiaro il riferimento al rossore che si manifesta durante gli attacchi febbrili.<br />
Ogni cattivo influsso del mestruo svanisce se <strong>le</strong> donne hanno con sé una triglia 19 . In questo caso il colore rosso della triglia ha<br />
un col<strong>le</strong>gamento con il rosso del sangue.<br />
<strong>Per</strong>no dell’azione magica dell’amu<strong>le</strong>to, restano i consueti principi logico-associativi, così: … una zampa di <strong>le</strong>pre strappata<br />
all’anima<strong>le</strong> vivo, se uno la porta sempre dietro, calma gli attacchi di gotta 20 . E l’uso si rifà, probabilmente, alla relazione tra<br />
la zampa di <strong>le</strong>pre, anima<strong>le</strong> che corre veloce, e la gotta che rende <strong>le</strong>nti ostacolando, per il forte dolore, la deambulazione.<br />
5 Plinio, Naturalis Historia, a cura di G.B. Conte, con la collaborazione di G. Ranucci, Einaudi, Torino 1982-<br />
1987 (i libri XXVIII-XXXII – medicina e farmacologia – sono a cura di U. Capitani, I.<br />
Garofalo); XXVIII,157<br />
6 Plinio, op. cit., XXX,82<br />
7 Plinio, op. cit., XXXII, 44.<br />
8 Plinio, op. cit., XXVIII, 263.<br />
9 Ars clinica dal greco téchne kliniké propriamente “arte di curare chi è degente a <strong>le</strong>tto”<br />
10 Plinio, op. cit., XXX,98.<br />
11 Plinio, op. cit., XXVIII, 172.<br />
12 Maria Cristina Martini, “Piante medicamentose e rituali magico- religiosi in Plinio”, Bulzoni Editore,Roma, 1977, pag. 154<br />
13 Plinio, op. cit., XXX, 130<br />
14 Plinio, op. cit., XXXII, 133<br />
15 Plinio, op. cit., XXVIII, 114-115<br />
16 Plinio, op. cit., XXXII, 6 ’WdinolúteV (che scioglie i dolori del parto)<br />
17 M. C. Martini, op. cit., pag. 155<br />
18 Plinio, op. cit., XXIX, 64<br />
19 Plinio, op. cit., XXVIII,80<br />
20 Plinio, op. cit., XXVIII,220
Erano poi ricercati i resti umani e tutto ciò che aveva avuto relazione con la morte ritenendo che per ta<strong>le</strong> motivo questi<br />
avessero acquisito speciali poteri, … nei casi di quartana, attaccano al collo del <strong>mala</strong>to il frammento di un chiodo tolto da<br />
una croce ravvolto nella lana, oppure una corda usata per una crocifissione, quindi, una volta sfebbrato il paziente,<br />
ripongono questi talismani in una caverna dove non penetri il so<strong>le</strong> 21 .<br />
…Alcuni raccomandano di esporre il dente <strong>mala</strong>to a suffumigi fatti con un dente di persona dello stesso sesso e di attaccare<br />
come amu<strong>le</strong>to un canino estratto a un morto non sepolto 22 .<br />
Si raccomandava poi che gli oggetti contaminati in cui era trasmigrato il demone della <strong>mala</strong>ttia dovessero essere fatti sparire<br />
dalla circolazione per evitare che contagiassero i sani.<br />
Qualsiasi azione si compiva su un oggetto materia<strong>le</strong>, avrebbe influenzato in ugua<strong>le</strong> misura la persona con cui l’oggetto era<br />
stato una volta in contatto, che esso formasse, o meno, parte integrante del suo corpo 23 :…perché una ferita non procuri<br />
dolore, che la persona porti attaccato, con un filo, un chiodo o un altro oggetto che abbia calpestato 24 . Similia similibus<br />
curantur: ovviamente il chiodo o l’oggetto calpestato è quello che ha causato la ferita. Quindi si parte dal presupposto che cose<br />
una volta congiunte lo resteranno per sempre, anche se separate l’una dall’altra, in un rapporto simpatico per cui ciò che viene<br />
fatto all’una si ripercuote analogamente sull’altra 25 . C’è poi la corrispondenza tra la parte o l’organo dell’anima<strong>le</strong> usati come<br />
vere e proprie medicine oppure come amu<strong>le</strong>ti, e la parte o l’organo del paziente su cui si intende intervenire terapeuticamente<br />
o di cui si cerca di stimolare o riattivare una funzione. …I denti della iena calmerebbero il ma<strong>le</strong> di denti per semplice contatto<br />
oppure attaccati come amu<strong>le</strong>to nell’ordine corrispondente 26 .<br />
Si favo<strong>le</strong>ggia che uno dei denti grossi di iena attaccato come amu<strong>le</strong>to con uno spago sia un rimedio contro gli incubi notturni<br />
e la paura degli spettri. […] La carne bianca del petto di iena e sette peli più un pene di cervo, attaccati alla donna come<br />
amu<strong>le</strong>to nella pel<strong>le</strong> di una gazzella portati appesi al collo, sono un antiabortivo garantito 27 .<br />
Alla base di questa medicina molto diffusa presso gli antichi sta la convinzione che la creatura sana possa trasmettere intatte<br />
certe sue proprietà a un organismo <strong>mala</strong>to, ristabi<strong>le</strong>ndo così un equilibrio natura<strong>le</strong>: … il primo dente caduto a un fanciullo,<br />
purché non tocchi terra [secondo il pensiero degli antichi il contatto con la terra, qua<strong>le</strong> sede di divinità ctonie, avverse ai<br />
viventi, poteva infirmare la riuscita di una terapia], incastonato in un braccia<strong>le</strong>tto e portato senza mai toglierlo al braccio<br />
preserva dai dolori dell’ utero 28 .<br />
… il dolor di denti si guarisce portando addosso come amu<strong>le</strong>to un dente strappato a una talpa viva. 29<br />
Considerazioni conclusive?<br />
“La Naturalis Historia è un autentico bacino di raccolta e di distribuzione del materia<strong>le</strong> attinente al folklore, al<strong>le</strong> credenze<br />
popolari, stratificatosi nel mondo antico attraverso i secoli, materia<strong>le</strong> talmente vasto che il <strong>le</strong>ttore ha soltanto l’imbarazzo della<br />
scelta nell’individuare gli e<strong>le</strong>menti di ricerca più interessanti”.(Capitani) 30<br />
Fonte preziosa l’opera di Plinio che offre, senza dubbio, un’analisi dettagliata del rapporto che nell’antica Roma esisteva tra<br />
medicina e magia permettendoci di approfondire la conoscenza della cultura di un mondo sospeso tra medicina e magia.<br />
L’incertezza tra soluzioni <strong>le</strong>gate a metodi scientifici o alla magia è stata, comunque, tramandata dal mondo antico sino a noi.<br />
Con essa, però, un postulato fondamenta<strong>le</strong> per l’uomo: quello di poter esprimere, in ogni momento ed in ogni circostanza, una<br />
scelta – si chiami essa scienza o magia – per ciò che più appaga la nostra mente.<br />
Bibliografia<br />
1. U. Capitani, “Celso, Scribonio Largo, Plinio il Vecchio e il loro atteggiamento nei confronti della medicina popolare”, in<br />
“Maia”, XXIV, 1972<br />
2. De Martino, Ernesto,”Il mondo magico. Pro<strong>le</strong>gomeni a una storia del magismo”, Boringhieri, Torino, 1973<br />
3. De Martino, Ernesto, “Magia e civiltà”, Garzanti, Milano 1962<br />
4. Frazer, James George, “Il ramo d’oro”, Newton & Compton editori, Roma 1999<br />
5. Robert Lenob<strong>le</strong>, Storie dell’idea di natura, op. cit., pagg. 169-251; e Michel Beagon, Roman Nature, Cambridge<br />
University Press, Cambridge, 1992<br />
6. Lugli, Ubaldo, “La magia a Roma”, Ecig, Genova, 1989<br />
7. Martini, Maria Cristina, “Piante medicamentose e rituali magico- religiosi in Plinio”, Bulzoni Editore, Roma, 1977<br />
8. Mauss, Marcel, “Teoria genera<strong>le</strong> della magia e altri saggi”, Einaudi, Torino 1970<br />
9. Plinio, Naturalis Historia, a cura di G.B. Conte, con la collaborazione di G. Ranucci,<br />
10. Einaudi, Torino 1982-1987 (i libri XXVIII-XXXII – medicina e farmacologia – sono a cura di U. Capitani, I. Garofalo);<br />
XXVIII, 157<br />
11. John Scarborough, “The Cyranides and Dioscorides: a possib<strong>le</strong> common source”, in I. Merkel e A.G. Debus (a cura di),<br />
Hermeticism and the Renaissance, Cambridge University Press, Cambridge,1988<br />
12. Xella, Paolo, “Magia. Studi di storia del<strong>le</strong> religioni in memoria di Raffaella Garosi”, Bulzoni, Roma 1976<br />
21 Plinio, op. cit., XXVIII, 46<br />
22 Plinio, op. cit., XXVIII, 45<br />
23 Frazer, James George, “Il ramo d’oro”, Newton & Compton editori, Roma 1999; pag. 22<br />
24 Plinio, op. cit., XXVIII,48<br />
25 Frazer, J. G. op. cit., pag. 60.<br />
<strong>Per</strong> il concetto di antipatia e simpatia “del<strong>le</strong> forze costitutive di tutti gli e<strong>le</strong>menti”, di derivazione a<strong>le</strong>ssandrina, cfr. Plinio, op. cit., XX, 1-2; XXIV, 1; XXVIII,<br />
84; XXXVII, 59<br />
26 Plinio, op. cit., XXVIII,95<br />
27 Plinio, op. cit., XXVIII, 98<br />
28 Plinio, op. cit., XXVIII, 41<br />
29 Plinio, op. cit., XXX, 20<br />
30 U. Capitani, “Celso, Scribonio Largo, Plinio il Vecchio e il loro atteggiamento nei confronti della medicina popolare”, in “Maia”, XXIV, 1972, pgg. 133-<br />
135.