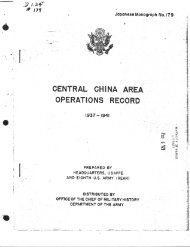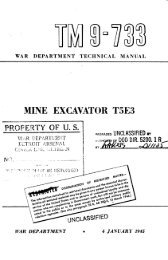364 Italian Bookshelf - Ibiblio
364 Italian Bookshelf - Ibiblio
364 Italian Bookshelf - Ibiblio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
“<strong>Italian</strong> <strong>Bookshelf</strong>” Annali d’ italianistica 24 (2006) 375<br />
María Hernández Esteban, ed. Cuadernos de filología italiana. El Canzoniere de<br />
Petrarca en Europa: ediciones, comentarios, traducciones y proyeción. Madrid:<br />
Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, 2005. Pp. 288.<br />
Il presente volume è il frutto del seminario tenutosi presso l’Università Complutense di<br />
Madrid nel Novembre 2004. Concepito con l’obiettivo di esplorare in modo panoramico,<br />
anche se non sempre specialistico, il fenomeno della diffusione del Canzoniere in Europa<br />
dal Quattrocento fino ai giorni nostri, il testo si divide in cinque sezioni (“El texto”,<br />
“Manuscritos, ediciones y comentarios”, “Las traducciones peninsulares”, “La<br />
proyección europea” e “La proyección hispánica”) finalizzate a mettere in luce il<br />
processo che ha consentito all’opera del Petrarca di diventare il punto di riferimento per<br />
la lirica europea moderna.<br />
La prima sezione, costituita dai saggi di Marco Santagata e di María José Rodrigo,<br />
rispettivamente riguardanti la dimensione interiore della poesia del Petrarca ed il registro<br />
stilistico delle rime politiche, non hanno in realtà diretta attinenza con la diffusione e<br />
ricezione dell’opera del Petrarca in Europa. Ciononostante, entrambi questi studi riescono<br />
a mettere in luce uno degli elementi che, come sottolinea Rodrigo (36), hanno contributo<br />
all’enorme successo europeo del Canzoniere: il ricorso ad uno stile “commuovente”, sia<br />
l’oggetto del componimento il disagio esistenziale del poeta oppure le sue posizioni<br />
politiche.<br />
La sezione seguente del volume si addentra nell’ambito delle innovazioni che le<br />
varie redazioni rinascimentali hanno apportato alla versione originale dei RVF, un<br />
aspetto, questo, a cui generalmente non viene prestata particolare attenzione dalla critica.<br />
Da esperta, Lucia Battaglia analizza il significato degli elementi iconografici introdotti<br />
all’interno delle versioni manoscritte ed a stampa del Canzoniere, mentre il contributo di<br />
Marco Santoro descrive il processo che ha condotto gli stampatori del Quattrocento e<br />
Cinquecento ad ampliare, con frontespizi, dediche, vite e commentari, il testo originale<br />
del Petrarca. Questa sezione si chiude con l’attento studio condotto da María Hernández<br />
Esteban e da Mercedez López Suárez sulle modifiche apportate all’ordine originale delle<br />
rime all’interno dei commentari, dei manoscritti e delle edizioni a stampa presenti in<br />
Spagna nel corso del Cinquecento. Nel quadro relativo alle varie modifiche subite dal<br />
testo originale del Petrarca, è tuttavia da rilevare l’assenza di qualsiasi menzione alle<br />
frequenti erronee esegesi fornite da alcuni commentatori rinascimentali che per molto<br />
tempo hanno portato a fraintendere il significato originario di alcune rime.<br />
La terza sezione si presenta come una sorta di excursus sulle traduzioni del<br />
Canzoniere realizzate in lingua castigliana, catalana e galiziana. Joaquín Rubio analizza<br />
la prima traduzione spagnola di una rima del Petrarca per poi riflettere, più in generale,<br />
sul valore della traduzione in quanto nuovo testo in grado di veicolare propri contenuti e<br />
forme. Questo contributo introduce il concetto di Petrarchismo come fenomeno di<br />
rielaborazione dell’originale italiano in relazione al contesto culturale, in questo caso più<br />
specificatamente quello spagnolo, in cui la traduzione viene recepita. Jordi Canals prende<br />
infatti in considerazione la prima versione castigliana completa del Canzoniere ad opera<br />
di Enrique Garcés (1591) e mette in evidenza come, a differenza di quella precedente di<br />
Salomón Usque (1567), questa traduzione abbia in molti casi alterato il senso originario<br />
del testo italiano. E Aviva Garribba giustifica questa caratteristica con il costante<br />
tentativo effettuato da Garcés di riprodurre in lingua castigliana lo schema metrico<br />
adottato dal Petrarca. Come spiega Manuel Carrera, è in realtà solo con l’edizione di<br />
Cortines del 1989 che si riesce davvero a raggiungere, con accurati accorgimenti