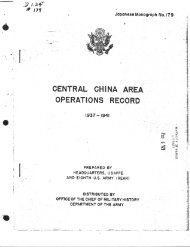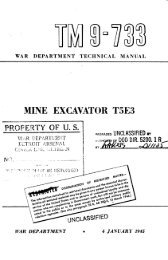364 Italian Bookshelf - Ibiblio
364 Italian Bookshelf - Ibiblio
364 Italian Bookshelf - Ibiblio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
“<strong>Italian</strong> <strong>Bookshelf</strong>” Annali d’ italianistica 24 (2006) 395<br />
stage irony in all Renaissance works discussed, even where the writings discussed are not<br />
plays. In the sixteenth century, era of rebirth for classical theater, consciousness of the<br />
“third wall,” of necessity, informed authors, allowing complicity through winks and nods<br />
to the audience from narrator(s), and shared humor on a wide range of subjects. At the<br />
end of the volume, there is a sense of twinned performance by the authors examined and<br />
the critics examining (who demonstrate the extent of their reading). Ferrara was at the<br />
center of the rebirth of classical theater, and played an essential role in its spread, so the<br />
theatricality – and humor – of Ferrarese rulers’ portraits is a perfect touchstone. Servants,<br />
non-courtly characters, and other marginal figures as objects of fun are nothing new;<br />
neither are substandard or scatological language and double entendres. But choices and<br />
acceptability of each object of ridicule vary according to the political context. The<br />
volume is itself ironic about humor but with an unfunny, pessimistic view of social and<br />
cultural trends in the Reformation-era <strong>Italian</strong> peninsula, perhaps inevitable when<br />
examining authors whose livelihood lay in political careers with individual princes. These<br />
readings merit examination, and their subjects deserve further juxtaposed close studies.<br />
Leslie Zarker Morgan, Loyola College in Maryland<br />
Luciano Bottoni. La messinscena del Rinascimento. I. Calandra, una commedia per il<br />
papato. Critica letteraria e linguistica. Milano: Franco Angeli, 2005. Pp. 119.<br />
In uno studio che dimostra le sue profonde conoscenze della letteratura e della cultura<br />
cortese dell’inizio del Cinquecento, Luciano Bottoni propone una stimolante rilettura in<br />
chiave di messinscena (termine privilegiato sin dal titolo della monografia) di alcuni testi<br />
teatrali chiave dei primi trent’anni del sedicesimo secolo. Bottoni utilizza un approccio<br />
ancora piuttosto inusitato nel campo dell’italianistica, ma già affermato nell’ambito<br />
dell’anglistica (ad esempio per lo studio del teatro inglese di Shakespeare e autori coevi):<br />
l’attenzione alla “specificità ‘istrionica’ [del testo] fatta di impliciti riferimenti tonali,<br />
mimici, iconici, ritmico-gestuali” (8). Benché quindi in questo senso questa monografia<br />
non rappresenti una novità assoluta in termini intellettuali, ha il merito di allargare il<br />
campo di questo assunto critico ad un ambito tanto vasto quanto cruciale, quello che<br />
Bottoni chiama l’“atto di nascita della commedia cinquecentesca” in Italia (7).<br />
Bottoni integra questo approccio con l’ormai altrettanto canonico self-fashioning di<br />
Stephen Greenblatt e del new historicism; in questo senso il titolo di questa monografia è<br />
particolarmente pregnante, in quanto le “messinscene” di cui Bottoni si occupa sono sia<br />
quelle propriamente teatrali che quelle dei cortigiani sul palcoscenico metaforico dei<br />
rapporti di potere a corte. La forza di questo studio scaturisce proprio dalla convergenza<br />
tra close reading (di testi teatrali ed altri documenti coevi, letterari e no) e attenzione per<br />
le messe in scena dei testi teatrali in questione.<br />
Lo studio si articola in sei capitoli ed un epilogo. Il primo, “La tecnica teatrale<br />
dell’Ariosto. Un preambolo discorsivo”, identifica nella Cassaria (1508) e nei Suppositi<br />
(1509) il nodo dell’emergere della commedia in vernacolo verso la fine del primo<br />
decennio del Cinquecento: i testi ariosteschi arrivano a “costruire una ‘fabula’ in volgare<br />
istituendo con i testi plautino-terenziani un rapporto di imitazione innovativo” (10).<br />
Bottoni legge entrambi testi con vasta sensibilità per le loro valenze fisiche e deittiche,<br />
concludendo che “l’Ariosto istituisce il genere commedia proprio nell’invenzione e nella<br />
pratica ludica di un linguaggio istrionico, fatto di ‘giochi,’ di parole e situazioni cariche