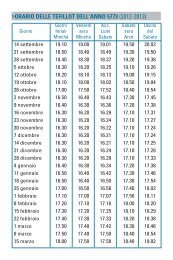PE 042011_Layout 1 - Unione delle comunità ebraiche italiane
PE 042011_Layout 1 - Unione delle comunità ebraiche italiane
PE 042011_Layout 1 - Unione delle comunità ebraiche italiane
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P6 POLITICA / SOCIETÀ<br />
ú–– Guido Vitale<br />
Si parla d’Italia, si parla di noi,<br />
mentre i tricolori tentano a Torino<br />
l’annuncio di una nuova<br />
primavera. Ai tavolini dello storico<br />
Caffè Elena, sotto i portici di una<br />
piazza Vittorio alla vigilia dell’apertura<br />
<strong>delle</strong> celebrazioni per i 150 anni<br />
dell’Unità nazionale, anche Elizabeth<br />
Schächter è venuta a godersi la festa.<br />
Vicende d’Italia e destini degli ebrei<br />
italiani una volta di più indissolubilmente<br />
intrecciati. La studiosa riproduce<br />
quel mix prodigioso di ingredienti<br />
britannici e mitteleuropei che<br />
con le grandi migrazioni <strong>ebraiche</strong> del<br />
‘900 ha segnato la storia di ebrei con<br />
un biglietto di sola andata da Vienna<br />
a Londra, come Karl Popper ed Elias<br />
Canetti. In un caleidoscopio<br />
costellato dai riflessi <strong>delle</strong><br />
coccarde <strong>italiane</strong><br />
che ornano ogni<br />
vetrina di Torino,<br />
girano le identità<br />
d’Europa: la sua<br />
discendenza dal compositore Gustav<br />
Mahler, i quattro nonni viennesi, i<br />
genitori in fuga dopo l’Anchluss, la<br />
cattedra in Inghilterra, la fama di italianista<br />
alla School of European Culture<br />
dell’Università del Kent. E sono<br />
immancabilmente le vicende <strong>ebraiche</strong><br />
a legare gli elementi disparati, oggi<br />
in particolare l’originalità degli ebrei<br />
italiani a costituire una possibile chiave<br />
di lettura. Il suo nuovo libro di<br />
storia (The Jews of Italy, Between<br />
Tradition and Transformation. 1848-<br />
1945) è fresco di stampa. Sulla copertina<br />
un momento di serenità nei<br />
giardini di Firenze: rav Samuel<br />
Hirsch Margulies con la moglie Recha<br />
e la nipote Regina accoglie Carlo<br />
Alberto Viterbo con la moglie Nella.<br />
Il suo studio apre un fronte difficile<br />
e offre la possibilità di rileggere la<br />
storia degli ebrei italiani in un modo<br />
nuovo, in Italia ancora largamente<br />
inesplorato perchè riprende opere e<br />
vicende di tutti i grandi dell’ebraismo<br />
italiano in una luce inedita.<br />
Perché l’Italia, professoressa Schächter,<br />
perché gli ebrei italiani?<br />
Le vicende degli ebrei italiani sono<br />
molto importanti per comprendere<br />
l’Europa e per comprendere l’Italia.<br />
Al di là <strong>delle</strong> apparenze, sono poco<br />
esplorate dal mondo accademico internazionale.<br />
E al di là della retorica<br />
<strong>delle</strong> celebrazioni del momento sono<br />
poco comprese. L’altissima lezione<br />
tenuta dalla storica Anna Foa al recente<br />
Congresso dell’<strong>Unione</strong> <strong>delle</strong><br />
Comunità Ebraiche Italiane credo<br />
abbia contribuito ad aumentare un<br />
poco la coscienza di quanto gli ebrei<br />
italiani abbiano dato per la costruzione<br />
dell’Unità nazionale. Non si<br />
tratta solo di celebrare i nomi noti<br />
degli italiani ebrei che all’apertura dei<br />
ghetti coraggiosamente combatterono<br />
e si fecero valere in tutti i campi<br />
della scienza, <strong>delle</strong> arti, della politica.<br />
Si tratta di scoprire una difficile identità<br />
comune, una storia che appartiene<br />
a tutti noi.<br />
Molti storici hanno affermato che<br />
proprio nel delicatissimo periodo preso<br />
in considerazione dal suo libro, dalla<br />
concessione <strong>delle</strong> libertà civili al<br />
La cosa più utile che si vorrebbe<br />
suggerire – ma nessuno l’ha fatto, -<br />
nelle ore in cui si festeggiano i 150<br />
anni dell’Unità d’Italia è di riprendere<br />
in mano e rileggere, nelle piazze<br />
e nelle aule, la Storia d’Italia dal<br />
1870 al 1915 di Benedetto Croce,<br />
scritta, giova ricordarlo, proprio<br />
mentre l’Italia precipitava nel baratro<br />
del regime di Mussolini. Viene<br />
una gran voglia di riprendere in<br />
mano questo capolavoro che per<br />
molti ebrei antifascisti è stato una<br />
sorta di laica Scrittura, proprio nelle<br />
ore, nient’affatto festose, in cui,<br />
con operazione vergognosa, prima<br />
in televisione ora in un best seller,<br />
Roberto Saviano ha accostato il nome<br />
del filosofo napoletano, e la tragedia<br />
della sua famiglia scomparsa<br />
per il terremoto, ai turpi costruttori<br />
della Casa dello studente dell’Aquila.<br />
L’arco cronologico ricostruito in<br />
quel mirabile affresco crociano è<br />
praticamente lo stesso che Elizabeth<br />
Schchter ha scelto per la sua ricerca.<br />
Nella sua Storia d’Italia Croce<br />
scrive: “Gli israeliti, che, in particolare<br />
nel Veneto, dove si trovavano<br />
in maggior numero, avevano da-<br />
Primo conflitto mondiale, non è possibile<br />
parlare di una storia nazionale<br />
degli ebrei italiani.<br />
È vero. In particolare Gadi Luzzatto<br />
Voghera afferma che non è possibile<br />
scrivere una storia dell’emancipazione<br />
ebraica in Italia nel quadro di un’esperienza<br />
comune a tutti gli ebrei. La<br />
ben nota frammentazione politica<br />
economica e giuridica non lo consentirebbe.<br />
La storiografia italiana<br />
mette in luce la natura eterogenea<br />
dell’ebraismo italiano e la miriade di<br />
modalità che contrassegnarono la sua<br />
conquista dei diritti civili. Tali differenze<br />
sono innegabili e ben visibili<br />
to mano all’opera del Risorgimento,<br />
non risparmiando fatiche e sacrifici,<br />
e che il Cavour aveva guardati<br />
d’assai buon occhio, prendevano<br />
parte alla vita degli affari e a quella<br />
pubblica, e altresì a quella scientifica”.<br />
Con quel gusto crociano per<br />
l’aneddoto storico, si ricordava<br />
l’esperienza fatta da Bertrando<br />
Spaventa “nel trattare per la prima<br />
www.moked.it<br />
ancora oggi.<br />
Ma resta aperto<br />
il problema<br />
di comprendere lo sforzo degli ebrei<br />
italiani di costruire un’identità comune,<br />
di bilanciare l’esigenza di autonomia<br />
locale e di identità nazionale, di<br />
accordare la propria riflessione con<br />
il processo di costruzione dell’identità<br />
nazionale. Ho tentato di lavorare in<br />
questa prospettiva.<br />
Dal suo lavoro emerge una visione<br />
nuova dell’ebraismo italiano. Non più<br />
una costellazione di realtà inguaribilmente<br />
malate di campanilismo e di<br />
volta, quando fu ministro dei lavori<br />
pubblici, con finanzieri ebrei; e stupito<br />
notava che solo israeliti come il<br />
suo amico Luzzatti potevano sentire<br />
il pathos e cantare la lirica della<br />
moneta”.<br />
L’intento di questo libro inglese<br />
non è di presentare un’indagine<br />
cronologica dello sviluppo storico e<br />
politico degli Ebrei in Italia, ma di<br />
n. 4 | aprile 2011 pagine <strong>ebraiche</strong><br />
Costruendo l’Italia unita<br />
vollero anche un ebraismo italiano<br />
La sfida dei nostri padri, racconta Elizabeth Schächter, fu quella di dare vita a un’identità ebraica di respiro nazionale<br />
Docente di letteratura comparata all’University of Kent di<br />
Canterbury, Elisabeth Schachter si occupa ormai da anni della realtà<br />
italiana. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni su Montale,<br />
Moravia, Pirandello e Verga, si è dedicata in modo particolare allo<br />
studio <strong>delle</strong> opere di Italo Svevo esplorando soprattutto il suo<br />
debito con la cultura psicanalitica. Il suo ultimo lavoro, dedicato agli<br />
ebrei italiani tra il 1848 e il 1915, affronta il tema dell’integrazione<br />
sotto molteplici aspetti senza mai trascurare il tema sociale.<br />
ú– L’ANALISI<br />
Dalla partecipazione all’assimilazione<br />
GIORGIO ALBERTINI<br />
GIORGIO ALBERTINI<br />
provincialismo, ma una minoranza,<br />
la maggiore minoranza presente<br />
allora sul territorio italiano,<br />
decisa a unirsi per prendere coraggiosamente<br />
in mano il proprio<br />
destino.<br />
È quello che ho tentato di documentare.<br />
Gli ebrei italiani<br />
sono sempre stati molto gelosi<br />
della propria identità<br />
comunale, ma quando ci<br />
fu da costruire l’Italia non<br />
si tirarono indietro. Furono<br />
protagonisti ed eroi,<br />
non solo perché combatterono,<br />
costruirono, studiarono<br />
e si affermarono nelle arti, ma<br />
anche perché intrapresero un difficile<br />
lavoro di coesione interna al mondo<br />
ebraico.<br />
Il suo è un testo accademico meticolosamente<br />
annotato e dotato di una<br />
bibliografia poderosa, in cui il rigore<br />
scientifico dell’indagine storica non<br />
spegne l’emozione della grande avventura.<br />
Come nelle pagine che raccontano<br />
del primo incontro fra le Comunità<br />
<strong>ebraiche</strong> <strong>italiane</strong>.<br />
esaminare la maniera in cui essi<br />
percepirono la loro integrazione -<br />
intendendo con integrazione l’entrata<br />
da pari in una società che prima<br />
li escludeva - e la loro risposta<br />
ai cambiamenti che l’integrazione<br />
comportò – così come vengono descritti<br />
nelle loro memorie, nei carteggi<br />
e nei discorsi rabbinici.<br />
Il periodo studiato inizia nel 1848,<br />
con il ritorno degli Ebrei nella<br />
storia italiana. In Italia, scrive<br />
l’autrice, “le premesse che portarono<br />
all’emancipazione degli<br />
Ebrei non erano infatti differenti<br />
da quelle del resto dell’Europa occidentale:<br />
la cittadinanza aveva<br />
un certo prezzo. Le richieste e le<br />
aspettative nei confronti degli<br />
Ebrei erano alte e includevano la<br />
rinuncia a ogni altra identità nazionale,<br />
a ogni tratto distintivo.<br />
Inoltre, l’emancipazione era un<br />
aspetto intrinseco agli stati-nazione<br />
emergenti come la Germania e<br />
l’Italia: la loro creazione e stabilità<br />
necessitavano integrazione e<br />
uniformità. La costruzione di<br />
un’identità nazionale si basava<br />
sull’inclusione del simile e