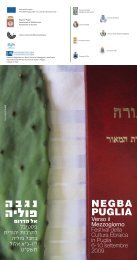Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P32<br />
CULTURA / ARTE / SPETTACOLO<br />
n. 10 | ottobre <strong>2011</strong> pagine ebraiche<br />
ú– SOCIETÀ<br />
uLa condizione della donna è uno dei temi centrali che percorrono l’ebraismo, a partire dalla Genesi e dal racconto della creazione. Ma in<br />
che modo si riflette negli assetti sociali? Sono alcuni interrogativi cui cerca risposta Haim Fabrizio Cipriani, rabbino della sinagoga riformata<br />
milanese Lev Chadash, nel libro Ascolta la sua voce-La donna nella legge ebraica (Giuntina, 186 pp.). Tre donne lo hanno letto e lo<br />
commentano. Un autorevole rabbino che si riconosce nella tradizione italiana traccia un percorso di lettura e di approfondimento.<br />
Donne e pregiudizio, dibattito aperto<br />
(…) Il racconto della creazione è importante perché<br />
molti dei pregiudizi che riguardano la donna<br />
hanno avuto origine proprio da esso o, meglio, da<br />
alcune sue interpretazioni. Abbiamo avuto già modo<br />
di citare Paolo di Tarso, il quale fonda la condizione<br />
d’inferiorità della donna rispetto all’uomo su<br />
questi due punti: “In effetti fu Adàm a essere creato<br />
per primo, ed Eva in seguito”. E ancora: “Non è<br />
l’uomo in effetti che è stato tratto dalla donna, ma<br />
la donna dall’uomo; e, naturalmente, non è l’uomo<br />
a essere stato creato per la donna, ma la donna per<br />
l’uomo”. La lettura di Paolo è chiara: Dio crea un<br />
essere di sesso maschile, e solo in un secondo momento<br />
completa la sua opera creando la donna, la<br />
quale ha come unico scopo quello di servire l’uomo,<br />
che conserva rispetto a essa una certa preminenza.<br />
In realtà, si tratta di una lettura non molto accurata.<br />
Nel Talmud troviamo, infatti, il passo seguente:<br />
“Rabbi Yirmià ben Elazàr insegna: il primo<br />
uomo fu creato con un doppio volto, come è<br />
detto: “Mi formasti dietro e davanti”». Questa interpretazione<br />
suggerisce che l’uomo sia stato creato<br />
come essere androgino, e che solamente in un<br />
secondo tempo sia avvenuta una separazione. In<br />
origine, non è un maschio a essere creato, ma un<br />
adàm, ossia un essere umano tratto dalla terra,<br />
adamà. Il progetto iniziale, quindi, contrariamente<br />
all’interpretazione di Paolo<br />
di Tarso, si basa sull’armonia perfetta e<br />
priva di gerarchie tra il femminile e il<br />
maschile.<br />
Il risultato è una creatura completa, che<br />
racchiude in se stessa la totalità dell’essere,<br />
ma proprio per questo condannata<br />
alla solitudine, senza un altro da sé con<br />
cui confrontarsi. Dio decide, quindi, di<br />
separare il lato femminile da quello maschile.<br />
Ma c’è dell’altro. Come nota Rashi, soltanto<br />
Dio può essere solo, senza bisogno di complementarità<br />
o di confronto. Creare l’essere umano con<br />
queste stesse caratteristiche avrebbe significato attribuirgli<br />
una dimensione propria del divino, con<br />
tutti gli eccessi e le distorsioni che questo avrebbe<br />
comportato. Va detto, però, che anticamente i rabbini<br />
erano divisi riguardo alla creazione di questo<br />
essere androgino. La Ghemarà riporta una discussione<br />
a proposito delle benedizioni da<br />
recitare durante il matrimonio, e sostiene,<br />
alla fine, che Dio avrebbe desiderato<br />
creare un essere di questo genere, ma di<br />
fatto realizzò un maschio, dal quale solamente<br />
in seguito trasse una femmina.<br />
Uno spunto anch’esso interessante,<br />
quello di uno scarto tra la volontà divina<br />
e la sua realizzazione, che fa eco ad altri<br />
midrashim. La creazione della donna<br />
sembra essere motivata, secondo la Tora,<br />
dalla necessita di un “aiuto davanti all’uomo”. Secondo<br />
la lettura che Paolo di Tarso dà di questo<br />
passo, l’espressione starebbe a indicare un tipo di<br />
rapporto come quello esistente tra un servitore e il<br />
suo padrone. Il testo, però, non parla di un aiuto<br />
per l’uomo, bensì di un aiuto davanti all’uomo. Il<br />
termine ézer kenegdò non implica, infatti, nessuna<br />
funzione subordinata. Stare “davanti a qualcosa”,<br />
néghed, in ebraico antico non significa trovarsi in<br />
una posizione inferiore, ma essere sullo stesso piano,<br />
avere lo stesso valore, come nel seguente e noto<br />
passo talmudico: “E lo studio della Tora vale<br />
quanto tutte [le altre mitzvot]”, talmud Torà kenéghed<br />
kullàm. Del resto, nemmeno il sostantivo<br />
ézer, aiuto, ha una connotazione servile. Al contrario,<br />
l’uso che se ne fa nei salmi, in cui si chiede<br />
a Dio stesso di essere il nostro “aiuto”, sembrerebbe<br />
suggerire una condizione di superiorità da parte<br />
di colui che aiuta l’altro. Eventualmente e colui<br />
che e bisognoso di aiuto ad essere in condizione di<br />
inferiorità. (…)<br />
(tratto da Haim Fabrizio Cipriani “Ascolta la Sua Voce<br />
– La donna nella legge ebraica” Giuntina editore)<br />
Lungo la via per diventare eguali<br />
ú––Anna Segre<br />
docente<br />
Un libro sull’uguaglianza delle donne<br />
scritto da un uomo (e, come il titolo<br />
porta a pensare, per gli uomini) potrebbe<br />
suscitare inizialmente qualche<br />
diffidenza. In effetti il testo ha il rispetto<br />
e la delicatezza tipici di chi invita<br />
a non discriminare una categoria di<br />
persone a cui non appartiene; forse<br />
un’autrice donna sarebbe stata più autoironica,<br />
e magari avrebbe messo<br />
maggiormente in luce le responsabilità<br />
delle donne stesse. D’altra parte il testo<br />
mi ha incuriosita fin dall’inizio, per<br />
l’importanza dell’argomento trattato<br />
e per l’autore, di cui ho già avuto occasione<br />
di leggere i commenti alla parashah<br />
settimanale diffusi attraverso<br />
la newsletter di Lev Chadash, che trovo<br />
sempre interessanti, con osservazioni<br />
talvolta illuminanti, basati su una<br />
ricca serie di citazioni di testi della tradizione<br />
ebraica di ogni epoca (Tanakh,<br />
Talmud, raccolte di midrashim, commentatori<br />
medievali, moderni e contemporanei:<br />
insomma, tutto quello che<br />
ci si può aspettare in un commento<br />
“ortodosso”).<br />
E in effetti il libro si è dimostrato all’altezza<br />
delle attese per la competenza<br />
e la serietà con cui sono affrontati sistematicamente<br />
i diversi temi: dal midrash<br />
alle riflessioni sociologiche, dalla<br />
pratica quotidiana (tallet e tefillin), alla<br />
possibilità di contare nel minian, allo<br />
studio e all’insegnamento della Torah,<br />
fino alla simbolica e fondamentale<br />
questione delle donne-rabbino; non<br />
manca un capitolo dedicato al diritto<br />
di famiglia e al gravissimo problema<br />
delle agunot (donne separate che non<br />
possono formarsi una nuova famiglia<br />
perché non riescono a ottenere un<br />
ghet, un documento di divorzio). Il riferimento<br />
puntuale a testi della tradizione<br />
ebraica è spesso accompagnato<br />
da brevi riflessioni sul significato delle<br />
mitzvot; in questo modo si corre talvolta<br />
il rischio di semplificare troppo,<br />
e naturalmente ammetterle al rabbinato.<br />
Il libro presuppone evidentemente un<br />
lettore legato alla tradizione ortodossa<br />
dell’ebraismo italiano, per cui cerca di<br />
dimostrare che per arrivare a questo<br />
non sarebbe necessario uscire dall’ortodossia<br />
(che peraltro viene definita<br />
come “una vera e propria controriforma”,<br />
nata solo nel XIX secolo in opposizione<br />
all’ebrai-<br />
/ segue a P35<br />
ú–– Miriam Camerini<br />
regista<br />
però in molti casi siamo portati a osservare<br />
sotto una nuova luce pratiche<br />
che tendiamo a ripetere meccanicamente<br />
senza farci troppo caso (per<br />
esempio, mi è piaciuta molto la considerazione<br />
sull’essenza “profondamente<br />
democratica” del minian: “nove<br />
rabbini non costituiscono un minian,<br />
ma dieci ebrei molto ignoranti sì”). Altra<br />
caratteristica tipica dello stile dell’autore<br />
è la scelta di traduzioni insolite,<br />
che ci aiutano a riflettere sul vero<br />
significato dei termini, ma corrono talvolta<br />
il rischio di spiazzare il lettore,<br />
togliendogli il linguaggio comune a<br />
cui è abituato. Qualcuno potrebbe forse<br />
obiettare che il libro non propone<br />
una vera apertura della cultura ebraica<br />
verso la specificità femminile, ma semplicemente<br />
un'estensione alle donne<br />
di riti e pratiche elaborati nel corso<br />
Vedere e ascoltare, sono queste le due<br />
gentili ingiunzioni che Haim Fabrizio<br />
Cipriani rivolge al lettore dal profondo<br />
del suo libro dalla copertina fucsia recentemente<br />
pubblicato da Giuntina.<br />
Ascolta la sua voce, così si intitolano<br />
le 177 pagine più glossario che Cipriani,<br />
rabbino della comunità Lev Chadash<br />
di Milano e membro del Collegio<br />
rabbinico progressivo europeo, ha dedicato<br />
al delicato tema della donna<br />
nella legge ebraica, nella letteratura,<br />
biblica e rabbinica, nonché nella società<br />
ebraica contemporanea. L'accento<br />
è però posto proprio sull'aspetto<br />
normativo, perché, spiega l'autore:<br />
“Non è difficile trovare nel mondo<br />
ebraico espressioni di stima e apprezzamento<br />
per le doti di intelligenza,<br />
comprensione e sensibilità che si attribuiscono<br />
alle donne. I concetti teorici<br />
assumono però un valore solo se<br />
inclusi e codificati nella halakhà, la legge<br />
ebraica”.<br />
Argutamente allusiva è la scelta del<br />
versetto di Bereshit (Genesi 21:12) che<br />
funge da titolo: Dio ordina ad Abramo<br />
di ascoltare la voce di sua moglie Sara.<br />
www.moked.it<br />
dei secoli dagli uomini per gli uomini;<br />
va detto, però, che alcune di queste<br />
pratiche (in particolare lo studio della<br />
Torah) costituiscono l’essenza stessa<br />
della cultura ebraica; inoltre l’uguaglianza<br />
non può prescindere in alcun<br />
modo dall’accesso delle donne alle<br />
stanze del potere, e questo nell’ebraismo<br />
significa al rabbinato.<br />
Il testo si propone sostanzialmente di<br />
dimostrare che tutte le discriminazioni<br />
a cui le donne sono soggette oggi nel<br />
mondo ebraico non hanno in realtà<br />
un fondamento halakhico insuperabile<br />
e che quindi non solo le donne possono<br />
indossare il tallet e i tefillin, ma<br />
che si potrebbe anche facilmente giungere<br />
a contarle nel minian, eliminare<br />
le barriere divisorie nelle sinagoghe,<br />
permettere alle donne di recitare una<br />
tefillah o leggere la Torah in pubblico,<br />
Occasione per ragionare<br />
La citazione – soltanto apparentemente<br />
femminista – è però a doppio taglio,<br />
in quanto rimanda al seguente atteggiamento:<br />
la donna è una creatura dotata<br />
di intuito, saggezza e pragmatismo<br />
che però non è autorizzata a utilizzare<br />
per la sua personale affermazione, bensì<br />
è tenuta a mettere a disposizione<br />
del marito o comunque di altri. Inizialmente<br />
sono caduta anch'io nella<br />
trappola abilmente tesa da Cipriani.<br />
Solo dopo qualche giorno ho capito<br />
quanto è facile essere presi in giro. Soprattutto<br />
se lo si desidera, per quieto<br />
vivere. La voce delle donne – al di là<br />
dell'uso metaforico – è uno dei temi<br />
concretamente trattati: la proibizione,<br />
rivolta alla donna, di far udire la pro-