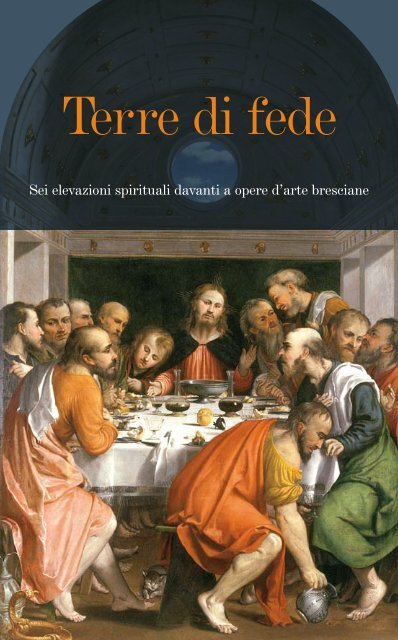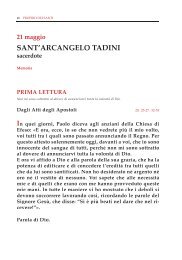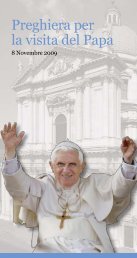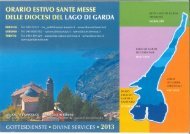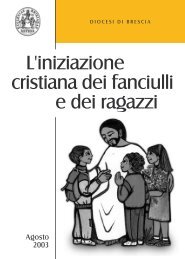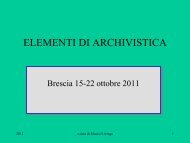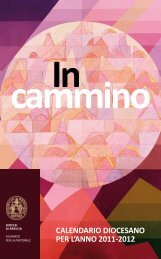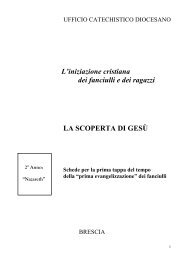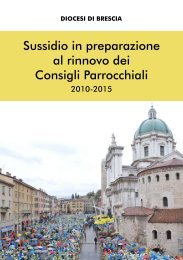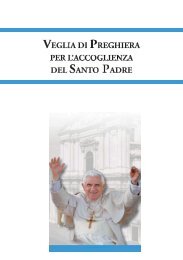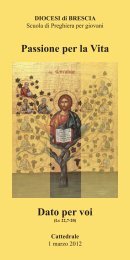Scarica l'opuscolo - Diocesi di Brescia
Scarica l'opuscolo - Diocesi di Brescia
Scarica l'opuscolo - Diocesi di Brescia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Terre <strong>di</strong> fede<br />
Sei elevazioni spirituali davanti a opere d’arte bresciane
Terre <strong>di</strong> fede<br />
L’origine della comunità<br />
Sarezzo, martedì 6 luglio<br />
Ecce mater tua<br />
Gussago, Collezione privata<br />
(in deposito al Museo Diocesano)<br />
Lo Spirito nella comunità<br />
<strong>Brescia</strong>, venerdì 9 luglio<br />
Pentecoste<br />
Bienno, Parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita<br />
La regola della comunità<br />
Ghe<strong>di</strong>, mercoledì 14 luglio<br />
Beatitu<strong>di</strong>ni<br />
<strong>Brescia</strong>, Duomo Nuovo<br />
Il senso della comunità<br />
Chiari, giovedì 15 luglio<br />
Lavanda dei pie<strong>di</strong><br />
<strong>Brescia</strong>, Santuario <strong>di</strong> Sant’Angela Merici<br />
Il cuore della comunità<br />
Villanuova sul Clisi, martedì 20 luglio<br />
Ultima cena<br />
Montichiari, Duomo <strong>di</strong> S. Maria Assunta<br />
Il volto della comunità<br />
Breno, mercoledì 21 luglio<br />
Cristo Re in gloria<br />
Parrocchiale, Maria Immacolata<br />
La scelta e la presentazione delle opere<br />
è a cura <strong>di</strong> don Giuseppe Fusari<br />
<strong>di</strong>rettore del museo <strong>di</strong>ocesano <strong>di</strong> brescia
A Gerusalemme, nel Cenacolo, l’ultima cena. La<br />
sera, dopo il tramonto del sole, Gesù si mette<br />
a tavola insieme ai suoi <strong>di</strong>scepoli. Lo hanno<br />
fatto tante volte, ma questo è un momento<br />
particolare, nel quale si uniscono attesa e<br />
trepidazione. Gesù spiega: “Ho tanto desiderato<br />
mangiare questa Pasqua con voi, prima della<br />
mia passione, perché io vi <strong>di</strong>co: non la mangerò<br />
più finché essa non si compia nel regno <strong>di</strong><br />
Dio” (Lc 22,15-16). L’ultima cena; dopo verrà la<br />
passione, poi il banchetto nel regno <strong>di</strong> Dio. Non<br />
so quanto i <strong>di</strong>scepoli possano avere capito <strong>di</strong><br />
queste parole profetiche ma non è <strong>di</strong>fficile<br />
immaginare l’atmosfera <strong>di</strong> desiderio e timore, <strong>di</strong><br />
sospensione e <strong>di</strong> mistero che deve aver riempito<br />
il cenacolo.<br />
+ Lu c i a n o Mo n a r i<br />
dalla Lettera pastorale “Tutti siano una cosa sola”
Sotto l’albero della croce<br />
si compie il duplice<br />
affidamento:<br />
la madre al <strong>di</strong>scepolo<br />
e il <strong>di</strong>scepolo alla madre.<br />
Qui è l’origine<br />
della comunità:<br />
il dono prezioso del<br />
testamento <strong>di</strong> Cristo<br />
che non è più solo<br />
<strong>di</strong> parole e gesti ma<br />
si prolunga nella<br />
<strong>di</strong>mensione della<br />
testimonianza e<br />
nell’accoglienza come<br />
primo passo per acquisire<br />
la <strong>di</strong>namica comunitaria.<br />
Si riceve l’adozione<br />
perché donati alla<br />
madre, si riceve la<br />
madre come para<strong>di</strong>gma<br />
dell’accoglienza,<br />
dell’ascolto<br />
e della sequela.<br />
Qui la madre non è più<br />
la donna storica,<br />
la madre <strong>di</strong> Gesù,<br />
ma l’immagine stessa<br />
della Chiesa,<br />
della comunità,<br />
<strong>di</strong>namica nel suo essere<br />
accolta da chi desidera<br />
<strong>di</strong>ventare <strong>di</strong>scepolo; ma,<br />
allo stesso tempo, non<br />
ci sarebbe <strong>di</strong>scepolo<br />
senza la casa, la madre,<br />
la comunità che nasce<br />
- madre e figlia insieme -<br />
dal sangue <strong>di</strong> Cristo.<br />
Così il <strong>di</strong>scepolo accoglie<br />
la comunità e ne fa parte.<br />
Non è appartenenza<br />
passiva: è scelta che<br />
coinvolge la vita intera.<br />
L’origine<br />
della comunità<br />
Ecce filium tuum,<br />
ecce mater tua<br />
olio su tela, 271x162 c m<br />
Antonio Gan<strong>di</strong>no<br />
(<strong>Brescia</strong> 1565-1630)<br />
Gussago, Collezione privata<br />
(in deposito al Museo Diocesano)<br />
Il <strong>di</strong>pinto, destinato alla cappella <strong>di</strong> un palazzo<br />
gentilizio, è stato realizzato dal Gan<strong>di</strong>no sul<br />
finire degli anni Dieci del Seicento. È in questi<br />
anni che l’artista comincia ad utilizzare tonalità<br />
più cupe e accenti patetici più pronunciati.<br />
La scena del Calvario non si <strong>di</strong>scosta dalla<br />
classica rappresentazione della crocifissione,<br />
ma qui l’artista concentra la sua attenzione sul<br />
momento nel quale il Cristo, secondo il racconto<br />
dell’evangelista Giovanni, affida la madre al<br />
<strong>di</strong>scepolo e il <strong>di</strong>scepolo alla madre. Tutto è<br />
concentrato nel <strong>di</strong>alogo muto tra il Figlio e la<br />
madre: Gesù sta pronunciando quelle poche<br />
parole e la madre lo guarda con intensità.<br />
Il <strong>di</strong>scepolo assiste quasi attonito. Aver<br />
concentrato l’attenzione su questo momento ha<br />
permesso al Gan<strong>di</strong>no <strong>di</strong> accentuare la tensione<br />
psicologica che lega i personaggi, col Cristo che,<br />
a labbra <strong>di</strong>schiuse, sembra parlare con la forza<br />
dello sguardo; con la madre che, avvolta<br />
<strong>di</strong> tristezza, assume con il suo atteggiamento tutto<br />
il senso della rassegnazione e dell’affidamento.<br />
Un gruppo compatto che traspone in immagine<br />
la solennità del dono ultimo <strong>di</strong> Cristo.<br />
Agostino, De Civitate Dei, XIX, 11.<br />
Perciò potremmo <strong>di</strong>re che la pace è il fine del nostro bene, come l’abbiamo detto della vita eterna,<br />
soprattutto perché alla città <strong>di</strong> Dio si <strong>di</strong>ce in un Salmo: Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda, Sion,<br />
il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte; in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli colui che<br />
ha posto la pace come tuo fine. Quando infatti saranno state rinforzate le sbarre delle sue porte, nessuno<br />
entrerà in essa e nessuno ne uscirà. Perciò come suo fine in questo caso dobbiamo ravvisare<br />
quella che inten<strong>di</strong>amo <strong>di</strong>mostrare come pace finale. Anche il nome simbolico della città, cioè Gerusalemme,<br />
come ho già detto, s’interpreta “visione della pace”. Ma poiché il termine “pace” si usa<br />
frequentemente anche per le cose nel <strong>di</strong>venire, in cui perciò non si avrà la vita eterna, ho preferito<br />
denominare “vita eterna” anziché “pace” il fine della città celeste in cui si avrà il sommo bene.
TESTAMENTO E DONO Gv 19, 25-27<br />
Stavano presso la croce <strong>di</strong> Gesù sua madre, la sorella <strong>di</strong> sua madre, Maria<br />
madre <strong>di</strong> Clèopa e Maria <strong>di</strong> Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre<br />
e accanto a lei il <strong>di</strong>scepolo che egli amava, <strong>di</strong>sse alla madre: “Donna, ecco<br />
tuo figlio!”. Poi <strong>di</strong>sse al <strong>di</strong>scepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora<br />
il <strong>di</strong>scepolo l’accolse con sé.
Non esiste corpo vivente<br />
senza ciò che lo anima.<br />
Così è per la comunità:<br />
i <strong>di</strong>versi membri non sono<br />
ancora comunità sebbene<br />
possano trovarsi insieme,<br />
avere gli stessi intenti<br />
e i medesimi obiettivi.<br />
Gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong>ventano<br />
comunità quando<br />
qualcuno dà lo Spirito,<br />
quando cioè<br />
lo stare insieme<br />
<strong>di</strong>venta essere insieme,<br />
essere nel nome<br />
<strong>di</strong> qualcuno,<br />
fare in memoria<br />
<strong>di</strong> qualcuno.<br />
In altre parole,<br />
gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong>ventano<br />
comunità quando<br />
l’obiettivo e la missione<br />
non <strong>di</strong>pendono da scelte<br />
interne ma sono prima<br />
<strong>di</strong> tutto dono da parte<br />
<strong>di</strong> qualcuno.<br />
È questa abbondanza<br />
(o sovrabbondanza)<br />
del dono che spinge<br />
a testimoniare e,<br />
con quel dono,<br />
nulla può esserci<br />
<strong>di</strong> ostacolo, né la paura,<br />
né la lingua, né il<br />
messaggio da annunciare.<br />
Lo Spirito nella comunità<br />
è colui che costringe<br />
a uscire dal gruppo<br />
e a mostrare l’opera<br />
da compiere.<br />
La comunità si compie<br />
nello Spirito quando esce<br />
da sé e <strong>di</strong>venta annuncio<br />
del Risorto.<br />
Lo Spirito<br />
nella comunità<br />
Pentecoste<br />
affresco<br />
Giovan Mauro della Rovere<br />
detto il Fiamminghino<br />
(Milano 1575c a-1643)<br />
Bienno,<br />
Chiesa Parrocchiale dei Santi<br />
Faustino e Giovita<br />
La decorazione della nuova parrocchiale <strong>di</strong> Bienno,<br />
de<strong>di</strong>cata ai Santi Faustino e Giovita, prende il via nel<br />
1621. Insieme a Tommaso Sandrini, bresciano, autore<br />
delle finte architetture, sui ponteggi della chiesa si<br />
trovano a realizzare le molte figure della volta e delle<br />
cappelle, Stefano Viviani e Giovan Mauro Della<br />
Rovere, attivo nel bresciano dal 1616 quando, insieme<br />
al fratello Giovan Battista, affrescava la <strong>di</strong>strutta<br />
chiesa <strong>di</strong> San Domenico in città e, l’anno successivo,<br />
il presbiterio <strong>di</strong> Santa Maria delle Grazie. La volta<br />
della chiesa <strong>di</strong> Bienno, con le monumentali figure<br />
dei profeti che annunciano i misteri <strong>di</strong> Cristo e con<br />
le medaglie figurate che rappresentano la Trasfigurazione,<br />
l’Ascensione e la Pentecoste, offre al credente<br />
un vero e proprio cammino per immagini che illustra<br />
il senso della storia della salvezza che prolunga nel<br />
presente attraverso l’opera della Chiesa. L’episo<strong>di</strong>o<br />
della Pentecoste, ambientato all’interno <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio<br />
monumentale, mostra gli apostoli e la Vergine<br />
animati dallo Spirito che scende in forma <strong>di</strong> lingue<br />
<strong>di</strong> fuoco. Il <strong>di</strong>namismo impresso alle figure cerca <strong>di</strong><br />
dare l’immagine del repentino cambiamento operato<br />
dallo Spirito nell’intimo dei <strong>di</strong>scepoli.<br />
Agostino, De Civitate Dei, XIX, 10.<br />
Qui ci consideriamo felici, quando abbiamo la pace nei limiti in cui qui si può<br />
conseguire con una vita onesta, ma questa felicità, paragonata alla felicità che<br />
consideriamo finale, è piuttosto infelicità. Quando come uomini posti nel <strong>di</strong>venire<br />
abbiamo nel <strong>di</strong>venire delle cose la pace che si può avere in questa vita, se<br />
viviamo onestamente, la virtù usa bene dei suoi beni; quando invece non l’abbiamo,<br />
la virtù usa bene anche i mali che l’uomo sopporta. Ma allora è vera virtù<br />
quando volge tutti i beni, <strong>di</strong> cui usa bene, tutto ciò che ottiene col buon uso del<br />
bene e del male e se stessa a quel fine, in cui per noi vi sarà una pace tanto bella<br />
e tanto grande che non ve ne può essere una più bella e più grande.
LA FORZA DELLA TESTIMONIANZA VIENE DALL’ALTO At 2, 1-6<br />
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme<br />
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi<br />
un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.<br />
Apparvero loro lingue come <strong>di</strong> fuoco, che si <strong>di</strong>videvano, e si posarono su<br />
ciascuno <strong>di</strong> loro, e tutti furono colmati <strong>di</strong> Spirito Santo e cominciarono<br />
a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere <strong>di</strong><br />
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, <strong>di</strong> ogni<br />
nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase<br />
turbata, perché ciascuno li u<strong>di</strong>va parlare nella propria lingua.
Il Vangelo interroga<br />
e critica la logica<br />
del mondo.<br />
Così è per la comunità<br />
che nasce da Cristo:<br />
non può accontentarsi<br />
<strong>di</strong> conoscere, deve<br />
riconoscere<br />
che il senso del suo<br />
esistere sta nel mettere<br />
in pratica quanto Gesù<br />
ha detto e fatto.<br />
La regola che definisce<br />
la comunità è breve,<br />
semplice e sta racchiusa<br />
nel comandamento<br />
dell’amore, ma si<br />
squaderna nella sua<br />
<strong>di</strong>rompente efficacia<br />
e contrad<strong>di</strong>ttorietà<br />
nei frutti che produce,<br />
nel ribaltamento<br />
della scala <strong>di</strong> valori<br />
voluta dal mondo.<br />
Chi è beato per Gesù è<br />
maledetto per il mondo.<br />
Ma perché il mondo<br />
valuta il presente,<br />
Dio valuta il futuro.<br />
E la soluzione <strong>di</strong> Dio<br />
chiede alla comunità<br />
<strong>di</strong> imparare questo<br />
metro <strong>di</strong> valutazione.<br />
È lo scandalo che si<br />
compie ogni volta che la<br />
comunità crede al futuro<br />
<strong>di</strong> Dio: <strong>di</strong>venta forza<br />
critica verso il presente,<br />
ma apre la strada verso il<br />
compimento del Regno,<br />
verso quel ribaltamento<br />
che non avviene per<br />
volere dell’uomo ma è<br />
soluzione donata da Dio.<br />
La regola<br />
della comunità<br />
Le beatitu<strong>di</strong>ni<br />
olio su tela centinata, 342x187 c m<br />
Michelangelo Grigoletti<br />
(Rorai Grande/Pd 1801-Venezia 1870)<br />
<strong>Brescia</strong>, Duomo Nuovo,<br />
Cappella del Santissimo Sacramento.<br />
La tela fu commissionata a Michelangelo<br />
Grigoletti negli anni Quaranta dell’Ottocento<br />
come pala per il nuovo altare del Santissimo<br />
Sacramento del Duomo Nuovo,<br />
progettato dal bresciano Rodolfo Vantini<br />
e messo in opera tra il 1842 e il 1846.<br />
Vantini avrebbe preferito il più quotato Francesco<br />
Hayez, ma la commissione preposta ai lavori<br />
preferì il pordenonese che produsse una tela<br />
accademicamente molto corretta e nell’insieme<br />
efficace, organizzando le figure su due piani<br />
e ponendo il Cristo al centro <strong>di</strong> un’ideale<br />
serpentina che parte dalle persone <strong>di</strong>pinte in<br />
primo piano e si compie nello sperone <strong>di</strong> roccia<br />
dello sfondo. Non mancano ricor<strong>di</strong> della pittura<br />
del Rinascimento veneziano, in particolare <strong>di</strong><br />
Veronese, ma tutto è come decantato in uno<br />
stile privo <strong>di</strong> accensioni e attento a tenere un<br />
tono me<strong>di</strong>o, ben calibrato, in rispondenza anche<br />
alla struttura giocata sui toni fred<strong>di</strong> dei marmi<br />
bianchi e grigi voluta dal Vantini. Grigoletti<br />
costruisce una scena ben recitata dove i gesti e<br />
gli atteggiamenti esprimono, quasi come se si<br />
trattasse <strong>di</strong> un teatro, la verità delle intenzioni e<br />
delle parole pronunciate.<br />
Agostino, De Civitate Dei, XIX, 27.<br />
La pace propriamente nostra si ha con Dio anche nel tempo me<strong>di</strong>ante la<br />
fede e nell’eternità si avrà con lui nella visione. Ma nel tempo tanto la pace<br />
comune come quella propriamente nostra è pace più come sollievo dell’infelicità<br />
che come go<strong>di</strong>mento della felicità. Anche la nostra <strong>di</strong>gnità morale,<br />
sebbene sia vera in riferimento al vero fine del bene al quale si rapporta, è<br />
così relativa in questa vita da consistere più nella remissione dei peccati che<br />
nella pienezza della virtù. Lo conferma la preghiera <strong>di</strong> tutta la città <strong>di</strong> Dio<br />
che è in cammino sulla terra. Difatti lo grida a Dio in tutti i suoi adepti: Rimetti<br />
a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
SCANDALO E ROVESCIAMENTO Mt 5, 1-12<br />
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi <strong>di</strong>scepoli.<br />
Si mise a parlare e insegnava loro <strong>di</strong>cendo: Beati i poveri in spirito, perché <strong>di</strong> essi è<br />
il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti,<br />
perché avranno in ere<strong>di</strong>tà la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché<br />
saranno saziati. Beati i misericor<strong>di</strong>osi, perché troveranno misericor<strong>di</strong>a. Beati i puri <strong>di</strong><br />
cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori <strong>di</strong> pace, perché saranno chiamati figli <strong>di</strong><br />
Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché <strong>di</strong> essi è il regno dei cieli. Beati voi quando<br />
vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, <strong>di</strong>ranno ogni sorta <strong>di</strong> male contro <strong>di</strong> voi<br />
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Davanti all’esempio<br />
non è possibile tentare<br />
interpretazioni.<br />
Semmai si cercherà<br />
<strong>di</strong> attenuare la forza<br />
del comandamento ma,<br />
nel profondo del cuore,<br />
si sarà certi <strong>di</strong> non aver<br />
compiuto tutto quanto<br />
andava fatto.<br />
La comunità <strong>di</strong> Cristo<br />
ha senso quando accetta<br />
che il suo compito è<br />
quello <strong>di</strong> amare fino<br />
in fondo e <strong>di</strong> compiere<br />
questo amore così come<br />
ha fatto Lui: ribaltando,<br />
cioè, i criteri<br />
<strong>di</strong> rispettabilità<br />
del maestro per assumere<br />
i panni del servo.<br />
E questo per in<strong>di</strong>care che<br />
il vero insegnamento,<br />
la vera cattedra è quella<br />
dove chi è maestro<br />
è al servizio e sta<br />
in ginocchio davanti<br />
agli altri.<br />
Solo così la comunità<br />
ha senso: perché sta<br />
nel solco <strong>di</strong> Colui<br />
che l’ha costituita.<br />
E solo così la comunità<br />
non perde la sua identità:<br />
il servizio ha un motivo,<br />
ed è l’amore<br />
agli altri così come l’ha<br />
insegnato Cristo.<br />
Non è soccorso<br />
umanitario, non è<br />
sostituzione: è riconoscere<br />
nell’altro il motivo<br />
per il quale si è comunità.<br />
E comunità <strong>di</strong> Cristo.<br />
Il senso<br />
della comunità<br />
Lavanda dei pie<strong>di</strong><br />
olio su tavola, 32x48 c m<br />
Paolo da Caylina il Giovane<br />
(<strong>Brescia</strong> 1485c a-1545c a)<br />
<strong>Brescia</strong>,<br />
Santuario <strong>di</strong> Sant’Angela Merici<br />
(già Sant’Afra)<br />
La tavola fa parte della predella del polittico realizzato<br />
per l’antica chiesa <strong>di</strong> Sant’Afra verso gli<br />
anni Trenta del Cinquecento.<br />
Il polittico, molto articolato, raffigura nella tavola<br />
centrale il Compianto sul Cristo morto, e nelle due<br />
altre tavole della predella la Flagellazione e il Noli<br />
me tangere. A completamento sono stati raffigurati,<br />
oltre a una piccola Annunciazione, due Angeli<br />
in adorazione dell’Eucaristia e i Santi Faustino<br />
e Giovita, Felice e Faustino vescovi. La pittura <strong>di</strong><br />
Paolo da Caylina in questo polittico è giunta alla<br />
piena maturità: si notano apporti da Moretto e da<br />
Romanino e non mancano riferimenti alla lontana<br />
al Foppa e al Civerchio. L’artista amalgama tutti<br />
questi apporti nel suo stile dolce e semplificato.<br />
La vivacità specialmente delle scenette minori della<br />
predella mostrano la sua capacità calligrafica e,<br />
insieme, una vena quasi popolare che dà alla scena<br />
un piglio narrativo facile e gustoso.<br />
Lontano dall’intensità drammatica dei maggiori<br />
del Rinascimento bresciano, Paolo da Caylina<br />
il Giovane si <strong>di</strong>mostra buon illustratore <strong>di</strong> scene<br />
sacre trattate con garbo e schiettezza.<br />
Agostino, De Civitate Dei, XIX, 17.<br />
Questa città del cielo, mentre è esule in cammino sulla terra, accoglie citta<strong>di</strong>ni da tutti i popoli e aduna<br />
una società in cammino da tutte le lingue. Anche la città del cielo in questo suo esilio trae profitto dalla<br />
pace terrena, tutela e desidera, per quanto è consentito dal rispetto per il sentimento religioso, l’accordo<br />
degli umani interessi nel settore dei beni spettanti alla natura degli uomini soggetta al <strong>di</strong>venire e subor<strong>di</strong>na<br />
la pace terrena a quella celeste. Ed essa è veramente pace in modo che unica pace della creatura<br />
ragionevole dev’essere ritenuta e considerata l’unione sommamente or<strong>di</strong>nata e concorde <strong>di</strong> avere Dio<br />
come fine e l’un l’altro in lui. La città del cielo, mentre è esule in cammino nella fede, ha questa pace e<br />
vive onestamente <strong>di</strong> questa fede, quando al conseguimento della sua pace eterna subor<strong>di</strong>na ogni buona<br />
azione, che compie verso Dio e il prossimo, perché la vita della città è essenzialmente sociale.
IL COMANDAMENTO E L’ESEMPIO Gv 13, 1-15<br />
Prima della festa <strong>di</strong> Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora <strong>di</strong> passare da questo mondo<br />
al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando<br />
il <strong>di</strong>avolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio <strong>di</strong> Simone Iscariota, <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>rlo, Gesù, sapendo<br />
che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da<br />
tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua<br />
nel catino e cominciò a lavare i pie<strong>di</strong> dei <strong>di</strong>scepoli e ad asciugarli con l’asciugamano <strong>di</strong> cui si era<br />
cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli <strong>di</strong>sse: “Signore, tu lavi i pie<strong>di</strong> a me?”. Rispose<br />
Gesù: “Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo”. Gli <strong>di</strong>sse Pietro: “Tu non mi<br />
laverai i pie<strong>di</strong> in eterno!”. Gli rispose Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con me”. Gli <strong>di</strong>sse<br />
Simon Pietro: “Signore, non solo i miei pie<strong>di</strong>, ma anche le mani e il capo!”. Soggiunse Gesù: “Chi<br />
ha fatto il bagno, non ha bisogno <strong>di</strong> lavarsi se non i pie<strong>di</strong> ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non<br />
tutti”. Sapeva infatti chi lo tra<strong>di</strong>va; per questo <strong>di</strong>sse: “Non tutti siete puri”. Quando ebbe lavato<br />
loro i pie<strong>di</strong>, riprese le sue vesti, sedette <strong>di</strong> nuovo e <strong>di</strong>sse loro: “Capite quello che ho fatto per voi?<br />
Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e <strong>di</strong>te bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e<br />
il Maestro, ho lavato i pie<strong>di</strong> a voi, anche voi dovete lavare i pie<strong>di</strong> gli uni agli altri. Vi ho dato un<br />
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi”.
Un gruppo non è ancora<br />
una comunità.<br />
Quello che trasforma<br />
il gruppo in comunità non<br />
è solo un fine comune:<br />
è la consapevolezza<br />
che qualcosa continua,<br />
che qualcosa la precede<br />
e sarà ancora dopo <strong>di</strong> lei.<br />
Comunità è memoria<br />
che <strong>di</strong>venta presente<br />
e che lo motiva.<br />
Fare in sua memoria<br />
non è solo ricordare:<br />
è essere presenti,<br />
è accettare<br />
<strong>di</strong> non essere se non<br />
quando c’è Lui.<br />
Memoria per la comunità<br />
è attesa del compimento<br />
che non <strong>di</strong>pende da lei<br />
e certezza che<br />
questo avverrà.<br />
Pane e vino, corpo e<br />
sangue, il dono assoluto<br />
ed eterno della sua<br />
presenza, del suo essere<br />
con noi tutti i giorni<br />
fino alla fine dei tempi,<br />
sono il modo <strong>di</strong> vita,<br />
della comunità, il cuore<br />
che, come per il corpo,<br />
permette alla vita<br />
<strong>di</strong> esserci.<br />
È lì che la comunità<br />
si riconosce, pur nella<br />
<strong>di</strong>versità dei singoli,<br />
come corpo nato<br />
da un dono.<br />
E come tale capace<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare dono<br />
attraverso la memoria<br />
<strong>di</strong> Lui, la sua presenza,<br />
il suo corpo.<br />
Il cuore<br />
della comunità<br />
Ultima cena<br />
olio su tela centinata, 293x190 c m<br />
Girolamo Romanino<br />
(<strong>Brescia</strong> 1484c a-1566c a)<br />
Montichiari, Chiesa Abbaziale,<br />
Cappella del Santissimo Sacramento<br />
Collocata dalla critica verso la metà degli anni<br />
Quaranta del Cinquecento, questa Ultima Cena fu<br />
realizzata per la Scuola del Santissimo Sacramento<br />
e collocata nella vecchia parrocchiale <strong>di</strong> Montichiari.<br />
Ricostruita in forme monumentali la chiesa,<br />
la tela venne racchiusa nel monumentale altare<br />
marmoreo della Cappella del Sacramento. Le mutate<br />
proporzioni della chiesa e dell’altare un poco<br />
<strong>di</strong>minuiscono l’effetto che la tela doveva avere in<br />
origine. Qui Romanino calcola con grande precisione<br />
il punto <strong>di</strong> vista, molto ribassato, dando forte<br />
risalto alla volta a botte con lacunari della stanza<br />
nella quale si svolge la scena, in un’ora non ancora<br />
serale, con la chiarezza del cielo che ancora si vede<br />
dall’oculo aperto nella parete <strong>di</strong> fondo.<br />
La tavola è un capolavoro <strong>di</strong> indagine realistica e<br />
<strong>di</strong> virtuosismi luministici, ma più ancora colpisce la<br />
profon<strong>di</strong>tà psicologica con la quale sono indagati i<br />
personaggi alle prese con l’annuncio del tra<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> Cristo e con l’istituzione dell’Eucaristia.<br />
A questo turbine emozionale non partecipa solo<br />
Giuda che, con l’atto simbolico <strong>di</strong> versare il vino<br />
per terra, esprime la sua volontà <strong>di</strong> sprecare<br />
il dono ricevuto da Cristo.<br />
Agostino, De Civitate Dei, XX, 17.<br />
E dal cielo fin dalla sua origine <strong>di</strong>scende la città <strong>di</strong> Dio, da quando<br />
continuamente i suoi citta<strong>di</strong>ni aumentano nella successione del<br />
tempo, con la grazia <strong>di</strong> Dio che viene dall’alto me<strong>di</strong>ante il lavacro<br />
<strong>di</strong> rigenerazione nello Spirito Santo mandato dal cielo. Ma col<br />
giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Dio, che sarà l’ultimo, me<strong>di</strong>ante il suo Figlio Gesù<br />
Cristo si manifesterà il suo splendore così grande e così nuovo<br />
in modo che non rimarranno tracce della tarda età, giacché i<br />
corpi soggetti al <strong>di</strong>venire e alla morte <strong>di</strong> una volta passeranno<br />
alla immunità dal <strong>di</strong>venire e dalla morte.
L’ESSENZA DEL DONO Lc 22, 14-20<br />
Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e <strong>di</strong>sse loro: “Ho<br />
tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché<br />
io vi <strong>di</strong>co: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno <strong>di</strong> Dio”.<br />
E, ricevuto un calice, rese grazie e <strong>di</strong>sse: “Prendetelo e fatelo passare tra voi,<br />
perché io vi <strong>di</strong>co: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché<br />
non verrà il regno <strong>di</strong> Dio”. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo <strong>di</strong>ede loro<br />
<strong>di</strong>cendo: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria<br />
<strong>di</strong> me”. E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice <strong>di</strong>cendo: “Questo calice<br />
è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”.
Può essere visto solo<br />
in prospettiva: la<br />
comunità reale non può<br />
che proiettarsi sulla<br />
comunità definitiva.<br />
Questo solo è il volto<br />
vero della comunità.<br />
Pensare che la comunità<br />
presente, quella che,<br />
concreta, realizza più<br />
o meno perfettamente<br />
la regola <strong>di</strong> Cristo,<br />
sia il volto vero della<br />
comunità <strong>di</strong> Cristo è<br />
vedere parzialmente.<br />
Il volto della comunità<br />
è il volto vero<br />
solo quando è estensivo,<br />
quando, cioè,<br />
abbraccia l’esperienza<br />
delle comunità storiche<br />
e si orienta verso la<br />
comunità che vedrà<br />
faccia a faccia il suo<br />
Signore.<br />
La comunità storica<br />
abbozza solo questo<br />
volto in attesa del<br />
perfezionamento che<br />
non sarà suo ma, come<br />
sempre nella <strong>di</strong>namica <strong>di</strong><br />
Dio, darà dono gratuito<br />
del Suo amore.<br />
Compito della comunità<br />
è plasmarsi<br />
secondo la <strong>di</strong>namica<br />
dell’amore concreto<br />
ma scorgendo in esso<br />
il riflesso del volto<br />
<strong>di</strong> Cristo.<br />
Fare a Lui è fare<br />
al fratello.<br />
Per imparare ad essere<br />
a sua somiglianza.<br />
Il volto<br />
della comunità<br />
Il Para<strong>di</strong>so<br />
affresco<br />
Gaetano Cresseri<br />
(<strong>Brescia</strong> 1870-1933)<br />
Nave, Chiesa Parrocchiale<br />
All’inizio del Novecento sono molte le chiese<br />
bresciane, specialmente quelle costruite<br />
nel XVIII secolo, che vengono completamente<br />
decorate secondo un gusto eclettico,<br />
debitore al Liberty e al Neobarocco.<br />
Anche la Parrocchiale <strong>di</strong> Nave è interessata<br />
da questi lavori <strong>di</strong> rilettura in senso<br />
neosettecentesco. Per il più vasto degli affreschi,<br />
quello della cupola, viene chiamato il maggiore<br />
degli artisti bresciani del tempo,<br />
Gaetano Cresseri, maestro in<strong>di</strong>scusso<br />
nell’affresco, grande decoratore <strong>di</strong> chiese<br />
e palazzi. Intrapresi nel 1930 i lavori <strong>di</strong><br />
affrescatura della cupola terminarono nel 1932.<br />
Cresseri raffigurò, secondo il gusto dell’epoca,<br />
la gloria <strong>di</strong> Cristo re dell’universo:<br />
al centro, sopra le nubi e avvolto <strong>di</strong> luce sta il<br />
Cristo attorniato da una schiera <strong>di</strong> angeli e santi.<br />
Nel giro più esterno sono invece raffigurati<br />
uomini e donne dei <strong>di</strong>versi continenti.<br />
L’influsso della pittura settecentesca,<br />
specialmente del Tiepolo, è evidente.<br />
Qui Cresseri, superando anche le <strong>di</strong>fficoltà<br />
prospettiche imposte dallo scorcio,<br />
dà un esempio magistrale della grande<br />
decorazione novecentesca bresciana.<br />
Agostino, De Civitate Dei, XIX, 20.<br />
Il sommo bene della città <strong>di</strong> Dio è la pace eterna definitiva, non quella attraverso la quale i mortali passano col<br />
nascere e il morire, ma quella in cui gli immortali rimangono senza alcuna soggezione ai contrari. Chi dunque<br />
può negare che quella vita è sommamente felice e nel confronto non giu<strong>di</strong>ca sommamente infelice questa che<br />
trascorre nel tempo anche se è colma dei beni dell’anima, del corpo e del mondo esteriore? Ma chiunque la<br />
giu<strong>di</strong>ca in maniera da riferire il suo scorrere al fine <strong>di</strong> quella vita che ama con grande ardore e che spera con<br />
grande fiducia, non assurdamente si può considerare felice anche in questo tempo <strong>di</strong> quella speranza anziché<br />
<strong>di</strong> questa vicenda. La vicenda presente senza la speranza è una falsa felicità e una grande infelicità. Difatti<br />
non ha esperienza dei veri beni dell’anima poiché non è vera saggezza quella la quale, nelle azioni che giu<strong>di</strong>ca<br />
con la prudenza, compie con la fortezza, frena con la temperanza, <strong>di</strong>stribuisce con la giustizia, non orienta la<br />
propria scelta a quel fine in cui Dio sarà tutto in tutti, in un’eternità certa e in una pace definitiva.
IL DISCRIMINE DEFINITIVO Mt 25, 31-40<br />
Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti<br />
a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle<br />
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re <strong>di</strong>rà a quelli che saranno alla sua destra:<br />
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in ere<strong>di</strong>tà il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo,<br />
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi<br />
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora<br />
i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato<br />
e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo<br />
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?” E il re risponderà loro:<br />
“In verità io vi <strong>di</strong>co: tutto quello che avete fatto a uno solo <strong>di</strong> questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Agorà della <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
Inizio dell’Anno pastorale 2010/2011<br />
<strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> brescia<br />
Via Trieste, 13 <strong>Brescia</strong> tel. 030.37221<br />
Centro <strong>di</strong>ocesano pER le Comunicazioni Sociali<br />
Via Callegari, 6 <strong>Brescia</strong> tel. 030.44250<br />
info: www.<strong>di</strong>ocesi.brescia.it/agora<br />
e-mail: comunicazioni@<strong>di</strong>ocesi.brescia.it