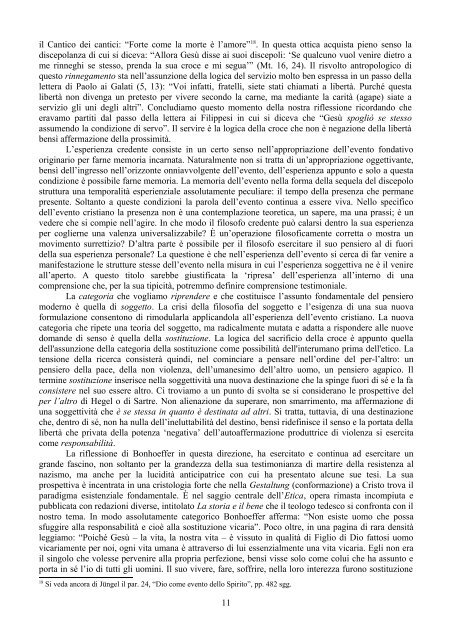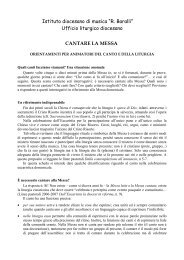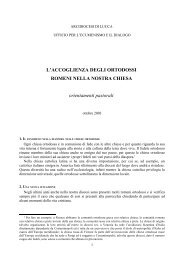Prof. Emilio Baccarini Alla ricerca del significante. Il sé e il suo futuro
Prof. Emilio Baccarini Alla ricerca del significante. Il sé e il suo futuro
Prof. Emilio Baccarini Alla ricerca del significante. Il sé e il suo futuro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>il</strong> Cantico dei cantici: “Forte come la morte è l’amore” 18 . In questa ottica acquista pieno senso la<br />
discepolanza di cui si diceva: “Allora Gesù disse ai <strong>suo</strong>i discepoli: ‘Se qualcuno vuol venire dietro a<br />
me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua’” (Mt. 16, 24). <strong>Il</strong> risvolto antropologico di<br />
questo rinnegamento sta nell’assunzione <strong>del</strong>la logica <strong>del</strong> servizio molto ben espressa in un passo <strong>del</strong>la<br />
lettera di Paolo ai Galati (5, 13): “Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa<br />
libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità (agape) siate a<br />
servizio gli uni degli altri”. Concludiamo questo momento <strong>del</strong>la nostra riflessione ricordando che<br />
eravamo partiti dal passo <strong>del</strong>la lettera ai F<strong>il</strong>ippesi in cui si diceva che “Gesù spogliò se stesso<br />
assumendo la condizione di servo”. <strong>Il</strong> servire è la logica <strong>del</strong>la croce che non è negazione <strong>del</strong>la libertà<br />
bensì affermazione <strong>del</strong>la prossimità.<br />
L’esperienza credente consiste in un certo senso nell’appropriazione <strong>del</strong>l’evento fondativo<br />
originario per farne memoria incarnata. Naturalmente non si tratta di un’appropriazione oggettivante,<br />
bensì <strong>del</strong>l’ingresso nell’orizzonte onniavvolgente <strong>del</strong>l’evento, <strong>del</strong>l’esperienza appunto e solo a questa<br />
condizione è possib<strong>il</strong>e farne memoria. La memoria <strong>del</strong>l’evento nella forma <strong>del</strong>la sequela <strong>del</strong> discepolo<br />
struttura una temporalità esperienziale assolutamente peculiare: <strong>il</strong> tempo <strong>del</strong>la presenza che permane<br />
presente. Soltanto a queste condizioni la parola <strong>del</strong>l’evento continua a essere viva. Nello specifico<br />
<strong>del</strong>l’evento cristiano la presenza non è una contemplazione teoretica, un sapere, ma una prassi; è un<br />
vedere che si compie nell’agire. In che modo <strong>il</strong> f<strong>il</strong>osofo credente può calarsi dentro la sua esperienza<br />
per coglierne una valenza universalizzab<strong>il</strong>e? È un’operazione f<strong>il</strong>osoficamente corretta o mostra un<br />
movimento surrettizio? D’altra parte è possib<strong>il</strong>e per <strong>il</strong> f<strong>il</strong>osofo esercitare <strong>il</strong> <strong>suo</strong> pensiero al di fuori<br />
<strong>del</strong>la sua esperienza personale? La questione è che nell’esperienza <strong>del</strong>l’evento si cerca di far venire a<br />
manifestazione le strutture stesse <strong>del</strong>l’evento nella misura in cui l’esperienza soggettiva ne è <strong>il</strong> venire<br />
all’aperto. A questo titolo sarebbe giustificata la ‘ripresa’ <strong>del</strong>l’esperienza all’interno di una<br />
comprensione che, per la sua tipicità, potremmo definire comprensione testimoniale.<br />
La categoria che vogliamo riprendere e che costituisce l’assunto fondamentale <strong>del</strong> pensiero<br />
moderno è quella di soggetto. La crisi <strong>del</strong>la f<strong>il</strong>osofia <strong>del</strong> soggetto e l’esigenza di una sua nuova<br />
formulazione consentono di rimodularla applicandola all’esperienza <strong>del</strong>l’evento cristiano. La nuova<br />
categoria che ripete una teoria <strong>del</strong> soggetto, ma radicalmente mutata e adatta a rispondere alle nuove<br />
domande di senso è quella <strong>del</strong>la sostituzione. La logica <strong>del</strong> sacrificio <strong>del</strong>la croce è appunto quella<br />
<strong>del</strong>l'assunzione <strong>del</strong>la categoria <strong>del</strong>la sostituzione come possib<strong>il</strong>ità <strong>del</strong>l'interumano prima <strong>del</strong>l'etico. La<br />
tensione <strong>del</strong>la <strong>ricerca</strong> consisterà quindi, nel cominciare a pensare nell’ordine <strong>del</strong> per-l’altro: un<br />
pensiero <strong>del</strong>la pace, <strong>del</strong>la non violenza, <strong>del</strong>l’umanesimo <strong>del</strong>l’altro uomo, un pensiero agapico. <strong>Il</strong><br />
termine sostituzione inserisce nella soggettività una nuova destinazione che la spinge fuori di sé e la fa<br />
consistere nel <strong>suo</strong> essere altro. Ci troviamo a un punto di svolta se si considerano le prospettive <strong>del</strong><br />
per l’altro di Hegel o di Sartre. Non alienazione da superare, non smarrimento, ma affermazione di<br />
una soggettività che è se stessa in quanto è destinata ad altri. Si tratta, tuttavia, di una destinazione<br />
che, dentro di sé, non ha nulla <strong>del</strong>l’ineluttab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> destino, bensì ridefinisce <strong>il</strong> senso e la portata <strong>del</strong>la<br />
libertà che privata <strong>del</strong>la potenza ‘negativa’ <strong>del</strong>l’autoaffermazione produttrice di violenza si esercita<br />
come responsab<strong>il</strong>ità.<br />
La riflessione di Bonhoeffer in questa direzione, ha esercitato e continua ad esercitare un<br />
grande fascino, non soltanto per la grandezza <strong>del</strong>la sua testimonianza di martire <strong>del</strong>la resistenza al<br />
nazismo, ma anche per la lucidità anticipatrice con cui ha presentato alcune sue tesi. La sua<br />
prospettiva è incentrata in una cristologia forte che nella Gestaltung (conformazione) a Cristo trova <strong>il</strong><br />
paradigma esistenziale fondamentale. È nel saggio centrale <strong>del</strong>l’Etica, opera rimasta incompiuta e<br />
pubblicata con redazioni diverse, intitolato La storia e <strong>il</strong> bene che <strong>il</strong> teologo tedesco si confronta con <strong>il</strong><br />
nostro tema. In modo assolutamente categorico Bonhoeffer afferma: “Non esiste uomo che possa<br />
sfuggire alla responsab<strong>il</strong>ità e cioè alla sostituzione vicaria”. Poco oltre, in una pagina di rara densità<br />
leggiamo: “Poiché Gesù – la vita, la nostra vita – è vissuto in qualità di Figlio di Dio fattosi uomo<br />
vicariamente per noi, ogni vita umana è attraverso di lui essenzialmente una vita vicaria. Egli non era<br />
<strong>il</strong> singolo che volesse pervenire alla propria perfezione, bensì visse solo come colui che ha assunto e<br />
porta in sé l’io di tutti gli uomini. <strong>Il</strong> <strong>suo</strong> vivere, fare, soffrire, nella loro interezza furono sostituzione<br />
18<br />
Si veda ancora di Jüngel <strong>il</strong> par. 24, “Dio come evento <strong>del</strong>lo Spirito”, pp. 482 sgg.<br />
11