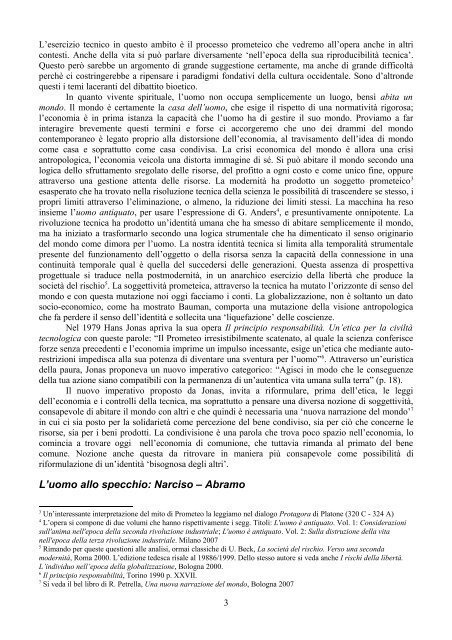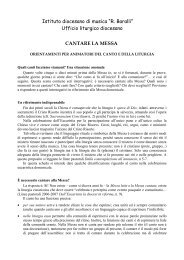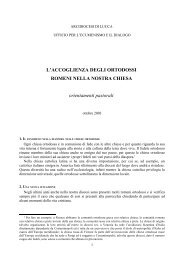Prof. Emilio Baccarini Alla ricerca del significante. Il sé e il suo futuro
Prof. Emilio Baccarini Alla ricerca del significante. Il sé e il suo futuro
Prof. Emilio Baccarini Alla ricerca del significante. Il sé e il suo futuro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’esercizio tecnico in questo ambito è <strong>il</strong> processo prometeico che vedremo all’opera anche in altri<br />
contesti. Anche <strong>del</strong>la vita si può parlare diversamente ‘nell’epoca <strong>del</strong>la sua riproducib<strong>il</strong>ità tecnica’.<br />
Questo però sarebbe un argomento di grande suggestione certamente, ma anche di grande difficoltà<br />
perchè ci costringerebbe a ripensare i paradigmi fondativi <strong>del</strong>la cultura occidentale. Sono d’altronde<br />
questi i temi laceranti <strong>del</strong> dibattito bioetico.<br />
In quanto vivente spirituale, l’uomo non occupa semplicemente un luogo, bensì abita un<br />
mondo. <strong>Il</strong> mondo è certamente la casa <strong>del</strong>l’uomo, che esige <strong>il</strong> rispetto di una normatività rigorosa;<br />
l’economia è in prima istanza la capacità che l’uomo ha di gestire <strong>il</strong> <strong>suo</strong> mondo. Proviamo a far<br />
interagire brevemente questi termini e forse ci accorgeremo che uno dei drammi <strong>del</strong> mondo<br />
contemporaneo è legato proprio alla distorsione <strong>del</strong>l’economia, al travisamento <strong>del</strong>l’idea di mondo<br />
come casa e soprattutto come casa condivisa. La crisi economica <strong>del</strong> mondo è allora una crisi<br />
antropologica, l’economia veicola una distorta immagine di sé. Si può abitare <strong>il</strong> mondo secondo una<br />
logica <strong>del</strong>lo sfruttamento sregolato <strong>del</strong>le risorse, <strong>del</strong> profitto a ogni costo e come unico fine, oppure<br />
attraverso una gestione attenta <strong>del</strong>le risorse. La modernità ha prodotto un soggetto prometeico 3<br />
esasperato che ha trovato nella risoluzione tecnica <strong>del</strong>la scienza le possib<strong>il</strong>ità di trascendere se stesso, i<br />
propri limiti attraverso l’eliminazione, o almeno, la riduzione dei limiti stessi. La macchina ha reso<br />
insieme l’uomo antiquato, per usare l’espressione di G. Anders 4 , e presuntivamente onnipotente. La<br />
rivoluzione tecnica ha prodotto un’identità umana che ha smesso di abitare semplicemente <strong>il</strong> mondo,<br />
ma ha iniziato a trasformarlo secondo una logica strumentale che ha dimenticato <strong>il</strong> senso originario<br />
<strong>del</strong> mondo come dimora per l’uomo. La nostra identità tecnica si limita alla temporalità strumentale<br />
presente <strong>del</strong> funzionamento <strong>del</strong>l’oggetto o <strong>del</strong>la risorsa senza la capacità <strong>del</strong>la connessione in una<br />
continuità temporale qual è quella <strong>del</strong> succedersi <strong>del</strong>le generazioni. Questa assenza di prospettiva<br />
progettuale si traduce nella postmodernità, in un anarchico esercizio <strong>del</strong>la libertà che produce la<br />
società <strong>del</strong> rischio 5 . La soggettività prometeica, attraverso la tecnica ha mutato l’orizzonte di senso <strong>del</strong><br />
mondo e con questa mutazione noi oggi facciamo i conti. La globalizzazione, non è soltanto un dato<br />
socio-economico, come ha mostrato Bauman, comporta una mutazione <strong>del</strong>la visione antropologica<br />
che fa perdere <strong>il</strong> senso <strong>del</strong>l’identità e sollecita una ‘liquefazione’ <strong>del</strong>le coscienze.<br />
Nel 1979 Hans Jonas apriva la sua opera <strong>Il</strong> principio responsab<strong>il</strong>ità. Un’etica per la civ<strong>il</strong>tà<br />
tecnologica con queste parole: “<strong>Il</strong> Prometeo irresistib<strong>il</strong>mente scatenato, al quale la scienza conferisce<br />
forze senza precedenti e l’economia imprime un impulso incessante, esige un’etica che mediante autorestrizioni<br />
impedisca alla sua potenza di diventare una sventura per l’uomo” 6 . Attraverso un’euristica<br />
<strong>del</strong>la paura, Jonas proponeva un nuovo imperativo categorico: “Agisci in modo che le conseguenze<br />
<strong>del</strong>la tua azione siano compatib<strong>il</strong>i con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra” (p. 18).<br />
<strong>Il</strong> nuovo imperativo proposto da Jonas, invita a riformulare, prima <strong>del</strong>l’etica, le leggi<br />
<strong>del</strong>l’economia e i controlli <strong>del</strong>la tecnica, ma soprattutto a pensare una diversa nozione di soggettività,<br />
consapevole di abitare <strong>il</strong> mondo con altri e che quindi è necessaria una ‘nuova narrazione <strong>del</strong> mondo’ 7<br />
in cui ci sia posto per la solidarietà come percezione <strong>del</strong> bene condiviso, sia per ciò che concerne le<br />
risorse, sia per i beni prodotti. La condivisione è una parola che trova poco spazio nell’economia, lo<br />
comincia a trovare oggi nell’economia di comunione, che tuttavia rimanda al primato <strong>del</strong> bene<br />
comune. Nozione anche questa da ritrovare in maniera più consapevole come possib<strong>il</strong>ità di<br />
riformulazione di un’identità ‘bisognosa degli altri’.<br />
L’uomo allo specchio: Narciso – Abramo<br />
3<br />
Un’interessante interpretazione <strong>del</strong> mito di Prometeo la leggiamo nel dialogo Protagora di Platone (320 C - 324 A)<br />
4<br />
L’opera si compone di due volumi che hanno rispettivamente i segg. Titoli: L'uomo è antiquato. Vol. 1: Considerazioni<br />
sull'anima nell'epoca <strong>del</strong>la seconda rivoluzione industriale; L'uomo è antiquato. Vol. 2: Sulla distruzione <strong>del</strong>la vita<br />
nell'epoca <strong>del</strong>la terza rivoluzione industriale. M<strong>il</strong>ano 2007<br />
5<br />
Rimando per queste questioni alle analisi, ormai classiche di U. Beck, La società <strong>del</strong> rischio. Verso una seconda<br />
modernità, Roma 2000. L’edizione tedesca risale al 19886/1999. Dello stesso autore si veda anche I rischi <strong>del</strong>la libertà.<br />
L’individuo nell’epoca <strong>del</strong>la globalizzazione, Bologna 2000.<br />
6<br />
<strong>Il</strong> principio responsab<strong>il</strong>ità, Torino 1990 p. XXVII.<br />
7<br />
Si veda <strong>il</strong> bel libro di R. Petrella, Una nuova narrazione <strong>del</strong> mondo, Bologna 2007<br />
3