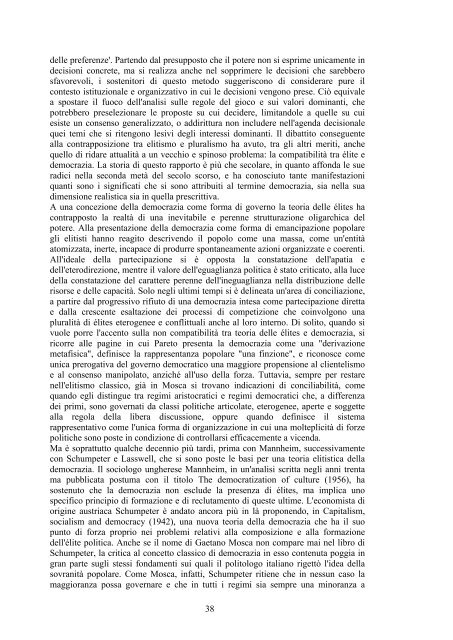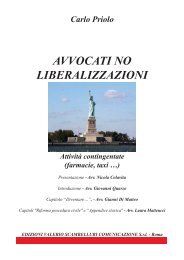Processo alla - Avvocato Carlo Priolo
Processo alla - Avvocato Carlo Priolo
Processo alla - Avvocato Carlo Priolo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
delle preferenze'. Partendo dal presupposto che il potere non si esprime unicamente in<br />
decisioni concrete, ma si realizza anche nel sopprimere le decisioni che sarebbero<br />
sfavorevoli, i sostenitori di questo metodo suggeriscono di considerare pure il<br />
contesto istituzionale e organizzativo in cui le decisioni vengono prese. Ciò equivale<br />
a spostare il fuoco dell'analisi sulle regole del gioco e sui valori dominanti, che<br />
potrebbero preselezionare le proposte su cui decidere, limitandole a quelle su cui<br />
esiste un consenso generalizzato, o addirittura non includere nell'agenda decisionale<br />
quei temi che si ritengono lesivi degli interessi dominanti. Il dibattito conseguente<br />
<strong>alla</strong> contrapposizione tra elitismo e pluralismo ha avuto, tra gli altri meriti, anche<br />
quello di ridare attualità a un vecchio e spinoso problema: la compatibilità tra élite e<br />
democrazia. La storia di questo rapporto è più che secolare, in quanto affonda le sue<br />
radici nella seconda metà del secolo scorso, e ha conosciuto tante manifestazioni<br />
quanti sono i significati che si sono attribuiti al termine democrazia, sia nella sua<br />
dimensione realistica sia in quella prescrittiva.<br />
A una concezione della democrazia come forma di governo la teoria delle élites ha<br />
contrapposto la realtà di una inevitabile e perenne strutturazione oligarchica del<br />
potere. Alla presentazione della democrazia come forma di emancipazione popolare<br />
gli elitisti hanno reagito descrivendo il popolo come una massa, come un'entità<br />
atomizzata, inerte, incapace di produrre spontaneamente azioni organizzate e coerenti.<br />
All'ideale della partecipazione si è opposta la constatazione dell'apatia e<br />
dell'eterodirezione, mentre il valore dell'eguaglianza politica è stato criticato, <strong>alla</strong> luce<br />
della constatazione del carattere perenne dell'ineguaglianza nella distribuzione delle<br />
risorse e delle capacità. Solo negli ultimi tempi si è delineata un'area di conciliazione,<br />
a partire dal progressivo rifiuto di una democrazia intesa come partecipazione diretta<br />
e d<strong>alla</strong> crescente esaltazione dei processi di competizione che coinvolgono una<br />
pluralità di élites eterogenee e conflittuali anche al loro interno. Di solito, quando si<br />
vuole porre l'accento sulla non compatibilità tra teoria delle élites e democrazia, si<br />
ricorre alle pagine in cui Pareto presenta la democrazia come una "derivazione<br />
metafisica", definisce la rappresentanza popolare "una finzione", e riconosce come<br />
unica prerogativa del governo democratico una maggiore propensione al clientelismo<br />
e al consenso manipolato, anziché all'uso della forza. Tuttavia, sempre per restare<br />
nell'elitismo classico, già in Mosca si trovano indicazioni di conciliabilità, come<br />
quando egli distingue tra regimi aristocratici e regimi democratici che, a differenza<br />
dei primi, sono governati da classi politiche articolate, eterogenee, aperte e soggette<br />
<strong>alla</strong> regola della libera discussione, oppure quando definisce il sistema<br />
rappresentativo come l'unica forma di organizzazione in cui una molteplicità di forze<br />
politiche sono poste in condizione di controllarsi efficacemente a vicenda.<br />
Ma è soprattutto qualche decennio più tardi, prima con Mannheim, successivamente<br />
con Schumpeter e Lasswell, che si sono poste le basi per una teoria elitistica della<br />
democrazia. Il sociologo ungherese Mannheim, in un'analisi scritta negli anni trenta<br />
ma pubblicata postuma con il titolo The democratization of culture (1956), ha<br />
sostenuto che la democrazia non esclude la presenza di élites, ma implica uno<br />
specifico principio di formazione e di reclutamento di queste ultime. L'economista di<br />
origine austriaca Schumpeter è andato ancora più in là proponendo, in Capitalism,<br />
socialism and democracy (1942), una nuova teoria della democrazia che ha il suo<br />
punto di forza proprio nei problemi relativi <strong>alla</strong> composizione e <strong>alla</strong> formazione<br />
dell'élite politica. Anche se il nome di Gaetano Mosca non compare mai nel libro di<br />
Schumpeter, la critica al concetto classico di democrazia in esso contenuta poggia in<br />
gran parte sugli stessi fondamenti sui quali il politologo italiano rigettò l'idea della<br />
sovranità popolare. Come Mosca, infatti, Schumpeter ritiene che in nessun caso la<br />
maggioranza possa governare e che in tutti i regimi sia sempre una minoranza a<br />
38