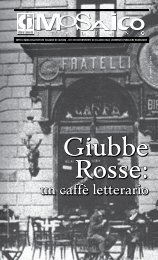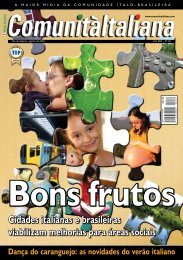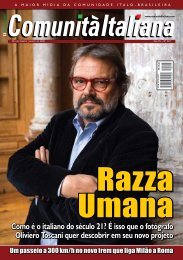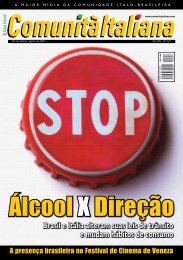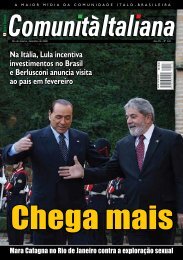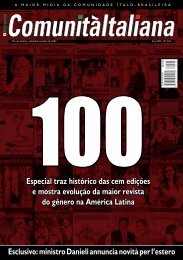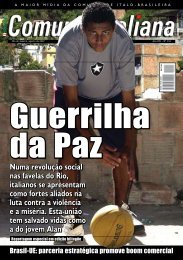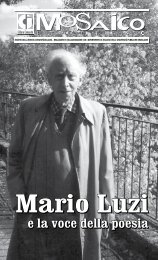ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana
ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana
ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
efficace e significativo, di realismo.<br />
Anzi, il pulp era iperrealistico,<br />
pur essendo una mimesi<br />
di «Hide», di ciò che era nascosto,<br />
sul punto di esplodere.<br />
Era, in qualche modo, il mostro<br />
che viene a galla dall’abisso.<br />
Mimesi della (in)coscienza<br />
e della (a)moralità dell’uomo<br />
contemporaneo. Non bisognava<br />
andar lontani per registrare<br />
violenza, volgarità, potenza e<br />
velocità allo stato puro. E ora<br />
gli scrittori ce lo insegnav<strong>ano</strong>.<br />
Tuttavia, il pericolo dell’incomprensione<br />
e del fraintendimento<br />
che il nuovo linguaggio<br />
si assumeva, credo sia tale<br />
e quale a quello assuntosi da<br />
D’Annunzio quando raccoglieva<br />
certe sue novelle.<br />
In pieno clima veristico,<br />
D’Annunzio, specie nelle Novelle<br />
della Pescara (1902), si<br />
allontanava dai modelli, dalla<br />
analisi scientifica del naturalismo<br />
francese alla Zola, per<br />
approdare a una propria cifra<br />
stilistica in grado di raccontare<br />
con precisione l’Abruzzo pur<br />
elevandolo, a tratti in una sfera<br />
leggendaria e favolosa, a simbolo<br />
di una umanità assolutamente<br />
degradata, bassa, povera,<br />
istintuale, selvaggiamente<br />
violenta e perversa, così poco<br />
morale, così tanto ribellistica e<br />
ferina che agli occhi dei contemporanei<br />
dovette sembrar<br />
sospetta. In quel tempo, coi<br />
vari verismi regionali, si doveva<br />
portare alla luce soprattutto<br />
la realtà di un’Italia ancora<br />
sconosciuta ai più: coglierne<br />
aspetti, tendenze specifiche,<br />
problematiche, tradizioni, usi<br />
e costumi. D’Annunzio condivideva<br />
con gli scrittori della<br />
sua generazione, tutti avidi<br />
lettori di Verga, il punto di partenza<br />
– registrare la realtà – ma<br />
non gli esiti. La sua innata e<br />
precoce capacità di deformare<br />
i fenomeni, alimentata dalla<br />
sua esuberanza sensuale, dal<br />
suo gusto per la carne, il sangue,<br />
l’odore, lo portarono, assieme<br />
a molte altre suggestioni<br />
letterarie, a scrivere delle scene<br />
di inaudita violenza. C’è,<br />
tra le pieghe dei suoi racconti,<br />
un empito pulp che a molti lettori<br />
di allora dovette sembrare<br />
superfluo, irrilevante, ma che<br />
non lo fu, così come non lo fu<br />
nel caso di Nove.<br />
Questa scenetta pulp è<br />
tratta dalle Novelle della Pescara<br />
aprendo a caso il libro.<br />
C’è una ribellione in corso, i<br />
ribelli assedi<strong>ano</strong> un palazzo<br />
gentilizio, a una finestra compare<br />
un uomo: «– Mazzagrogna!<br />
Mazzagrogna! A morte<br />
il ruffi<strong>ano</strong>! A morte il guercio!<br />
– gridav<strong>ano</strong> tutti accalcandosi<br />
per iscagliar più da vicino<br />
l’insulto. Il Mazzagrogna stese<br />
una m<strong>ano</strong>, come per sedare i<br />
clamori; raccolse tutta la sua<br />
potenza vocale; e incominciò<br />
col nome del Re, quasi promulgasse<br />
una legge, per incutere<br />
al popolo il rispetto. – In<br />
nome di S. M. Ferdinando II,<br />
per la grazia di Dio, Re delle<br />
Due Sicilie, di Gerusalemme...–.<br />
– A morte il ladro! –<br />
Due, tre schioppettate risonarono<br />
fra le grida; e l’arringatore,<br />
colpito al petto e in fronte,<br />
vacillò, agitò in alto le mani e<br />
cadde in avanti. Nel cadere,<br />
la testa entrò fra l’un ferro e<br />
l’altro della ringhiera e penzolò<br />
di fuori come una zucca. Il<br />
sangue gocciolava sul terreno<br />
sottostante». Poi cominci<strong>ano</strong><br />
a tirar sassate al cranio che ad<br />
ogni colpo butta sangue a destra<br />
e a sinistra. Ma si potrebbe<br />
ricordare anche la barbarica<br />
pratica dell’incanata che<br />
compare nella Figlia di Iorio.<br />
Allora si chiamava gusto<br />
dell’orrido, e si diceva che<br />
veniva da certi aspetti del romanticismo<br />
– molto in voga,<br />
l’orrido e il macabro, anche<br />
tra gli scapigliati del secondo<br />
Ottocento che mentre baciav<strong>ano</strong><br />
una donna pensav<strong>ano</strong><br />
al teschio bianco che stava<br />
sotto la carne, vedi Tarchetti e<br />
compagni –, ma forse accanto<br />
al D’Annunzio sensuale,<br />
vate, superomista, esteta, notturno,<br />
comandante, c’è anche<br />
quello pulp. I linguaggi e<br />
le storie, dunque, si ripetono<br />
sotto luci diverse.<br />
Un’avventura teatrale<br />
di Ignazio Silone<br />
Andrea Santurb<strong>ano</strong><br />
Friedrich Nietzsche, nel suo<br />
Ecce homo, ricorda come –<br />
siamo nel 1883 – riponesse<br />
grandi aspettative nel viaggio<br />
da Roma alla volta della città<br />
dell’Aquila; L’Aquila da lui definita<br />
come l’antitesi dell’odiata<br />
Roma papalina, perché fondata<br />
da “un ateo e anticlericale<br />
comme il faut”, cioè Federico<br />
II di Svevia. Poi, per motivi<br />
poco chiari, queste aspettative<br />
non si concretizzarono e il<br />
grande filosofo tedesco, di salute<br />
già instabile, all’Aquila si<br />
fermò pochissimo, adducendo<br />
la vaga giustificazione climatica<br />
di uno scirocco che anche<br />
lì non gli avrebbe dato tregua.<br />
Questo aneddoto, più o<br />
meno conosciuto, si arricchisce<br />
di altri tasselli, se si pensa<br />
ad altre vicende storiche succedutesi<br />
nei dintorni del capoluogo<br />
abruzzese, vicende che<br />
evidentemente non avev<strong>ano</strong><br />
inficiato la visione “ideale” che<br />
Nietzsche conservava della città.<br />
Innanzitutto, la battaglia di<br />
Tagliacozzo nel 1268, che segnò<br />
definitivamente le sorti politiche<br />
dell’Italia meridionale.<br />
Gli angioini, infatti, capitanati<br />
da Carlo I d’Angiò, investito re<br />
di Sicilia da papa Clemente IV,<br />
sconfiggono le truppe di Corradino<br />
di Svevia, mettendo fine<br />
alle ambizioni imperialistiche<br />
degli Hohenstaufen e al loro<br />
plurisecolare governo in Sicilia.<br />
In questa circostanza, L’Aquila,<br />
già al centro di grandi dispute<br />
nei pochi anni intercorsi dalla<br />
propria nascita tra i suoi fondatori<br />
ghibellini e i “protetto-<br />
ri” guelfi, aveva compiuto una<br />
scelta filopapale appoggiando<br />
Carlo I. E di lì a poco, nell’agosto<br />
del 1294, sarebbe stata addirittura<br />
sede di una investitura<br />
papale: quella di Celestino V.<br />
Da questo confluire di storia e<br />
mito Ignazio Silone trae spunto,<br />
nel 1968, per una delle sue<br />
rare esperienze in campo teatrale:<br />
L’avventura d’un povero<br />
cristi<strong>ano</strong>.<br />
Come si sa, la tematica religiosa,<br />
sempre trattata in modo<br />
antidogmatico e antidottrinario,<br />
fu molto cara allo scrittore<br />
abruzzese. Il cineasta Ermanno<br />
Olmi, una volta, utilizzò un’efficace<br />
metafora per definire il<br />
cristianesimo siloni<strong>ano</strong>, allorché<br />
attribuì all’autore la straordinaria<br />
capacità di cogliere<br />
il trascendente con lo sguardo<br />
ben rivolto verso il basso, cioè<br />
verso la materialità quotidiana<br />
degli uomini e delle cose, e non<br />
restando a contemplare il cielo<br />
a testa in su. È noto con quanto<br />
drammatico e naturale lirismo<br />
lo scrittore non abbia mai<br />
smesso d’indagare sull’umile<br />
condizione umana stretta nei<br />
(Universidade Federal de Santa Catarina)<br />
difficili rapporti tra giustizia e<br />
potere, libertà e asservimento,<br />
politica e religione.<br />
Il “cafone” siloni<strong>ano</strong> è atavicamente<br />
legato alla sua terra<br />
marsicana e ad un senso pauperistico<br />
della religiosità. Silone<br />
si fece fautore per tutta la<br />
vita di un cristianesimo socialista,<br />
cogliendo da subito o quasi<br />
l’inadeguatezza dell’ortodossia<br />
comunista, nonché delle ideologie<br />
più estreme in generale, a<br />
rispondere alle esigenze intime<br />
di libera espressione dell’uomo.<br />
Il dialogismo de L’avventura<br />
d’un povero cristi<strong>ano</strong> ripercorre<br />
e dà voce, dunque, a<br />
molte delle problematiche già<br />
presenti nell’opera di Silone.<br />
Questo testo drammatico,<br />
diviso in tre tempi, può essere<br />
considerato un’opera ibrida. È<br />
innanzitutto un dramma storico,<br />
composto da lunghi dialoghi<br />
e concepito per un’azione<br />
scenica molto ridotta; in decisa<br />
controtendenza, tra l’altro,<br />
rispetto agli orientamenti<br />
teatrali degli anni ’60, che<br />
vedev<strong>ano</strong> affermarsi la desacralizzazione<br />
del testo, con i<br />
non-sense di Ionesco, Beckett<br />
e degli altri esponenti del cosiddetto<br />
“teatro dell’assurdo”,<br />
oppure privilegiare le creazioni<br />
collettive, i movimenti e le<br />
performance degli attori, per<br />
esempio del Leaving Theatre,<br />
con la gestualità e non la parola<br />
al centro della scena. In<br />
secondo luogo, il testo de L’avventura<br />
d’un povero cristi<strong>ano</strong><br />
viene pubblicato in un’edizione<br />
corredata da un ricco tessu-<br />
10 11