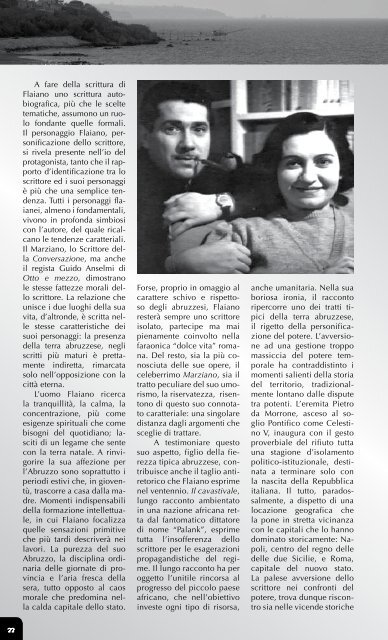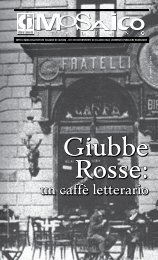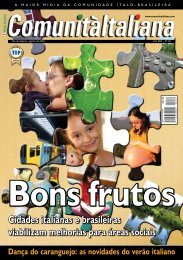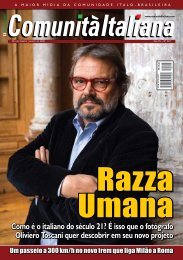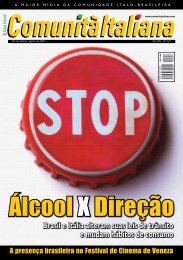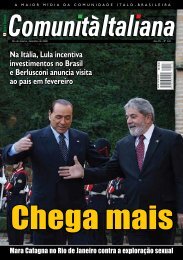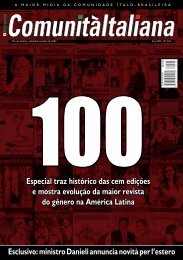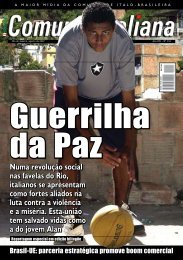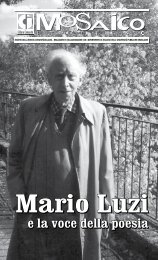ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana
ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana
ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A fare della scrittura di<br />
Flai<strong>ano</strong> uno scrittura autobiografica,<br />
più che le scelte<br />
tematiche, assumono un ruolo<br />
fondante quelle formali.<br />
Il personaggio Flai<strong>ano</strong>, personificazione<br />
dello scrittore,<br />
si rivela presente nell’io del<br />
protagonista, tanto che il rapporto<br />
d’identificazione tra lo<br />
scrittore ed i suoi personaggi<br />
è più che una semplice tendenza.<br />
Tutti i personaggi flaianei,<br />
almeno i fondamentali,<br />
vivono in profonda simbiosi<br />
con l’autore, del quale ricalc<strong>ano</strong><br />
le tendenze caratteriali.<br />
Il Marzi<strong>ano</strong>, lo Scrittore della<br />
Conversazione, ma anche<br />
il regista Guido Anselmi di<br />
Otto e mezzo, dimostr<strong>ano</strong><br />
le stesse fattezze morali dello<br />
scrittore. La relazione che<br />
unisce i due luoghi della sua<br />
vita, d’altronde, è scritta nelle<br />
stesse caratteristiche dei<br />
suoi personaggi: la presenza<br />
della terra abruzzese, negli<br />
scritti più maturi è prettamente<br />
indiretta, rimarcata<br />
solo nell’opposizione con la<br />
città eterna.<br />
L’uomo Flai<strong>ano</strong> ricerca<br />
la tranquillità, la calma, la<br />
concentrazione, più come<br />
esigenze spirituali che come<br />
bisogni del quotidi<strong>ano</strong>; lasciti<br />
di un legame che sente<br />
con la terra natale. A rinvigorire<br />
la sua affezione per<br />
l’Abruzzo sono soprattutto i<br />
periodi estivi che, in gioventù,<br />
trascorre a casa dalla madre.<br />
Momenti indispensabili<br />
della formazione intellettuale,<br />
in cui Flai<strong>ano</strong> focalizza<br />
quelle sensazioni primitive<br />
che più tardi descriverà nei<br />
lavori. La purezza del suo<br />
Abruzzo, la disciplina ordinaria<br />
delle giornate di provincia<br />
e l’aria fresca della<br />
sera, tutto opposto al caos<br />
morale che predomina nella<br />
calda capitale dello stato.<br />
Forse, proprio in omaggio al<br />
carattere schivo e rispettoso<br />
degli abruzzesi, Flai<strong>ano</strong><br />
resterà sempre uno scrittore<br />
isolato, partecipe ma mai<br />
pienamente coinvolto nella<br />
faraonica “dolce vita” romana.<br />
Del resto, sia la più conosciuta<br />
delle sue opere, il<br />
celeberrimo Marzi<strong>ano</strong>, sia il<br />
tratto peculiare del suo umorismo,<br />
la riservatezza, risentono<br />
di questo suo connotato<br />
caratteriale: una singolare<br />
distanza dagli argomenti che<br />
sceglie di trattare.<br />
A testimoniare questo<br />
suo aspetto, figlio della fierezza<br />
tipica abruzzese, contribuisce<br />
anche il taglio antiretorico<br />
che Flai<strong>ano</strong> esprime<br />
nel ventennio. Il cavastivale,<br />
lungo racconto ambientato<br />
in una nazione africana retta<br />
dal fantomatico dittatore<br />
di nome “Palank”, esprime<br />
tutta l’insofferenza dello<br />
scrittore per le esagerazioni<br />
propagandistiche del regime.<br />
Il lungo racconto ha per<br />
oggetto l’unitile rincorsa al<br />
progresso del piccolo paese<br />
afric<strong>ano</strong>, che nell’obiettivo<br />
investe ogni tipo di risorsa,<br />
anche umanitaria. Nella sua<br />
boriosa ironia, il racconto<br />
ripercorre uno dei tratti tipici<br />
della terra abruzzese,<br />
il rigetto della personificazione<br />
del potere. L’avversione<br />
ad una gestione troppo<br />
massiccia del potere temporale<br />
ha contraddistinto i<br />
momenti salienti della storia<br />
del territorio, tradizionalmente<br />
lont<strong>ano</strong> dalle dispute<br />
tra potenti. L’eremita Pietro<br />
da Morrone, asceso al soglio<br />
Pontifico come Celestino<br />
V, inaugura con il gesto<br />
proverbiale del rifiuto tutta<br />
una stagione d’isolamento<br />
politico-istituzionale, destinata<br />
a terminare solo con<br />
la nascita della Repubblica<br />
italiana. Il tutto, paradossalmente,<br />
a dispetto di una<br />
locazione geografica che<br />
la pone in stretta vicinanza<br />
con le capitali che lo hanno<br />
dominato storicamente: Napoli,<br />
centro del regno delle<br />
delle due Sicilie, e Roma,<br />
capitale del nuovo stato.<br />
La palese avversione dello<br />
scrittore nei confronti del<br />
potere, trova dunque riscontro<br />
sia nelle vicende storiche<br />
di molti celebri conterranei,<br />
sia nella letteratura coeva,<br />
dove il solo Silone lo ribadisce<br />
più volte con forza.<br />
Il suo percepire “lontana”<br />
la terra di origine, gli<br />
permette di approfondirne<br />
meglio alcuni caratteri peculiari,<br />
come la religiosità. Nel<br />
racconto Il Messia, pubblicato<br />
postumo nell’Autobiografia<br />
del Blu di Prussia, racconta<br />
d’un fantomatico prete<br />
abruzzese, improvvisatosi<br />
messia tra le sue terre. Nel<br />
racconto prende forma un<br />
Abruzzo irto di contraddizioni,<br />
arcaico e pag<strong>ano</strong>, dove la<br />
fede sposa la cultura contadina<br />
e la religione incontra la<br />
credulità popolare.<br />
“Se l’Abruzzo è la regione<br />
d’Italia dove la pratica<br />
della religione cristiana<br />
ha conservato molti caratteri<br />
pagani, è tuttavia<br />
anche la regione dove si<br />
“crede” nel senso più filosofico<br />
della parola : per<br />
il bisogno di credere alla<br />
metafisica stessa .Perciò<br />
in questo paese religione<br />
e vita spesso ,si identific<strong>ano</strong>:<br />
le Madonne Abruzzesi,<br />
per esempio, rispondono<br />
iconograficamente<br />
all’immagine della madre<br />
abruzzese: addolorata,<br />
sempre in angustia per i<br />
figli che lasci<strong>ano</strong> il paese<br />
in cerca di migliore fortuna,<br />
sempre vestita di nero<br />
per i lutti del parentado,<br />
col cuore trafitto da sette<br />
spade e due tonde lacrime<br />
eternamente fermate<br />
sulle guance” 1<br />
Questa particolare devozione<br />
evoca quella narrata da<br />
Silone in Fontamara, quando<br />
nel descrivere il culto di San<br />
Giuseppe da Copertino, mescola<br />
patriottismo e credulità.<br />
Proprio la colorita religiosità<br />
abruzzese, fatta di santi<br />
come di miti, appare l’ideale<br />
sottostrato su cui collocare<br />
le vicende di Don Oreste<br />
de Amicis, che verso il 1870<br />
si proclamò il nuovo Messia<br />
d’Abruzzo. Il contenuto<br />
della storia non rappresenta<br />
tuttavia una novità letteraria:<br />
è stato gia narrato dal De<br />
Nino e anche Gabriele d’Annunzio<br />
ne ha accennato in<br />
un suo romanzo. Come suo<br />
costume, Flai<strong>ano</strong> coglie nella<br />
vicenda del nuovo messia<br />
gli aspetti più comici e grotteschi,<br />
venandola di un provincialismo<br />
che a tratti tocca<br />
livelli esilaranti.<br />
“Don Oreste fu chiamato<br />
il “pretone” per le sue forme<br />
atletiche. Era patriota.<br />
Odiò sempre certi suoi parenti<br />
perché di principi non<br />
liberali. Spesso si recava<br />
nella fortezza di Pescara a<br />
visitare i prigionieri politici,<br />
portando giornali esteri che<br />
riceveva da un capit<strong>ano</strong><br />
svizzero in ritiro. Quando<br />
nel ‘60 il regno delle Due<br />
Sicilie fu unito all’Italia,<br />
don Oreste fece addirittura<br />
stranezze per la grande<br />
gioia. La notte del 25 con<br />
l’aiuto dei fratelli montò un<br />
palcoscenico con telone<br />
sull’altare maggiore” 2<br />
Questa breve dissertazione<br />
religiosa, non restituisce<br />
un Flai<strong>ano</strong> dedito ai grandi<br />
interrogativi o avvezzo all’indagine<br />
delle profondità spirituali,<br />
ma conferma un autore<br />
che guarda alla religione con<br />
disincanto e concreta ironia,<br />
la stessa che rivolge ai problemi<br />
concreti e alle fatiche<br />
quotidiane. Per Flai<strong>ano</strong><br />
la religione e la religiosità,<br />
sono concetti umani più che<br />
divini, e present<strong>ano</strong> particolare<br />
propensione ad incarnare<br />
tanto i valori culturali,<br />
quanto le stranezze di chi le<br />
professa. Sempre nel Messia<br />
l’autore ripete:<br />
“A lode di Don Oreste<br />
deve essere precisato che<br />
non cercò di imitare i miracoli<br />
più in voga (ma preferì<br />
riecheggiare gli avvenimenti<br />
biblici, e in un secondo<br />
genere tutto nuovo,<br />
come quello del treno, che<br />
a me è servito per approfondire<br />
le idee personali<br />
sul progresso, e l’evoluzione<br />
scientifica” 3<br />
La religiosità abruzzese<br />
del Messia e, in minima<br />
parte, l’ambiente familiare<br />
descritto nel Minore, costituiscono<br />
per Flai<strong>ano</strong> le chiavi<br />
di un ritorno alle origini:<br />
quell’Abruzzo cui è legato<br />
in modo imprescindibile.<br />
L’intensità del legame con la<br />
sua terra, è deducibile proprio<br />
dal primo volume degli<br />
scritti postumi, L’Autobiografia<br />
del blu di Prussia, che<br />
segnaliamo tra le opere più<br />
interessanti. In essa, specie<br />
quando il tono surreale dei<br />
racconti sposa lo stile caustico<br />
ammirabile in La pietra<br />
turchina, si genera un’ideale<br />
autobiografia indiretta;<br />
ponte tra il passato (spesso<br />
immaginario) in cui l’autore<br />
inizia la sua vita ed il caos<br />
creativo in cui la conclude.<br />
1 Ennio Flai<strong>ano</strong>, Opere. Scritti postumi, a cura di A. Longoni e M. Corti, Ed. Bompiani, Roma, 2001, p. 75<br />
2 Ennio Flai<strong>ano</strong>, Opere. Scritti postumi, p. 82<br />
3 Ennio Flai<strong>ano</strong>, Opere. Scritti postumi, p. 99<br />
22 23