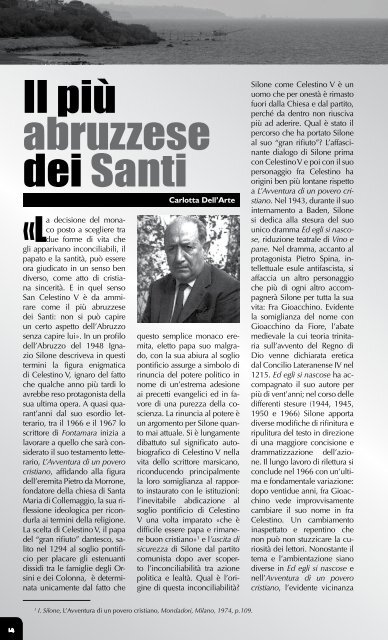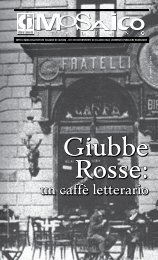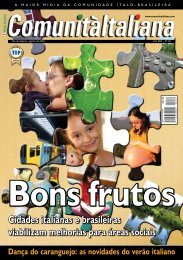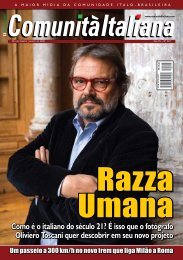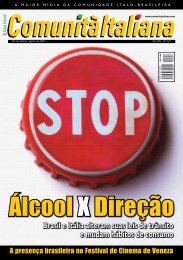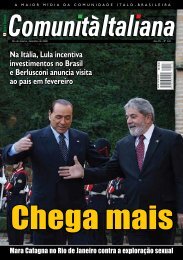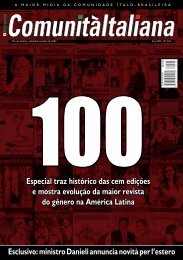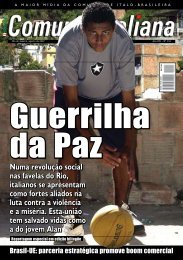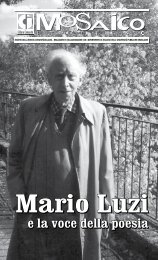ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana
ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana
ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il più<br />
abruzzese<br />
dei Santi<br />
Carlotta Dell’Arte<br />
decisione del monaco<br />
posto a scegliere tra «La<br />
due forme di vita che<br />
gli appariv<strong>ano</strong> inconciliabili, il<br />
papato e la santità, può essere<br />
ora giudicato in un senso ben<br />
diverso, come atto di cristiana<br />
sincerità. E in quel senso<br />
San Celestino V è da ammirare<br />
come il più abruzzese<br />
dei Santi: non si può capire<br />
un certo aspetto dell’Abruzzo<br />
senza capire lui». In un profilo<br />
dell’Abruzzo del 1948 Ignazio<br />
Silone descriveva in questi<br />
termini la figura enigmatica<br />
di Celestino V, ignaro del fatto<br />
che qualche anno più tardi lo<br />
avrebbe reso protagonista della<br />
sua ultima opera. A quasi quarant’anni<br />
dal suo esordio letterario,<br />
tra il 1966 e il 19<strong>67</strong> lo<br />
scrittore di Fontamara inizia a<br />
lavorare a quello che sarà considerato<br />
il suo testamento letterario,<br />
L’Avventura di un povero<br />
cristi<strong>ano</strong>, affidando alla figura<br />
dell’eremita Pietro da Morrone,<br />
fondatore della chiesa di Santa<br />
Maria di Collemaggio, la sua riflessione<br />
ideologica per ricondurla<br />
ai termini della religione.<br />
La scelta di Celestino V, il papa<br />
del “gran rifiuto” dantesco, salito<br />
nel 1294 al soglio pontificio<br />
per placare gli estenuanti<br />
dissidi tra le famiglie degli Orsini<br />
e dei Colonna, è determinata<br />
unicamente dal fatto che<br />
questo semplice monaco eremita,<br />
eletto papa suo malgrado,<br />
con la sua abiura al soglio<br />
pontificio assurge a simbolo di<br />
rinuncia del potere politico in<br />
nome di un’estrema adesione<br />
ai precetti evangelici ed in favore<br />
di una purezza della coscienza.<br />
La rinuncia al potere è<br />
un argomento per Silone quanto<br />
mai attuale. Si è lungamente<br />
dibattuto sul significato autobiografico<br />
di Celestino V nella<br />
vita dello scrittore marsic<strong>ano</strong>,<br />
riconducendo principalmente<br />
la loro somiglianza al rapporto<br />
instaurato con le istituzioni:<br />
l’inevitabile abdicazione al<br />
soglio pontificio di Celestino<br />
V una volta imparato «che è<br />
difficile essere papa e rimanere<br />
buon cristi<strong>ano</strong>» 1 e l’uscita di<br />
sicurezza di Silone dal partito<br />
comunista dopo aver scoperto<br />
l’inconciliabilità tra azione<br />
politica e lealtà. Qual è l’origine<br />
di questa inconciliabilità?<br />
1 I. Silone, L’Avventura di un povero cristi<strong>ano</strong>, Mondadori, Mil<strong>ano</strong>, 1974, p.109.<br />
Silone come Celestino V è un<br />
uomo che per onestà è rimasto<br />
fuori dalla Chiesa e dal partito,<br />
perché da dentro non riusciva<br />
più ad aderire. Qual è stato il<br />
percorso che ha portato Silone<br />
al suo “gran rifiuto”? L’affascinante<br />
dialogo di Silone prima<br />
con Celestino V e poi con il suo<br />
personaggio fra Celestino ha<br />
origini ben più lontane rispetto<br />
a L’Avventura di un povero cristi<strong>ano</strong>.<br />
Nel 1943, durante il suo<br />
internamento a Baden, Silone<br />
si dedica alla stesura del suo<br />
unico dramma Ed egli si nascose,<br />
riduzione teatrale di Vino e<br />
pane. Nel dramma, accanto al<br />
protagonista Pietro Spina, intellettuale<br />
esule antifascista, si<br />
affaccia un altro personaggio<br />
che più di ogni altro accompagnerà<br />
Silone per tutta la sua<br />
vita: Fra Gioacchino. Evidente<br />
la somiglianza del nome con<br />
Gioacchino da Fiore, l’abate<br />
medievale la cui teoria trinitaria<br />
sull’avvento del Regno di<br />
Dio venne dichiarata eretica<br />
dal Concilio Lateranense IV nel<br />
1215. Ed egli si nascose ha accompagnato<br />
il suo autore per<br />
più di vent’anni; nel corso delle<br />
differenti stesure (1944, 1945,<br />
1950 e 1966) Silone apporta<br />
diverse modifiche di rifinitura e<br />
ripulitura del testo in direzione<br />
di una maggiore concisione e<br />
drammatizzazione dell’azione.<br />
Il lungo lavoro di rilettura si<br />
conclude nel 1966 con un’ultima<br />
e fondamentale variazione:<br />
dopo ventidue anni, fra Gioacchino<br />
vede improvvisamente<br />
cambiare il suo nome in fra<br />
Celestino. Un cambiamento<br />
inaspettato e repentino che<br />
non può non stuzzicare la curiosità<br />
dei lettori. Nonostante il<br />
tema e l’ambientazione si<strong>ano</strong><br />
diverse in Ed egli si nascose e<br />
nell’Avventura di un povero<br />
cristi<strong>ano</strong>, l’evidente vicinanza<br />
temporale tra il cambiamento<br />
del nome di fra Gioacchino in<br />
fra Celestino nel dramma teatrale,<br />
e la stesura di un’opera<br />
interamente dedicata all’eremita<br />
divenuto papa, non può non<br />
essere presa in considerazione.<br />
Infatti la variazione del nome<br />
da fra Gioacchino a fra Celestino<br />
racchiude a mio avviso,<br />
in una parabola discendente il<br />
travagliato rapporto di Silone<br />
con la fede. L’attenzione verso<br />
l’abate da Fiore nasce in Silone<br />
dal riconoscimento, all’interno<br />
del messaggio gioachimita, di<br />
quell’utopia della giustizia che<br />
fin dai suoi primi contatti con<br />
la lega dei contadini di Pescina<br />
lo aveva sempre guidato nella<br />
sua attività politica e letteraria<br />
nel ricordo «dell’attesa di una<br />
terza età del genere um<strong>ano</strong>,<br />
l’età dello Spirito, senza Chiesa,<br />
senza Stato, senza coercizioni,<br />
in una società ugualitaria,<br />
sobria, umile e benigna,<br />
affidata alla spontanea carità<br />
degli uomini» 2 . Gioacchino da<br />
Fiore si rivela l’anello principale<br />
a partire dal quale l’appello<br />
allo Spirito di liberazione si propaga<br />
nei secoli, e di cui Silone<br />
subisce un indubbio fascino. Il<br />
personaggio di fra Gioacchino<br />
si rende portatore di una<br />
nuova speranza di ribellione<br />
al destino: «l’antica speranza<br />
del Regno, l’antica attesa della<br />
carità che sostituisca la legge,<br />
l’antico sogno di Gioacchino<br />
da Fiore, degli Spirituali e dei<br />
Celestini» 3 . Fra Gioacchino rimane<br />
figura essenzialmente<br />
escatologica 4 , attesa impazien-<br />
te di ultimi eventi: «nelle Sante<br />
Scritture è segnato il destino di<br />
noi cristiani. Per ora esso fermo<br />
nella pagina del Venerdì<br />
Santo, nella pagina del Cristo<br />
in agonia» 5 . Silone ha ragione<br />
quando a fra Celestino farà dire<br />
che « è impossibile scoprire la<br />
continuità dell’agonia di Cristo<br />
e rassegnarsi» 6 . Se è vero<br />
che Lui è la vita e dà la vita, il<br />
Venerdì Santo si può accettare<br />
solo con la speranza dell’avvenimento<br />
pasquale della domenica.<br />
Nella Resurrezione di<br />
Cristo si rivela tutta la fede: «se<br />
Cristo non è risorto, vana è la<br />
nostra fede» 7 . Con l’incarnazione<br />
Dio è entrato nella storia,<br />
il cristianesimo è un fatto<br />
storico, e in quanto storico è<br />
presente. Questo avvenimento<br />
è presente ed è conservato<br />
nella Chiesa: Chiesa spirituale<br />
e Chiesa istituzionale non si<br />
possono separare, è una sola<br />
Chiesa presente e concreta nelle<br />
sue glorie e nelle sue debolezze.<br />
L’utopia siloniana della<br />
realizzazione della giustizia e<br />
dell’uguaglianza sociale è però<br />
evidentemente inconciliabile<br />
con la realtà contemporanea<br />
della Chiesa: «la storia dell’utopia<br />
è in definitiva la contropartita<br />
della storia ufficiale della<br />
Chiesa. […] La Chiesa da<br />
quando si fondò […] con il suo<br />
apparato dogmatico ed ecclesiastico,<br />
ha considerato sempre<br />
con sospetto ogni resipiscenza<br />
del mito. Dal momento che la<br />
Chiesa presentò se stessa come<br />
il Regno, […] essa ha cercato<br />
di reprimere ogni movimento<br />
con tendenza a promuovere<br />
un ritorno alla credenza primitiva.<br />
L’utopia è il suo rimorso» 8 .<br />
Crolla così il sogno di Gioacchino<br />
da Fiore, l’ennesimo<br />
tentativo di Silone di realizzare<br />
la sua utopia non si concretizza<br />
neanche con l’avvento del<br />
Regno dello Spirito. Distrutta<br />
ogni speranza fra Gioacchino<br />
lascia silenziosamente la scena<br />
per far entrare il papa del gran<br />
rifiuto dantesco: «l’avventura<br />
di Celestino si svolse, per un<br />
lungo tratto, nell’illusione che<br />
le due diverse vie di seguire<br />
Cristo si potessero ravvicinare e<br />
unire. Ma, costretto a scegliere,<br />
non esitò» 9 . Nel passaggio da<br />
fra Gioacchino a fra Celestino<br />
Ignazio Silone delinea le condizioni<br />
che hanno impedito in<br />
lui la crescita della fede. Con<br />
l’utopia gioachimita dell’avvento<br />
del Regno dello Spirito,<br />
Silone credeva che fosse ancora<br />
possibile trovare la fede in<br />
questa attesa, la quale però, se<br />
non parte dalla certezza della<br />
Resurrezione di Cristo si riduce<br />
ad un’illusione, ad un’amara<br />
rassegnazione all’agonia<br />
di Cristo. Con fra Gioacchino<br />
Silone aveva cercato di mantenere<br />
in vita la fede nell’attesa<br />
del Regno, ma quando si<br />
è reso conto che l’attesa non<br />
può nascere da un’incertezza<br />
permanente, e deciso anche a<br />
non rassegnarsi semplicemente<br />
all’agonia della Croce, Silone<br />
abbandona il sogno di Gioacchino<br />
da Fiore riconoscendo<br />
come unica possibilità il gran<br />
rifiuto di Celestino V.<br />
2 I.Silone, L’Avventura di un povero cristi<strong>ano</strong>, Oscar Mondadori, Mil<strong>ano</strong>, 1974, p.17.<br />
3 I.Silone, Uscita di sicurezza, Longanesi, Mil<strong>ano</strong>, 1971, p.81.<br />
4 Nei suoi studi su Gioacchino da Fiore Silone è stato influenzato dalla lettura che ne aveva dato Ernesto Buonaiuti,<br />
il quale, indotto dalle sue idee moderniste, riconosceva negli scritti di Gioacchino una preoccupazione che non è mai<br />
teologica, bensì puro intento morale ed escatologico. La differenza nell’attribuire alla teoria delle tre età dello Spirito di<br />
Gioacchino un intento escatologico piuttosto che uno teologico, è determinante per delineare la figura di fra Gioacchino.<br />
5 I.Silone, Ed egli si nascose, Città Nuova, Roma, 2000, p.39.<br />
6 Ivi p.40.<br />
7 1 Cor 15,17.<br />
8 I. Silone, L’Avventura di un povero cristi<strong>ano</strong>, Oscar Mondadori, Mil<strong>ano</strong>, 1974 p. 18<br />
14 15<br />
9 Ibidem