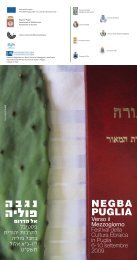Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
pagine ebraiche n. 7 | luglio 2012<br />
ú– YIBANEH!<br />
Trieste, la sinagoga compie cent’anni<br />
ú–– Adachiara<br />
Zevi<br />
architetto<br />
Inaugurata nel 1912, la sinagoga<br />
di Trieste compie 100 anni. Nel<br />
1903, quando è bandito il concorso,<br />
esistono in città tre “scole”,<br />
mimetizzate in edifici esistenti: Scola<br />
Piccola, per gli ebrei askenaziti, Scola<br />
Grande, di rito sefardita e askenazita,<br />
Scola Vivante, di rito sefardita. Grazie<br />
allo status di porto franco dichiarato<br />
dagli Asburgo nel 1719, all’Editto<br />
di Tolleranza del 1781 e, quattro<br />
anni dopo, all’apertura del ghetto,<br />
ebrei da tutta Europa convergono<br />
su Trieste per esercitare le loro attività<br />
professionali, commerciali, finanziarie,<br />
assicurative, oltre che intellettuali.<br />
Si aggiungono presto gli<br />
ebrei di Corfù che, grazie a un dialetto<br />
che mescola pugliese-veneto a<br />
greco ed ebraico, arricchiscono la liturgia<br />
ebraico-triestina. Nessuna ‘scola’<br />
è sopravvissuta: l’àron di Scola<br />
Vivante è ad Abbazia, quello di Scola<br />
Grande a Fiume, quello di Scola Piccola<br />
a Tel Aviv. L’idea di una unica<br />
grande sinagoga risale al 1870 ma il<br />
progetto dell’ingegner Geiringer è<br />
accantonato fino al concorso del<br />
1903.<br />
Al bando sono allegati: la planimetria<br />
del luogo - il Borgo Franceschino<br />
- schizzi e sezioni degli edifici<br />
circostanti, indicazioni tecniche relative<br />
al sottosuolo, alle uscite di sicurezza,<br />
alla resistenza alle intemperie<br />
e al tempo. Si pensa insomma<br />
a un edificio monumentale, sicuro<br />
ed eterno. Massima libertà è lasciata<br />
ai partecipanti circa le scelte stilistiche<br />
e formali. 42 i concorrenti, da<br />
tutto l’Impero, le cui proposte, divise<br />
per stile - gotico, secessionista, orientale<br />
- sono oggi di ardua consultazione<br />
causa la disseminazione e spesso<br />
dispersione degli originali. Nonostante<br />
le 42 sedute, la giuria, composta<br />
da esponenti della Comunità<br />
ebraica triestina e dal direttore della<br />
Regia Accademia e Istituto di Belle<br />
Arti di Venezia, non è in grado di<br />
indicare un unico vincitore: come<br />
per tutti i grandi concorsi, i progetti<br />
sono esposti nel 1904 in una mostra<br />
al Ridotto del Politeama. Sorprendente<br />
la motivazione della fumata<br />
nera: l’inadeguatezza delle proposte<br />
alle aspirazioni moderne della Comunità.<br />
“Che cosa c’entra il medioevo<br />
col romanico e col gotico nella<br />
religione ebraica? Come col bizantino<br />
e col moresco? Se gli artisti<br />
avessero pensato alla meravigliosa<br />
capacità d’adattamento degli Israeliti<br />
e al loro grande amore per il moderno,<br />
non si sarebbero umiliati nel-<br />
l’imitazione, ma avrebbero acceso la<br />
loro fantasia alla creazione del novo…!”.<br />
Una comunità aperta, variegata<br />
e cosmopolita esige dunque un<br />
edificio linguisticamente innovativo,<br />
moderno e al passo con i tempi. Fallito<br />
l’incarico ai due architetti ungheresi<br />
favoriti dalla giuria, non resta<br />
che l’opzione per un architetto triestino.<br />
Quasi inevitabile che la scelta<br />
cada sullo studio Berlam, fondato da<br />
Giovanni Andrea nel 1847 e portato<br />
avanti dal figlio Ruggero e dal nipote<br />
Arduino fino al 1936: una vera dinastia,<br />
con all’attivo importanti in-<br />
ARCHITETTURA<br />
u La sinagoga di Trieste festeggia i suoi<br />
cent’anni il primo luglio. A realizzarla,<br />
dopo un concorso che aveva raccolto ben<br />
42 progetti senza che nessuno riuscisse a soddisfare la giuria, fu lo studio<br />
Berlam. Il risultato è un edificio monumentale e al tempo stesso austero, Le<br />
belle immagini che illustrano questa pagina sono tratte dalla pubblicazione di<br />
Aulo Guagnini La sinagoga di Trieste - Architettura, cantiere, protagonisti<br />
edita dal Rotary club Trieste.<br />
carichi professionali e ottimi agganci<br />
istituzionali.<br />
Realizzata nel tempo record di quattro<br />
anni, la sinagoga di Berlam spicca<br />
nettamente su altri esempi coevi: è<br />
monumentale – l’altezza della cupola<br />
raggiunge i 30 metri e la dimensione<br />
è calcolata per mille persone – ma<br />
allo stesso tempo austera; denuncia<br />
all’esterno l’articolazione degli spazi<br />
interni; predilige volumi squadrati,<br />
seppur fortemente rastremati; adotta<br />
una decorazione ricca e preziosa ma<br />
non ostentata, a intaglio più che a<br />
rilievo; è rivoluzionaria infine sul pia-<br />
Particolari degli esterni. Foto Alida Cartagine - da Aulo Guagnini “La Sinagoga di Trieste. Architettura, cantiere, protagonisti” - Rotary Trieste<br />
Foto: Marino Ierman - da Aulo Guagnini “La Sinagoga di Trieste. Architettura, cantiere, protagonisti” - Rotary Trieste<br />
www.moked.it<br />
Foto: Marino Ierman - da Aulo Guagnini “La Sinagoga di Trieste. Architettura, cantiere, protagonisti” - Rotary Trieste<br />
Archivio Storico della Comunità Ebraica<br />
da Aulo Guagnini “La Sinagoga di Trieste. Architettura,<br />
cantiere, protagonisti” - Rotary Trieste<br />
no tecnico e strutturale. Tre i corpi<br />
principali: l’avancorpo loggiato su<br />
piazza Giotti, con il grande rosone<br />
in pietra a forma di Stella di Davide<br />
- originalmente collocato sul fianco<br />
- che ospita l’Oratorio; il vano centrale,<br />
un possente cubo sovrastato<br />
dalla cupola, che si protende, all’estremo<br />
opposto dell’ingresso, nella<br />
zona absidale composta da un semicilindro<br />
che ospita l’Aron haKodesh,<br />
e da due parallelepipedi, coperti<br />
rispettivamente da una semicupola<br />
e da due cupolini; la torre a<br />
base rettangolare, infine, che sor-<br />
Fototeca dei CMSA - da Aulo Guagnini “La Sinagoga di Trieste. Architettura, cantiere, protagonisti” - Rotary Trieste<br />
Fototeca dei CMSA - da Aulo Guagnini “La Sinagoga di Trieste. Architettura, cantiere, protagonisti” - Rotary Trieste<br />
/ P15<br />
monta l’ingresso principale su via<br />
Donizetti ma è invisibile all’interno.<br />
A dispetto degli anatemi contro i<br />
partecipanti al concorso del 1903,<br />
tacciati di ricorrere a “stili fortemente<br />
e inscindibilmente legati a edifici cristiani”,<br />
la sinagoga di Berlam è, a<br />
detta di Aulo Guagnini, autore di un<br />
dotto studio pubblicato dal Rotary<br />
di Trieste, un raro esempio di adattamento<br />
al culto ebraico di un impianto<br />
basilicale.<br />
E’ ancora lui a riferirci le scelte degli<br />
architetti: “Si ricorse allo stile della<br />
Siria Centrale del IV secolo dell’era<br />
volgare, singolare fenomeno di ripullulamento<br />
delle antichissime forme<br />
assire di mezzo ai ruderi dell’arte<br />
romana…Il nostro è dunque uno stile<br />
fortemente influenzato dalle preesistenti<br />
forme d’una remota civiltà e<br />
dalle condizioni peculiari al suo paese<br />
d’origine”.<br />
Architettura siriana tardo-antica,<br />
dunque, la cui influenza sull’arte medioevale<br />
europea è sostenuta con<br />
convinzione dallo storico dell’arte<br />
Josef Strzygowski, ben noto ai Berlam,<br />
ma anche struttura romana nelle<br />
quattro grandi volte a botte su cui<br />
s’innesta la cupola culminante in<br />
un’apertura circolare.<br />
Nel rispetto delle tre prerogative di<br />
ogni sinagoga: l’Aron haKodesh,<br />
orientato a est, decisamente ridondante<br />
nella struttura a baldacchino<br />
realizzato con preziosi marmi policromi,<br />
con porte di rame e bronzo<br />
e culminante nelle Tavole della Legge;<br />
la tevah e i tre grandiosi matronei,<br />
cui si accede da due scaloni anteriori.<br />
Sono però le innovazioni tecniche<br />
e tecnologiche, l’organizzazione<br />
del cantiere, la qualità delle<br />
maestranze, la polifonia dei materiali<br />
a fare della sinagoga di Trieste un<br />
caso paradigmatico, “uno degli<br />
esempi più rilevanti nella storia della<br />
tecnica edilizia italiana degli inizi<br />
del Novecento”. Se le strutture di<br />
fondazione sono calibrate per fronteggiare<br />
la natura argillosa del terreno,<br />
le piastre in calcestruzzo armato<br />
nelle murature, le travi che sostengono<br />
le gallerie dei matronei ma<br />
soprattutto la cupola, uno dei primi<br />
esempi in Europa a doppio guscio<br />
parabolico, richiedono, per il loro<br />
carattere pionieristico, l’intervento<br />
di maestranze bavaresi.<br />
Esemplari le decorazioni, in materiali<br />
allo stesso tempo preziosi e “ingannevoli”:<br />
pietra bianca artificiale, stesa<br />
a intonaco sulla superficie muraria<br />
per l’esterno, stucco lucido e mosaico<br />
per l’abside, marmi per balaustre,<br />
podio e gradinate, pietre di taglio<br />
per portali e rosoni. E, per confermare<br />
il duplice richiamo alle origini<br />
orientali e alla patria d’adozione, il<br />
pregevole portale d’ingresso evoca<br />
sia il Duomo di Orvieto di Lorenzo<br />
Maitani sia un monastero armeno.