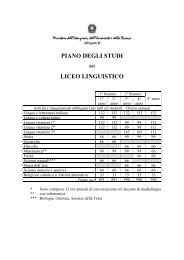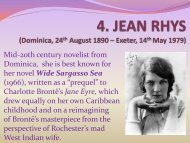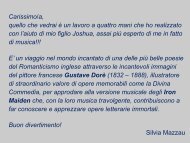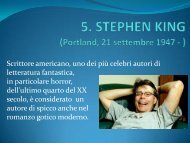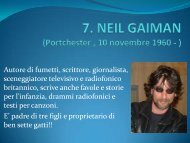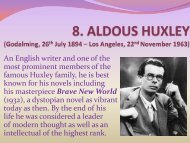Compendio di relatività - Liceo Scientifico Galilei
Compendio di relatività - Liceo Scientifico Galilei
Compendio di relatività - Liceo Scientifico Galilei
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
INTRODUZIONE<br />
Nel XIX secolo i sorprendenti risultati del progresso tecnico determinarono una fede illimitata nei proce<strong>di</strong>menti<br />
scientifici ed una insod<strong>di</strong>sfazione per la filosofia romantica. La filosofia doveva solo fornire i principi del metodo,<br />
soprattutto per ciò che riguarda in<strong>di</strong>vidui e società nel loro processo evolutivo. A partire dall’Illuminismo, passando<br />
attraverso Romanticismo e Positivismo, la cultura scientifica giunse fino al Materialismo storico con la convinzione<br />
sempre più salda <strong>di</strong> poter comprendere l’uomo, il mondo in cui vive ed il suo sviluppo storico, racchiudendoli in una<br />
visione ottimistica e deterministica, dettata dalle semplici leggi fisiche che la caratterizzano.<br />
Tuttavia nell’ultimo decennio dell’800 e nei primi del ‘900 la scienza abbandona l’illimitata fiducia nelle leggi e<br />
negli schemi in cui si era illusa <strong>di</strong> poter racchiudere, me<strong>di</strong>ante sintesi definitive, l’infinita ricchezza dell’Universo.<br />
La scoperta delle geometrie non-euclidee, la fisica atomica <strong>di</strong> Planck, la teoria matematica della <strong>relatività</strong> <strong>di</strong><br />
Einstein, le esplorazioni sulla vita psichica inconscia <strong>di</strong> Freud, portano ad una ra<strong>di</strong>cale revisione critica dei modelli<br />
del sapere fino ad allora vali<strong>di</strong>. Tra le scienze che per prime misero in crisi le basi stesse su cui si fondavano, vi si<br />
deve senz’altro annoverare la fisica, grazie all’opera <strong>di</strong> due gran<strong>di</strong> scienziati:<br />
Max Planck (1858-1947) ed Albert Einstein (1879-1955).<br />
Il primo <strong>di</strong> essi è da molti considerato il “padre della fisica moderna”, grazie agli<br />
stu<strong>di</strong> sull’energia; con essi le conoscenze della materia e dell’estensione vennero<br />
rivoluzionate ed i limiti della rappresentazione umana della realtà esterna vennero<br />
messi in luce; le sue teorie aprirono la strada a tutti i successivi sviluppi della fisica<br />
quantistica. Le idee fondamentali della teoria dei quanti ricevettero un’importante<br />
convalida nell’interpretazione <strong>di</strong> Einstein.<br />
La teoria della <strong>relatività</strong> è stata definita da Einstein, nella forma che fu detta della<br />
“<strong>relatività</strong> speciale”, nel 1905, per risolvere l’apparente contrad<strong>di</strong>zione alla quale si<br />
era giunti nello stu<strong>di</strong>o dell’elettro<strong>di</strong>namica dei corpi in movimento, contrad<strong>di</strong>zione<br />
derivante dalla impossibilità <strong>di</strong> rilevare sperimentalmente alcuna <strong>di</strong>fferenza nella<br />
velocità <strong>di</strong> propagazione delle onde elettromagnetiche da parte <strong>di</strong> un osservatore in<br />
moto rispetto all’ipotetico mezzo, l’etere, sede della propagazione delle onde stesse.<br />
Il fallimento degli esperimenti volti a questo scopo ebbe da Einstein la seguente<br />
spiegazione: l’esistenza dell’etere non può essere rivelata, in quanto ogni movimento è relativo e si misura rispetto<br />
a qualche cosa che è a sua volta in movimento. Come con esperimenti compiuti entro una nave non si può stabilire<br />
se la nave si muove rispetto all’acqua, così non si può misurare la variazione della velocità della luce facendo<br />
ricorso ad un campione <strong>di</strong> misura che comporta proprio quella variazione; e poiché non abbiamo modo <strong>di</strong> sottrarci<br />
a tale riferimento, dobbiamo concludere che la velocità della luce è sempre la stessa rispetto ad un osservatore<br />
qualunque. Il maggior merito della teoria della <strong>relatività</strong> sta proprio nell’aver introdotto nella scienza il concetto <strong>di</strong><br />
“<strong>relatività</strong>” -la nozione che non esiste alcun movimento assoluto nell'universo, solo movimenti relativi- soppiantando<br />
la meccanica tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> Isaac Newton. La teoria <strong>di</strong> Einstein, da questo punto <strong>di</strong> vista, si muove nella stessa<br />
<strong>di</strong>rezione della critica mossa da Mach al valore assoluto<br />
dei concetti e delle leggi scientifiche.<br />
Nel 1915 Einstein pubblicò una teoria <strong>di</strong> portata più<br />
generale, chiamata appunto “<strong>relatività</strong> generale”, nella<br />
quale vengono approfon<strong>di</strong>te le proprietà dei corpi in<br />
moto accelerato qualsiasi, giungendo a ricondurre ad<br />
un’unica spiegazione le proprietà inerziali e le proprietà<br />
gravitazionali della materia. Einstein mostrò che noi<br />
non stiamo nel piatto spazio euclideo e nell'uniforme<br />
ed assoluto tempo dell'esperienza quoti<strong>di</strong>ana, ma in un<br />
altro sistema: lo spazio-tempo curvo.<br />
Le teorie <strong>di</strong> Albert Einstein, non solo i lavori sulla<br />
Albert Einstein<br />
Max Planck<br />
<strong>relatività</strong> ma anche le spiegazioni dell’effetto<br />
fotoelettrico (premiate con il Nobel) e dei moti<br />
browniani, hanno innescato un'importante rivoluzione<br />
in fisica ed in astronomia nel corso del ventesimo secolo. Esse giocarono un ruolo importantissimo in fisica: portarono<br />
infatti all'era nucleare, con i suoi potenziali positivi e negativi, resero possibile la conoscenza del microcosmo delle<br />
particelle elementari e delle loro interazioni; hanno altresì rivoluzionato il nostro punto <strong>di</strong> vista sul cosmo con le sue<br />
previsioni <strong>di</strong> fenomeni astronomici apparentemente bizzarri, come il Big Bang, stelle <strong>di</strong> neutroni, le onde gravitazionali<br />
ed i Black Holes. Alla base delle teorie sulla <strong>relatività</strong>, argomento che si intende trattare in questa sede, sta il<br />
principio <strong>di</strong> <strong>relatività</strong> einsteniano, estensione ai fenomeni fisici <strong>di</strong> qualsiasi tipo del principio <strong>di</strong> <strong>relatività</strong> galileiano,<br />
fondamento basilare della meccanica classica: bisogna perciò partire da una analisi del principio da lui formulato<br />
per una corretta comprensione del significato delle teorie relativistiche.<br />
3