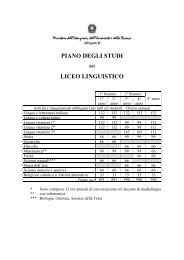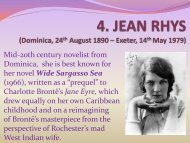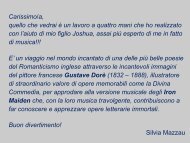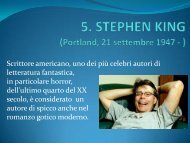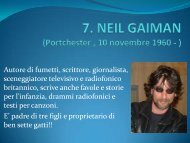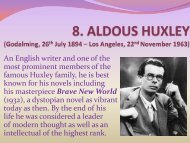Compendio di relatività - Liceo Scientifico Galilei
Compendio di relatività - Liceo Scientifico Galilei
Compendio di relatività - Liceo Scientifico Galilei
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LA RELATIVITÀ EINSTENIANA<br />
La teoria della <strong>relatività</strong> ristretta consta <strong>di</strong> due principi fondamentali, enunciati<br />
entrambi da Einstein nel 1905, che, insieme, portano alla famosa equazione<br />
E=mc 2 , dove E, m, c rappresentano rispettivamente l’energia, la massa e la<br />
velocità della luce.<br />
Il primo principio della <strong>relatività</strong> afferma che le leggi fondamentali della fisica<br />
sono uguali ovunque e per qualunque osservatore, in<strong>di</strong>pendentemente da<br />
dove si trovi o dalla velocità costante alla quale eventualmente si muova.<br />
Ne è corollario il fatto che la velocità della luce deve essere la stessa in ogni<br />
sistema inerziale (poiché la misurazione <strong>di</strong> c è un esperimento scientifico),<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dalla velocità della sua sorgente o dell'osservatore.<br />
Il secondo principio della <strong>relatività</strong> postula che esiste una quarta <strong>di</strong>mensione,<br />
il tempo, completamente equivalente alle tre solite <strong>di</strong>mensioni spaziali.<br />
La posizione <strong>di</strong> un oggetto è normalmente definibile tramite tre <strong>di</strong>mensioni spaziali, avanti o in<strong>di</strong>etro,<br />
su o giù, dentro o fuori.<br />
Tre <strong>di</strong>mensioni bastano a descrivere la posizione <strong>di</strong> un oggetto nello spazio. Ma occorre una quarta<br />
<strong>di</strong>mensione, il tempo, per descrivere quando, passato o futuro, un oggetto esiste nello spazio.<br />
Aggiungendo il tempo alla tre <strong>di</strong>mensioni spaziali, Einstein riuscì a completare le manchevolezze<br />
della concezione Newtoniana dell'Universo; ma, quel che più conta, riuscì a giustificare i risultati<br />
dell'esperienza <strong>di</strong> Michelson e Morley, ipotizzando che il valore numerico della velocità della luce sia<br />
un numero costante assoluto, in qualunque istante, per ogni osservatore, in<strong>di</strong>pendentemente da<br />
come, dove e quando se ne effettui la misurazione.<br />
Spazio e tempo, in effetti sono così strettamente interconnessi nella concezione dell'Universo<br />
<strong>di</strong> Einstein che egli esortò a considerare queste due quantità non come spazio e tempo ma come una<br />
singola entità: lo spazio-tempo.<br />
Altr ove<br />
Futuro<br />
Altr ove<br />
in<strong>di</strong>etro avanti<br />
Passato<br />
Diagramma spazio-tempo generale<br />
Albert Einstein<br />
La rappresentazione grafica <strong>di</strong> una superficie quadri<strong>di</strong>mensionale<br />
pone notevoli problemi non solo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne tecnico, ma anche <strong>di</strong><br />
interpretazione mentale. Per rendersi conto <strong>di</strong> come si possa<br />
unificare il concetto <strong>di</strong> tempo con quello <strong>di</strong> spazio, bisogna<br />
trascurare due <strong>di</strong>mensioni spaziali. Lo schema a sinistra mostra<br />
un sistema <strong>di</strong> riferimento spazio-temporale <strong>di</strong> questo tipo, in cui<br />
il tempo è riportato sull’asse verticale e lo spazio su quello<br />
orizzontale. L’origine del <strong>di</strong>agramma, il punto <strong>di</strong> intersezione<br />
degli assi, rappresenta qui nello spazio ed ora nel tempo. Ad un<br />
intervallo <strong>di</strong> 300000 Km <strong>di</strong> spazio ne corrisponde uno <strong>di</strong> un<br />
secondo <strong>di</strong> tempo. Quin<strong>di</strong> la velocità della luce è rappresentata<br />
da una linea inclinata <strong>di</strong> 45°, mentre gli eventi della nostra<br />
esperienza (che avvengono a velocità infinitesimali rispetto a c)<br />
sono linee vicinissime all’asse verticale del tempo. Questo <strong>di</strong>agramma è <strong>di</strong>viso in quattro coni; le due<br />
sezioni scure vengono definite altrove, in quanto non possono essere esplorate da alcuna particella:<br />
sarebbe infatti necessaria una velocità maggiore <strong>di</strong> c; le due sezioni chiare, invece, rappresentano i<br />
due coni all’interno dei quali sono comprese tutte le rette che rappresentano spostamenti a velocità<br />
minore <strong>di</strong> c; i tracciati possibili devono essere compresi nei coni delimitati dalle linee a 45°.<br />
Ciò implica che, nel cono in cui ci troviamo, un evento non può non solo andare in<strong>di</strong>etro nel tempo<br />
ma nemmeno rimanere in un tempo fisso.<br />
Essenzialmente tutte le leggi e le conseguenze della <strong>relatività</strong> speciale derivano da questi concetti.<br />
La prima importante conseguenza è la <strong>relatività</strong> del concetto <strong>di</strong> simultaneità, <strong>di</strong> cui parleremo nel<br />
seguente paragrafo.<br />
7