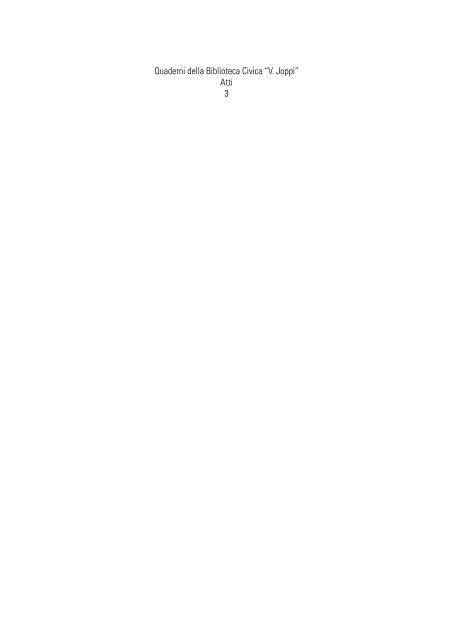Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Quaderni della Biblioteca Civica “V. Joppi”<br />
Atti<br />
3
CARLO<br />
SGORLON<br />
SCRITTORE FRIULANO<br />
a cura di Romano Vecchiet<br />
Comune di <strong>Udine</strong><br />
Biblioteca Civica “V. Joppi”<br />
2012
© 2012 Comune di <strong>Udine</strong> – Biblioteca Civica «V. Joppi»<br />
Piazza Marconi 8 - 33100 <strong>Udine</strong><br />
Tel. 0432 271583 Fax 0432 271776<br />
www. comune.udine.it/biblioteca.htm<br />
www.sbhu.it<br />
Progetto grafico: Altrementi Adv - Tricesimo (Ud)<br />
Stampa: Grafiche Filacorda<br />
ISBN 978-88-97360-08-7
Indice<br />
Prefazione<br />
Furio Honsell p. 7<br />
Premessa<br />
Romano Vecchiet p. 9<br />
Elvio Guagnini<br />
Sgorlon. Gli esordi del narratorie p. 11<br />
Marco A. Bazzocchi<br />
Carlo Sgorlon: mito, fiaba, racconto p. 17<br />
Stefano Lazzarin<br />
Sul fantastico di Carlo Sgorlon p. 25<br />
Jean-Igor Ghidina<br />
Topoi e figure dell’ospitalità in Carlo Sgorlon p. 41<br />
Gaimpaolo Borghello<br />
Un labirinto pronto a inghiottirci: Sgorlon legge Pasolini<br />
(con un inedito di Carlo Sgorlon) p. 53<br />
Fabiana Savorgnan di Brazzà<br />
La figura femminile nella narrativa di Carlo Sgorlon p. 69<br />
Luigi Reitani<br />
Lo Sgorlon “tedesco” p. 77<br />
Mario Turello<br />
I racconti di Carlo Sgorlon p. 87
Franco Fabbro<br />
Sgorlon e il sacro p. 97<br />
Gianfranco Ellero<br />
Il friulano nei romanzi di Carlo Sgorlon p. 103<br />
Laura Nascimben<br />
Appunti sui romanzi friulani di Sgorlon p. 109<br />
Luisa Sello<br />
L’espressione musicale nella narrativa di Carlo Sgorlon p. 117<br />
Marcello Staglieno<br />
Sgorlon: un coraggioso giornalista militante conservatore p. 125<br />
Romano Vecchiet<br />
I treni di Carlo Sgorlon p. 133<br />
Appendice<br />
p. 139<br />
Indice nei nomi<br />
p. 147
Il primo Sgorlon<br />
di Elvio Guagnini<br />
Università degli Studi di Trieste<br />
Vorrei partire da un ricordo personale. Verso la metà degli anni Settanta dello scorso secolo<br />
(fa impressione dire così, ma così è) mi trovavo a Milano, nella casa di una famiglia patrizia, alle prese<br />
con carte settecentesche e altri documenti dell’archivio familiare. Ero sistemato su un tavolo di fronte<br />
a uno splendido ritratto di Pompeo Batoni, il pittore al quale Londra e Roma hanno recentemente dedicato<br />
una grande mostra, e avevo appena trovato – in mezzo alle altre carte dell’archivio – anche delle<br />
lettere di Carducci e di Pascoli. Ne parlavo con gli amabili padroni di casa. Non so come (anzi, ora lo ricordo:<br />
in giro c’era un libro del mio amico), era spuntato – nella nostra conversazione – il nome di Carlo<br />
Sgorlon. Il discorso aveva sùbito preso una piega diversa rispetto a prima. Doveva essere il periodo in<br />
cui era uscito il romanzo Gli dèi torneranno. «Davvero lei lo conosce?». E avevano voluto sapere di lui,<br />
mostrando una viva simpatia per le sue opere.<br />
È un fatto che Carlo Sgorlon si era conquistato, in quegli anni, una larga popolarità, dal Trono di<br />
legno in avanti (cioè dopo il 1973, soprattutto). Ma, anche prima di questa data, Sgorlon aveva scritto<br />
dei libri di grande interesse.<br />
L’esordio narrativo di Sgorlon avviene con il romanzo La poltrona (Milano, Mondadori, 1968;<br />
scritto nel 1965). Il secondo romanzo a stampa è La notte del ragno mannaro (<strong>Udine</strong>, La Nuova Base,<br />
1970). Il terzo sarà Il vento del vigneto (Roma, Gremese, 1973). Poi viene pubblicato Il trono di legno<br />
(Milano, Mondadori, 1973) con il quale – come dicevo – Sgorlon conquista il largo pubblico, tra il quale<br />
i miei interlocutori milanesi.<br />
Se, invece, guardiamo ai tempi di composizione, la prima opera scritta da Sgorlon sarebbe Il<br />
vento nel vigneto. La sua stesura risalirebbe al 1960. Il testo italiano appare nel 1973. Ma, nel 1970, il<br />
romanzo viene pubblicato in un rifacimento friulano con il titolo di Prime di sere (<strong>Udine</strong>, Società Filologica<br />
Friulana), con – in copertina – un quadro dello stesso Sgorlon, interessante perché costituisce una<br />
significativa interpretazione figurativa del suo progetto.<br />
Già qui, dunque, ci troviamo di fronte a un problema, che già si sono posti – magari implicitamente<br />
– gli studiosi dell’opera di Sgorlon (tra i quali Bruno Maier e Claudio Toscani: mi riferisco, rispettivamente,<br />
a Sgorlon, Firenze, La Nuova Italia, 1965, e a Invito alla lettura di Sgorlon, Milano, Mursia,<br />
1994). Da dove prendere le mosse per disegnare il diagramma <strong>sgorlon</strong>iano?<br />
Quando ho cominciato a occuparmi di Sgorlon, in varie occasioni, La poltrona era, per il lettore,<br />
il primo libro a stampa dello scrittore (e resta – ovviamente – tale) ed era da considerarsi l’incipit di una<br />
bibliografia narrativa che poi si è allargata molto, in Italia e all’estero. Dunque, La Poltrona è il libro che<br />
ha segnato l’avvio di un rapporto con i lettori destinato a crescere nel tempo in modo considerevole.<br />
Se vogliamo, invece, seguire l’ordine cronologico delle stesure, della composizione delle ope-<br />
11
12<br />
re, Il vento nel vigneto – del 1960, ma pubblicato nel 1973 – sarebbe il primo testo narrativo scritto da<br />
Sgorlon. Si tratta, in questo caso, di un libro certamente diverso da quelli che seguono. Rappresenta<br />
la vicenda di un ex carradore di Cassacco (il paese di Sgorlon), che è stato condannato all’ergastolo e<br />
poi graziato. Sarà lo stesso Eliseo Bastianutti, ora più che cinquantenne, che ha trascorso gli anni della<br />
sua carcerazione in vari istituti di pena dell’Italia meridionale, a rivelare – nel racconto – i moventi del<br />
crimine commesso nel 1931. Da giovane, era stato uomo iroso, altero e violento. Aveva rivolto le sue<br />
attenzioni a una donna sposata il cui marito, anziché prendersela direttamente con lui, aveva preso di<br />
mira, beffeggiandolo, il fratello paralitico. Da cui, l’omicidio. E poi la pena, scontata dal Bastanutti. E,<br />
ancora, all’uscita dal carcere, la volontà di una vita pacificata, il desiderio di un lavoro, forse anche di<br />
una famiglia. Ma il ritorno al paese presenta dei problemi: l’ambiente e la famiglia (la stessa sorella<br />
tesa a difendere le proprietà) gli si rivelano ostili; la sua casa è distrutta. Anche l’ex fidanzata gli si mostra<br />
indifferente e lontana. Eppure Eliseo riesce, a poco a poco, a reinserirsi. Una vedova di Treppo lo<br />
ospita e gli offre assistenza. Comincia a trovare dei piccoli lavori, poi acquista una bottega da falegname.<br />
Un po’ alla volta trova un accordo con il contesto e con i personaggi della sua vita. Una richiesta<br />
di matrimonio alla vedova che lo ospita, Rita, fallisce per ragioni di carattere pratico (l’età; lei ha un figlio;<br />
la necessità di conservare la pensione). Ma si stabilisce un accordo ed Eliseo entra a far parte, un<br />
po’ per volta, della vita collettiva del paese, e trova una forma di armonia anche con la natura e con la<br />
campagna, sintonizzandosi sui ritmi di quel mondo.<br />
Certo, Il vento nel vigneto è un libro legato a una stagione. Tutti i critici e i lettori di Sgorlon<br />
hanno parlato di neorealismo, di uno spontaneo collegamento che si può fare di fronte a pagine che<br />
presentano - cito Maier – “indubbi contatti” con questo indirizzo. «Anche se lo scrittore – aggiunge<br />
Maier – si viene gradualmente staccando da tale letteratura tiene presente la lezione di alcuni autori<br />
stranieri a lui particolarmente consentanei e percorre una strada che è chiaramente sua». Sia Maier,<br />
sia altri critici che si sono occupati di Sgorlon, sottolineano però anche la distanza da certi indirizzi politici<br />
e di “impegno” propri del movimento neorealistico. Ma, d’altra parte, andrebbe anche sottolineata<br />
la distanza cronologica di questa prova rispetto al movimento stesso. E, poi, pure il fatto che lo stesso<br />
neorealismo, sia negli anni Quaranta sia negli Cinquanta, al momento della sua crisi, era stato declinato<br />
in molti modi, anche in quella chiave intimistica di tipo cassoliano (da Carlo Cassola, che pure Maier<br />
cita come scrittore da avvicinare a questa esperienza di Sgorlon).<br />
Certo, come ha scritto Claudio Toscani, nell’attenzione di Sgorlon alle classi subalterne non c’è<br />
alcunché di populistico o di quella “ideologia sociale” che era sembrata propria del neorealismo in senso<br />
più stretto. Se si vuole, si potrebbe parlare (come qualcuno ha fatto, credo di averlo fatto anch’io)<br />
di impianto naturalistico, di realismo. Il procedere del racconto, le descrizioni di paesaggio, la rappresentazione<br />
dei sentimenti, sono trattati in modo lineare, analitico. La storia viene presentata secondo<br />
le regole e le prospettive di un’etica umanitaria – provvidenziale e rigorosa che, se ammette sconfitte<br />
e drammi, non ammette però una sconfitta totale; anzi il finale, se non è happy end in senso stretto, offre<br />
gli elementi per una ricomposizione dei rapporti con la realtà circostante e per una ripresa di fiducia<br />
dell’uomo verso il suo prossimo.<br />
Molto accurata risulta anche la definizione dei vari piani della meccanica e della realtà vissuta<br />
e rappresentata. Peraltro il libro appare interessante pure sul piano linguistico, per l’inserimento di<br />
termini ed espressioni “locali”, in friulano, per l’approccio alla lingua parlata, al colorito della conversazione<br />
quotidiana. E anche per l’attenzione, “realistica” (sottolinea Maier), all’ambiente, al paesaggio<br />
friulano; forse, pure per qualche anticipazione di tratti della futura narrativa <strong>sgorlon</strong>iana nella rappresentazione<br />
della donna, concreta e attenta alla vita, pratica e materna, qual è la sua affittuaria, Rita,<br />
con la quale Eliseo si trova in sintonia, come si troverà in sintonia con il figlio di lei, Riccardo.
Il vento nel vigneto è un libro che contiene diverse pagine asciutte ed essenziali: per esempio<br />
quelle sul ritrovamento – dopo il periodo di espiazione da parte di Eliseo – della propria terra natale,<br />
sul primo incontro con la sorella, sulle più o meno esplicite diffidenze dei paesani. Ed è da sottolineare<br />
la capacità del narratore di creare una struttura semplice e complessa nella rappresentazione di questo<br />
“ritorno”, di questo “nostos”, al paese, sulla ricerca di reintegrazione, facendo scoprire al lettore, un<br />
po’ per volta, antecedenti e particolari della vita e della storia di Eliseo.<br />
Due elementi, dunque, andrebbero ricordati di questo romanzo, che si ritrovano anche nella ricerca<br />
successiva di Sgorlon: in primo luogo, il tema del ritorno al paese come occasione in cui ritrovarsi<br />
nuovamente; in secondo luogo, il distacco dal mondo storico, che in Eliseo – però – aveva origine nel<br />
salto di anni dovuto alla segregazione nel carcere da ergastolano: su un altro piano – più tardi – l’assenza,<br />
il distacco dalla storia di Sgorlon (e dei suoi personaggi) si sarebbero definiti e concretati come<br />
elemento dell’ideologia e della poetica.<br />
Eliseo è uno sradicato rispetto al corso della storia; il suo distacco, di cui si vergogna un po’, è<br />
giustificato da una assenza forzata: «C’erano state la guerra d’Africa, quella di Spagna e quella Mondiale,<br />
l’invasione tedesca, la lotta partigiana. Ma quando succedevano tutte quelle cose, lui non c’era.<br />
Le aveva guardate da lontano, stando alla finestra... l’ergastolo era come un mondo a sé, e tutto ciò che<br />
non aveva rapporti con la speranza di fuggire o di essere graziato o con la vita di animali che facevano,<br />
era come succedesse sulla luna...» (p. 105). Da ciò la sua accettazione, come una grazia, di ciò che nel<br />
mondo – cioè fuori dalla prigione – sapeva di lavoro, di attività, di rapporto con gli altri, di sopravvivenza<br />
(anche se umiliante), di fatica, di alienazione.<br />
Interessante qualche riscontro cronologico con altre grandi opere narrative relative al contesto<br />
in cui opera Sgorlon: nel 1962, Pasolini pubblica Il sogno di una cosa; nel 1950 era uscito Icaro e Petronio<br />
di Elio Bartolini; il Ghebo dello stesso Bartolini era del 1970 (ma una prima stesura risaliva al 1944).<br />
Ben diverso il quadro che ci si presenta nel libro successivo di Sgorlon, il primo pubblicato,<br />
l’esordio materiale, La poltrona. Un libro di grande forza, essenzialità, maturità, originalità. La lettura<br />
ad alta voce di una sua pagina rende bene l’idea del ritmo incalzante di una tenuta che riguarda tutto<br />
il libro, senza cadute di tensione. La poltrona appare, tra l’altro, come un libro di forma e dimensione<br />
adeguata. Non ci sono capitoli. La lettura può scorrere – così – ininterrotta, senza pause, dall’inizio alla<br />
fine.<br />
Il romanzo si presenta come il resoconto di alcune giornate ossessive vissute dal protagonista,<br />
prospetta uno spaccato breve della sua esistenza, uno svelamento delle cause che ne hanno determinato<br />
il fallimento. Protagonista del romanzo è Giacomo Cojaniz, un insegnante di scuola media, che ha<br />
tentato (ma lasciato a metà) anche i concorsi, scapolo quarantenne che viene da un paese, dove vive la<br />
famiglia, e che abita in una camera d’affitto in una casa fatiscente di <strong>Udine</strong>. È ossessionato dalla velleità<br />
di comporre un enorme trattato filosofico (che dovrà – ha deciso – avere mille pagine) e che dovrebbe<br />
avere il titolo simbolico (e significativo) La torre di Babele (con un richiamo a Ficciones, ai racconti<br />
di Borges, tra cui La biblioteca de Babele, dove l’universo è guardato come una biblioteca infinita<br />
e difficile da definire).<br />
Giacomo Cojaniz è vittima di una nevrosi cronica determinata da una sostanziale incapacità di<br />
condurre a termine i propri propositi. Primo di questi, è la composizione del trattato filosofico in cui egli<br />
ripone – come l’Alfonso Nitti di Una vita di Svevo – un obiettivo fondamentale della propria esistenza:<br />
anche un modo per essere qualcuno, per uscire dall’oscurità, per contare qualcosa; un modo per sbloccarsi,<br />
per uscire dalla condizione di immobilità, per risolvere certi problemi rinviati al dopo.<br />
Il trattato ha richiesto una lunga preparazione: appunti, note, schede che Cojaniz non riesce a<br />
13
14<br />
coordinare e di cui rinvia (con vari alibi) l’organizzazione. E così non riesce a procedere nella stesura:<br />
ogni tanto scrive qualche pagina, in preda a una sorta di eccitazione e a momenti di artificioso superomismo.<br />
Ma poi gli vengono tutti i dubbi. E tutti i pretesti sono buoni per rinviare. È il periodo delle vacanze<br />
di Natale, ma i giorni passano.<br />
Giacomo è chiuso, barricato, nella sua stanza, che – con la soffitta – è quasi l’ambiente fisso<br />
del libro (qui non c’è la natura, che ha un suo ruolo importante nel libro precedente). E la storia è anche<br />
quella degli ostacoli capitati (o procurati dallo stesso Giacomo) per procedere in un’opera rispetto alla<br />
quale egli si rivela un inetto, un velleitario.<br />
Altro obiettivo, che diventa un alibi per bloccare spesso il lavoro di scrittura, è (oltre al disordine<br />
e alla confusione che gli regna attorno nella stanza e nella casa: vorrebbe vivere in una stanza foderata<br />
di sughero, alla Proust, e – oltre a ciò – trovare le cose che, invece, come càpita ai nevrotici, gli sfuggono,<br />
e che non trova più, e la cui scomparsa gli provoca ulteriori disagi e difficoltà), la costruzione di una<br />
poltrona (quella che dà il titolo emblematico al libro), di quella poltrona che egli spera di costruire per<br />
procurarsi un conforto e non essere costretto a scrivere a letto. Da ricordare che Sgorlon amava i lavori<br />
di falegnameria, le attività artigiane, che ne aveva il gusto al punto che aveva voluto apprenderne le<br />
basi per costruirsi una libreria di cui andava molto fiero.<br />
A differenza del suo autore, Sgorlon, che era attivo e metodico sul lavoro, il suo personaggio –<br />
Giacomo Cojaniz – scrive tre pagine del proprio trattato, poi interrompe il lavoro, passa alla correzione<br />
dei compiti, interrompe di nuovo, passa di nuovo al lavoro della poltrona. C’è sempre qualcosa che lo<br />
costringe a interrompere.<br />
La sua vita è tutto un insieme di fatti sospesi, di pensieri e atti incompiuti, di fallimenti. Cojaniz<br />
è un ipocondriaco: sente, avverte malattie in ogni dove (c’è – anche qui, forse – qualche reminiscenza<br />
sveviana, dalla Coscienza di Zeno). Alla fine, una scheggia gli entra nel piede, se la toglie adoperando<br />
una tenaglia, poi una pinzetta, pensa di aver preso il tetano. Una broncopolmonite (vera) alla fine – a<br />
Natale – lo costringe a letto. Ed ecco, allora, alcune pagine splendide sul delirio: sintesi e summa di<br />
pensieri, speranze, incubi, ossessioni.<br />
Poi, quando guarisce, Cojaniz ha la perfetta sensazione che tutto resterà come prima, fino alla<br />
morte (mentre prima sperava – contava – di cambiare): «Finirò qui l’inverno, ci starò anche quest’estate,<br />
e chissà quando me ne andrò. Forse non cambierò neanche di casa. Qualcosa di questa casa mi aderisce<br />
addosso, tra me e lei c’è un legame più forte di quel che credo, un legame che forse non riuscirò<br />
a rompere mai. Stando qui nel freddo, collo stomaco inchiodato dall’indigestione, guarderò ancora per<br />
chissà quanto tempo le macchie del camino, le crepe del muro, i visi delle vecchie che si spiano dalle<br />
finestre. Penserò ad Anna, alle sue mani delicate, alle sue dita sottili, alle sue gambe che un giorno,<br />
prima o poi, si trascineranno svogliate sull’erba per essere accarezzate da un altro. Io mi torcerò di nostalgia<br />
e di impotenza maledicendo ancora la mia casacca di soldato, la mia tonaca di frate, sporca di<br />
fango e di sudore, ma so bene quello che farò... Io mi conosco bene, conosco la mia razza e ho sempre<br />
davanti agli occhi il vecchio che, pieno di reumatismi com’è, va ancora nell’officina aperta ai quattro<br />
venti a battere i suoi ferri incandescenti» (p. 183).<br />
Il vecchio, la razza, la famiglia. Il padre, anzitutto (anche lui carradore, si occupa di carri che ora<br />
nessuno più vuole). Il mestiere artigiano del padre, una tradizione di famiglia che si estingue con il venir<br />
meno dei segni della vecchia civiltà.<br />
Degli artigiani la caratteristica è la tenacia (Sgorlon la esalterà come mito in altri libri successivi).<br />
Ma in Giacomo, intellettuale e professore, questa virtù diventa una qualità dal segno negativo, uno<br />
strumento di autopunizione, una forma di masochismo che gli vieta di desistere da imprese assurde, di<br />
troncare progetti impossibili, di costruirsi un’esistenza serena e tranquilla, di programmare realistica-
mente la propria vita. E, così, dopo la malattia, dopo la presa d’atto definitiva della situazione, la tenacia<br />
si convertirà di rassegnazione.<br />
Giacomo, a suo modo, è un inetto e uno sradicato. Dunque, un personaggio moderno. La sua<br />
impotenza umana e intellettuale deriva anzitutto dalla sua assoluta incapacità di stabilire dei rapporti<br />
con il mondo esterno, nel suo straniamento dalle radici familiari (la natura; il lavoro manuale), nel suo<br />
inserimento – mancato o poco organico – in un ambiente di lavoro che Cojaniz trova poco stimolante e<br />
da cui si sente frustrato (anche nel sogno di mancate presenze e di ritardi).<br />
Il racconto è in forma di diario, in prima persona, il ritmo della narrazione è affannoso come i<br />
pensieri contorti, labirintici, le contraddizioni, le angosce del protagonista. Il libro è come la registrazione,<br />
in forma di vibrazione e oscillazione nervosa continua (ma ordinata), delle reazioni del protagonista;<br />
una resa, in forma precisa e chiara, senza concessioni formalistiche, del continuo avvicendarsi e accavallarsi<br />
delle impressioni ossessive, rese con assoluto puntiglio analitico dei particolari, in un fluire ora<br />
lento ora irruente del monologo.<br />
Direi, ancora, che nella resa di queste reazioni, pensieri, impressioni vi è – sottesa – una qualche<br />
dose di ironia: per esempio, quando Sgorlon rappresenta il suo protagonista che si agita convulsamente,<br />
o quando lo coglie nei momenti di calma (o relativa quiete, raramente) mentre pensa alla propria<br />
aspirazione naturale a vivere in pace con se stesso e con gli altri, a sentirsi in armonia con il suo tempo;<br />
o quando ce lo fa vedere alle prese con quella strana famiglia da cui vive in affitto: le due ragazze, la<br />
madre , il gatto (forse) rognoso, Sandro (“forse” epilettico, forse malato, ma sveglio, iperattivo, furbo,<br />
abile, acuto: lo riconosce lo stesso Cojaniz).<br />
Il ragazzo è la coscienza umoristica di quegli avvenimenti, sa fare parodie, usa il comico, fa<br />
sentire ridicolo Cojaniz che si sente come un clown. Si tratta di pagine importanti. Come quella in cui<br />
Sandro fa la parodia del professore che così lo rappresenta: «È un genio della parodia, lo devo riconoscere,<br />
anche se mi scotta. Vorrei che fosse un ebete [...] ma non lo è [...] è un mostriciattolo diabolico<br />
[...] Altro che bambino, è dieci volte più maligno di un grande. È incredibile come abbia potuto vedermi<br />
così a fondo» (p.158).<br />
E sarà proprio ciò che lo aiuterà a prendere coscienza di se stesso.<br />
«Forse proprio la parodia è la strada giusta, dovrei fare una satira del regnum hominis e di me<br />
stesso, dovrei andare avanti allegramente, fregandomene di tutto e anche della paura di sbagliare. In<br />
fondo sapevo di essere un clown, in fondo lo sentivo, non è che lo scopra veramente solo adesso. Quando<br />
mai ho preso le cose sul serio, veramente sul serio? Quando ho sentito veramente qualcosa, qualunque<br />
cosa, la politica, la scuola, la scienza, la letteratura, la civiltà? Mi sento diverso, mi sento allegro o<br />
quasi, adesso, l’allegria del disperato, allegria di naufraghi. Ho voglia di farmi una gran risata alla maniera<br />
del Sandro o delle sue sorelle-iene, è l’unica cosa ragionevole, una risata senza fine, risolvere la<br />
realtà in una risata. Forse ho trovato la strada giusta per La torre di Babele, speriamo che duri, speriamo<br />
che questa convinzione continui [...] Ma già mi è passata la voglia di ridere, la risata mi si è gelata<br />
nella gola e non vuol più venire fuori: Non sono capace di ridere, né di me né degli altri. Son buono solo<br />
di tormentarmi, sono un buffone che non sa ridere [...]» (p. 158-159).<br />
La storia raccontata da Sgorlon è, al tempo stesso, una satira efficace dell’intellettuale entrato<br />
nel dedalo delle aspirazioni eccessive (e nevrotizzato dall’incapacità di uscirne) e un diario psicopatologico<br />
della progressiva alienazione di chi rinuncia a vedersi e a guardare a fondo se stesso e a procedere<br />
all’autocoscienza.<br />
Il racconto propone una vicenda grottesca che serve a indicare come la schiavitù, l’alienazione<br />
non toccano solo chi vive nella civiltà delle macchine ma anche chi fa professione intellettuale (o<br />
è uno pseudointellettuale), da cui nessuno si aspetta nulla, ma che si illude, sente “chiamate” che lo<br />
15
16<br />
spingono verso l’ignoto, alla ricerca della libertà, attraverso la “creazione”, senza sapere cosa essa sia,<br />
senza concretezza.<br />
Il libro è tramato da molti riferimenti intellettuali: Joyce, Marsilio Ficino, Ungaretti, Musil, Pirandello<br />
(Il berretto a sonagli). Maier ha indicato un punto di affinità con Kafka citando La tana, uno<br />
splendido racconto postumo.<br />
Certo, La poltrona è un libro dove si rappresentano il caos, la solitudine, la sofferenza, ma dove<br />
si sfiora anche il comico, dove si ritrovano insieme tanti registri, tante intuizioni, tanti interessi. E,<br />
ancora, paesaggi dell’anima, immagini gotiche di fatiscenza, trasandatezza, disgregazione. E, tutto ciò,<br />
risolto in una sorta di monologo ininterrotto che riflette il flusso di coscienza. Con la capacità, davvero<br />
straordinaria, di Sgorlon, di rendere “vere” le sofferenze artificiali e le finzioni di dolore che – in ogni<br />
caso – sono dolore autentico, come lo è – in ogni caso – quello di un nevrotico, di un ipocondriaco. E<br />
con la capacità di dare vita a gag, a scene comiche, grottesche, rese in velocità: «[Ada] corre dietro alla<br />
madre e continua a ridere, a ridere come una pazza, anzi non si capisce bene se rida o pianga. Sostiene<br />
la madre pel didietro, mentre quella è agitata da sforzi di vomito, e anche lei è ripresa dagli sforzi,<br />
mentre vien giù dalle scale il Sandro col corno a tracolla. Non riesce a passare subito perché la scala<br />
è occupata dalle due donne, e vedendole in preda agli sforzi si sente male anche lui, e corre verso il<br />
cesso arrivandoci prima di loro. Adesso non li vedo più, sento solo i loro urli e le loro risate nel bagno»<br />
(p. 110-111).<br />
Lo scrittore rivela una notevole capacità di rappresentare le velleità, le esaltazioni di un inetto,<br />
le cadute di tensione. In questo senso, Giacomo Cojaniz è anche – come già si suggeriva - fratello di<br />
Alfonso Nitti, il protagonista di Una vita di Svevo, anche lui venuto dal paese alla città, anche lui frustrato,<br />
anche lui alla ricerca di una integrazione impossibile.<br />
Il finale (la malattia, il delirio, le visioni) è un capolavoro di abilità immaginativa e di strutturazione<br />
del racconto («Le lastre si spaccano sul pavimento, ma la vecchia continua a sbattere le porte e le<br />
finestre, anche se entrano gelide sberle di freddo, anche se entrano volando oche e tacchini. La vecchia<br />
prende lo scialle nero e comincia a far vento, sperando che gli animali se ne vadano. Invece è proprio il<br />
contrario [...]. L’aria è tutta piena di piume, di becchi, di bargigli rossi e gonfi di sangue, di occhi tondi e<br />
immobili, di creste molli e sanguigne, di lingue a punta dure come schegge» (p.172). Una scena che –<br />
alla fine – porterà anche alla rappresentazione di una cruda solitudine.<br />
A questa stessa fase può essere ascritto anche La notte del ragno mannaro (<strong>Udine</strong>, La Nuova<br />
Base, 1970), in una caratterizzazione in cui suggestioni kafkiane ed espressionistiche collaborano a dar<br />
volto a una realtà allucinata, che emerge alla coscienza nella sua carica di deformazione del reale talvolta<br />
violenta. La fase successiva, quella in cui campeggia Il trono di legno (1973), viene poi preannunciata<br />
da uno dei libri più suggestivi e concentrati dello scrittore, La luna color ametista (1972): una fase<br />
dove si sarebbe manifestata la tendenza di una scrittura che – in un racconto fondato sull’immaginario<br />
e sul fantastico – avrebbe teso a raccogliere i segni di un universo archetipico e le tracce immutabili<br />
del destino, ignorati da una civiltà che vuol sfuggire alla ricerca della propria identità. Ma di questo si<br />
parlerà nei prossimi incontri.
Carlo Sgorlon: mito, fiaba, racconto<br />
di Marco A. Bazzocchi<br />
Università degli Studi di Bologna<br />
Una delle caratteristiche dei romanzi di Carlo Sgorlon consiste nella molteplicità di eventi, episodi,<br />
intrecci che riescono a comporsi in un’unica avventura mettendo alla prova la visione del personaggio<br />
protagonista, portatore di un sistema di pensiero che cerca di tenere insieme tutti gli aspetti<br />
della realtà. A un tasso molto alto di avventurosità del racconto, corrisponde così un pensiero unitario<br />
sul mondo. Questa opposizione è insita nell’idea stessa che Sgorlon ha elaborato intorno all’arte del<br />
narrare, idea per la quale potremmo evocare la contrapposizione formulata da Walter Benjamin tra il<br />
narratore delle culture orali e il romanziere, l’uno capace di far transitare nei suoi racconti la densità<br />
dell’esperienza che si deposita nella memoria collettiva, l’altro in lotta contro l’oblio per salvare i pochi<br />
residui con cui si caratterizza il destino dei personaggi borghesi.<br />
Se vogliamo osservare da un’altra prospettiva il problema, dobbiamo allora considerare che<br />
per capire l’attività di narratore di Sgorlon è necessario mettere a fuoco il nodo tra narrazione mitica<br />
e astrazione fiabesca, cioè tra forze esterne all’individuo (forze cosmiche, energie della materia) e<br />
incarnazione di queste forze nei comportamenti umani. Per Sgorlon ogni storia narrata parte da realtà<br />
immensamente piccole e circoscritte (microcosmi, spesso di aspetto friulano ben riconoscibile) e fa<br />
lievitare all’interno di questi microcosmi eventi che oltrepassano la percezione ristretta dell’individuo.<br />
Così in lui la Storia rimane sempre sullo sfondo, oltrepassata dalla favola che diventa allegoria. Sono<br />
i narratori tedeschi i suoi modelli: Thomas Mann, per il nesso mito e ironia narrativa, e Kafka, per l’aspetto<br />
allegorico. E se un nome va fatto per l’Italia, è quello di Elsa Morante, una scrittrice atipica e a<br />
sua volta controcorrente, sulla quale Sgorlon ha scritto in sede critica. La concentrazione su microcosmi<br />
e microstorie che gli viene dalla Morante si coniuga così con l’astrazione e la tensione simbolica e<br />
mitica che risalgono a Kafka o a Thomas Mann. Sgorlon è un narratore poco italiano e molto europeo,<br />
e come tale va considerato.<br />
All’incrocio di questa serie di opposizioni (molteplicità delle azioni e unità della visione, ricchezza<br />
narrativa arcaica e coscienza romanzesca, mito e fiaba) possiamo collocare gran parte della produzione<br />
narrativa con cui Sgorlon, in una posizione defilata ma con una attenzione vivacissima, ha interpretato<br />
le vicende culturali del novecento, difendendo il suo ruolo di narratore che non cede alle mode<br />
e che rivendica la funzione nobile e inalienabile del racconto.<br />
Prendiamo ad esempio L’uomo di Praga, il romanzo del 2003 che vede come protagonista il misterioso<br />
Alvar Kunslica, un uomo che compare portando con sé i segnali del destino e dell’incertezza:<br />
è uno straniero di origini misteriose, sembra accompagnato da caratteristiche oltreumane, vive con il<br />
gusto della teatralità e della maschera, si inserisce con abilità nelle vite altrui. Ci sono nel personaggio<br />
alcune caratteristiche tipiche del romanzo moderno (si potrebbe fare il nome del manniano Felix<br />
17
18<br />
Krull) ma nello stesso tempo sembra che l’autore lo abbia ritagliato su un materiale di origini antichissime,<br />
arcaiche, precedenti a qualsiasi epoca romanzesca. Potremmo addirittura evocare la figura del<br />
“trickster”, cioè quello che Jung e Kerényj chiamano il “briccone divino”, una figura connessa con il<br />
folklore arcaico, con un mondo non razionalizzato e tecnicizzato, una figura che porta sconvolgimenti e<br />
rovescia comicamente gli ordini sociali. Alvar è una versione romanzesca del briccone divino: è abile<br />
e agisce sulla sorte di coloro che lo circondano, modifica i destini, è un “alchimista della fortuna” ma<br />
nello stesso tempo è indefinibile, imprendibile, ha un piede sulla terra e sulla luna, si caratterizza per<br />
il piacere legato al dono, all’elargizione di denaro, al gusto per la festa e per il gioco. Non per niente la<br />
sua apparizione nel paese di Naularo è accompagnata dall’introduzione del cinematografo, cioè di una<br />
grande illusione fondata sulle ombre e sulle immagini, sull’uso di strumenti visivi che modificano il reale,<br />
mentre la sua fortuna è legata all’accumulo di grandi ricchezze dovute all’abilità nel gioco e nella<br />
sfida alla sorte. Sgorlon rivela chiaramente quali sono i materiali mitologici da lui usati nella ideazione<br />
del suo personaggio che è come i personaggi pirandelliani alla ricerca di un’identità sempre sfuggente:<br />
...lui era Nessuno, come l’Ulisse omerico per Polifemo; per chissà quanto tempo, forse per tutta<br />
la vita, avrebbe dovuto continuare a essere uno che non c’era più. Era pensoso e malinconico, anche<br />
se le cose andavano perfettamente secondo i suoi piani (...) Ma, nella sua tristezza di fondo, Alvar si<br />
sentiva anche leggero come una nuvola. Il suo pensiero era sempre lieve, arcanamente staccato dalle<br />
vicende umane, che si annidavano tra loro per formare la storia. Anche il suo corpo e le sue membra<br />
erano educate alla leggerezza, come fosse un acrobata. 1<br />
Dunque una nuova opposizione, l’elemento saturnino della meditazione e dell’angoscia sull’identità<br />
unito all’elemento mercuriale della leggerezza e della passione per la velocità: Alvar può egualmente<br />
guidare la carrozza, vestito come un uomo dell’ottocento in frac e cilindro, e utilizzare l’automobile<br />
o l’aereo, è un uomo al confine tra le epoche, un perfetto equilibrista tra mondi finiti e mondi che<br />
devono ancora sorgere: in lui si consumano i fasti della Belle Époque e le tragedie della prima guerra<br />
mondiale, dopo la rotta di Caporetto. Sgorlon ha volontariamente collocato il suo eroe in una dimensione<br />
epocale dove la fine di un’epoca sfocia nell’apertura di un’epoca nuova. Come accade per quasi tutti<br />
i suoi intrecci storici, la ricchezza dei particolari e dei riferimenti nasconde un secondo piano di lettura,<br />
un piano nascosto che allude a movimenti epocali molto più ampi, all’aprirsi e chiudersi di cicli storici,<br />
alla scomparsa di culture nelle pieghe della storia.<br />
Penso all’Armata dei fiumi perduti dove viene recuperata la vicenda di un’armata cosacca approdata<br />
in Friuli durante la seconda guerra mondiale: i cosacchi, in rivolta contro il regime sovietico comunista<br />
che ha giustiziato lo zar, si trovano nella paradossale situazione di essere alleati dei tedeschi,<br />
a loro volta ex alleati degli italiani. Un episodio storico minore, una memoria di genocidio dimenticata:<br />
Sgorlon la recupera, le ridà consistenza, ma nello stesso tempo ne fa l’allegoria della lotta tra il male<br />
che si annida nei labirinti della storia e un principio di salvezza rappresentato dalla protagonista femminile,<br />
Marta, una donna capace di resistere alle violenze sia dei cosacchi che dei tedeschi e di porgere<br />
un principio di speranza grazie al suo rapporto privilegiato con le forze positive del mondo naturale.<br />
Dunque Alvar è, allegoricamente, al discrimine tra due epoche, è colui che porta nel mondo moderno<br />
i conflitti del mondo appena chiuso: è il Senex che incarna la storia e ne resta dipendente, ed è il<br />
Puer che vorrebbe uscir fuori dalla storia e vederla ricominciare da capo. A questo contribuisce anche<br />
1 Carlo Sgorlon, L’uomo di Praga, Milano, Mondadori, 2003, p. 125.
l’origine misteriosa di Alvar, che lo pone nella schiera dei personaggi mitici, i fanciulli divini che non<br />
conoscono i genitori e che possono quindi farsi portatori di nuovi inizi. Per questo in Alvar sopravvive la<br />
memoria di un popolo esotico, i Tarahumara, le cui abitudini Sgorlon ricava dagli scritti di Antonin Artaud,<br />
un popolo che segue abitudini mistiche fondate sulla danza e che vive sulla Sierra Madre, in una<br />
condizione precedente alle innovazioni tecnologiche su cui si basa il mondo occidentale. E per questo<br />
in Alvar rivive qualcosa della nonna, la nobile Costanza, iniziata ai misteri della Terra, capace di una comunicazione<br />
con forze naturali. Costanza rappresenta il principio saldo di comunicazione con il creato<br />
che tutti i personaggi del romanzo, Alvar in primis, vanno cercando. In lei la Terra è forza riproduttiva<br />
ma anche morte e sacrificio, se è vero che l’anziana donna muore proprio spargendo il suo sangue nella<br />
terra dei suoi possedimenti e lasciandoli quindi in eredità al nipote. Costanza rappresenta un nucleo<br />
mitico intenso, un pensiero primitivo che Alvar deve metabolizzare nella sua ricerca. Per lui non può<br />
esserci pienezza mitica come per la nonna: Sgorlon è ben consapevole che il mito riesce a sopravvivere<br />
solo come memoria, come bagliore che illumina il presente, come recupero sempre ai limiti dell’impossibile.<br />
Per questo in Alvar devono trovare conciliazione la mitologia arcaica della nonna Costanza e il<br />
senso della proprietà terriera di un moderno amministratore che però impronta la sua visione a quella<br />
dei Tarahumara, per i quali non esiste il senso della proprietà ma i beni naturali sono condivisi.<br />
L’altro stratagemma con cui Sgorlon riesce a far sopravvivere le memorie del mito in un contesto<br />
completamente desacralizzato è la presenza della vita collettiva colta nel suo aspetto festoso e<br />
pubblico: la Sala Olympia, un lussuoso locale da ballo risalente alla Belle Époque, continua a essere il<br />
luogo frequentato dai personaggi, che vi ritrovano il sentimento di leggerezza e di spontaneità che si<br />
incarna nella danza. Alvar, Veronica, Marta, Edoardo sembra che siano sulla terra solo per trovare l’intreccio<br />
adatto ai loro destini, per entrare in rapporto e realizzare una linea coerente negli accordi reciproci.<br />
Sgorlon li segue nel delinearsi di campi magnetici con i quali si attraggono o si respingono, anche<br />
se c’è in loro la consapevolezza della dissoluzione e della scomparsa. Nella Sala Olympia “tutti si sentivano<br />
trasportati da un’onda alla quale si affidavano con letizia e con una leggera vertigine. Essa era la<br />
risultanza di varie cose, la musica, le luci, i colori, i profumi, le decorazioni di stile floreale. La saggezza<br />
elementare insegnava che a quell’onda conveniva abbandonarsi e lasciarsi trascinare da essa. La dolcezza<br />
del vivere consisteva nel non opporsi alla corrente” 2 (190). Ma i personaggi esistono in quanto i<br />
loro destini producono effetti positivi dovuti a un agire e a un fare fondati sulla sapienza tecnica: sono<br />
artisti, creatori, pensatori, sono in realtà tutte immagini del creare artistico-letterario e del suo muoversi<br />
nel dubbio e nell’incertezza. Per questo, un romanzo di Sgorlon ha l’aspetto di un oggetto solidissimo<br />
e concreto, ma al suo interno si muove una forza disgregante che lentamente corrode le frasi e consuma<br />
le parole, lasciando appena alla fine un appiglio con la concretezza del mondo.<br />
Compare qui la concezione scientifica dello scrittore, concezione che convive con la visione mitica<br />
e di cui Alvar dà una prima versione:<br />
A volte, pensando alla propria inconsistenza, gli pareva di essere un’ombra cui non corrisponde<br />
niente di solido e di sostanziale. Anche la materia era fatta enormemente più di vuoti che di pieni,<br />
ossia di particelle infinitamente piccole, organizzate da un quid che nessuno sapeva cosa fosse, un’energia<br />
senza massa e senza dimensione. Sarebbe bastata una brevissima disfunzione di un paio d’ore,<br />
nel sistema della gravitazione universale, perché la terra uscisse dall’orbita, e si perdesse negli spazi<br />
siderali per sempre... 3<br />
2 Carlo Sgorlon, L’uomo di Praga, cit. p. 190.<br />
3 Ibidem.<br />
19
20<br />
Questa visione atomistica, rinforzata dalle teorie sull’energia insita nella materia, sembra corrodere<br />
dall’interno gli intrecci complicatissimi e elaborati dei racconti di Sgorlon, che ne darà diverse<br />
varianti, fino a metterla al centro del suo ultimo romanzo, Il circolo Swedenborg. Alla fine, la vita è il<br />
risultato della conciliazione tra un vorticare di particelle che restano coese per l’azione di un’inesplicabile<br />
energia cosmica e il forsennato interrogarsi da parte degli individui sul senso della loro sorte<br />
nell’universo. Le domande di Alvar su di sé sono le domande ultime sulla natura del mondo. Ma l’effetto<br />
di instabilità del personaggio si riflette nella vertigine della lettura, per cui tanto più gli intrecci si<br />
infittiscono quanto più il racconto sembra smaterializzarsi: resta solo il limitato terreno su cui in quel<br />
momento si appoggiano i piedi, e intorno c’è il vuoto.<br />
Per tutti i personaggi di Sgorlon la sfida è sempre rivolta alla complessità del mondo e al mistero<br />
che si cela dietro a questa complessità, dal quale deve nascere un’opera dell’azione o della creazione<br />
artistica. Qualcosa di simile avviene per Fabrizio Mattioni, il regista della Tredicesima notte che<br />
torna al paese di Monterosso e ritrova le radici della propria creatività. Potremmo leggere questo percorso<br />
di recupero delle radici e di riapertura di uno spazio fecondo dell’immaginazione in controluce con<br />
le idee di Cesare Pavese sul mito e sul bisogno di ritrovare i paesaggi originari che caratterizzano la vita<br />
infantile di ogni individuo per estrarre da essi il significato del destino. Pavese è l’autore che più ha<br />
investigato nel nostro novecento l’importanza del mito e della fiaba come fonti di operazione letteraria<br />
moderna. E Sgorlon non ignora di certo i legami di Pavese con la cultura irrazionalistica del secolo, con<br />
gli studi di antropologia e di storia della religione. Nel caso di Sgorlon, però, la presenza di un fondo<br />
mitico non porta a esiti tragici o cruenti ma produce effetti di positiva riscoperta delle origini individuali<br />
e collettive. E questo avviene sempre grazie alla mediazione di creature femminili capaci di donare<br />
agli uomini nuove ricchezze creative (nel caso del regista Mattioni si tratta della strega Veronica). La<br />
femminilità, col suo lato oscuro, era per Pavese uno scoglio su cui si infrangeva il destino maschile,<br />
nel tormento della scoperta e della comprensione. Sgorlon vede invece l’operazione feconda e salvifica<br />
delle donne. Quando si tratta di ricostruire la cattedrale di Monterosso, simbolo della ritrovata unità<br />
del paese, la strega Veronica vuole che rimangano nell’edificio tutti i segni di culture arcaiche anche<br />
nel loro aspetto più conturbante:<br />
Lei a nessun patto avrebbe voluto rinunciare alla ‘zoologia fantastica’ della Cattedrale, o alle<br />
maschere degli androni, e meno che mai all’immaginario collettivo, da cui quelle cose traevano la loro<br />
origine, perché esso era sentito da lei come una ricchezza, un vero serbatoio di fantasie, immagini e<br />
suggestioni, profondamente legate con l’arte. Le incarnazioni del fantastico e dello spettrale impressionavano<br />
anche lei, a volte, però mai avrebbe voluto rinunciarvi. Sentiva che facevano parte di sé e<br />
di Monterosso, così come di tutte le civiltà di montagna e di campagna, e la loro dissoluzione sarebbe<br />
stata una perdita grave. 4<br />
Qui emerge con forza la posizione che assumono i personaggi femminili nei racconti di Sgorlon,<br />
dove non si può dare vera ricerca da parte degli uomini senza l’intervento risolutore dell’ottica femminile.<br />
Nel romanzo sui cosacchi, è proprio una donna, Marta, a svolgere un ruolo di mediazione non solo<br />
tra i popoli nemici ma anche tra una posizione interna alla Storia e una posizione di contatto con le forze<br />
irrazionali che scorrono sotto gli eventi storici. All’inizio del romanzo, si dice che Marta non riusciva a<br />
comprendere il concetto di “nemico” e che non poteva concepire la guerra, e proprio per questo la sua<br />
4 Carlo Sgorlon, La tredicesima notte, Milano, Mondadori, 2001, p. 230.
casa, nel corso delle vicende, diventa approdo di uomini di nazionalità diverse, partigiani e cosacchi,<br />
friulani e russi, che vengono accolti e amati senza distinzioni. Lei stessa può legarsi in due momenti<br />
diversi a due uomini di partiti opposti, il cosacco Urvàn e il partigiano Ivos, due personaggi malinconici<br />
che sentono profondamente il dramma che li circonda, pur su fronti avversi. Intorno a Marta si apre<br />
uno spazio di salvezza che viene presto messo in crisi dalla violenza del combattimento e dalla ferocia<br />
con cui i cosacchi reagiscono alla situazione storica dentro la quale si sentono condannati a soffocare.<br />
Il male si incarna nel violento e distruttivo Burlak, mentre Urvàn possiede un filtro meditativo che gli<br />
consente di tenere a bada gli istinti barbarici della sua razza. Marta vede subito negli invasori stranieri<br />
delle vittime della storia, e li accoglie come tali nel cerchio della sua protezione:<br />
A Marta i cosacchi facevano pena. Tutti le facevano compassione, i soldati che rischiavano la<br />
vita sui fronti, i partigiani che stavano a morire di freddo sulle montagne, i prigionieri, gli sbandati, i dispersi.<br />
Ma i cosacchi più di tutti le provocavano uno stringimento di cuore doloroso perché sentiva che<br />
non avevano più una patria né un destino. 5<br />
In altra sede, ho ipotizzato che Sgorlon continuasse a guardare a uno dei modelli della sua operazione<br />
letteraria, cioè Elsa Morante, e che la concezione del male e del sacrificio delle creature umili<br />
che la Morante mette al centro del suo grande affresco epocale, La Storia, venga ripresa nel racconto<br />
del genocidio dei cosacchi, un genocidio sommerso e dimenticato. Al confronto con la misera maestra<br />
Ida Ramundo, madre di creature destinate alla morte e quindi portatrice sulla propria carne delle tragedie<br />
del secolo, Marta, il personaggio di Sgorlon, assomma su di sé i modelli mitici di Penelope e di<br />
Circe, è oggetto d’amore e nello stesso tempo conosce i ritmi eterni del mondo naturale al di là della<br />
storia, non diventa madre perché implicitamente è già madre di tutti, sa risolvere le contraddizioni della<br />
storia nell’abbraccio di una femminilità cosmica.<br />
Quando Sgorlon affronta il suo ultimo, impegnativo romanzo, tutti i motivi del mito e della visione<br />
scientifica dell’universo che ho elencato acquistano un nuovo spessore. Il circolo Swedemborg è<br />
un romanzo di idee, come lo era stato in precedenza Il velo di Maya, e si tratta di idee incarnate in figure<br />
concrete, uomini e donne, dalla cui collaborazione nasce una nuova immagine dell’universo. Come<br />
l’Alvar dell’Uomo di Praga, anche il protagonista del nuovo romanzo possiede le caratteristiche dell’avventuriero<br />
la cui origine mitica conferisce un ruolo privilegiato. Ermes si rivela esplicitamente, fin dal<br />
nome, l’incarnazione dello spirito Mercurio che Sgorlon ricava dalle letture di Jung: abile, colto, intuitivo,<br />
Ermes è il portatore di un messaggio salvifico che si oppone al pensiero comune, alla doxa, e cerca<br />
di realizzare la sua missione con un concreto e complesso progetto intellettuale. Come Alvar, Ermes è<br />
“alchimista della fortuna”, è imprendibile e indefinibile, sente la vastità del cosmo come un problema<br />
personale da risolvere nel nome dell’intera umanità:<br />
Lo attiravano, come sempre, i problemi metafisici, quelli che parlavano delle questioni di fondo<br />
dell’Essere, perché di esse possedeva un sentimento vastissimo e intenso. Cercava anche di scoprirne<br />
il motivo, e riteneva di aver trovato la risposta: sentiva infinitamente e profondamente di far parte del<br />
sistema infinito del Reale.<br />
Tutto ciò che egli era veniva da spazi e da tempi infinitamente lontani, nella sconfinata storia<br />
dell’universo, che era cominciata chissà dove e chissà quando. Lui non era soltanto Ermete Lunati<br />
5 Carlo Sgorlon, L’armata dei fiumi perduti, Milano, Mondadori, 1985, p. 77.<br />
21
22<br />
Eudòxios, perché, come tutti, veniva da entità e forze vertiginosamente remote, da infinite generazioni<br />
del passato, da mutamenti e trasformazioni arcanamente numerose della Vita. 6<br />
Proprio perché discendente del dio Mercurio, Ermete possiede la leggerezza e la mobilità del<br />
pensiero che gli consentono di non restare invischiato nella pesantezza materiale del mondo. In lui si<br />
tirano le somme di un pensiero antichissimo, che risale ai greci, ai mistici, a Giochino da Fiore e a Giordano<br />
Bruno, un pensiero che guarda alle cose sempre tenendo presente un altro aspetto nascosto, per<br />
cui le cose sono anche il loro non essere. Sgorlon sembra rendere ancora più fitti in questo romanzo i<br />
riferimenti culturali a un pensiero che il materialismo occidentale ha sempre voluto allontanare e ignorare.<br />
Ma non si tratta di un atteggiamento banalmente spiritualista o misticheggiante. Il romanzo è una<br />
struttura narrativa e funziona in quanto fa muovere personaggi che compiono azioni. Sgorlon non può<br />
rinunciare alla sua abilità di costruttore di intrecci che hanno origine sempre in un sostrato fiabesco,<br />
fortemente allusivo. La ricerca di un luogo “magico” in cui realizzare il progetto intellettuale e tutte<br />
le avversità che Ermete affronta con la moglie Octavia per fondare nell’Abbazia il centro di diffusione<br />
del nuovo pensiero costituiscono il nucleo del romanzo vero e proprio. Anche in questo caso, l’Abbazia<br />
assume il ruolo che hanno nei romanzi precedenti i piccoli cosmi di Monterosso o Naularo, cioè di<br />
uno spazio determinato dentro al quale un gruppo ristretto di persone si trova a vivere un’esperienza<br />
eccezionale: il legame tra questi eletti, il rapporto intellettuale che li lega costituiscono una forma di<br />
erotismo sublimato per cui questa piccola comunità, all’insegna dell’amore, può farsi modello di comunità<br />
future. Così Sgorlon riprende la base “comica” e “parodica” che sta all’origine del romanzo antico,<br />
quell’origine che porta direttamente ai dialoghi platonici e alla figura di Socrate come primo personaggio<br />
romanzesco della cultura occidentale.<br />
In questo caso, i legami profondi che in altre opere venivano ricercati con forze primigenie della<br />
natura, o con simboli che si facevano mediatori di quelle forze, sono stati trasposti in una dimensione<br />
aerea e cosmica, perché Ermes cerca nei segreti dell’universo la base sulla quale fondare una spiegazione<br />
della vita umana. Uomo “acosmico” come Alvar, Ermes usa la metafora dei “naufraghi dell’universo”<br />
per definire la condizione degli uomini. Non esistono cioè immagini che possono rendere la complessità<br />
inspiegabile del cosmo: “Gli parve che una delle regole incomprensibili del mondo consistesse<br />
nel fatto che ciò che appariva come cosa salda fosse sorretto da un’ombra, un fantasma, un nulla” (le<br />
tre espressioni finali sono un’esplicita citazione leopardiana). È per questa strada che dunque Ermete<br />
giunge a mettere in crisi il principio stesso della razionalità occidentale e a ipotizzare un nuovo ordine<br />
dell’universo, un ordine ancora tutto da scoprire e codificare: “Allora, se le due ipotesi non lo persuadevano,<br />
né quella dell’eternità della materia, né quella della sua creazione, doveva cercarne una terza,<br />
che la logica aristotelica non ammetteva, perché una cosa o era vera o era falsa”.<br />
In sintonia con queste idee, sembra che tutto il romanzo voglia recuperare il valore originario<br />
di una parola nuova che si oppone alla “doxa”, cioè alla parola consumata dell’opinione comune. Secondo<br />
quello che spiega Bachtin, la parola romanzesca è sempre legata alla libertà sovvertitrice e liberatoria<br />
del carnevalesco e del comico, cioè di un’origine antropologica che ha a che fare con culture<br />
popolari fondate sul rispetto di cicli stagionali nei quali si alternano i grandi principi della morte e della<br />
vita, della fine e dell’inizio. Nella concezione di Sgorlon, il carnevalesco permane non nella presenza<br />
del comico ma nella forza con cui le situazioni dialogiche e narrative portano i personaggi a elaborare<br />
soluzioni di uscita dalle concezioni vecchie e scontate del mondo. Ogni personaggio dei romanzi<br />
6 Carlo Sgorlon, Il circolo Swedenborg, Milano, Mondadori, 2010, p. 66.
di Sgorlon sembra guardare verso ordini e assetti universali completamente anomali rispetto a quelli<br />
esistenti: può sembrare un “fool”, un “trickster”, un “briccone divino” proprio in virtù dello sconvolgimento<br />
che la sua azione opera all’interno del mondo così com’è. Proprio le fantasticherie e le visioni<br />
oniriche – spiega Bachtin – rompono l’immagine di una integrità “epica” dell’uomo, cioè l’idea di una<br />
compiutezza intangibile, e si aprono le possibilità di un altro uomo e di un’altra vita, cioè il percorso di<br />
ricerca di nuove verità.<br />
All’interno del romanzo, uno dei segni di sovversione più espliciti rispetto a un ordine costituito,<br />
lo troviamo quando Ermete accetta la proposta della “maga” Sabina (una discendente della Veronica<br />
del romanzo di Monterosso) di diffondere un calendario completamente alternativo rispetto a quello<br />
gregoriano. Il calendario di Sabina, che è creatura notturna, vicino alla natura dei licantropi, si rivela<br />
infatti un “lunario” (uno dei cognomi di Ermete è Lunati) ed è fondato sui cicli della luna, con un ritmo di<br />
tredici mesi anziché dodici. Questa rivoluzione costituisce una versione del “carnevalesco” all’interno<br />
del romanzo: la sovversione di un pensiero anomalo che non riconosce più l’ordine istituito e condiviso.<br />
Ermete rielabora così le suggestioni che derivano da una modalità femminile del pensiero, sia dalla<br />
moglie Octavia sia dall’adepta Sabina. Il circolo di iniziati si fonda interamente sullo spostamento del<br />
potere dalla prospettiva maschile a quella femminile. Ermete elabora un articolo che nasce dagli scambi<br />
di idee con le due donne: “come se volesse mettersi accanto alle due donne del circolo ancora senza<br />
nome, e con loro costituire una specie di troika storica, o mistica, o letteraria, o tutte e tre le cose insieme,<br />
sopra uno sfondo religioso che pareva un po’ il trait d’union che le collegava.” 7<br />
E così il circolo, che prende nome dal mistico svedese Swedenborg, nasce proprio nel nome di<br />
una comunanza spirituale fondata su una liturgia che ricorda, parodiandolo, il mito eucaristico su cui è<br />
fondata la comunità cristiana. Si tratta dell’assunzione del vino come bevanda che dona unità al gruppo:<br />
Era invece una sorta di liturgia carismatica, quasi che il vino subisse un’arcana modificazione.<br />
Quando si riunivano pareva loro di appartenere a un’antica setta. Da essa non sarebbe scaturito mai<br />
nulla di violento o di distruttivo, bensì qualcosa in rapporto con gli enigmatici mutamenti che avvengono<br />
nel sentire profondo degli uomini, nello Spirito del Tempo e nel Mondo della Storia, di cui un po’ tutti<br />
si alimentano, ne siano consapevoli o no. 8<br />
Gli adepti cercano di recuperare quelle facoltà sensitive che la civilizzazione ha cancellato e<br />
che invece caratterizzavano la vita dei primitivi. Il recupero di un passato arcaico e la prospettiva di fondare<br />
un pensiero nuovo e inatteso fanno parte ancora una volta della carica utopica e sovversiva che la<br />
parola romanzesca possiede sin dalle sue origini.<br />
In questo senso, percepiamo ancora il legame tenace che unisce il racconto di idee contenuto<br />
nel racconto avventuroso con le origini del dialogo socratico: ogni episodio che caratterizza il romanzo<br />
contiene una parte della elaborazione di idee “ultime”, cioè assolute, dalla cui combinazione nasce<br />
l’insieme dell’opera. Qualcosa di simile si dicevano Thomas Mann e Carlo Kerényi scambiandosi opinioni<br />
intorno al romanzo, alla mitologia e alla religione. Secondo Kerényi, il poeta è un uomo “festoso”<br />
perché la natura della festa sta proprio nell’interruzione del cammino del mondo e nell’apparizione di<br />
figure eterne che allargano le dimensioni normali del tempo “fino ai limiti di una immobile eternità”.<br />
Anche il progetto di Ermete Lunati partecipa della natura del “festoso”, cioè di un agire intenso tra gli<br />
7 Op. cit., p. 169.<br />
8 Op. cit., p. xxxx<br />
23
24<br />
uomini guardando a una nuova dimensione dell’esistere. In lui si sommano tutti i grandi progetti dei<br />
personaggi di Sgorlon, e tutte le imprese eroiche che vanno nella direzione di una profonda revisione<br />
dei parametri con cui si intende il mondo. Sgorlon aveva bisogno della natura eterna e intoccabile del<br />
racconto fiabesco per elaborare i suoi complessi messaggi di interprete del mondo attuale (interprete,<br />
cioè ermeneuta, cioè figlio di Hermes). Quando, nell’ultima parte del romanzo, l’abbazia e la stamperia<br />
con cui gli adepti diffondono le loro pubblicazioni vengono distrutte dal fuoco, Ermete riesce a superare<br />
subito la fase dell’angoscia e a riprogettare il futuro per sé e per i suoi compagni d’avventura. Da<br />
giovane, Ermete aveva salvato dall’incendio una grande nave sulla quale lavorava come ufficiale, e ora<br />
questa stessa nave serve per distrarre gli amici mentre lui, da solo, pensa alla ricostruzione. Si tratta di<br />
un passaggio ancora una volta mitico-fiabesco, dove l’eroe si fa carico di un nuovo inizio grazie a forze<br />
immense che gli consentono di superare la crisi sua e della sua comunità di appartenenza. Così l’abbazia<br />
rinasce dalle ceneri e diventa una nuova casa editrice adatta a diffondere grandi testi di spiritualità.<br />
In questo modo lo scrittore accenna anche alla sua stessa operazione, il romanzo parla della possibilità<br />
di far ritornare in vita un mondo intellettuale lontanissimo dai nostri tempi. Sgorlon non può rinunciare<br />
a questa sigla utopica che probabilmente sentiva con molta intensità. Così come non poteva chiudere<br />
le imprese del suo ultimo eroe se non nel pensiero della morte e dei cicli cosmici che si succedono<br />
nell’eternità: “Un giorno era nato, un altro sarebbe morto su questa astronave per noi immensa, ma<br />
piccolissima nei confronti dell’universo, chiamata Terra, che corre a oltre centomila chilometri all’ora<br />
dentro il labirinto sconfinato dello spazio, verso un porto che nessuno conosce”. 9 La festa del racconto<br />
non ha paura di guardare direttamente alla fine, dal momento che nell’ottica del tempo carnevalesco<br />
c’è continuità tra morte e rinascita, costruzione e distruzione, e il mondo degli uomini può essere osservato<br />
dall’esterno, come un oggetto definito: il narratore, con un’ultima immagine, ci fa sentire qual è la<br />
strada che resta ancora da percorrere prima di arrivare a nuove verità.<br />
Nota<br />
Mi fa piacere qui ricordare che Sgorlon mi chiese di scrivere i risvolti dei suoi ultimi romanzi, in particolare Il velo di Maya, Le sorelle<br />
Boreali e Il circolo Swedenborg. Questo onore derivò dall’amicizia nata tra noi dopo la presentazione, fatta a Bologna, alla<br />
Biblioteca dell’Archiginnasio, del Processo di Tolosa.<br />
9 Op. cit., p. xxxx
Sul fantastico di Carlo Sgorlon<br />
di Srefano Lazzarin<br />
Università di Saint-Étienne, Francia<br />
Horror, fiabesco, fantastico nell’opera di Sgorlon<br />
[N]el mondo reale tutto aveva una spiegazione<br />
che non era tale fino in fondo, ma<br />
un’ipotesi di genere mitico. La realtà era<br />
sempre ambigua, contraddittoria, misteriosa,<br />
incoerente, e come tale una cosa<br />
soltanto sarebbe stata logica e razionale,<br />
ossia che non esistesse. Invece esisteva. 1<br />
Il dibattito sulla nozione di ‘letteratura fantastica’ dura da circa un secolo e si è acceso soprattutto<br />
negli ultimi quarant’anni, a partire dalla pubblicazione di un famoso libro di Tzvetan Todorov, l’Introduction<br />
à la littérature fantastique (1970) 2 . Secondo Todorov – e altri studiosi, soprattutto francesi,<br />
che ne hanno anticipato o ripreso le tesi 3 – il fantastico andrebbe inteso come un genere o un modo<br />
letterario di preferenza breve, che mette in scena un tipo di soprannaturale inquietante, perturbante,<br />
terrificante. Un racconto sarebbe fantastico quando riferisce eventi che mettono in crisi la coerenza del<br />
nostro universo: eventi inesplicabili, sconcertanti e spaventosi perché, se fossero veri, farebbero esplodere<br />
il «paradigma di realtà» 4 su cui fondiamo la nostra rappresentazione del mondo. Roger Caillois ha<br />
detto, con una formula felice, che il fantastico è la manifestazione di «un scandale, une déchirure, une<br />
irruption insolite, presque insupportable dans le monde réel» 5 .<br />
Nel presente saggio si farà riferimento a questa nozione del fantastico, e non alla pur geniale<br />
provocazione di due scrittori argentini, Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, i quali ebbero ad af-<br />
1 C. Sgorlon, L’alchimista degli strati, Milano, Mondadori, 2008, p. 15.<br />
2 Cfr. T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970.<br />
3 Sulla ‘scuola francese’ – contrapposta a quella ‘anglosassone’ – e sulla definizione di fantastico qui adottata cfr. S. Lazzarin,<br />
Il modo fantastico, Roma-Bari, Laterza, 2000, soprattutto le pp. 14 e 79, e Idem, Dérive(s) du fantastique. Considérations<br />
intempestives sur la théorie d’un genre, «Comparatistica», XIV, 2005, pp. 113-136.<br />
4 Su questa nozione cfr. L. Lugnani, Pear una delimitazione del «genere», in R. Ceserani et alii, La narrazione fantastica, Pisa,<br />
Nistri-Lischi, 1983, pp. 37-73, e in particolare la definizione sintetica che si legge a p. 54.<br />
5 R. Caillois, De la féerie à la science-fiction. L’image fantastique (1958), in Idem, Obliques, précédé de Images, images..., Paris,<br />
Stock, 1975, p. 14.<br />
25
26<br />
fermare che «tutta la letteratura è fantastica» 6 . Ma oltre al fantastico così concepito evocheremo altri<br />
generi o modi letterari, contigui seppur non assimilabili al fantastico: per esempio l’horror e il fiabesco.<br />
Nell’opera narrativa di Carlo Sgorlon (1930-2009), in effetti, compaiono tracce significative di tutti<br />
i generi della littérature de l’imaginaire, secondo la terminologia degli studiosi francesi (gli anglo-americani<br />
parlerebbero invece di fantastic literature). I ‘generi dell’immaginario’ – se mi si passa l’espressione<br />
imprecisa, che adopero per comodità di linguaggio – sono non soltanto soggiacenti alla scrittura<br />
di Sgorlon, ma soprattutto nella fase iniziale della carriera dell’autore friulano, pervasivi. Cercherò di<br />
dimostrarlo attraverso l’analisi di tre campioni testuali che appartengono rispettivamente ai romanzi La<br />
notte del ragno mannaro (1970), La luna color ametista (1972) e Il trono di legno (1973).<br />
La notte del ragno mannaro (1970), ovvero: il Licantropo<br />
Uno dei principali temi della letteratura fantastica è quello del licantropo o lupo mannaro.<br />
Quest’ultimo – come accade al vampiro suo parente – si presta alle interpretazioni allegorico-metaforiche<br />
e può assumere perciò i significati più diversi. Già nel marxiano Das Kapital (1867) l’immagine del<br />
licantropo veniva adoperata – accanto a quella del vampiro appunto – per indicare la brama smisurata<br />
di pluslavoro del capitale. Afferma Karl Marx che «[i]l capitale è lavoro morto che resuscita, come un<br />
vampiro, solo succhiando lavoro vivo, e tanto più vive quanto più succhia» 7 ; e descrive il capitalista come<br />
un licantropo, divoratore perché divorato lui stesso da una «fame da lupi mannari di pluslavoro» 8 .<br />
Questa imagerie non sorprende troppo in chi, nel Manifest der Kommunistischen Partei (1848) scritto<br />
in collaborazione con Friedrich Engels, aveva nominato – ed esorcizzato – fantasmi e stregoni; nel famosissimo<br />
incipit «[u]no spettro si aggira per l’Europa» 9 , mentre poche pagine più avanti ci imbattiamo<br />
addirittura in un evocatore di demoni:<br />
Le condizioni borghesi di produzione e di scambio, i rapporti borghesi di proprietà, la moderna società borghese,<br />
che ha evocato come per incanto così potenti mezzi di produzione e di scambio, rassomigliano allo stregone che non può<br />
più dominare le potenze sotterranee da lui evocate. 10<br />
In tutto ciò si possono cercare conferme della vivacità propriamente stilistica della prosa di<br />
Marx, o del fatto che a metà Ottocento era molto diffusa non soltanto la paura delle rivendicazioni proletarie,<br />
ma pure l’ambiguo piacere del soprannaturale 11 ; quanto a noi, può bastare l’osservazione iniziale:<br />
che il lupo mannaro è un personaggio disposto a indossare vesti metaforiche. E se un politologo può<br />
6 J. L. Borges, A. Bioy Casares, Prefazione all’edizione italiana (1980), in J. L. Borges, S. Ocampo, A. Bioy Casares (a cura di),<br />
Antologia della letteratura fantastica (Antología de la literatura fantástica, 1940), Roma, Editori Riuniti, 1992, p. IX.<br />
7 K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 1867), a cura di E. Sbardella,<br />
Roma, Newton Compton, 1996, p. 181. Cfr. anche ivi, p. 197: «la sete da vampiro che il capitale ha del sangue vivo del lavoro».<br />
8 Ivi, p. 188. Cfr. anche ivi, p. 203: «avidità da lupo mannaro di pluslavoro».<br />
9 K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista (Manifest der Kommunistischen Partei, 1848), Roma, Editori Riuniti, 1994,<br />
p. 3.<br />
10 Ivi, p. 12.<br />
11 In questa prospettiva, l’incipit del Manifesto è stato analizzato a più riprese. Ricorderò soltanto: F. Orlando, Per una teoria<br />
freudiana della letteratura (1973), Torino, Einaudi, 1987, p. 119; R. Jackson, Fantasy: The Literature of Subversion, London-<br />
New York, Methuen, 1981, p. 131; J. B. Monleón, A Specter is Haunting Europe. A Sociohistorical Approach to the Fantastic,<br />
Princeton (New Jersey), Princeton University Press, 1990, p. 60; S. Albertazzi, Il punto su: La letteratura fantastica, Roma-Bari,<br />
Laterza, 1993, p. 17; R. Ceserani, Il fantastico, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 109; S. Melani, L’eclisse del consueto. Angeli,<br />
demoni e vampiri nell’immaginario vittoriano, Napoli, Liguori, 1996, p. 131.
servirsene in tal senso, cosa non faranno gli autori di narrazioni dichiaratamente immaginarie? Sono in<br />
effetti i testi di finzione a sviluppare più ampiamente queste potenzialità del personaggio, soprattutto<br />
quelli novecenteschi. Limitandoci alla letteratura italiana, potremmo menzionare per esempio un racconto<br />
di Alberto Savinio, Villetta in collina, pubblicato nella raccolta Il signor Dido (i cui testi, apparsi<br />
originariamente sul «Corriere della Sera» fra il 1949 e il 1952, furono poi riuniti in volume dopo la morte<br />
dello scrittore, nel 1978). Qui la licantropia è immagine trasparente e tragica del morbo di Parkinson,<br />
che immobilizza un uomo nella sua poltrona e lo obbliga a ululare per essere assistito:<br />
Nel punto medesimo in cui il signor Dodi [sic] sta per completare la sua immaginaria felicità coniugale, dalla finestra<br />
della tenda bianca viene fuori un ululato. Il signor Dodi, gelato sul sedile della sua vetturetta scoperta, pensa: “Un<br />
lupo mannaro”. Il signor Dodi, più esattamente, pensa: “Un licantropo”. Questo uomo ‘bianco’, questo nemico di ogni cura,<br />
di ogni responsabilità, gli piace parlare fino. 12<br />
Ogni interpretazione patologica della licantropia è al tempo stesso un’interpretazione metaforica:<br />
vent’anni dopo Savinio, e sessanta dopo il Luigi Pirandello di Male di luna (1913), un’altra significativa<br />
allegoria della condizione licantropica compare nel secondo romanzo di Carlo Sgorlon, La notte del<br />
ragno mannaro (1970) 13 . A dire il vero, il lettore che cercasse l’aracnidantropo – se mi si passa la parola<br />
– nel testo di Sgorlon resterebbe deluso: in esso non v’è se non qualche innocuo ragno domestico, e<br />
la ragnatela telefonica delle fantasie paranoidi del narratore 14 . Solo per un attimo quest’ultimo sembra<br />
conformarsi al destino promesso dal titolo, quando si «sollev[a] sulle braccia e sulle gambe come un<br />
ragno gigantesco» 15 ; ma quest’abbozzo di trasformazione abortisce, né in definitiva il protagonista assomiglia<br />
a un ragno più di quanto assomigli a una giraffa – alla quale si paragona per due volte 16 – o a<br />
un qualsiasi altro esponente del regno animale (similitudini e metafore animalizzanti costellano quasi<br />
ogni pagina del romanzo). Si dovrà concludere che il ragno stia per generico animale mannaro? che la<br />
notte del titolo vada intesa come notte degli esseri mannari, notte delle metamorfosi periodiche? Forse:<br />
il titolo di Sgorlon alluderebbe così allo scatenamento dell’animalità umana nella lunga notte del<br />
sabba, e a quella componente metamorfica che nel romanzo è predominante.<br />
Esiste comunque, nella Notte del ragno mannaro, qualcosa che ricorda una trasformazione licantropica:<br />
la danza di Mirko lo stregone. Vale la pena di citarne alcune sequenze:<br />
È incredibile come riesca a piegarsi tanto all’indietro, massiccio com’è. Si può spiegare soltanto con una lunga<br />
abitudine al contorsionismo, o una tendenza atavica ad esso. Abbassa le mani fino sul pavimento, si mette a ballare<br />
dimenandosi, avvitandosi, mentre l’esercito di figli intorno batte le mani ritmicamente. Ha la faccia rossa, congestionata<br />
e sudata, e gocce di sudore gli schizzano via come soffiate da una cerbottana. È un ballo questo? È ancora un ballo? 17<br />
Mirko non si appoggia più al pavimento con le mani ma con la schiena. Urla, si contorce, si dimena, si rivolta.<br />
[...] Ogni tanto solleva le gambe, [...] e poi le lascia ricadere e ricomincia a dimenarsi disteso sul pavimento, sembra se-<br />
12 A. Savinio, Villetta in collina, in Idem, Il signor Dido (1949-1952, 1978), Milano, Adelphi, 1978, p. 98.<br />
13 Cfr. C. Sgorlon, La notte del ragno mannaro (1970), Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1995. Per un’analisi dettagliata di questo<br />
testo e dei suoi temi licantropici si veda S. Lazzarin, «La notte del ragno mannaro» di Carlo Sgorlon, o del fantastico ancestrale,<br />
«Critica Letteraria», XXXII, ii, 123, 2004, pp. 315-350, di cui riprendo qui parzialmente l’argomentazione.<br />
14 Cfr. C. Sgorlon, La notte del ragno mannaro, cit., rispettivamente p. 14: «ragni, scorpioni, scarafaggi»; e p. 83: «stavolta è sicuro<br />
che sono incappato nella telaragna dei fili del telefono».<br />
15 Ivi, p. 14.<br />
16 Cfr. ivi, pp. 68 e 84.<br />
17 Ivi, p. 52.<br />
27
28<br />
duto sulla sedia elettrica, o bruciato vivo sopra una graticola. [...] Non articola più parole comprensibili ma mugola, squittisce,<br />
ruggisce. 18<br />
Si straccia il bolero rossogiallo [...]. Ad un tratto, di colpo, compare la sua schiena pelosa, scimmiesca, che egli<br />
cerca di abbracciare con le mani, come se lo stessero frustando. È proprio così, lo stanno frustando, perché ogni secondo<br />
la sua schiena ha un guizzo doloroso, e un urlo si rovescia disordinato dalle sue labbra deformate. È un epilettico, un<br />
ossesso, un indemoniato. 19<br />
Se non è una metamorfosi poco ci manca; la scena è estremamente spettacolare, quasi cinematografica:<br />
viene in mente certa filmografia di argomento licantropico, e in particolare un famoso episodio<br />
del film di John Landis An American Werewolf in London (che tuttavia è del 1981, dunque posteriore<br />
al romanzo di Sgorlon). Ma non mancano precedenti letterari, talora illustri: penso a racconti come<br />
The Mark of the Beast (1890) di Rudyard Kipling, e al già menzionato Male di luna di Pirandello. La perdita<br />
progressiva della posizione eretta, la dissoluzione della voce, le contorsioni bestiali simili a quelle<br />
di un indemoniato rappresentano tappe obbligate della metamorfosi licantropica, anche in letteratura:<br />
già il Licaone ovidiano – che propriamente non è un licantropo, ma ha esercitato una grande influenza<br />
sulla letteratura licantropica di tutte le epoche – cerca vanamente di recuperare la parola, ultimo vestigio<br />
della propria umanità ormai dissoltasi («Territus ipse fugit nactusque silentia ruris / Exululat frustraque<br />
loqui conatur») 20 . La danza di Mirko si configura d’altra parte come un rituale sciamanico, secondo<br />
una delle possibili origini della licantropia nel folclore europeo:<br />
È nei rituali sciamanici delle culture nomadi paleolitiche che gli antropologi rintracciano le radici di quella che,<br />
più tardi, venne chiamata – con termine estensivo – «licantropia»: ovvero la capacità, da parte di esseri umani, di trasformarsi<br />
in determinate condizioni nell’animale totemico, ovverossia rappresentativo e protettivo della tribù. [...] A poco a<br />
poco, lo Sciamano che assume in sé lo spirito del lupo a beneficio della tribù si trasforma in creatura infernale dedita a<br />
pratiche esecrabili. I residui della primordiale religione sciamanica si trasformano già in epoca classica in culti infernali<br />
e stregoneschi. L’antica capacità degli Sciamani di identificarsi con gli animali totemici assume connotazioni tenebrose.<br />
Nasce la figura dello Stregone, in contatto per via diabolica con le istintualità più perverse. 21<br />
Durante la sua danza licantropica Mirko esemplifica i due volti della figura sciamanica – quello<br />
totemico e quello diabolico – qui analizzati. Dal punto di vista della tribù dei figli-piragna, egli è lo<br />
sciamano che per via imitativa raggiunge l’identificazione con l’animale totemico; donde l’approvazione<br />
incondizionata che i piragna gli tributano, espressa attraverso l’applauso ritmico che accompagna la<br />
danza e l’entusiasmo orgiastico con cui partecipano al rito 22 . Dal punto di vista degli individui che rappresentano<br />
la razionalità – nella fattispecie il narratore e Dolores – Mirko è invece fonte di malessere<br />
(il narratore: «Mi sento male solo a vederlo, a seguirne le contorsioni») 23 , nervosismo e paura (Dolores:<br />
18 Ivi, p. 53.<br />
19 Ibidem.<br />
20 Ovidio, Le metamorfosi, 2 voll., a cura di E. Oddone, Milano, Bompiani, 1992, canto I, vv. 232-233.<br />
21 G. Pilo, S. Fusco, Il Lupo Mannaro, in Eidem (a cura di), Storie di lupi mannari, Roma, Newton Compton, 1994, pp. 7-9.<br />
22 Cfr. C. Sgorlon, La notte del ragno mannaro, cit., p. 54: «Alcuni bambini si mettono a urlare, altri si pisciano addosso per il<br />
terrore o l’entusiasmo, non so». Più avanti, i diavoletti cercano di totemizzare nientemeno che l’esterrefatto narratore: «L’idea<br />
[...] è rinverdita improvvisamente nel loro sangue di piccoli selvaggi. Vogliono trasformarmi in un totem, e infatti alcuni si<br />
genuflettono, bruciano tabacco o altre porcherie in barattoli, o salmodiano con urla da cavernicoli» (ivi, p. 58).<br />
23 Ivi, p. 53.
«è scossa da un pianto nervoso») 24 ; forse è «malato», probabilmente è «un epilettico, un ossesso» 25 .<br />
Soprannaturale o autosuggestione, dunque? metamorfosi e magia nera, oppure epilessia e convulsioni?<br />
Si ripresenta in questo testo l’alternativa classica del fantastico, quell’hésitation fra spiegazione<br />
razionale e irrazionale in cui Todorov ha riconosciuto la struttura fondamentale del genere 26 ; e come<br />
già in Pirandello, anche in Sgorlon un legame solidissimo stringe licantropia e folclore – non più quello<br />
siciliano, ovviamente, ma il folclore tradizionale del Friuli profondo che sempre Sgorlon mette in scena<br />
nei suoi romanzi 27 .<br />
La luna color ametista (1972), ovvero: Cenerentola<br />
Se nella Notte del ragno mannaro Sgorlon riscrive il tema del Licantropo – secondo Stephen<br />
King, uno dei tre grandi archetipi eternamente ricorrenti nella letteratura d’orrore 28 – nella Luna color<br />
ametista, pubblicata due anni dopo, lo scrittore friulano sembra rivolgere il proprio interesse a una delle<br />
più famose fiabe della letteratura universale: quella di Cenerentola. Il passo cui alludo si legge alla<br />
fine del terzo capitolo. Rabàl, il misterioso giovane che ha in fronte lo «strano segnale» 29 di una mezzaluna<br />
color ametista, è scomparso da diversi giorni, e Viola e Riccardo si sono appena dichiarati il loro<br />
amore, quando all’improvviso l’attenzione dei due viene richiamata da qualcosa di insolito:<br />
Da quella sensazione mi riscosse un rumore che parve subito inconsueto, anche se non avrei saputo indicare<br />
la causa. Restammo immobili, per evitare ogni scricchiolio. Il rumore si sentiva più distintamente. Uno scampanellio, un<br />
tintinnio lontano.<br />
«Cosa pensi che sia?» chiesi a Viola.<br />
«Si direbbero le sonagliere di un cavallo...».<br />
La sua risposta confermava la mia ipotesi. Però non era possibile. Da chissà quanto tempo nessuna carrozza attraversava<br />
il paese, anzi, non ne avevo mai vista una per le strade, solo nelle vecchie pellicole sull’Ottocento [...]. Eppure<br />
doveva trattarsi di una carrozza. Il suono era inconfondibile. 30<br />
Delegittimata fin da subito come improbabile e respinta nel passato ingiallito di un Ottocento<br />
da oleografia, l’ipotesi della carrozza persiste tuttavia ostinatamente:<br />
Andammo a vedere. Il piazzale era deserto. Si scorgevano solo le ombre delle case e degli ippocastani, della<br />
base di un monumento abbattuto forse prima che io nascessi, e della stazione con le colonne bianche sul davanti e l’orologio<br />
nel centro. Il rumore della carrozza si era allontanato. [...] Giungemmo in una viuzza dove potemmo vedere chiaramente<br />
i segni delle ruote nel fango reso molle da una pioggia recente. Infatti la carrozza era dietro una svolta. Aveva<br />
rallentato, come se ci aspettasse; un vecchio veicolo con due fanali anche dietro, luccicante di vernice e con carte oleate<br />
al posto dei vetri. Sentimmo lo scalpitio dei cavalli e vedemmo apparire il cappello piumato del postiglione seduto a cas-<br />
24 Ivi, p. 54.<br />
25 Ivi, rispettivamente pp. 54 e 53 (il primo parere è espresso da Dolores, il secondo dal narratore). Nelle letture in chiave<br />
patologica della licantropia entrambi i motivi sono ricorrenti: basterà pensare, di nuovo, al pirandelliano Male di luna.<br />
26 Cfr. T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, cit.<br />
27 Si può vedere in proposito l’ottimo studio di J.-I. Ghidina, Carlo Sgorlon, romancier frioulan. Société, mythe, écriture, Paris,<br />
L’Harmattan, 2008.<br />
28 S. King, Danse macabre (1981), introduzione di S. Cesari, Roma-Napoli, Theoria, 1992, identifica tre grandi miti che sarebbero<br />
all’origine della letteratura e del cinema d’orrore: Dracula, Frankenstein e il dottor Jekyll. Quest’ultimo, con la sua capacità<br />
metamorfica, rappresenterebbe la più convincente incarnazione dell’archetipo del Licantropo.<br />
29 C. Sgorlon, La luna color ametista (1972), Milano, Mondadori, 1978, p. 17.<br />
30 Ivi, pp. 47-48.<br />
29
30<br />
setta. Accelerammo la corsa, mentre in me una segreta speranza andava gonfiandosi come una mongolfiera. Altri curiosi<br />
erano comparsi. Suonò un grido:<br />
«Rabàl! È Rabàl!».<br />
La mia speranza diventò certezza. Chi altri poteva essere il postiglione, se non Rabàl?<br />
«Rabàl! Fermati, Rabàl!». 31<br />
Quando Viola e il narratore riescono infine a raggiungere la fantomatica apparizione, essa si rivela<br />
ben reale ancorché meravigliosa. È proprio una carrozza, guidata da Rabàl nei panni di cocchiere<br />
«favoloso» – si noti, qui e altrove, il lessico metagenerico – e magicamente traboccante di gatti:<br />
La carrozza non si fermò ma rallentò ancora, di modo che potemmo raggiungerla e salirci. Era piena di gatti di<br />
tutti i tipi, che non s’impaurirono per la nostra presenza, ma si lasciarono subito prendere, carezzare, addirittura ci saltarono<br />
sulle braccia miagolando amichevoli. Rabàl si voltò un momento, e vidi il solito sorriso enigmatico sfiorargli le labbra.<br />
Al posto degli stracci di quando l’avevo trovato, o di quelli che gli avevo passati io, indossava un’elegante livrea rossa e<br />
un mantello azzurro sulle spalle. Di galloni dorati e fregi cuciti alla meglio ne aveva un po’ dappertutto. Non pareva più<br />
uno zingaro famelico e spaurito, neppure un postiglione, ma un ufficiale di qualche favoloso esercito.<br />
La voglia di chiedere a Rabàl dove fosse stato in quei giorni svanì. Mi limitai a guardargli sulla tempia la macchia<br />
a forma di mezzaluna, [...] come volessi accertarmi istintivamente che si trattava proprio di lui. 32<br />
A proposito della scena horror della danza orgiastica di Mirko nella Notte del ragno mannaro<br />
ho parlato di cinema, e anche qui menzionerò un film successivo al romanzo di Sgorlon, cui il lettore cinefilo<br />
avrà forse pensato. La trovata dei gatti può richiamare una celebre fiaba cinematografica, il film<br />
d’animazione Il mio vicino Totoro (1988) del regista giapponese Hayao Miyazaki, e in particolar modo<br />
l’invenzione surreale del Gattobus: un autobus a forma di gatto con dodici zampe, velocissimo e che<br />
sembra quasi volare perché supera facilmente ogni ostacolo (può correre sui fili dell’alta tensione, e gli<br />
alberi sembrano scostarsi al suo passaggio). Al pari del coltissimo Miyazaki, che mescola suggestioni<br />
letterarie e leggende giapponesi, tradizione orientale e occidentale, Sgorlon contamina il fiabesco con<br />
il surreale, secondo i modi letteratissimi che sono propri dei due romanzi finora esaminati (La notte del<br />
ragno mannaro e La luna color ametista sono forse i due testi più nutriti di letteratura che Sgorlon abbia<br />
scritto). La carrozza magica e il cocchiere dall’abito sfavillante di lustrini rimandano al codice generico<br />
del conte de fées, per esempio quello di Cenerentola: anche se Sgorlon sembra tener presente<br />
meno la versione di Charles Perrault poi ripresa dai fratelli Grimm – e ispirata da Giambattista Basile<br />
– che la versione cinematografica di Walt Disney (Cinderella, 1950). Nel classico disneyano, la fata<br />
Smemorina trasforma una zucca in carrozza, quattro topolini in altrettanti cavalli bianchi, un cavallo in<br />
cocchiere e un cane in lacchè; ebbene, quando la carrozza di Rabàl si presenta allo sguardo del narratore<br />
e di Viola, ci aspetteremmo quasi di assistere, a ritroso, alle metamorfosi operate dalla fata buona...<br />
Una carrozza piena di gatti; e perché non una muta di topolini al posto del tiro a quattro, o appunto un<br />
cavallo alle redini?<br />
Ma il sorriso leonardesco di Rabàl sembra alludere ad altri modelli letterari e ad altre contaminazioni,<br />
in un romanzo dove – val la pena di sottolinearlo – si parla moltissimo di libri, si fanno numerosissime<br />
citazioni, e i personaggi – Andrea e il narratore su tutti – sono sempre alla ricerca delle<br />
parole altrui che potrebbero nascondersi dietro le frasi di tutti i giorni, anche le più anodine. Così, possiamo<br />
raccogliere la sfida intertestuale che Sgorlon ci propone, e paragonare l’arrivo della carrozza nel<br />
31 Ivi, p. 48.<br />
32 Ivi, pp. 48-49.
«piazzale [...] deserto» del paese a una scena altrettanto surreale del primo romanzo di Goffredo Parise,<br />
Il ragazzo morto e le comete (1951). Qui un cavallo che trasporta una carcassa metallica sbuca all’improvviso<br />
in una «piazza» ugualmente deserta, di notte, sotto gli sguardi sbalorditi del protagonista e di<br />
Harry Goetzl:<br />
L’eco di un leggero scalpiccio che risuona al di là della piazza gli fa voltare la testa di scatto; per un attimo il rumore<br />
si spegne nel vuoto dei casamenti, poi riprende simile a un breve scroscio di calcinacci: dall’angolo della via sbuca<br />
un cavallo che trascina lentamente la carrozzeria sconquassata e arrugginita di un’automobile.<br />
«Qualcuno sì, conosco alcune famiglie, ma poche» dice Harry Goetzl, e segue con lo sguardo il cavallo che attraversa<br />
passo passo la piazza e si inoltra in un portico. 33<br />
Parise – scrittore veneto che Sgorlon doveva sentire come consanguineo, e al quale sembra<br />
alludere nel Circolo Swedenborg (2010) 34 – dichiarò a più riprese che il principale modello del suo romanzo<br />
era stato un film di Carol Reed, The Third Man (1949) 35 . Ora, se nel tintinnio di sonagliere della<br />
carrozza di Rabàl riecheggia forse il rumore della carcassa metallica del Ragazzo morto e le comete, la<br />
stazione deserta e semidiroccata descritta da Sgorlon può rievocare gli scenari fantomatici in cui giocano<br />
la loro partita Holly Martins (interpretato da Joseph Cotten) e Harry Lime (Orson Welles), nel film<br />
di Reed. Numerose pagine della Luna color ametista rappresentano il paesotto in cui vivono Riccardo,<br />
Rabàl e gli amici come una successione di luoghi semiabbandonati, caratterizzati dall’incuria degli abitanti,<br />
talora ridotti a un cumulo di macerie: proprio come accade nella Vienna notturna e inquietante di<br />
Reed, e in certi squarci cittadini del romanzo di Parise.<br />
Il trono di legno (1973), ovvero: l’Olandese Volante<br />
Un anno dopo La luna color ametista esce Il trono di legno. Più che di un romanzo fantastico<br />
si tratta di una storia ricca di virtualità fantastiche non totalmente realizzate; in effetti, agli occhi<br />
del narratore e protagonista «le cose sbav[ano] di continuo dal loro interno frange fantastiche o<br />
avventurose» 36 : per Giuliano Bertoni non esiste «una netta separazione tra una cosa vera e accaduta e<br />
una incerta, probabile e possibile», e il mondo appare «fluttuante e nuvoloso, quasi che la realtà fosse<br />
qualcosa di vago e di soggettivo, e [...] potessero esservi vari livelli di consistenza, tra i limiti estremi<br />
del fantastico e del reale» 37 . Ma in questo teatro di ombre solide e realtà inconsistenti c’è una trama sicuramente<br />
fantastica, un tema che rimanda alla grande tradizione otto-novecentesca del genere: quello<br />
dell’Olandese Volante.<br />
33 G. Parise, Il ragazzo morto e le comete (1951), in Idem, Opere, 2 voll., a cura di B. Callegher, M. Portello, introduzione di A.<br />
Zanzotto, Milano, Mondadori, 1987, vol. I, p. 99.<br />
34 Nel cap. II compare infatti una probabile allusione – esclusivamente verbale – al secondo romanzo di Parise, La grande<br />
vacanza (1953): «giravano insieme per la Grecia, in una sorta di Grande Vacanza» (C. Sgorlon, Il circolo Swedenborg, Milano,<br />
Mondadori, 2010, p. 29).<br />
35 Così per esempio in un’intervista del 1972, in cui lo scrittore dichiara: «Quando scrivevo Il ragazzo morto e le comete sentivo<br />
sempre la musica de Il terzo uomo» (citato in C. Altarocca, Goffredo Parise, Firenze, La Nuova Italia, 1972, p. 6). E nel<br />
risvolto di copertina dell’edizione 1972 del romanzo, uscita presso Einaudi: «La sola cultura che ha ispirato questo libro è<br />
cinematografica: ero un appassionato frequentatore di cinematografi» (citato in G. Parise, Opere, cit., vol. I, p. 1573).<br />
36 C. Sgorlon, Il trono di legno (1973), introduzione di C. Marabini, Milano, Mondadori, 1987, p. 21.<br />
37 Ivi, p. 43.<br />
31
32<br />
Secondo la leggenda del Vascello Fantasma 38 , che affonda le sue radici nel folclore nordico ed è<br />
stata codificata in alcuni testi ottocenteschi – fra i quali ricorderemo Aus den Memoiren des Herren von<br />
Schnabelewopski (1834) di Heinrich Heine e The Phantom Ship (1837) di Frederick Marryat – e nell’opera<br />
di Richard Wagner Der fliegende Holländer (1841), durante una tempesta un capitano olandese, blasfemo<br />
e forsennatamente superbo, avrebbe giurato di doppiare il capo Horn anche a costo di navigare<br />
per l’eternità: in seguito a quest’atto di hybris lui e la sua ciurma, trasformati in fantasmi su un veliero<br />
spettrale, sarebbero stati condannati a vagare senza fine per i mari, avvolti da un terrificante uragano.<br />
Altre versioni della storia affermano che l’Olandese avrebbe promesso l’anima al demonio per poter<br />
doppiare il capo fatale (in Heine, non è Dio a punire l’Olandese per la sua bestemmia ma il Diavolo a<br />
prenderlo in parola) 39 ; la sostanza non cambia: l’Olandese è uno dei grandi maledetti della letteratura ottocentesca,<br />
al pari dell’Ebreo Errante e di Don Giovanni, di Melmoth il Vagabondo, del Vecchio Marinaio<br />
e del Vampiro. Nel Trono di legno, Sgorlon ha costruito il personaggio del Danese attingendo parecchi<br />
elementi da questa tradizione, e da quelle parallele relative agli altri reietti del mito e della letteratura.<br />
La figura del Danese, marinaio «che ha navigato in tutti i mari del mondo» 40 , acquista, nei racconti degli<br />
anziani di Ontàns, contorni diabolici: «essi avevano cominciato a vedere nel Danese l’immagine stessa<br />
del Tentatore, e su di lui erano nate paurose leggende» 41 . Fra gli aneddoti corruschi che circolano sul<br />
misterioso lupo di mare, si sussurra ch’egli sia «un prete spretato, scappato da qualche convento, dopo<br />
aver rubato e incendiato» 42 : un po’ come il personaggio di Medardus nel romanzo gotico hoffmanniano<br />
Die Elixiere des Teufels (1815-1816). Ci sarebbe perfino un quadro sinistro che ne ritrae le fattezze, come<br />
accade in tanti racconti e romanzi dello stesso Ernst Theodor Amadeus Hoffmann e secondo un topos<br />
affermato che dal romanzo gotico – si pensi al quadro che sconvolge il vecchio Melmoth nelle prime<br />
pagine di Melmoth the Wanderer (1820) di Charles Robert Maturin 43 – arriva fino al racconto fantastico<br />
otto-novecentesco: «“Allora l’hai conosciuto...” “No. L’ho visto in un quadro che era stato fatto da un<br />
suo amico pittore. Me lo fece vedere il gastaldo della Contessa. Quella barba, quei denti... Mi vengono<br />
i brividi, solo a pensarci”» 44 . Un ritratto diabolico appare anche in Heine e, a più riprese, in Wagner 45 .<br />
L’aspetto e il comportamento del Danese, le facoltà abbastanza eccezionali di cui dà prova,<br />
non sono meno inquietanti e rimandano infallibilmente alla letteratura sul patto con il diavolo. Con dispetto<br />
e una punta di turbamento, Maddalena descrive a Giuliano «la risata del Danese» 46 , rumorosa<br />
38 Si vedano in proposito L. Stapper, P. Altena, M. Uyen, L’Olandese volante, in Eidem, Miti e personaggi della modernità.<br />
Dizionario di storia, letteratura, arte, musica e cinema, Milano, Bruno Mondadori, 1998, pp. 263-269, e M. Letourneux,<br />
Vaisseau fantôme (et Hollandais volant), in P. Brunel, J. Vion-Dury (a cura di), Dictionnaire des mythes du fantastique, Limoges,<br />
Presses Universitaires de Limoges, 2003, pp. 279-289. Non si parla invece dell’Olandese in altri, pur ottimi, dizionari tematici<br />
e dei personaggi: ad esempio P. Brunel (a cura di), Dictionnaire des mythes littéraires (1988), nuova edizione aumentata,<br />
Monaco, Editions du Rocher, 1994; F. Marenco (a cura di), Dizionario dei personaggi letterari, 3 voll., Torino, UTET, 2003; e R.<br />
Ceserani, M. Domenichelli, P. Fasano (a cura di), Dizionario dei temi letterari, 3 voll., Torino, UTET, 2007.<br />
39 Cfr. H. Heine, Schnabelewopski (Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski, 1834), a cura di P. Chiarini, Venezia,<br />
Marsilio, 1991, p. 97: «Il diavolo l’ha preso in parola» (cfr. p. 96: «Der Teufel hat ihn beim Wort gefaßt»).<br />
40 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., p. 56.<br />
41 Ivi, p. 53.<br />
42 Ivi, p. 45.<br />
43 Cfr. C. R. Maturin, Melmoth the Wanderer (1820), a cura di D. Grant, introduzione di C. Baldick, Oxford-New York, Oxford<br />
University Press, 1989, pp. 18-19 (§ I, i).<br />
44 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., p. 45.<br />
45 Cfr. rispettivamente H. Heine, Schnabelewopski, cit., pp. 98-99, e R. Wagner, L’olandese volante (Der fliegende Holländer,<br />
1841), a cura di G. Manacorda, Firenze, Sansoni, 1974, vv. 274 sgg., 401, 412-413, e la didascalia che segue il v. 443. In<br />
Wagner il ritratto è addirittura «[a]bbominevole» («[a]bscheulich Bild», v. 351).<br />
46 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., p. 44.
e sguaiata: il riso sarcastico e agghiacciante è uno dei contrassegni più sicuri del Maligno e dei suoi<br />
alter ego nella tradizione gotico-fantastica (e diabolicamente beffarda è la risata della ciurma spettrale<br />
nel Fliegende Holländer di Wagner) 47 . Il Danese sembra inoltre aver consuetudine con il fuoco, l’elemento<br />
infernale: «quando si pettinava faceva scricchiolare il pettine. [...] Faceva scoccare scintille più<br />
grosse di quelle degli zoccoli dei cavalli sulle pietre. Una vecchia mi giurò che il suo pettine era tutto<br />
bruciacchiato» 48 . E la «pelle cotta dal sole» 49 sarà davvero un retaggio della vita di mare? o non piuttosto<br />
il segno tangibile di un’occulta prossimità con le fiamme dell’inferno? (su questo punto Sgorlon<br />
sembra capovolgere deliberatamente la tradizione, che presentava l’Olandese come affetto dal pallore<br />
soprannaturale tipico di tanti revenants: Wagner lo chiama «der bleiche Mann» o «Seemann», Stéphane<br />
Mallarmé lo definisce «pâle») 50 . Ancora: stando alla testimonianza di un falegname che lo ha conosciuto,<br />
il Danese possiede una straordinaria facilità nell’imparare – o nell’inventare – le lingue:<br />
Aveva una facilità da non credere nell’apprendere le lingue e ne parlava parecchie, anche se lui non poteva dire<br />
se fossero vere e proprie lingue straniere, quelle che gli aveva sentito parlare, oppure invenzioni farsesche per impressionare<br />
i suoi ingenui ascoltatori, perché il Danese quanto a fantasia poteva dare dei punti anche al diavolo. 51<br />
Impossibile non registrare, in questa citazione, la presenza del «diavolo»; sarei tentato di imputarla<br />
ancora una volta alla tradizione letteraria. Un personaggio circondato da un’aura diabolica<br />
come il Conte di Monte-Cristo nell’omonimo romanzo di Alexandre Dumas (Le Comte de Monte-Cristo,<br />
1844-1846) e l’esplicitamente satanico Woland nel Maestro e Margherita (pubblicato nel 1966-<br />
1967) di Mikhail Bulgakov parlano tutte le lingue senza accento; modello di entrambi i personaggi è<br />
quel Conte di Saint-Germain che nella credenza popolare avrebbe attraversato i secoli, indenne dallo<br />
scorrere del tempo, accumulando nella sua esistenza pluricentenaria una prodigiosa somma di conoscenze<br />
52 .<br />
Ma veniamo all’inesauribile patrimonio del personaggio <strong>sgorlon</strong>iano: «Dalla Danimarca, o da<br />
chissà dove, [il Danese] era arrivato carico di quattrini. Distribuiva mance a tutti, nelle osterie e nelle<br />
botteghe, e aveva sempre grossi conti da pagare per le infinite cose che comprava» 53 . In letteratura<br />
come nella realtà, ogni ricchezza favolosa di cui non si conosca l’origine diventa sospetta; ma in letteratura<br />
il diavolo ci mette quasi sempre lo zampino... Sul denaro del Danese fioriscono le spiegazioni<br />
più inverosimili:<br />
Molti si domandavano da dove venissero i soldi del Danese. Erano d’accordo soltanto nel ritenere che non era<br />
possibile fossero denari puliti. Il marinaio era certo un ladro, o almeno un contrabbandiere. Forse si era arricchito tra-<br />
47 Cfr. R. Wagner, L’olandese volante, cit., la didascalia che segue il v. 716: «L’equipaggio dell’olandeSe [...] lancia uno stridente<br />
riso beffardo» («Die Mannschaft des HolländerS [...] schlägt ein gellendes Hohngelächter auf»).<br />
48 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., p. 44.<br />
49 Ivi, p. 51.<br />
50 Cfr. rispettivamente R. Wagner, L’olandese volante, cit., vv. 272, 308, 314, 329, 332, 429, 444; e S. Mallarmé, Au seul souci de<br />
voyager (1898), in Idem, Œuvres, a cura di Y.-A. Favre, Paris, Garnier, 1992, p. 76, vv. 13-14: «Par son chant reflété jusqu’au /<br />
sourire du pâle Vasco» (l’esploratore portoghese Vasco da Gama, che Mallarmé identifica con l’Olandese).<br />
51 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., p. 51.<br />
52 Sulla figura del Conte di Saint-Germain cfr. A. Viatte, Les sources occultes du Romantisme. Illuminisme, théosophie. 1770-<br />
1820 (1928), 2 voll., Paris, Honoré Champion, 1965, che lo presenta come il modello per eccellenza di un altro personaggio<br />
diabolico, immortale ed errante: Cagliostro (cfr. in particolare ivi, vol. I, p. 202: Saint-Germain è l’«exemple [...] illustre [qui]<br />
traçait d’avance à Cagliostro le programme de sa carrière»).<br />
53 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., p. 52.<br />
33
34<br />
sportando merce proibita e maledetta con la sua nave che, a quanto aveva raccontato, toccava le coste danesi, quelle<br />
dell’Islanda e del Labrador. 54<br />
Si noterà en passant quell’aggettivo, «maledetta», che aggiunge un ulteriore tassello al ritratto<br />
del Danese come personaggio sulfureo. Anche l’origine sospetta del denaro è un dettaglio inequivocabile:<br />
nella letteratura ottocentesca sul patto con il diavolo, che attinge peraltro dal folclore, Satana<br />
e i suoi adepti – in primis l’Olandese Volante – hanno un sacco di soldi, né si riesce a capire dove li<br />
prendano. Potrei ricordare in proposito molti testi, ma mi limiterò a citare uno dei raccontini di Centuria<br />
(1979) di Giorgio Manganelli, successivo al Trono di legno ma che possiamo utilizzare come compendio<br />
della tradizione letteraria del Vascello Fantasma. Si tratta della centuria numero Sessantotto, quasi<br />
una voce da enciclopedia o da dizionario sul tema; ebbene, nella paginetta e mezza a sua disposizione<br />
Manganelli non tralascia di ricordare, fra i motivi caratteristici della leggenda dell’Olandese, l’abbondanza<br />
(sospetta) di quattrini: il suo capitano «ha sempre molto denaro con sé, della moneta corrente al<br />
porto cui ha fatto scalo» 55 .<br />
Spesso inoltre il denaro del diavolo rende un suono sospetto, o risulta nuovo fiammante (i soldi<br />
del capitano di Manganelli sono «sempre nuov[i], dallo strano suono sul bancone dell’oste») 56 , o sparisce<br />
celermente; o tutte queste cose al tempo stesso. Nel Trono di legno, a prima vista, pecunia non olet,<br />
né suscita allarme per altro che non sia la sua origine. Tuttavia, nelle pieghe del racconto di Sgorlon si<br />
nasconde una dichiarazione interessante:<br />
Il giovane aveva poi chiesto al Danese se davvero aveva vinto i suoi soldi giocando. La risposta lasciò tutti di<br />
stucco. Disse che non si ricordava da dove venisse il suo denaro, e che la cosa era per lui del tutto priva d’interesse. Lui<br />
non pensava al passato né al futuro, e perciò non gli importava di ricordare l’origine dei soldi, né di sapere quanto sarebbero<br />
durati. 57<br />
La ragione contestuale dell’enigmatica risposta non è difficile da identificare: come altri personaggi<br />
<strong>sgorlon</strong>iani il Danese vive esclusivamente nel presente, in una specie di tempo assoluto che<br />
lo avvicina alla sfera del divino («Solo il presente m’interessa, perché vivendo nel presente si diventa<br />
eterni come gli dèi!», aggiunge subito dopo) 58 . Ma le sue parole, dopo tanti segnali inquietanti e tante<br />
allusioni sinistre, non possono non suonare sottilmente ambigue. Non gli importava l’origine dei soldi,<br />
né quanto sarebbero durati: non sarà pure questo denaro del diavolo, che come la farina nel noto detto<br />
popolare, ‘finisce tutto in crusca’? Maestro di retorica proprio come l’Avversario, il diabolico Danese<br />
non si starà facendo beffe dei suoi creditori, destinati presto a ritrovarsi in mano, al posto delle monete<br />
pregiate, un mucchio di sassolini?<br />
Certo è che nel paese si continua a mormorare, fino al giorno in cui il mistero sembra venire<br />
d’un tratto risolto:<br />
54 Ivi, p. 54.<br />
55 G. Manganelli, Centuria. Cento piccoli romanzi fiume (1979), a cura di P. Italia, con un saggio di I. Calvino, Milano, Adelphi,<br />
1995, p. 151. Sul tema dell’Olandese Volante in Manganelli si può vedere S. Lazzarin, «Centuria». Le sorti del fantastico nel<br />
Novecento, «Studi Novecenteschi», XXIV, 53, giugno 1997, pp. 99-145, e in particolare pp. 123-126; poi anche in francese:<br />
cfr. Idem, Des êtres inexistants, le catalogue est le suivant, in Idem, L’ombre et la forme. Du fantastique italien au XX e siècle,<br />
Caen, Presses Universitaires de Caen, 2004, cap. VIII, pp. 173-207, e in particolare pp. 188-190.<br />
56 G. Manganelli, Centuria, cit., p. 151.<br />
57 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., pp. 54-55.<br />
58 Ivi, p. 55.
Gli anziani avevano continuato a guardare il Danese con estrema diffidenza, almeno finché un giovane [...] in<br />
osteria aveva all’improvviso gettato il berretto in terra gridando: «Perdiana, ma è semplicissimo! Sapete dove il Danese<br />
ha preso i denari? Secondo me li ha vinti al gioco!». I presenti si guardarono in faccia. Sì, questa era una spiegazione possibile,<br />
e tutto sommato erano contenti di aver trovato per lui una soluzione che lo scagionava. 59<br />
Se gli anziani si acquietano, non così il lettore di classici ottocenteschi, né l’appassionato di<br />
storie di navigazioni maledette; costoro penseranno piuttosto: altro che circostanza attenuante! è la<br />
prova decisiva. La natura diabolica del gioco non richiede l’esercizio di nessun particolare acume interpretativo,<br />
dal momento che la saggezza popolare la considera un’ovvietà – si pensi alla metafora<br />
lessicalizzata, quasi proverbiale, che allude al ‘demone del gioco’ – e visto soprattutto che sono numerosissimi<br />
i testi otto- e novecenteschi a ricamarvi sopra, dalla letteratura romantica per arrivare fino al<br />
fantastico di un Tommaso Landolfi. Ma ciò che risulta maggiormente interessante, dal nostro punto di<br />
vista, è constatare come l’Olandese sia, nel folclore e in letteratura, un giocatore accanito: alcune versioni<br />
della leggenda ce lo presentano mentre siede sul ponte del Vascello Fantasma, giocando a dadi<br />
con il Diavolo in persona!<br />
E a proposito di vascello: nel Trono di legno compare anche quello; non trasporta la ciurma di<br />
marinai morti agli ordini del capitano maledetto come in Heine, Wagner o Marryat, bensì la madre del<br />
protagonista, da lui mai conosciuta. Nella sezione Il battello, e in pagine fra le più suggestive del romanzo<br />
<strong>sgorlon</strong>iano, viene infatti riferito il seguente sogno di Giuliano:<br />
Avevo sognato un mare di un verde intenso, dalle onde crestate di spuma, ma lente e silenziose, che parevano<br />
adatte soltanto a far dondolare una nave, non certo a metterla in pericolo. [...] A occidente vedevo un oggetto scuro,<br />
non più grande di un grillo, che veniva avanti lentamente, oscillando. [...] Solo dopo molto tempo vedevo che si trattava<br />
di un battello, più piccolo di una nave ma molto più grande di una barca. Aveva grandi oblò in cima, una carena dipinta<br />
di viola, e veniva avanti silenzioso, scivolando sulle onde, come fosse spinto dal vento. Non aveva vele e quindi doveva<br />
possedere un motore, il cui rumore era totalmente assorbito dal mare. Vedevo la barra del timone, a poppa, ma nessuno<br />
che la reggeva. Nessuno si affacciava agli oblò. In un primo tempo pensavo che il battello fosse vuoto, ma poi mi accorgevo<br />
che non era possibile perché dall’interno veniva un canto in sordina, appena percettibile a causa della lontananza:<br />
O che bel castello, marco ’ndiro ’ndiro ’ndello,<br />
o che bel castello, marco ’ndiro ’ndiro ’nda...<br />
La voce era quella di mia madre. Arrivato a qualche centinaio di metri dal mio scoglio il battello si fermava, cessava<br />
del tutto anche il leggero ronzio del motore, e si sentiva solo il canto di mia madre. Aspettavo che lei comparisse,<br />
salisse sul ponte o almeno sporgesse la testa da uno degli oblò. Invece niente. Dovevo accontentarmi di sapere che lei<br />
era su quel battello, ma non avrei mai visto il suo viso. Finito il canto, la nave passava oltre, scivolando sulle onde come<br />
prima, finché diventava di nuovo un punto nero, e spariva all’orizzonte. 60<br />
Su un mare funereo, che può richiamare le pagine finali di Moby-Dick or, The Whale (1851) 61 ,<br />
va lentamente alla deriva la nave dei morti; sull’imbarcazione sta, invisibile agli sguardi, la Regina del<br />
mondo di là: una Proserpina che il protagonista sente dolorosamente vicina e al tempo stesso inattingibile.<br />
La scena è perfettamente onirica: il silenzio è quello della morte, ma anche di certi sogni ovattati<br />
nei quali non riecheggia alcun rumore.<br />
59 Ivi, p. 54.<br />
60 Ivi, pp. 58-59.<br />
61 Cfr. H. Melville, Moby-Dick or, The Whale, a cura di T. Quirk, introduzione di A. Delbanco, New York, Penguin, 2003, pp. 623-<br />
625.<br />
35
36<br />
Se il Danese pare un Olandese sotto mentite spoglie o per lo meno fornito di doppio passaporto,<br />
anche il personaggio del narratore non è scevro da tratti che rimandano ai maledetti della letteratura<br />
ottocentesca. A caccia di archetipi per sé e per gli altri, Giuliano si paragona infatti all’Ebreo Errante:<br />
«Come l’“Etrusca” aveva il suo modello nel volto di pietra di qualche statua o canopo etruschi, anche<br />
se lei non lo sapeva, io forse ce l’avevo in qualche personaggio mitico, errabondo e senza requie, come<br />
Ulisse o l’Ebreo errante» 62 . Forse non è un caso che l’Ebreo Errante – altro grande personaggio diabolico<br />
della letteratura dell’Ottocento – sia legato proprio all’Olandese da vincoli di parentela: seguendo<br />
l’intuizione di Heine, si potrebbe dire che l’Olandese Volante altri non sia che l’Ebreo Errante – o l’Ulisse<br />
– dei mari, l’«eterno Ebreo dell’oceano» 63 . Ulisse ed Ebreo, Giuliano si presenta inoltre come Ishmael,<br />
o almeno aspirerebbe a diventare come il personaggio di Herman Melville:<br />
Il prodigio si era verificato fin dalla prima riga [di Moby-Dick]. Appena letto “Chiamatemi Ismaele...” mi ero sentito<br />
afferrare da una strana vergogna che il mio nome fosse Giuliano, soltanto Giuliano. Ismaele era un vero, grande nome<br />
e possederlo significava assicurarsi un destino privilegiato e pieno di promesse. Non volevo essere Giuliano, ma Ismaele.<br />
In certo modo lo ero. Le esperienze di Ismaele mi pareva di averle già vissute. 64<br />
Moby-Dick è il libro che Giuliano cita più spesso, e dal quale nascono più numerosi i suoi sogni<br />
giovanili, come mostra la sezione Chiamatemi Ismaele 65 che ripete fin dal titolo il famoso incipit melvilliano.<br />
Ma chi dice ‘Ishmael’ dice ‘Ahab’ e ‘Pequod’: il nome del protagonista di Melville rimanda alle<br />
innumerevoli storie di navigazioni maledette della letteratura ottocentesca 66 ; l’eco di queste risuona<br />
nelle pagine del romanzo di Sgorlon e in particolar modo, come è logico, laddove vengono descritte le<br />
gesta del Danese e il suo passato leggendario. Sono allora navi fantasma ed erranze infernali, interminabili<br />
cacce alla balena e uragani terrificanti, naufragi e pirati a far capolino fra le righe o a riempire<br />
tutt’intero lo spazio della narrazione. Talora basta una similitudine a evocare fulmineamente i capolavori<br />
della letteratura marinaresca, come quando la lettera ritrovata da Giuliano nel cassetto di Maddalena<br />
«arriv[a] [...] [al protagonista] come un manoscritto contenuto in una bottiglia» 67 : Manuscript Found<br />
in a Bottle (1838) è il titolo di uno dei più famosi racconti di Edgar Allan Poe, e di una delle più belle<br />
versioni del tema del Vascello Maledetto. Altrove, una frase condensa con vertiginosa sintesi un’intera<br />
letteratura, come nella sezione Il Grande Giocatore; qui Giuliano tesse l’elogio del potere magico della<br />
parola di Pietro, il Re dei Racconti, che raccontando cancella la frontiera tra reale e fittizio: «Vicino a lui<br />
pareva non fosse necessario recarsi chissà dove per vederlo mutato in realtà [questo ideale], mentre io<br />
avevo sempre creduto che potesse accadere soltanto sui ghiacci del Polo, nei mari del Nord, nelle terre<br />
del Danese o sul ponte del Pequod...» 68 .<br />
62 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., p. 134.<br />
63 H. Heine, Schnabelewopski, cit., p. 99 (cfr. p. 98: «den ewigen Juden des Ozeans»). Come nota Giuliano Manacorda, Wagner<br />
riprende lo spunto heiniano e accosta, nell’importante testo teorico Eine Mitteilung an meine Freunde (1851), Ulisse, l’Ebreo<br />
e l’Olandese (cfr. R. Wagner, L’olandese volante, cit., pp. 111-112).<br />
64 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., p. 32.<br />
65 Ivi, pp. 31-34. Su Ismaele si veda anche la sezione intitolata Il molo di Aarhus, ivi, pp. 246-250.<br />
66 Lo stesso accade nel cap. II del Circolo Swedenborg, in cui la Balena Bianca di Melville e l’Olandese Volante si ritrovano<br />
significativamente accomunati: Sgorlon allude nella fattispecie a «libri recenti e antichi, che parlavano di grandi viaggiatori,<br />
di navi da guerra, di balene bianche, di vascelli maledetti che sfidavano il mare, il cielo, le forze cosmiche, e finivano<br />
miseramente nelle tempeste per scontare i complessi di Prometeo dei loro comandanti» (C. Sgorlon, Il circolo Swedenborg,<br />
cit., p. 23).<br />
67 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., p. 247.<br />
68 Ivi, p. 184.
La svolta del 1973: la scoperta del potere magico della parola<br />
Ricapitolando: nella Notte del ragno mannaro – in particolare nell’episodio della danza di Mirko<br />
– Sgorlon riscrive il tema orroroso del Licantropo; la scena dell’arrivo di Rabàl alla guida di una carrozza<br />
traboccante di gatti, nella Luna color ametista, strizza l’occhio al codice del fiabesco e alla carrozza fatata<br />
di Cenerentola; nel Trono di legno sono disseminate numerose allusioni al tema fantastico dell’Olandese<br />
Volante: quest’ultimo si reincarna nella leggendaria figura del Danese. Tre romanzi, tre archetipi<br />
narrativi (il Licantropo, Cenerentola, l’Olandese) e tre generi (horror, fiabesco, fantastico): davvero<br />
Sgorlon sembra aver voluto adoperare tutti i registri dell’immaginario.<br />
Ma il quadro va sfumato. Innanzitutto, questi confini che per ragioni di chiarezza espositiva ho<br />
cercato di delineare nettamente non sono pareti stagne, bensì frontiere permeabili: nell’opera di Sgorlon<br />
i generi risultano per lo più ibridati fra loro. Si è visto ad esempio come il fiabesco della Luna color<br />
ametista sia contaminato con un certo ‘surreale’ che abbiamo ricondotto alla linea veneta della letteratura<br />
novecentesca, nella persona di Goffredo Parise. Ma nella Luna color ametista il fiabesco può assumere<br />
anche le sfumature inquietanti proprie del fantastico, o addirittura tinte vagamente horror. È<br />
innegabile, in tal senso, l’affinità di comportamento fra Rabàl e il sinistro Mirko della Notte del ragno<br />
mannaro. Anche Rabàl va soggetto a tentazioni licantropiche: è preda di sintomi epilettici proprio come<br />
Mirko 69 , e come lui frequenta i territori psichici dell’ipnosi, esercitando per esempio nei confronti degli<br />
animali un inesplicabile magnetismo (il narratore si dice convinto «che Rabàl fosse stato allevato dai<br />
lupi e perciò possedesse con le bestie una capacità magnetica, che tra lui ed esse scattasse una misteriosa<br />
simpatia che noi civilizzati non potevamo sentire, privi com’eravamo ormai da millenni di un vero<br />
contatto con la natura») 70 . Addirittura, nel secondo capitolo Rabàl sopravvive alla propria morte, riprendendo<br />
miracolosamente i sensi dopo una catalessi lunga e in apparenza senza ritorno 71 : Sgorlon riusa<br />
nella fattispecie uno dei grandi temi del fantastico occidentale, almeno dai racconti di Poe (si pensi<br />
all’eponimo The Premature Burial, 1844) in poi, quello del seppellimento prematuro. Infine, se Mirko è<br />
un gitano, Rabàl capisce e parla – unico del gruppo di amici della Luna color ametista – le «lingue cantanti»<br />
dei nomadi 72 : a dimostrazione del fatto che se si fossero incontrati nello stesso romanzo, i due<br />
personaggi avrebbero finito con l’intendersi...<br />
Elementi fantastici sono dunque presenti anche in altri romanzi <strong>sgorlon</strong>iani, non soltanto in<br />
quello – La notte del ragno mannaro – che abbiamo etichettato come propriamente fantastico. E tuttavia,<br />
la nostra tripartizione generica non è meramente di comodo. È pur vero che nell’opera di Sgorlon<br />
il fantastico ‘autentico’ sembra soltanto quello della Notte del ragno mannaro: perché è l’unico (quasi)<br />
del tutto esente da razionalizzazioni, perfettamente ‘todoroviano’ nella sua logica. Nelle opere successive,<br />
invece, Sgorlon ricorrerà sempre più spesso a razionalizzazioni di ogni tipo. Già nella Luna color<br />
ametista il fantastico viene per lo più ridotto a superstizione, denunciata come tale: «girava voce che il<br />
proprietario [della fabbrica di scatolette], il quale si era ammazzato mangiando tre scatole di capocchie<br />
di fiammiferi, riapparisse ogni tanto, gridando che aveva il fuoco nello stomaco e accendendo all’improvviso<br />
fiammiferi giganteschi» 73 . L’industriale divoratore di fiammiferi è improbabile di per sé, ma la<br />
credibilità dell’apparizione subirà un colpo definitivo quando il narratore si renderà conto che Rabàl,<br />
69 Si vedano le crisi – fra epilessia e catalessi – descritte in C. Sgorlon, La luna color ametista, cit., pp. 25-27 e 72-73.<br />
70 Ivi, p. 53. Ma il narratore stesso, a un certo punto, risulta vittima di «un inavvertibile stato ipnotico» (ivi, p. 46).<br />
71 Il risveglio di Rabàl avviene ivi, p. 32.<br />
72 Ivi, p. 58.<br />
73 Ivi, p. 43.a<br />
37
38<br />
vestito di lenzuola e cosparso di gesso, si diverte a interpretare il ruolo dello spettro del suicida 74 . Dopo<br />
Il trono di legno, sempre più spesso i motivi fantastici tendono a sopravvivere solo allo stadio di metafore:<br />
la tendenza è particolarmente visibile nei romanzi degli ultimi anni, dall’Alchimista degli strati<br />
(2008) al Circolo Swedenborg (pubblicato postumo nel 2010). Nell’Alchimista degli strati Martino è<br />
dotato di un prodigioso fiuto che gli permette di intuire l’esistenza di un giacimento petrolifero prima<br />
ancora di aver effettuato sondaggi geologici: egli è «lo sciamano delle estrazioni», o «una specie di inesplicabile<br />
rabdomante del petrolio» 75 . Gli arabi attribuiscono questo potere misterioso all’influenza dei<br />
ginn, i genii del folclore islamico: «I ginn erano esseri intermediari tra gli uomini e Allah, ma ve n’erano<br />
anche al servizio delle potenze oscure. In Martino certo prevaleva il ginn benefico e ispirato da Dio» 76 .<br />
Tuttavia le potenzialità fantastiche di questo tema non vengono sviluppate; Sgorlon preferisce qui percorrere<br />
altre strade. Quanto al Circolo Swedenborg, l’ultimo romanzo <strong>sgorlon</strong>iano offre parecchi esempi<br />
di riuso ‘neutralizzante’ del repertorio fantastico. Prendiamo l’episodio dell’incendio a bordo del Liguria;<br />
Ermete Lunati Eudoxiòs sente odor di bruciato, ma non riesce a localizzarne l’origine: «Sembrava una<br />
faccenda stregata. Non riusciva ad andare al di là del problematico indizio, come se il diavolo avesse<br />
infilato la sua coda nella vicenda» 77 . Questo diavolo non possiede neppure un briciolo di letteralità; e<br />
altrettanto si può dire di quel suo compare che si fa vivo dopo la stampa e diffusione del lunario di Sabina:<br />
«le quotazioni dei quadri di Agrippa si moltiplicarono per tre, assolutamente da sole, come fosse<br />
intervenuto un invisibile patto col diavolo» 78 . Del tutto metaforico è pure il lupo mannaro al femminile<br />
che Sgorlon ci presenta nel dodicesimo capitolo, sottolineando la predilezione di Sabina per le notti di<br />
luna piena: «Se esiste una versione femminile e rovesciata del lupo mannaro, lei era certamente tale» 79 .<br />
Ma il personaggio più notevole, dal nostro punto di vista, è Teodoro Cadorin: il pover’uomo risulta ricchissimo<br />
di tratti diabolici, che però si riveleranno altrettanti gusci vuoti. La zoppìa, e addirittura il piede<br />
caprino, come il Mefistofele goethiano (Faust, 1773-1832): «Quando la sua andatura si faceva più<br />
veloce ci si accorgeva che era un po’ zoppo, o che aveva una gamba rigida, oppure un piede caprino,<br />
coperto fino alla caviglia da scarpe ortopediche altissime, di cuoio verde» 80 . Le dicerie che lo vorrebbero<br />
«appartenente a sette segrete, per esempio di religioni strane o rovesciate» 81 : rovesciato è per eccellenza<br />
il culto di Satana, che capovolge parodicamente quello cristiano, come dimostra lo studio del<br />
folclore 82 . La fama di jettatore: la gente è «convint[a] che [Teodoro] port[i] sfortuna», sussurra si tratti di<br />
uno «jettatore testardo e malinconico» 83 . Per di più, Teodoro risulta implicato in «una serie di fatti in cui<br />
il diavolo aveva messo la coda, e non c’era stato più verso di cacciarlo» 84 . Ma in definitiva le sue presunte<br />
arti magiche il povero Teodoro non le esercita se non a proprio danno: si scopre che porta sfor-<br />
74 Cfr. ivi, pp. 125-126 e 130.<br />
75 C. Sgorlon, L’alchimista degli strati, cit., rispettivamente pp. 64 e 105.<br />
76 Ivi, p. 62.<br />
77 C. Sgorlon, Il circolo Swedenborg, cit., p. 36.<br />
78 Ivi, p. 166.<br />
79 Ivi, p. 160.<br />
80 Ivi, p. 100. Notevole anche il dettaglio del cuoio verde – dopo il rosso, il colore più frequentemente associato al diavolo nella<br />
tradizione folclorica e letteraria.<br />
81 Ivi, p. 101.<br />
82 Basterà rimandare alle osservazioni di Ernest Jones nel suo classico libro sulle rappresentazioni dell’incubo e i loro legami<br />
con la cultura popolare: cfr. E. Jones, Psicoanalisi dell’incubo (On the Nightmare, 1931), Roma, Newton Compton, 1978,<br />
passim.<br />
83 C. Sgorlon, Il circolo Swedenborg, cit., rispettivamente pp. 101 e 102.<br />
84 Ivi, p. 101.
tuna soltanto a se stesso, e che le attività industriali sabotate dal Maligno sono le cartiere Cadorin 85 !<br />
Lo si vede: a partire da una certa epoca, nell’opera di Sgorlon le immagini del fantastico sembrano<br />
perdere consistenza, farsi evanescenti, diventare pure immagini (appunto). Ciò confermerebbe<br />
l’interessante intuizione di Claudio Toscani, secondo il quale Sgorlon, con Il trono di legno, passerebbe<br />
da un fantastico in cui le componenti grottesche sono molto forti a un fiabesco in cui esse scompaiono<br />
quasi del tutto. Lo scrittore friulano si allontanerebbe dalla tradizione mitteleuropea la cui presenza<br />
era determinante nei primi romanzi – i nomi da fare sono soprattutto quelli di Kafka, Meyrink, Bruno<br />
Schulz – per privilegiare atmosfere nordiche che possono far pensare alle saghe, alla pittura di Caspar<br />
David Friedrich, o a certi racconti di Hans Christian Andersen. «Costruito per magiche coincidenze e<br />
arcani sortilegi» – osserva Toscani – «Il trono di legno è un romanzo che emana la leggerezza e il fiabesco<br />
alone di una saga nordica: ciò che vi è di avventuroso, di picaresco, di favoloso nella mente di<br />
Sgorlon si deposita in queste pagine di narrativa lenta e sognante, dalla inconsueta atmosfera sacrale,<br />
quasi poema arcaico e religioso» 86 . Per questo suo favolismo nordico il romanzo del 1973 segnerebbe<br />
una svolta nella carriera di Sgorlon: «Il Trono scioglie definitivamente alcuni nodi della narrativa <strong>sgorlon</strong>iana:<br />
l’umore espressionistico, il grottesco-assurdo, le nevrosi e le deformazioni dei primi romanzi.<br />
Il suo favolismo realistico è l’unico in grado di significare l’universo come anima totale di ogni espressione<br />
di vita» 87 .<br />
L’ipotesi di periodizzazione di Toscani sembra funzionare anche sul versante del fantastico: potremmo<br />
dire che Il trono di legno segna la fine della (breve) stagione propriamente fantastica di Sgorlon.<br />
In effetti, a partire dal romanzo del 1973 – che dal nostro punto di vista va considerato come uno<br />
spartiacque – l’opera <strong>sgorlon</strong>iana si allinea alla scoperta decisiva – presagita fin dagli esordi letterari<br />
ma nel Trono di legno lucidamente teorizzata – del magico potere della parola, o per dirla con lo scrittore,<br />
della «strepitosa potenza della parola e del racconto» 88 . Sgorlon viene elaborando con sempre<br />
maggior consapevolezza una poetica che vorrei definire, in termini jamesiani, del ‘rapinoso piacere di<br />
raccontare’ 89 , in virtù della quale le storie narrate sostituiscono le avventure vissute, l’atto di raccontare<br />
diventa la magia più straordinaria che esista, e il confine stesso tra realtà e finzione tende a sfumare,<br />
trasformando la nozione di ‘realtà’ in materia porosa e neutralizzando le opposizioni categoriali<br />
– reale versus soprannaturale, razionale versus irrazionale – su cui si reggeva il fantastico classico<br />
(todoroviano). Conseguenza inevitabile: il fantastico in quanto genere rimane confinato all’esperimento<br />
licantropico della Notte del ragno mannaro, proprio nel momento in cui i personaggi di Sgorlon riflettono<br />
sempre più spesso e in termini sempre più espliciti sull’inconsistenza della frontiera che separa<br />
il mondo ‘quotidiano’ dal mondo ‘altro’. Rabàl è già pienamente cosciente dell’inutilità di ogni tentativo<br />
di separare ‘reale’ e ‘fantastico’, almeno se dobbiamo credere a Riccardo: «mi pareva [...] che per<br />
lui la finzione coincidesse con la realtà, che il mondo per lui non fosse che un teatro sterminato sopra<br />
il quale qualunque fiaba o stramberia erano rappresentabili, così come il suo denaro chimerico valeva<br />
esattamente quello a corso legale» 90 . Ma Rabàl parla spesso per monosillabi o per enigmi, e di lui sap-<br />
85 Cfr. ibidem.<br />
86 C. Toscani, Invito alla lettura di Carlo Sgorlon, Milano, Mursia, 1994, p. 61.<br />
87 Ibidem.<br />
88 C. Sgorlon, Il trono di legno, cit., p. 200.<br />
89 Si veda in particolare H. James, Preface to «The Altar of the Dead», in Idem, The Art of the Novel. Critical Prefaces (1907-<br />
1909), a cura di R. P. Blackmur, New York, Charles Scribner’s Sons, 1934, pp. 241-266, dove si parla fra l’altro dell’amore per<br />
la storia in quanto tale, «that love of “a story as a story” which had from far back beset and beguiled their author [delle storie<br />
di fantasmi jamesiane]» (ivi, p. 252).<br />
90 C. Sgorlon, La luna color ametista, cit., p. 145.<br />
39
40<br />
piamo soltanto quel che ci dice il narratore o pensano gli altri componenti del gruppo di amici. Diverso<br />
è il caso del Trono di legno, dove Giuliano racconta e argomenta la scoperta dei prodigi della finzione<br />
in prima persona, e per uno spazio testuale molto esteso: ben 247 pagine 91 . In tal senso, il passo più<br />
significativo è forse quello in cui il protagonista narra come abbia rinunciato a inseguire il Danese per<br />
inseguire piuttosto Ismaele... Su questa pagina – che è una delle migliori del romanzo e merita di essere<br />
trascritta per intero – vorrei concludere:<br />
per tutto il tempo che stetti lassù [ad Aarhus] [...] mi pareva che tutti i miei gesti, le mie parole, gli incontri con<br />
la gente, l’odore salmastro del mare, gli spruzzi, le sirene delle navi, tutto fosse già visto e accaduto, perché ci avevo già<br />
troppo pensato e fantasticato. Non desideravo più salire sulle navi in partenza, percorrere le rotte del Baltico o del mare<br />
del Nord, dei mari d’Islanda e di Groenlandia, scrutare la nebbia nell’attesa impaurita dell’iceberg, o vedere i soffi delle<br />
balene, come Ismaele. [...] Forse, qualunque cosa avessi intrapresa, avrei avuto d’ora in poi la sensazione che fosse già<br />
accaduta, e che io fossi soltanto il mezzo per farla rivivere, la puntina d’acciaio del grammofono che avrebbe restituito per<br />
l’ennesima volta un’antica sinfonia. Ma certo. Noi non eravamo che musiche effimere contenute da un disco, da uno spartito<br />
che può essere suonato infinite volte, mentre ritenevamo di essere lo spartito medesimo, e che i suoi fogli venissero<br />
stracciati con la nostra morte, in maniera che le note non venissero più ripetute. Le cose si ripetevano, ritornavano uguali,<br />
si ripercuotevano come echi, somigliando tutte quante a una accaduta in principio del tempo. Non era assolutamente<br />
necessario che io salissi su quelle navi. Mille prima di me l’avevano fatto (e tra gli altri Daniel Wivallius [, il Danese]) e<br />
mille l’avrebbero fatto dopo di me. Io potevo farne a meno appunto perché sapevo che era già successo, e soprattutto<br />
perché mi pareva di esserci già stato.<br />
Non serviva che io andassi a caccia di balene perché l’avevo già fatto quando avevo letto Moby Dick nelle fredde<br />
stanze della casa di Ontàns. Che erano i mille e mille cacciatori di balene esistiti prima e dopo Ismaele, in confronto a<br />
lui? Ombre, soltanto ombre, che avevano popolato i ponti delle navi nei mari caldi e freddi, nelle nebbie e nelle tempeste,<br />
che avevano sentito un entusiasmo incontenibile quando il gabbiere aveva gridato “laggiù Soffia!”, che avevano rischiato<br />
la vita, cacciato ramponi nel cuore dei capodogli, eseguendo sempre i medesimi gesti, provando gli stessi sentimenti, una<br />
ripetizione infinita, inconsapevole, che soltanto a ciascuno di essi poteva sembrare novità, perché non pensavano a ciò<br />
che era accaduto agli altri, prima di loro. Soltanto uno faceva eccezione perché l’aveva raccontato, tingendo la sua penna<br />
nell’inchiostro di un’incredibile forza vitale, e aveva fatto di se stesso un personaggio eterno, con il quale prima o poi<br />
avrebbero potuto o dovuto fare i conti tutti i marinai delle baleniere. era iSmaele, era melville.<br />
Mi sembrò di essere sulla strada di una grande scoperta. Fui certissimo che Ismaele era più vero e reale di tutti<br />
gli altri marinai di ogni tempo, fantasmi insignificanti i quali non avevano fatto altro che ripetere un antico modello.<br />
Anch’io, anch’io ero soltanto un’ombra affascinata dai miti e dalle avventure. Attraverso la fantasia avrei potuto vivere<br />
e raccontare tutte le avventure del mondo, mentre viverle veramente, ora, mi avrebbe soltanto generato un sentimento<br />
di noia e di ripetizione. Che errore, cercare il Danese! Che delusione se l’avessi trovato! Non avrebbe potuto essere che<br />
un vecchio pieno di reumatismi, che si trascinava da una taverna all’altra, che viveva in qualche miserabile ospizio e si<br />
lamentava dei propri guai. Forse Maddalena aveva risposto alla sua lettera, tanti anni prima, ma lui non per questo era<br />
uscito dalla sua cupa bottega di Aarhus perché sestanti arrugginiti e vecchie carte nautiche, nel suo strambo delirio senile,<br />
gli parevano ormai le cose più importanti del mondo. No. Il vero Danese non dovevo cercarlo quassù, nelle case o nelle<br />
bettole di Aarhus, ma a Ontàns, nei discorsi e nei ricordi di quelli che avevano creato la sua leggenda, e soprattutto nella<br />
mia fantasia, e il mio compito era di ricavare da essi una forma perenne, come Melville aveva fatto con Ismaele, scrivendo<br />
una storia su di lui. Questa era la mia vera, unica avventura. 92<br />
91 Tante sono nella nostra edizione di riferimento, pubblicata negli Oscar Mondadori (cfr. C. Sgorlon, Il trono di legno, cit.): il<br />
romanzo inizia infatti a p. 19 e si conclude a p. 265.<br />
92 Ivi, pp. 247-249.
Topoi e figure dell’ospitalità in Carlo Sgorlon<br />
di Jean-Igor Ghidina<br />
Università di Clermont-Ferrand, Francia<br />
Nella narrativa di Sgorlon, far mente locale ai topoi dell’ospitalità, esula da un’impostazione<br />
squisitamente sociologica perché viene posto il dilemma del confronto fra identità e alterità, fra particolare<br />
e universale, fra rattrappimento solipsistico magari foriero di un cupio dissolvi e palesarsi della<br />
propria condizione umana.<br />
I topoi vanno collegati a spazi sovradeterminati entro il dipanarsi della diegesi nel senso in<br />
cui vengono costellati da elementi simbolici, mentre alcuni personaggi che ricoprono una funzione attanziale<br />
perspicua assurgono a figure paradigmatiche qualora prospettiamo i riecheggiamenti intra- o<br />
inter-testuali.<br />
La donna <strong>sgorlon</strong>iana in particolar modo ripristina alcuni tratti di personaggi biblici, da Giuditta<br />
a Maria-Maddalena, il che sembra indicare che l’ospitalità scaturisca da un contegno religioso di fronte<br />
al mondo e all’alterità. Peraltro, le figure dello straniero, dell’apolide e dell’esule sono ricorrenti nelle<br />
opere di uno scrittore rappresentativo di un Friuli già terra di emigrazione e ormai di immigrazione,<br />
crogiolo di un’identità complessa.<br />
Di fronte alla coazione della storia funestata da guerre micidiali e da esodi di disperati, l’ospitalità<br />
può diventare l’afflato che infonde una letizia anticipatrice della beatitudine.<br />
Questa relazione sarà imperniata dapprima sull’ospitalità nei romanzi migratori, poi sull’ospitalità<br />
nello spazio domestico per le vittime della storia, infine sull’intreccio tra ospitalità ed incontri di<br />
civiltà ne le sorelle boreali e ne l’alchimista degli strati.<br />
I) L’ospitalità nei racconti migratori<br />
Con La conchiglia di Anataj, ci inoltriamo appunto in un tipo di romanzo nel quale il personaggio<br />
del migrante assurge ad espressione della condizione umana. Il protagonista Valerio è percepito sin<br />
dall’incipit come un valetudinario che manifesta innanzitutto la propria estasi davanti al mondo dopo<br />
una lunga malattia.<br />
Valeriano non viene rappresentato come un emigrante mosso prevalentemente da fattori di<br />
matrice economica o politica. Notiamo tuttavia che il racconto <strong>sgorlon</strong>iano non appartiene alla mera<br />
finzione, perché tra lo scorcio dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, i taglialegna ed i muratori friulani<br />
parteciparono effettivamente alla costruzione della Transiberiana. La durezza dell’esperienza migratoria<br />
è percettibile attraverso i racconti di Bastiano in cui viena a galla la realtà delle condizioni di lavoro<br />
imposte ai minorenni nelle fornaci tedesche. Inoltre, il testo fa chiaramente riferimento alla povertà<br />
delle famiglie contadine nell’Ottocento. Detto ciò, anche fra i personaggi secondari, l’emigrazione di-<br />
41
42<br />
venta il simbolo del vagare esistenziale, la ricerca indefessa di un luogo e di persone pronte ad offrire<br />
un’ospitalità che darebbe un senso al pellegrinaggio terrestre.<br />
Il destino dell’emigrante friulano include comunque la relazione viscerale con la pietra, il mâl<br />
dal clap, specie di vocazione all’operosità che appaga anche un’ansia metafisica. Il lavoro dello scalpellino<br />
non è considerato alla stregua di un castigo di Sisifo, ma si muta in co-creazione del mondo, in<br />
uno straniamento costruttivo che esprime una lode alla bellezza dell’universo.<br />
Pareva che tra noi e la pietra ci fosse una parentela che aveva le sue radici in un istinto remoto. (...) Quando<br />
venivano tagliate dal filo d’acciaio elicoidale ero sfiorato da fantasie e metafore sontuose, come se ogni blocco venisse<br />
dal Sinai, e contenesse le tavole di una legge che non conoscevo, ma che andavo recuperando nel momento stesso in cui<br />
le lavoravo. Incidendo le pietre mi pareva di venire scoprendo me stesso, chi ero e cosa facevo a questo mondo. (p. 28)<br />
L’intensità del rapporto col mondo inibisce in certo modo ogni predilezione definitiva per lo spazio<br />
dell’ospitalità domestica. Pur condividendo la gioia della convivialità russa, Valeriano si sente acciuffato<br />
dalla sconfinatezza siberiana. La morte d’Irina e del loro figlio travolge ogni sogno di un’ospitalità<br />
risolutrice, al punto che Valeriano riprende la propria vita randagia. Il personaggio dell’emigrante si<br />
atteggia ad apolide, non perché non possa raggiungere la terra natia, ma perché non ha trovato il luogo<br />
che porrà termine al proprio peregrinare. La traiettoria di Valeriano assomiglia ad un periplo senza fine,<br />
ad un nomadismo radicale di modo che viene escluso ogni stanziamento duraturo.<br />
Mi sentivo il senzapatria, l’uomo dalla terra perduta, che vagava a casaccio sotto cieli stranieri. La mia vita era<br />
tutta un viaggio che ricominciava sempre daccapo. (p. 33)<br />
In realtà, Valeriano accetta l’ospitalità solo in una prospettiva probatoria ed iniziatica, come<br />
una tappa che deve condurlo verso una meta ignota, qualunque siano i momenti di profonda derelizione.<br />
Egli non condivide il contegno di Bastiano, che, dal canto suo, rappresenta invece l’emigrante per<br />
cui il soggiorno all’estero equivale ad un esilio implacabile. Bastiano sembra ligio ad un’identità che<br />
attribuisce all’alterità una minaccia.<br />
Perciò Bastiano diffidava dell’estero, di qualunque paese si trattasse, e stava eternamente in allarme, come potesse<br />
capitargli qualsiasi cosa. Ogni momento aveva coscienza di trovarsi tal forest, in un luogo forestiero, che poteva<br />
generare qualsiasi sorpresa, come un territorio nemico durante la guerra. (p. 37)<br />
In compenso, l’isba di Ajdym diventa per Valeriano il luogo dell’ospitalità per eccellenza. Ajdym<br />
è immune da qualsiasi contaminazione oscena, perché appare quale la risorgenza di una figura mitica,<br />
nella fattispecie biblica, della donna consolatrice, dispensatrice di una pietas che non si cura del perbenismo.<br />
Seduto sul pancone o su una sedia dell’isba, mi pareva di capire fino in fondo perché i due esploratori di Giosuè,<br />
inseguiti dal re di Gerico, si fossero rifugiati nella casa di Raab la meretrice. (...) Chi entrava da Ajdym perdeva l’aria di<br />
individuo disperso e vagabondo, la luce di smarrimento che tremava negli occhi, e si sentiva restituito a se stesso e alla<br />
propria dignità. (p. 124)<br />
Tutt’altro che alcova furtiva e peccaminosa, l’isba d’Ajdym unisce la comunità degli emigranti<br />
e dei semi-autoctoni. L’isba si trasforma in una cornucopia gioiosa di cui la donna kirghisa è l’ispiratrice<br />
e la figura di spicco.<br />
Se Ajdym incarna effettivamente l’emblema dell’ospitalità umana più compiuta, la conchiglia<br />
di Anataj materializza maggiormente l’ospitalità come dono simbolico, destinato a tramandare il ricordo<br />
di tutti coloro che l’hanno posseduta. Oggetto incongruo che si presenta di primo acchito all’ospite,<br />
la conchiglia simboleggia peraltro il concatenarsi delle relazioni umane, l’interdipendenza sostanziale<br />
che unisce tutti gli uomini, nonostante le distanze spazio-temporali. Scambiata varie volte fra gli ospiti,<br />
la conchiglia sedimenta i significati latenti. La sua lunga storia è il frutto della benevolenza di ognuno<br />
degli ospiti che hanno visto in essa un oggetto prezioso anzi pregevole.<br />
Una delle cose che ci univano era, stranamente, una conchiglia, che si mostrava all’ospite sopra l’ultimo ripiano<br />
di uno scaffale, in una rientranza del muro. Era una grande conchiglia a spirale, e pareva la cupola di una pagoda orienta-
le, che finisse in una guglia. Anataj l’aveva avuta da un mongolo in cambio di un coltello col manico di corno...ma il mongolo<br />
l’aveva avuta da un tibetano, a cui l’aveva regalata un indiano, perché gli aveva insegnato a distinguere un’erba che<br />
guariva la dissenteria. (...) Nessuno dei proprietari, tranne il primo, aveva mai veduto il mare. (p. 126)<br />
La conchiglia diventa per Anataj il preludio all’autonarrazione, l’oggetto evocatore di una retrospezione<br />
che scandisce i momenti gloriosi della sua esistenza, e per l’uditorio l’istante di meditazione<br />
e di raccoglimento di fronte ad un vecchio venerando che si accinge a non poter più proferire una sola<br />
parola. Dal punto di vista diegetico assolve il compito di mise en abyme dell’intero romanzo.<br />
Ogni tanto riprendeva in mano la sua grande conchiglia, passata attraverso tante mani di mercanti e di giramondo<br />
prima di arrivare a lui, e se l’accostava all’orecchio. Che cosa recuperava nel ronzio della sua cavità? La steppa della<br />
sua giovinezza, i ricordi della sua tribù di nomadi? O l’epoca, ormai lontanissima, in cui aveva fatto il fuorilegge? (p. 257)<br />
Vi sono affinità tra la figura del migrante ne La conchiglia di Anataj e il viaggio eurasiatico dei<br />
frati francescani Odorico e Giacomo ne Il filo di seta, anche se indubbiamente, l’ospitalità ne Il filo di<br />
seta è la risultanza di una disposizione mentale di matrice religiosa, ché i personaggi di questo romanzo<br />
realizzano una missione di evangelizzazione cammin facendo, prima di raggiungere la Cina, meta ultima<br />
del loro lunghissimo viaggio.<br />
Tutto il racconto è percorso da una meditazione sulla natura dell’ospitalità massime nei luoghi<br />
precisi che presiedono alla descrizione e all’azione dei personaggi. Nell’incipit, l’ospitalità subita esprime<br />
l’oppressione di una consorteria nobiliare nei confronti di ospiti subalterni, Viola e Franz, l’intromissione<br />
ignominiosa nel ricettacolo intimo che dovrebbe essere la casa. Lungi dal consentire lo scambio<br />
e l’armonia in uno spazio condiviso nella concordia, l’ospitalità imposta rivela invece le angherie della<br />
classe egemonica. Ritroviamo qui il motivo del cuc, già presente ne La conchiglia di Anataj.<br />
Scelta la vita monacale, Odorico manifesterà una costante magnanimità nei rapporti con gli uomini<br />
afflitti e abbandonati, anche a costo di turbare le consuetudini inveterate e le convenzioni legali.<br />
Nel convento di <strong>Udine</strong>, Odorico soccorre e accoglie un vagabondo, Uzbek, che è il prototipo dello straniero<br />
ingombrante, attraverso cui si evidenziano le reticenze dei religiosi davanti alle conseguenze di<br />
un’accoglienza che potrebbe renderli invisi alla popolazione autoctona. Uzbek rappresenta il personaggio<br />
provvidenziale e propiziatorio, accolto mentre rischia la propria vita, perché egli è anche il mediatore<br />
che insegna a Odorico i rudimenti della lingua e della civiltà mongole, e quindi dell’identità di questo<br />
popolo. Uzbek finisce coll’assurgere a vettore di un’ospitalità reversibile, che permetterà ad Odorico di<br />
approfondire la conoscenza del paese in cui sarà chiamato a esercitare il proprio ministero.<br />
Uzbek doveva andarsene, non poteva continuare ad abusare della loro ospitalità e generosità, a meno che non<br />
si facesse cristiano. (p. 99)<br />
Odorico ricorse alle parole mongoliche che aveva appreso da Uzbek il mongolo, fattosi frate minore, e la cosa<br />
funzionò. (...) Riusciva a dire le cose fondamentali all’ospite mongolo, figlio di un militare che aveva servito l’esercito sotto<br />
Kublai Khan. (pp. 214-215)<br />
Partiti in Cina per la via della seta, i frati Odorico e Giacomo incontrano il carovaniere musulmano<br />
Selìm, che accetta di accompagnarli dall’Armenia alla Persia attraverso il Caucaso. L’ospite musulmano<br />
non va più identificato col rigorista per cui era stato spacciato in un primo tempo, ma col conoscitore<br />
delle religioni monoteiste. Al cospetto dei frati cristiani, Selìm osserva molto scrupolosamente<br />
le leggi dell’ospitalità all’insegna della teoxenia.<br />
«Montagna sacra» disse Selìm. «Certo. Come il Sinai, la Montagna nera su cui Dio parlò a Mosè!» Selìm fece<br />
un viso perplesso, come dire che era molto più probabile che Dio avesse piuttosto parlato a Maometto, ma insomma non<br />
voleva insistere per ragioni di buon gusto e di ospitalità. (p. 144)<br />
«Ti saranno amici come io stesso lo sono stato, perché l’ospite è sacro e sotto la protezione di Allah.» (p. 159)<br />
Confrontato ai riti buddisti, Odorico è presentato come un personaggio che prova a decifrare<br />
una spiritualità che gli è profondamente estranea. Alla stregua del suo ospite Selìm durante la prima<br />
parte del viaggio, adotta un atteggiamento di discrezione esemplare.<br />
43
44<br />
Odorico non rispose. Erano tutte convinzioni che a lui sembravano infantili, ma che non si sentiva e non voleva<br />
contrastare, quasi per ragioni di ospitalità. (p. 236)<br />
Il filo di seta non significa più la resistenza di una stoffa adoperata per fini militari, dato che diventa<br />
la metafora del legame tenue, ma incommensurabile dell’ospitalità fra uomini che non condividono<br />
comunque le stesse convinzioni.<br />
Forse v’era un filo di seta sottile da dipanare anche adesso. Forse era il «bozzolo del ritorno», e nell’anima di<br />
Odorico tutti coloro che li avevano ospitati, fossero frati minori, o nestoriani, o buddisti o musulmani, li sentiva fratelli nel<br />
fondo, figli di Dio e compagni di viaggio nella strada lunghissima della vita.<br />
II) L’ospitalità nello spazio domestico come salvezza per le vittime della storia<br />
Anche se la casa può essere pregna di ricordi aviti, talvolta squallidi, quello che primeggia in<br />
questo filone narrativo sta nel fatto che essa viene collegata alla presenza sintomatica degli apolidi<br />
per eccellenza che sono gli ebrei e gli zingari. La regina di Saba e L’armata dei fiumi perduti ritraggono<br />
uno spazio domestico che, oltre la scomparsa eventuale dell’ospite primigenio, secerne un messaggio<br />
accorato di speranza nonostante il parossismo di imbarbarimento imposto dal totalitarismo. L’ospitalità<br />
domestica assume qui un significato rinvigorito rispetto ad altri romanzi <strong>sgorlon</strong>iani. La casa diventa<br />
veramente una «dilection adoptive», per riprendere la bell’espressione di Michel Serres 1 , l’emergere di<br />
una famiglia in fieri dove il dialogo e la meditazione sulla condizione umana diventano prevalenti anche<br />
al di fuori dei rapporti di filiazione identitaria, etnica e culturale.<br />
Nell’appartamento d’Isabella si crea una relazione di ospitalità multiforme dove l’identità ebrea<br />
non si oppone all’accoglienza dell’estraneo, qualora sia animato dal sentimento universale dell’amore.<br />
La riunione commensale degli ospiti che assaporano pasticcini tipici del cosmopolitismo ebreo non<br />
ha ovviamente un fine in sé, non è un episodio aneddotico atto a soddisfare un qualunque ghiribizzo.<br />
Si tratta proprio di una festa prandiale, in quanto preludio a uno scambio autentico d’informazioni sulla<br />
comunità e soprattutto a una meditazione sugli eventi locali. Di fronte alla catastrofe incombente,<br />
il protagonista Silvano vive in una specie di scrigno magico che non è totalmente tagliato fuori dal<br />
mondo. Certo, la relazione erotica che magnifica l’intensità dell’amore tra Silvano e Isabella può assomigliare<br />
a un regno della voluttà avulso dall’ambiente circostante, come i giardini d’Armida. Tuttavia,<br />
questa felicità lascia intendere che, lungi dal rattrappirlo, la comunità ebrea contribuisce all’apoteosi<br />
dello scrigno domestico. Se esiste un’atmosfera metatemporale, essa supera la relazione individuale<br />
per collocarla entro il microcosmo della comunità ebrea emarginata quanto universale, per via del suo<br />
anelito ad un’ospitalità utopica che spezzi la catena dell’odio secolare. Grazie a questo spazio dell’ospitalità,<br />
il personaggio di Silvano abbandona l’alveo angusto di un’identità atavica inquietante, e soprattutto<br />
i miti alienanti che si impadroniscono della comunità friulana, di cui è originario. Nel contempo<br />
si affranca da un solipsismo che rischiava di impegolarlo in una monomania assurda. La sua nuova<br />
vita nell’appartamento d’Isabella a Trieste gli rivela i pregi di un’ospitalità che trascende la situazione<br />
personale per favorire un nuovo spirito nelle relazioni umane.<br />
Progressivamente, nella casa di Isabella, l’accoglienza di nuovi ospiti diventa unilaterale, asimmetrica,<br />
perché si tratta di persone che fuggono la persecuzione, recando su di sé le stigmate della violenza,<br />
che vedono nell’appartamento d’Isabella una tappa ristoratrice verso una terra promessa quanto<br />
mai irraggiungibile.<br />
Arrivava gente da via, con sulla faccia il segno di notti insonni, di fughe, di spaventi e di ansia per un futuro pie-<br />
1 Michel Serres, Hominescence, Paris, Le Pommier, 2001
no di ombre (...) Soggiornavano nel casamento per poche settimane, ospiti di questo e di quello, e poi sparivano com’erano<br />
venuti. Anche noi, che avevamo dello spazio in più, spesso ne ospitavamo e pensavamo a rifocillarli e a farli riposare,<br />
senza domande, contentandoci di quello che volevano dirci. (p. 238)<br />
L’appartamento diventa sempre più un santuario dell’ospitalità, a tal segno che Isabella compie<br />
non solo la sua missione vulneraria, ma giunge a donare interamente sé stessa. Il suo senso dell’ospitalità<br />
raggiunge un culmine quasi l’oblazione potesse lasciare intorno a lei un ricordo imperituro dell’amore<br />
come un’ode carica di risonanza, nonostante l’ombra strisciante della morte. Isabella diventa un<br />
mito perché si presenta come mediatrice di beatitudine con atti apparentemente amorali, che rispecchiano<br />
un senso acuto dell’etica, una generosità che metamorfizza, almeno per poco, la condizione di<br />
tutti gli esseri defraudati della loro fede nella vita.<br />
Ne L’armata dei fiumi perduti, la casa in cui abita la protagonista Marta manterrà lungo l’intero<br />
romanzo una cornice dell’ospitalità non solo ricorrente, ma farà pure da scenario per incontri tra tutte<br />
le vittime della guerra. La casa, cui viene conferita una specie di vocazione ospitale che si delinea sin<br />
dall’incipit in medias res, presiede alle azioni di maggiore spicco di Marta e risorge poco prima dell’epilogo<br />
in quanto spazio strutturante del romanzo. Precisiamo che questo spazio domestico non è adibito<br />
a scappatoia di fronte alle irruzioni devastanti della Storia, perché la sua capacità protettiva non è<br />
scontata. Grazie alla pietas della protagonista ed alla sua accettazione del lascito morale e spirituale<br />
dell’ospite precedente, la villa può cancellare gli eventi tragici che l’hanno segnata. Ne consegue che<br />
non esiste qui nessun’ombra atavica soffocante, ma un compenetrarsi con il mondo e la società circostante<br />
che viene orientato da Marta.<br />
Dopo i fatti di luglio parve a Marta che ogni cosa fosse per cambiare e che la fine della guerra stesse ormai a<br />
portata di mano. (...) ma l’accadere di ogni giorno è una cosa e la logica è un’altra, e raramente coincidono. Perciò Marta<br />
non riusciva neppure a trovar parole per tranquillizzare la signora Esther, nella cui villa viveva da moltissimi anni. (p. 7)<br />
Giova notare che, sin dall’inizio, la protagonista viene associata spazialmente ad una casa che<br />
non le appartiene nemmeno, mentre il narratore non ci ha fornito nessun’informazione sul ritratto fisico<br />
o psicologico di lei. Ciò significa che tale spazio domestico non è un orpello, ma che la sua comparsa<br />
subito dopo l’evocazione del referente storico gli attribuisce un ruolo fondamentale.<br />
Marta è accolta materialmente dall’ebrea Esther, che incarna l’ospite sprovvista di ogni vana<br />
munificenza, di ogni sfoggio sociale. In realtà, Esther, naufraga della storia, è a sua volta ospite di Marta,<br />
la quale offre alla padrona una capacità di ascolto e di conforto.<br />
Nel contempo, Marta può essere assimilata all’antonomasia della donna friulana di tipo <strong>sgorlon</strong>iano<br />
plene di snait, che oppone l’ospitalità ricostruita del fogolâr al flagello della guerra. La casa di<br />
Esther non si limita più ad ostentare la propria vulnerabilità; sprigiona ormai una forza latente, un’essenza<br />
inespugnabile poiché si trova saldamente collegata alla terra e al cosmo, al mistero della vita<br />
racchiuso nella natura.<br />
III) Ospitalità e incontri di civiltà nell’ultima narrativa di Sgorlon<br />
Le sorelle boreali e L’alchimista degli strati riecheggiano di nuovo i topoi e le figure dell’ospitalità<br />
che ho cercato di evidenziare in questa scorribanda intertestuale attraverso i romanzi <strong>sgorlon</strong>iani,<br />
pur presentando peculiarità su cui vale la pena soffermarsi.<br />
Intanto, non esiste soluzione di continuità nell’opera omnia <strong>sgorlon</strong>iana nella rappresentazione<br />
diegetica degli spazi domestici, pregni di risonanze ataviche equiparabili a numi tutelari o tramandanti<br />
un messaggio che gli ospiti dovranno interpretare per dare un senso alla loro esistenza. Alla stregua<br />
delle dimore secolari, talvolta irrorate da una temperie patrizia, così frequenti nel Bildungsroman e nei<br />
romanzi storici, ci imbattiamo ne Le sorelle boreali e ne L’alchimista degli strati rispettivamente nella<br />
45
46<br />
maison dell’antenato russo, di nobili natali e nel castello, anzi lo Schloss, in cui abitò una nobildonna,<br />
resa memorabile per via della sua relazione con Massimiliano d’Austria.<br />
Analogamente, le figure femminili rimangono una costante indelebile poiché Magdalena/Leni<br />
de L’alchimista degli strati appare indubbiamente come una prosecuzione del personaggio di Margherita<br />
ne Gli dei torneranno. Le donne <strong>sgorlon</strong>iane si stagliano come depositarie di una sapienza in grado<br />
di cozzare contro i pregiudizi incalliti e di sublimare il dilagare del male grazie al dono dell’ospitalità<br />
che assume nella fattispecie il volto di un eros non scisso dalla pietas/agapé, vale a dire di un amore<br />
sensuale che non reifica l’amato ma esprime letizia, gratuità e profondo rispetto nei suoi confronti.<br />
Altre figure maschili, stavolta, essenziali nell’intreccio de Le sorelle boreali e de L’alchimista<br />
degli strati vanno annoverate come l’esemplificazione di due bersagli polemici di Sgorlon. Per un verso,<br />
gli araldi spregiudicati dell’infatuazione materialista ovvero dell’hybris come Spiro la cui rapacità immorale<br />
rammenta l’Etienne de La fontana di Lorena ; per l’altro verso, i fanatici seguaci di una religione<br />
o dediti alla violenza come Ismael che presenta non poche attinenze con il Burlak de L’armata dei fiumi<br />
perduti e con Branko Bosnič de La malga di Sîr. Tali figure vanno annoverate fra gli antagonisti che intralciano<br />
il dispiegarsi dell’ospitalità.<br />
Per quanto riguarda le specificità di quest’ultima narrativa <strong>sgorlon</strong>iana, va osservato innanzitutto<br />
il dileguarsi dell’abbarbicamento friulano che diventa labilissimo, e a questo riguardo non è casuale<br />
se scompare quasi interamente l’eteroglossia cui erano improntate non solo le opere inaugurali, ma<br />
anche quelle più tardive, quali Il costruttore. Non appaiono più elementi onomastici, toponomastici o<br />
idiomatici che ribadivano l’ambientazione friulana. Semmai, ne L’alchimista degli strati, prevale un accenno<br />
abbastanza nitido alla componente germanofona del Südtirol/Alto Adige che assume talora un<br />
risvolto narrativo non trascurabile nell’involucro di mistero che avvolge tanto il castello di Rosenkrug,<br />
spazio sovradeterminato dell’ospitalità, chiamato Schloss, quanto la sua ospite Leni insieme alla sua<br />
antenata, insignita del titolo di Gräfin.<br />
L’altra originalità, sempre ne L’alchimista, che colpisce il lettore, sta nella gemellità in certo<br />
qual modo elettiva che lega i due protagonisti maschili Martino Senales e Abramo Fusswi. Oltre all’interesse<br />
comune per una scienza che non esclude altre forme di conoscenza cosmica e tellurica, donde<br />
il titolo dell’opera, i due amici, uno italiano, l’altro arabo, si ospitano a vicenda ed amano le stesse<br />
donne. In uno scenario convulso per via dell’esodo delle popolazioni diseredate provenienti dall’Africa<br />
e dall’Asia e delle guerre miranti al controllo dei giacimenti petroliferi, il vincolo inscindibile tra Martino<br />
e Abramo, la cui simbologia onomastica non è certamente casuale, appare come il concretarsi di<br />
un incontro interculturale.<br />
Quello che si potrebbe chiamare il tropismo ospitale funge da chiave di lettura de L’alchimista<br />
degli strati poco dopo l’incipit con una battuta apparentemente innocua che assume la valenza di una<br />
sineddoche, di una spia pars pro toto anzi di una mise en abyme dell’intero romanzo.<br />
«Ma certo. Anzi, ti posso ospitare in casa mia...» 2<br />
Essa interviene nel momento in cui i due personaggi di Martino e Abramo festeggiano la specializzazione<br />
e si stanno accomiatando da Karen. Rammentiamo che proprio costei aveva offerto la<br />
propria ospitalità ai due amici i quali, lasciata la ragazza, hanno paradossalmente rinsaldato il legame<br />
d’amicizia. Sin da questa fase diegetica, si colgono gli eventi in nuce che coinvolgeranno Martino e<br />
Abramo. Karen è tutto sommato la donna pronuba che anticipa non solo le altre donne dei protagonisti,<br />
2 Carlo Sgorlon, L’alchimista degli strati, Milano, Mondadori, 2008, p. 20
ma soprattutto il nesso di gemellità cui verrà improntato il loro agire. Ovviamente, Karen non è nemmeno<br />
una deuteragonista, poiché non apparirà più in quanto tale nella narrazione, ma si badi al fatto<br />
che la sua figura di ospite nel capitolo I «Abramo» appare come paradigmatica in quanto anticipatrice<br />
delpersonaggio di Leni, archetipo <strong>sgorlon</strong>iano della donna vulneraria.<br />
In quanto poi all’ospitalità profferta da Martino ad Abramo, si tratta proprio dell’approfondimento<br />
di un legame che supererà l’alveo angusto e conformista di un mero sentimento di amicizia. Essa<br />
si inserisce anche nello schema antropologico del dono/controdono, pur assurgendo in Sgorlon un<br />
significato che palesa più un confronto esistenziale con l’alterità religiosa e culturale che un baratto<br />
transeunte di beni materiali e di affetti.<br />
“Verrò a passarci le vacanze ; e tu sarai mio ospite, spero.” 3<br />
La casa familiare di Martino che accoglierà Abramo simboleggerà per costui un primo contatto<br />
propiziatorio con la cornice naturale del Südtirol che si tramuterà nella patria d’adozione del giovane<br />
arabo dopo il crollo dell’Emirato di cui è oriundo, come nel romanzo lo stambecco bianco. Inoltre, la casa<br />
di Martino e i dintorni si muteranno in avventura tecnologica e tellurica fervidamente condivisa dal<br />
momento in cui Abramo, ormai deciso a non lasciare più l’Italia, spronerà l’amico a finalizzare il progetto<br />
di sfruttamento dell’energia geotermica.<br />
Questa interpretazione viene suffragata dalla descrizione della torta a strati che si esplica subito<br />
dopo nella narrazione.<br />
Alla fine della cena portarono una torta che i commensali difficilmente avrebbero dimenticata. Infatti, era confezionata<br />
a strati di colore diverso, come fosse una roccia di qualche era geologica, e anche la forma ricordava la sagoma<br />
di uno sperone roccioso. 4<br />
La torta suggella certo un momento di condivisione commensale, ma rivela un aspetto oltremodo<br />
polisemico dato che i suoi strati e il suo colore fosco rimandano da un lato ad uno spaccato geologico<br />
e dall’altro al petrolio, vale a dire a due capisaldi diegetici collegati, ma antinomici. Difatti, Martino<br />
ed Abramo sono affascinati dall’acqua in quanto risorsa insieme sacra e favolosa per gli uomini,<br />
un’acqua anche ipogea che sgorga dalla terra e che permetterà di collaudare un sistema di produzione<br />
energetica inesauribile ed ecologico. Per converso, il petrolio pur stuzzicando la somma perizia tecnica<br />
e la pertinacia di Martino equivale ad una risorsa energetica dell’Oriente in balia di imperialismi, il che<br />
si traduce nel testo con una spirale drammatica.<br />
Insomma, questa scena in cui si intersecano varie forme di ospitalità include un elemento che<br />
anticipa l’apice del crescendo narrativo se non trascuriamo il titolo L’alchimista degli strati. L’incontro<br />
tra Abramo ed i suoi ospitanti non occupa molte pagine, ma al di là degli ossequi e del galateo, giova<br />
notare un ampliamento di stampo morale e universale. Abramo non viene sbirciato o squadrato dalla<br />
famiglia che lo accoglie alla stregua di un esemplare esotico latore di un’estraneità insieme suggestiva<br />
e insidiosa, tutt’altro! Il personaggio del pater familias, Antero, ricettacolo della memoria dei valori<br />
atavici viene indotto a interpretare la cornice paesaggistica di Abramo, quindi un parametro fondamentale<br />
della sua identità, come una metafora della condizione umana. La fratellanza rimanda qui, a mio<br />
parere, sia al concatenarsi degli eventi che segneranno la traiettoria di Martino sia al nucleo della poetica<br />
di Carlo Sgorlon.<br />
Si contentavano di stare pronti, se l’ospite avesse manifestato qualche desiderio o necessità.“Appunto siamo<br />
tutti figli del deserto. Ci sentiamo fratelli anche per questo.” 5<br />
3 Ibid, p. 52<br />
4 Ibid<br />
5 Ibid., p. 26<br />
47
48<br />
Tuttavia, tale volto magnanimo dell’ospitalità non significa un appartarsi dal mondo, tant’è vero<br />
che il dialogo tra Martino ed Antero precede il discorso in parte referenziale sulla realtà squallida<br />
dell’immigrazione dei clandestini, in cerca di un’ancora di salvezza per sfuggire alle pessime condizioni<br />
economiche e all’ostracismo politico.<br />
Il modo con cui viene poi descritto lo Schloss, topos domestico determinante, rammenta sul<br />
piano intertestuale molti spazi domestici prediletti da Sgorlon tra l’altro la Torre Francesca de la malga<br />
di Sîr. Si tratta di un castello che possiede propaggini remotissime ed illustri, sicché ai suoi ospiti spetta<br />
il dovere di tramandarne la memoria e di serbarne i valori di apertura all’alterità. D’altra parte, si ritrova<br />
nella prima descrizione di Leni il topos della donna vulneraria, provvista del dono di pietas verso<br />
altrui, sia pure mediante un accenno che crea un’aspettativa presso il lettore.<br />
La donna aveva qualcosa di enigmatico, ma si capiva facilmente che i guai degli altri la disturbavano oltre misura.<br />
Non disse apertamente queste cose ai due ospiti, ma alcune allusioni appena accennate avviavano i pensieri in quella<br />
direzione. Preferì fermarsi su altri argomenti. Tutti sapevano che il castello alla fine del Quattrocento aveva ospitato per<br />
qualche giorno il re Massimiliano d’Asburgo, che poi sarebbe diventato imperatore (...) 6<br />
Vorrei comunque soffermarmi su due particolari che innescano di nuovo un processo di mise en<br />
abyme, proprio in questo spazio del castello.<br />
Innanzitutto, colpisce l’immagine riflessa nello specchio del personaggio di Leni la quale non<br />
appare nel solco di un ritratto tradizionale, bensì in medias res attraverso la focalizzazione di Martino.<br />
Leni viene quindi avvolta in un alone di mistero e la sua immagine ammantata di una bellezza enigmatica<br />
e insospettata desta sin da quel momento in Martino un desiderio conoscitivo che caratterizza la<br />
sua assiologia per tutta la diegesi.<br />
La seconda mise en abyme riguarda invece il libro bilingue, scritto in ebraico e in arabo, che<br />
narra segnatamente l’episodio di Sodoma e Gomorra. Tale libro-cimelio suggella una specie di iniziazione<br />
cognitiva per gli ospiti, ma racchiude altresì in modo prolettico sia l’incendio dei pozzi di petrolio che<br />
l’idea ricorrente ne L’alchimista degli strati di una storia ciclica. Peraltro, il libro in questione diventa il<br />
tramite nella relazione tra Martino e Leni acquisendo un significato iperbolizzato alla fine della storia.<br />
Il rapporto amoroso tra Martino e Irene che viene ambientato nella capitale dell’emirato anticipa<br />
nella sua rappresentazione quello tra Martino e Leni. In ambedue possiamo individuare un eros<br />
abbinato al cosmo e all’idea di trascendenza. In un’ottica fenomenologica, l’amore sensuale che unisce<br />
questi personaggi s’inserisce nella consapevolezza di una bellezza dell’universo, ovvero non v’è nessuno<br />
iato tra il microcosmo e il macrocosmo. L’estasi sensuale diventa in questa pagina uno sprone a una<br />
considerazione cosmogonica, ma va osservata altresì la modalità di enunciazione che riesce abbastanza<br />
peregrina in Sgorlon. Difatti, l’amore viene raffigurato come un ospite tramite una prosopopea incipiente,<br />
in concomitanza con la descrizione di una cena trascurata, il che permette di sovrapporre gravità<br />
del proposito e umorismo della rappresentazione.<br />
“Ti chiamerò Eva” diceva Martino ridendo.<br />
“Come Leni? Ma io mi chiamo già Irene. È un nome significativo.”<br />
“Non c’è dubbio. Quello di Eva lo raggiungo io.”<br />
“Più o meno in ebraico antico vuol dire “donna”.”<br />
“Ti pare poco? È la più grande invenzione del Creatore.”<br />
“E se non esiste alcun creatore?”<br />
“Vuol dire che c’è un Nulla potente e inventivo come lui, e gli do il nome di Creatore.”<br />
E così di nuovo spalancavano le porte all’Ospite che bussava sempre da capo alla loro porta, mentre qualche<br />
minestra all’italiana si raffreddava nei piatti. 7<br />
6 Ibid., p. 40-41<br />
7 Ibid. , p 129
Ne L’alchimista degli strati, viene annessa molta rilevanza al senso dell’ospitalità da parte degli<br />
autoctoni arabi nei confronti degli occidentali. Vanno individuate a questo riguardo due pause narrative<br />
che illustrano sia i topoi che le figure dell’ospitalità.<br />
La prima si riferisce all’episodio della convalescenza di Irene consecutiva all’aborto da lei subito.<br />
Si assiste ad una scena corale che pur nella sua stringatezza si addice alla nostra impostazione critica.<br />
L’intreccio tra la focalizzazione neutra e quella interna connessa al sentimento provato dalle donne<br />
pone l’accento sulle ripercussioni psicologiche del repentino incontro interculturale. Indubbiamente,<br />
l’ospitalità esula dalla mera obbedienza ad una norma introiettata per quanto trapeli il retaggio di una<br />
consuetudine atavica. Le donne musulmane ospitanti non considerano l’accoglienza in modo unilaterale<br />
come un mero servigio reso ad una straniera che ha patito come loro nelle proprie viscere. Certo, si<br />
intuisce nel testo una solidarietà muliebre, ma ad essa si aggiunge la scoperta sconvolgente o conturbante<br />
dell’alterità di cui Irene è depositaria. La giovane italiana squarcia il velo su un altro sistema antropologico<br />
rimosso dalla psiche delle donne arabe oppure ancora ignoto. Va notato che questa scena<br />
evoca un incontro pacifico di civiltà perché Sgorlon è solito presentare la terrestrità femminile come un<br />
antidoto al fanatismo ideologico e religioso che permea l’azione di tanti personaggi maschili. In filigrana,<br />
il testo presenta l’idea secondo la quale anche una società in certo qual modo autarchica, retta da<br />
un sistema rigido di valori viene prima o poi confrontata a modelli antropologici esogeni.<br />
Ma le donne del villaggio insistevano perché si fermassero ancora. Avevano un forte senso dell’ospitalità. In più<br />
Irene aveva per esse un’attrattiva speciale, inconfessata e inconfessabile, perché in ogni particolare e in ogni atteggiamento,<br />
persino nel modo di vestire, era così diversa da loro. Sentivano il fascino della straniera, che però in pari tempo<br />
era anche quello del proibito e del diverso. 8<br />
La seconda pausa narrativa subentra alle traversie che incalzano Martino in seguito al golpe<br />
nell’emirato. Smarrita ogni traccia di Irene ed inviso al nuovo regime politico impadronitosi del potere,<br />
egli cerca refrigerio alla sua disperazione fuggendo nel deserto per cui incontra ad un certo punto i<br />
beduini. Il reticolo diegetico appare piuttosto parco dei particolari che conferirebbero a questi abitanti<br />
un fascino esotico. Primeggiano in compenso sia un’essenzialità della condizione nomada espressa<br />
con due frasi ellittiche che l’ospitalità nei confronti dello straniero qual è Martino, errabondo in questo<br />
frangente per necessità, ma anche per idiosincrasia. Pur appartenendo a due civiltà ritenute antagoniste,<br />
Martino e i nomadi sono pronti ad accogliersi a vicenda. Come ne Il filo di seta, accade l’intervento<br />
vulnerario ad opera dell’ospitato che salva la vita dell’ospitante o di un membro della sua famiglia.<br />
Facendo dono della sua perizia, Martino è ammantato del prestigio del taumaturgo dopo la guarigione<br />
della fanciulla affetta da difterite. Egli è quasi equiparato ad un inviato di Dio misericordioso, ovvero<br />
incarna la figura dell’ospite dotato di teoxenia.<br />
Nomadi del deserto. Beduini. Costoro non dissero molte parole, ma lui intese subito che il loro atteggiamento<br />
era ospitale e benevolo. 9<br />
Sempre in questa fase del racconto, la figura di Dhu l’Himma ricalca quella di moltissime donne<br />
<strong>sgorlon</strong>iane, segnatamente quella di Ajdym ne la conchiglia di Anataj. Viene tratteggiata mediante<br />
un susseguirsi di episodi che mettono in risalto la sua dedizione nei confronti di Martino per cui appare<br />
come una “meretrice serena” che lungi dall’essere rea di mercimonio viene soffusa da un’aura di sacralità.<br />
La relazione sensuale tra i due personaggi rappresenta quindi l’apice del dono di ospitalità anziché<br />
uno sfogo di concupiscenza avvilente. Particolarmente suggestivo riesce l’inserimento del rapporto<br />
amoroso entro la cornice del deserto giacché ribadisce il legame tra l’essere e il mondo in una prospet-<br />
8 Ibid., p. 139<br />
9 Ibid., p. 165<br />
49
50<br />
tiva icasticamente eudemonica. Non è casuale se viene adoperato il sostantivo eteroglosso di bonheur,<br />
non solo per evocare la felicità agognata dall’umanità, ma anche la ricerca utopica di essa resa possibile<br />
nei momenti di decentramento e di sfasatura spaziotemporale. Il deserto con le sue oasi e i suoi<br />
nomadi assurge perciò a universo metatemporale e metastorico rappresentando un’alternativa pacifica<br />
al deserto rinvilito a territorio di sfruttamento e di contese accanite. L’ospite assume il valore di un inviato<br />
di Dio per cui l’accoglienza trascende il mero galateo per diventare teoxenia.<br />
Anzi credette di capire che lei fosse la donna che il capo tribù indirettamente offriva agli ospiti che talvolta i<br />
beduini avevano salvato dai pericoli del deserto, o che si rifugiavano presso di loro per fuggire una grande minaccia. (...)<br />
Dhu l’Himma era servizievole ma non servile. Era dotata della dignità intensa e silenziosa del deserto. Era la moglie di un<br />
lungo percorso attraverso l’Arabia.<br />
Era una specie di meretrice serena, che si dedicava all’ospitalità come fosse una delle maggiori virtù, protetta<br />
direttamente dagli dèi. 10<br />
L’amore come emanazione di una forza che trascende le grettezze umane e l’impulso di thanatos<br />
si sublima con il dono del figlio. Molto riuscite risultano le pagine che narrano la rivelazione della<br />
gravidanza inaspettata di D’hu l’Himma. Va notata la battuta dalla sintassi paratattica, in cui l’anafora<br />
e l’antitesi verbale sottolineano vieppiù l’aggancio alle reminiscenze bibliche. Il figlio che Dhu l’Himma<br />
aspetta da Martino illustra il miracolo della vita che fuga i miasmi mortiferi che avvelenano l’animo.<br />
Si realizza qui un incontro favoloso tra gli esponenti di due civiltà apparentemente diverse se non<br />
contrapposte. Per il personaggio di Martino, la rivelazione della sua paternità innesca un processo di<br />
monologo interiore che sfocia su un’ascesi. La propria permanenza nel deserto e la relazione con Dhu<br />
l’Himma gli ha ritemprato l’animo per cui non si trova più nel vicolo cieco esistenziale dove era stato<br />
sospinto dopo la scomparsa di Irene.<br />
Tornato ad Alpendorf e mentre sta dialogando con Leni, Martino procede ad un’anamnesi che<br />
gli permette di evocare la figura imperitura di Dhu l’Himma. Leni dal canto suo inserisce la donna beduina<br />
nella prospettiva dell’universalità disinnescando nel contempo gli scrupoli di Martino timoroso di<br />
aver trasgredito una norma morale. La narrazione realizza quindi un concatenarsi dei personaggi femminili<br />
che al di là delle variabili individuali presentano una notevole coerenza assiologica.<br />
Paragonò i beduini agli esquimesi che all’ospite che passava la notte nel loro riparo di ghiaccio o di legno offrivano<br />
la propria donna. Non v’era forma di ospitalità più grande di questa. 11<br />
Se ora spostiamo la nostra attenzione a le sorelle boreali, il topos domestico determinante nella<br />
fabula riguarda la cosiddetta villa Elisa la quale cela un passato non proprio gradito dal personaggio<br />
di Lisa. Indubbiamente, l’omofonia tra l’onomastica e la toponomastica allude implicitamente sin<br />
dai primi capitoli ad un confronto tra il nuovo spazio ospitante e la sua ospite. Alla stregua dell’Italia,<br />
la maison offre un volto ambiguo, ma nel corso della diegesi si assiste ad una specie di sublimazione<br />
dell’ospitalità che non viene più sovrastata da figure ataviche sopraffatte dalla sola violenza o coinvolte<br />
in turpi vicende. In altri termini, l’arte pittorica e l’inno alla bellezza precedono come disposizione<br />
d’animo il concretarsi di quello che ho chiamato l’ospitalità vulneraria. Ospite in Italia, il personaggio<br />
di Ludmilla diventa ospitante a sua volta ripristinando i valori umani che la Russia e la famiglia le hanno<br />
tramandato. L’atteggiamento di Ludmilla è improntato alla dedizione disinteressata e incondizionata<br />
anche se l’ospitato non ricambia il dono d’amore che gli è prodigato. Il testo di Sgorlon non indulge<br />
all’irenismo, visto che non conferisce all’ospitalità offerta dalle sorelle boreali una valenza di toccasana.<br />
Difatti, la scontrosaggine e l’ingratitudine di alcuni clandestini musulmani precede di poco senza<br />
10 Ibid., p. 175<br />
11 Ibid., p. 225
transizione diegetica lo squarcio sulla forma mentis di Ismael che si avvale dell’accoglienza in Italia<br />
per compiere nefandezze. Narrativamente, quindi, i topoi e le figure dell’ospitalità accettata o distorta,<br />
presentano una schiera di situazioni che consentono da un lato di imprimere all’intreccio una dinamica<br />
pulsante straripante di suspense e dall’altro di far riflettere sulle difficoltà di instaurare un dialogo tra<br />
autoctoni, ex immigrati e nuovi immigrati.<br />
Per settimane li ospitarono nella villa, offrendo loro ministre calde e grandi piatti di pesce di lago 12<br />
La loro frustrazione era mascherata di disprezzo. Chiedevano ospitalità ma non amavano gli ospiti. (...) Ma Ludmilla<br />
non cambiava sostanzialmente il proprio stile. Era sempre lei che finiva per far prevalere il senso dell’antica ospitalità<br />
della Carelia. 13<br />
Ludmilla e le sue sorelle sono comunque mosse da un afflato dell’ospitalità che trascende la<br />
consuetudine per sconfinare nella meditazione sulla risonanza metafisica e perfino ontologica dell’esistenza<br />
terrena. Lo scorcio del capitolo intitolato “la conquista” riesce eloquente a questo riguardo. La<br />
frase finale è caratterizzata dall’anafora del sostantivo “ospiti” e dal nome “ospitante” nella clausola.<br />
La caducità della vita non sfocia sulla disperazione nichilista, bensì muove alla consapevolezza di un’eteronomia<br />
foriera di una responsabilità etica di fronte al dono dell’esistenza.<br />
Si sentivano straniere e ospiti sulla terra, dove si trovavano per effetto di inconoscibili forze cosmiche, o del<br />
destino, o delle stelle, o di Dio, e volevano comportarsi da ospiti perfettamente corretti, chiunque fosse l’ospitante. 14<br />
Ne le sorelle boreali, davvero avvincente risulta la traiettoria diegetica del personaggio di Ibrahim,<br />
l’iraniano in un primo tempo circuito dal verbo ammaliante di Ismael il quale sta farneticando una<br />
nuova guerra santa contro l’Europa. Il dissidio che travaglierà Ibrahim oppone la coazione del super-io<br />
incarnato da Ismael e la voce della coscienza che sorge quale un’emancipazione e un riscatto morale.<br />
Tale situazione rammenta la ribellione del personaggio di Abernathi ne Il filo di seta deciso a recidere<br />
il legame con la propria religione che impone sacrifici umani.<br />
Ibrahim scopre in Ruben, israeliano quindi nemico mortale dei palestinesi, un alter ego la cui<br />
figura non può essere compendiata nella guerra spietata cui ha partecipato. Ancora una volta, Sgorlon<br />
propende alla rappresentazione di un incontro di civiltà se non ecumenico, a rigor di termini, quanto<br />
meno interreligioso, dato che la villa di Ruben accoglie un ebreo, una cattolica, un’ortodossa e un musulmano.<br />
Il seppellimento nottetempo di Ibrahim che si è sacrificato per salvare Ruben e Olga sembra<br />
esorcizzare le morti che avevano funestato Villa Elisa la quale alla fine del romanzo assolve un compito<br />
eccelso di ospitalità accogliendo donne e uomini sbandati. Il musulmano Ibrahim diventa la figura emblematica<br />
del Giusto la cui morte acquista un vero senso eroico.<br />
L’iraniano sapeva che Ruben aveva tentato di vivere in Israele, ma poi era tornato, perché laggiù non v’era e non<br />
poteva esserci nessuna pace, trattandosi di una lotta di sterminio.(...) Ruben capì che Ibrahim era un solitario come lui,<br />
un essere pacifico e saggio. Ruben aveva perduto i suoi e l’iraniano era senza patria e aveva la famiglia lontana. Si somigliavano<br />
nella loro condizione esistenziale. (...) “Il mio alloggio è molto grande. Con qualche modifica potrebbe ospitare<br />
la mia famiglia per intiero” disse Ibrahim. 15<br />
A soffermarsi per un attimo sull’impostazione narratologica de le sorelle boreali e de l’alchimista<br />
degli strati, è proponibile uno schema attanziale che permetta di cogliere la funzione preponderante<br />
dell’ospitalità sia in quanto topos tematico che come molla determinante dell’intreccio e pertanto del<br />
fascino insito nella scrittura <strong>sgorlon</strong>iana.<br />
12 Carlo Sgorlon, Le sorelle boreali, Milano, Mondadori, 2004 p. 136-137<br />
13 Ibid., p. 138<br />
14 Ibid., p. 157<br />
15 Ibid., p. 169<br />
51
52<br />
DESTINATORE SOGGETTO DESTINATARIO<br />
La terrestrità<br />
Gli apolidi le vittime delle violenza<br />
Il destino<br />
I viandanti dell’esistenza<br />
I reietti<br />
L’entità ospitante<br />
Le vittime della Storia e delle sperequazioni<br />
mondiali<br />
AUSILIO OGGETTO OPPOSITORE<br />
I personaggi di ceto patrizio<br />
o popolare provvisti<br />
del dono dell’ospitalità<br />
L’anelito eudemonico come traguardo<br />
sublime dell’esistenza<br />
cioè l’ospitalità data o ricevuta<br />
I seguaci del fanatismo religioso<br />
e dell’idolatria consumistico-edonistica<br />
Come ho già detto altrove, le figure dell’apolide e del migrante sono onnipresenti in Sgorlon, al<br />
punto che frantumano l’immagine di un nordest e di un Friuli spesso assimilati, nel campo letterario, o<br />
alla regressione psicologica o alla ricerca assillante di identità esclusive. Sarebbe fuorviante considerare<br />
l’universo romanzesco di Carlo Sgorlon secondo il metro angusto di un campanilismo nostalgico,<br />
perché la sua opera induce una problematica universale per via dell’assiologia insita nei personaggi in<br />
cui il peso della tradizione non intralcia la conoscenza del mondo e dell’alterità.<br />
Di fronte al potere subdolo e pervasivo di una tecnologia onninvadente che ci dà l’illusione di<br />
un’ubiquità disincarnata, la salvaguardia del patrimonio culturale del Friuli richiede una consapevolezza<br />
rinvigorita in osmosi con i fermenti fecondi di culture anche al di fuori dell’alveo europeo, pena l’omologazione<br />
alienante già vaticinata da Pasolini.<br />
Magari a Carlo Sgorlon non si addice la qualifica di vate perché è stato parco di dichiarazioni<br />
dalla risonanza mediatica, tuttavia sono convinto che i topoi dell’ospitalità insiti nella sua narrativa lascino<br />
scaturire non solo un mondo finzionale avvincente e poderoso, ma pure un risvolto antropologico<br />
oltremodo sfaccettato visto che dallo scandaglio interiore nei recessi della psiche si passa alla rappresentazione<br />
multifocale dello scontro o dell’incontro di civiltà.<br />
Se ora badiamo a un’ottica di ricezione, in un’Europa non scevra di rigurgiti nazionalisti e perfino<br />
xenofobi, nella quale alcuni esponenti politici anche di spicco non hanno remore a stravolgere il<br />
messaggio cristiano, leggere e diffondere l’opera romanzesca di Carlo Sgorlon assolve una funzione<br />
dirompente, paratopica e sovversiva che diventa mallevadrice di libertà e di fratellanza, pur non celando<br />
i rischi incombenti di conflitti, per via del dilagare del fanatismo, spesso di stampo islamico. D’altra<br />
parte, l’imperare della videocrazia e della reificazione in nome della legge ferrea del mercato, come<br />
surrogato alla vacuità spirituale di ampi strati della civiltà occidentale, sembra agli antipodi della poetica<br />
<strong>sgorlon</strong>iana la quale decanta invece i valori preminenti di un’ospitalità squisitamente rispettosa<br />
dell’essere umano e della natura.<br />
Quantunque il genere romanzesco <strong>sgorlon</strong>iano possa sembrare ai margini dei filoni postmoderni<br />
della letteratura italiana, si ricollega in realtà ai grandi scrittori che hanno saputo nobilitare la propria<br />
opera con uno scavo etico ed esistenziale, delineando nel contempo l’utopia di un’umanità non più<br />
votata alla violenza, bensì anelante alla pace e all’amore del prossimo.
Un labirinto pronto a inghiottirci: Sgorlon legge Pasolini<br />
(con un inedito di Carlo Sgorlon)*<br />
di Giampaolo Borghello<br />
Università degli Studi di <strong>Udine</strong><br />
La morte non è ordine, superbi<br />
monopolisti della morte,<br />
il suo silenzio è una lingua troppo diversa<br />
perché voi possiate farvene forti:<br />
proprio intorno ad essa vortica<br />
la vita!<br />
Pier Paolo PaSolini, La libertà stilistica<br />
Non avrei più potuto raccontare a me stesso la favola che la morte<br />
non esisteva, e che io potevo pensarmi immortale, come Calypso<br />
o Titone. La morte di Maddalena dunque voleva dire la fine di una<br />
favola attraente, ma ingannatrice. Lo pensavo però senza crederci<br />
troppo, come fossi convinto in fondo che avevo ragione un tempo,<br />
e non adesso. Come se una favola dovesse sempre essere vera, perché<br />
tale era la sua più profonda natura...<br />
Carlo Sgorlon, Il trono di legno<br />
Proprio perché i mondi culturali, gli orizzonti ideologici, le personalità e gli stili di vita di Pier<br />
Paolo Pasolini e Carlo Sgorlon ci appaiono opposti e inconciliabili, è affascinante e utile cercare puntigliosamente<br />
i sentieri, i pertugi, le scorciatoie che li mettono in comunicazione. Sgorlon ha dedicato<br />
alla figura e all’opera di Pasolini numerosi interventi, distanziati nel tempo: 1 siamo così in presenza di<br />
una serie consistente di costanti, con alcune significative varianti.<br />
1 Cfr. Carlo Sgorlon, Crist, pietàt dal nuestri paìs, in «Tuttolibri-La stampa», 22 maggio 1976; Un monumento per Pier Paolo, in «Il<br />
Giornale», 7 gennaio 1979; L’occhio, la febbre, lo stile , in «Il Giornale», 24 giugno 1979; Pasolini-Sgorlon: due sentimenti per<br />
una stessa terra, in «L’Umanità», 17 luglio 1979; Nel caos dell’inquietudine, in «Il Giornale», 27 gennaio 1980; Pier Paolo era<br />
anche friulano, in «Il Giornale», 31 agosto 1980; Una mater dolorosa, in «Il Giornale», 2 novembre 1980; Pasolini, il labirinto,<br />
in «Il Piccolo», 16 giugno 1987; Pasolini è a pezzi e dappertutto, in «Il Piccolo» 19 dicembre 1989; Pasolini e il pasolinismo, in<br />
«Messaggero Veneto», 17 ottobre 1993; Pasolini, un’autorità di profeta?, in «Messaggero Veneto», 20 ottobre 1993; Pier Paolo<br />
profeta? E sia..., in «Messaggero Veneto», 7 novembre 1993; Quel teorema fascista, in «Messaggero Veneto», 21 giugno 1995;<br />
Un vitalismo incalzato dalla ‘commare secca’, in «Messaggero Veneto», 1 novembre 1995; Un Ulisse che non ha mai avuto la<br />
necessità di farsi legare..., in «Il tempo», 4 giugno 1996; Un innovatore in Friuli, «Messaggero Veneto», 31 ottobre 2000.<br />
53
54<br />
Il primo impatto, la prima impressione di Sgorlon è certo quella della ‘totalità’ e delle dimensioni<br />
del pianeta Pasolini. Ha scritto Sgorlon:<br />
Un critico francese, a proposito di L’art d’être grand-père di Hugo, disse che il grande scrittore<br />
avrebbe dovuto comporre, piuttosto, “L’arte di essere Dio”; tanto Victor tendeva a porsi demiurgicamente<br />
nei confronti del reale, e la sua scrittura ad essere universale ed onnicomprensiva.<br />
In certi momenti di irritazione nei confronti di Pasolini (chi non ne ha avuti?) mi è capitato di<br />
pensare la stessa cosa di lui. Che cosa non ha fatto Pier Paolo? Di quale aspetto del reale non si è occupato?<br />
Che cosa non ha sperimentato?<br />
Che tendesse alla totalità, cioè ad essere Dio, il povero Pasolini, non c’è dubbio. Ma che dio<br />
era? Non certo un dio alla Hugo, patriarcale e incensato. 2<br />
Pasolini è una personalità sconfinata, infinitamente contraddittoria; tendeva a inglobare (con<br />
straordinaria cultura, fertilità di idee, passione rovente e mutevolezza proteiforme) la totalità del reale.<br />
Pasolini fu, per così dire, ‘tutto’. 3<br />
Sgorlon appare stupito, incuriosito, attratto dalla straordinaria capacità di Pasolini di essere<br />
poeta, narratore, regista, critico letterario, saggista, polemista, intervenendo in ogni campo del reale e<br />
lasciando molto spesso segni del suo passaggio e della sua presenza. Alle radici di questa multiforme<br />
e proteiforme attività c’è nell’autore una straordinaria vitalità che affascina anche Sgorlon. Rispetto a<br />
una tendenza prevalente nelle alte vette della cultura europea, che registra una scarsità o un’assenza<br />
di vitalità, Pasolini si colloca al polo opposto. Sgorlon, non senza una suggestione polemica, allinea i<br />
nomi di Sartre, Camus, Moravia, Musil, Kafka, Beckett, Bernhard e li individua icasticamente come autori<br />
«anoressici, inariditi, devitalizzati, pieni di incubi senili, allucinati.» 4<br />
La presenza di una personalità come quella di Pasolini appare allora a Sgorlon come “un fatto<br />
squillante e, spero, gravido di conseguenze.” 5 Ma, come noto, il vitalismo di Pasolini appare incalzato<br />
dalla pulsione di morte, dalla ossessiva presenza della ‘commare secca’. La “disperata passione di<br />
essere al mondo”, il piacere biologico di esistere, la totale disponibilità a ogni frammento del reale, la<br />
dilatata sensibilità acquistano senso e dimensione in un sotterraneo ma fondamentale confronto con<br />
la pulsione di morte. Così la vitalità è “disperata”, cresce vorticosamente su se stessa, si sbizzarrisce,<br />
galoppa frenetica, ma si chiude (al tempo stesso) in un cerchio profondo e sempre più stretto con l’immagine<br />
della morte (la ‘commare secca’) ossessivamente presente. A chiarire il senso e la portata di<br />
questo intreccio resta sempre eloquente questa affermazione dello stesso Pasolini:<br />
Amo la vita così ferocemente, così disperatamente, che non me ne può venire bene: dico i dati<br />
fisici della vita, il sole, l’erba, la giovinezza: è un vizio molto più tremendo di quello della cocaina, non<br />
mi costa nulla, e ce n’è un’abbondanza sconfinata, senza limiti: e io divoro, divoro... Come andrà a finire<br />
non lo so... 6<br />
2 Carlo Sgorlon, Nel caos dell’inquietudine, cit.<br />
3 id., Pasolini, il labirinto, cit.<br />
4 id., Un vitalismo incalzato dalla ‘commare secca’, cit.<br />
5 Ibidem .<br />
6 Ritratti su misura, a cura di Elio Filippo Accrocca, Venezia, Sodalizio del libro, 1960, p.321; poi in «l’Unità», 4 novembre 1975.
Nella narrativa pasoliniana poche pagine siglano ed esprimono con eguale compiutezza e perentorietà<br />
questo intreccio di vitalità e pulsione di morte come in Ragazzi di vita la descrizione della<br />
morte di Amerigo:<br />
«Amerigo è morto,» disse. Il Riccetto si alzò a sedere puntando i gomiti e lo guardò in faccia.<br />
Gli angoli della bocca gli tremavano come per un sorrisetto divertito; era una notizia eccitante, e si sentiva<br />
tutto pieno di curiosità. «Ch’ai fatto?» chiese. «È morto, è morto,» ripeté Alduccio, contento di dare<br />
quella notizia inaspettata. «È morto ieri ar Poricrinico,» aggiunse. Quel cavolo di sera che il Riccetto<br />
aveva tagliato dalla casa di Fileni, il Caciotta e gli altri s’erano fatti beccare, ma non avevano fatto resistenza.<br />
Amerigo invece s’era lasciato portar fuori tenuto per le braccia da due carabinieri, ma appena<br />
sul terrazzino li aveva sbattuti contro la parete e aveva fatto un zompo di due o tre metri sul cortile;<br />
s’era acciaccato un ginocchio, ma era riuscito lo stesso a trascinarsi avanti lungo il muro del lotto: i carabinieri<br />
avevano sparato e l’avevano colto a una spalla, e lui ugualmente ce l’aveva fatta a arrivare fin<br />
sulla sponda dell’Aniene; lì stavano quasi per acchiapparlo, ma lui sanguinante com’era s’era buttato in<br />
acqua per attraversare il fiume e nascondersi negli orti dell’altra riva, scappare verso Ponte Mammolo<br />
o Tor Sapienza. Ma in mezzo al correntino s’era sturbato e i carubba l’avevano acchiappato e portato al<br />
commissariato zuppo di sangue e di fanga come una spugna: così che dovettero trasferirlo all’Ospedale<br />
e piantonarlo. Dopo una settimana gli era passato il febbrone, e lui tentò d’ammazzarsi tagliandosi i<br />
polsi coi vetri d’un bicchiere, ma anche stavolta lo avevano salvato; allora una decina di giorni appresso,<br />
prima che Alduccio e il Riccetto s’incontrassero all’Acqua Santa, s’era gettato giù dalla finestra del<br />
secondo piano: per una settimana aveva agonizzato, e finalmente se n’era andato all’alberi pizzuti. 7<br />
Proprio perché non c’è soluzione di continuità tra le innumerevoli forme dell’attività di Pasolini,<br />
l’attenzione deve concentrarsi sulla presenza, sul modo di stare ‘sulla scena’ dell’autore. Sgorlon<br />
registra fedelmente le contraddizioni dell’agire umano dello scrittore: a proposito dell’immagine che<br />
Pasolini dà di se stesso aggiunge “gridandola ai quattro venti, per sottili ragioni in cui il narcisismo si<br />
mescolava alla sofferenza, il desiderio dello scandalo e della provocazione alla disperazione, l’irrefrenabile<br />
vitalità al gusto di smuovere le acque dell’eterna arcadia letteraria italiana” 8 . E in un altro articolo<br />
il narratore friulano ribadisce:<br />
Ebbe un bisogno impetuoso di essere un vessillo che sventola su tutti i pennoni, magari per venire<br />
sbattuto dai venti e frustato dalla pioggia. Ebbe una necessità esistenziale, narcisistica, ma anche<br />
logorante e terribilmente dispersiva, di essere sempre in vista su ogni versante della vita. Volle essere<br />
sempre al centro dell’interesse, e per farlo accettò anche di stare nell’occhio del ciclone. Ebbe bisogno,<br />
sempre e dovunque, non solo di dire la sua, ma di vaticinare, di sentenziare, di gridare la sua opinione<br />
di profeta perseguitato, di eretico di tutte le sedi e di esiliato di tutte le patrie. Non poté trattenersi dal<br />
gridare in faccia a tutti il proprio dissenso e la propria protesta. Provò una necessità imperiosa di essere<br />
personalissimo, imprevedibile, dissonante, anticipatore, come un gallo spennacchiato che gridi il<br />
suo verso molte ore prima dell’alba. 9<br />
Il tocco squisitamente narrativo di Sgorlon con la similitudine del gallo si lega a un’altra forte e<br />
7 Pier Paolo PaSolini, Ragazzi di vita, Milano, Garzanti, 1955, p.106-107.<br />
8 Carlo Sgorlon, Un monumento per Pier Paolo, cit.<br />
9 id., L’occhio, la febbre, lo stile, cit.<br />
55
56<br />
icastica immagine di Pasolini che “carico di tutte le negatività del nostro tempo” è costretto a gridare<br />
contro tutto e contro tutti “fino a scorticarsi la gola.” 10 Attraverso questi e altri passi Sgorlon, pur ribadendo<br />
un suo saldo punto di vista, si accosta a una tematica ricorrente, quella del ‘Pasolini profeta’.<br />
Si tratta di un tema e di un’immagine che sono largamente presenti negli orientamenti della<br />
critica e nell’atteggiamento dei lettori. Le modalità improvvise e drammatiche della morte di Pasolini<br />
hanno interrotto, con un taglio netto e risoluto, un’attività ampia e febbrile, lasciando, per forza di cose,<br />
come vivida immagine quella dell’ ultimo Pasolini, polemista disperato di fronte all’universo orrendo. 11<br />
Ma questo è uno solo dei molti volti dello scrittore, che invece è caratterizzato proprio dalla vastità ed<br />
eterogeneità dei suoi interessi, dei suoi linguaggi, delle sue culture.<br />
Questa violenta cesura finale ha condizionato i percorsi della critica, impedendo spesso una serena<br />
parametrazione che illustrasse adeguatamente le singole tappe del lungo iter dell’artista, creando<br />
invece un notevole squilibrio nelle interpretazioni. È anche da questo punto di vista che va affrontata o<br />
riaffrontata tutta la tematica critica del ‘Pasolini profeta’.<br />
Carlo Sgorlon si è accostato, a mio avviso, con grande equilibrio, prudenza e saggezza a questo<br />
ordine di problemi. Indubbiamente negli ultimi anni della vita di Pasolini prevale una curvatura cupa,<br />
una considerazione opprimente dell’universo orrendo. Da questa angolazione la drammatica riscrittura<br />
distruttiva (e autodistruttiva) delle poesie friulane de La meglio gioventù 12 assume certo un valore<br />
testamentario. E se Pasolini aveva sicuramente colto, anche in termini antropologici, tutti i segnali del<br />
degrado della realtà italiana, bisogna riconoscere parallelamente che anche lui era cambiato.<br />
La discussione ritorna dunque nei termini e nei caratteri della ‘profezia’ di Pasolini. Giustamente<br />
Sgorlon constata che a Pasolini si attribuiscono con grande superficialità troppe cose, estrapolando<br />
scorrettamente una frase o una battuta da un’opera ‘totale’, magmatica, aggrovigliata, contraddittoria.<br />
Il narratore friulano contesta, ad esempio, l’unilateralità della denuncia pasoliniana contro il Palazzo.<br />
Qui, a mio avviso, invece Pasolini colpisce proprio nel segno con l’individuazione di una parola/concetto<br />
(Palazzo), che non a caso è diventata parte di un lessico e di un comune sentire negli anni e nei decenni<br />
successivi. Lo scrittore infatti colpiva la separatezza di una zona della società italiana, quella che oggi<br />
si chiamerebbe, più o meno propriamente e correttamente, ‘la casta’. E non è, a mio parere, possibile<br />
pensare a un Pasolini che metta sotto accusa tutte le forze politiche in un alone qualunquistico, senza<br />
sottolineare le precise e concrete responsabilità di chi sta al governo e al potere.<br />
Pur con accenti critici Sgorlon individua nell’estremismo una delle caratteristiche della personalità<br />
di Pasolini: da questo punto di vista sappiamo quale legame fortissimo ci sia in lui tra edonismo<br />
linguistico, narcisismo, disperata vitalità, populismo. Sgorlon rileva la contraddizione tra l’aver detto e<br />
fatto tutto e la qualifica di ‘profeta’: “Il profeta infatti solitamente fa e dice una cosa soltanto, e tutte le<br />
altre sono sempre compatibili con essa. Percorre una strada sola, non dieci, che vanno in tutte le direzioni<br />
della rosa dei venti.” 13 Io credo che questo equivoco nasca proprio dall’effetto di riverbero dell’ultimo<br />
Pasolini sulle fasi precedenti del suo iter culturale, ideologico e artistico, come già si diceva. Non<br />
è un caso che molto spesso negli interventi di Sgorlon l’attenzione si sposti sulla critica, sugli interpreti<br />
di Pasolini. Il narratore friulano, con grande attenzione e obiettività, riconosce il valore di alcune opere<br />
10 id., Nel caos dell’inquietudine, cit.<br />
11 Poiché (come è noto) con i ‘se’ si fa davvero la Storia, immaginiamoci per un attimo ‘virtualmente’ un Pasolini che si spegne<br />
a poco a poco nella serena vecchiaia e abbandona progressivamente piano piano la sua attività artistica. L’immagine<br />
complessiva dello scrittore sarebbe stata tutta diversa.<br />
12 Pier Paolo PaSolini, La nuova gioventù, Torino, Einaudi, 1995.<br />
13 Carlo Sgorlon, Pasolini, un’autorità di profeta? , cit.
di Pasolini, ma non è disposto a fare di ogni erba un fascio: l’arte di distinguere è la facoltà fondamentale<br />
di chi si cimenta nella critica letteraria. Da questo punto di vista Sgorlon non ha tutti i torti, perché<br />
fra alcuni settori della critica (soprattutto nel ‘blocco’ degli amici di Pasolini) spesso si è inteso proporre<br />
un’accettazione globale, entusiasta e indiscriminata.<br />
I percorsi ideologici e gli esiti stilistici sono molto diversi: indubbiamente, per fare un esempio,<br />
dopo Poesia in forma di rosa si assiste a un progressiva immissione nei versi pasoliniani di contenuti e<br />
impostazioni ‘prosastiche’. Non si tratta naturalmente di respingere in blocco determinate opere o una<br />
particolare fase dell’iter di Pasolini: ma al contrario di cogliere il contesto complessivo dell’evoluzione<br />
di Pasolini e di studiarne la dinamica interna. Esiste una questione di punti d’equilibrio dell’opera ed è<br />
indubbio che la progressiva e totalizzante inclinazione verso il cinema abbia spostato in modo netto il<br />
baricentro dell’opera dello scrittore, anche sul versante saggistico.<br />
Sgorlon ha poi più volte notato un eccesso di analisi critiche dedicate a Pasolini, perché, a<br />
suo dire, la notorietà dello scrittore proietterebbe i critici su un palcoscenico mediatico internazionale.<br />
Sgorlon cita maliziosamente il libro di Dario Bellezza («buon poeta, mediocre narratore») La morte<br />
di Pasolini 14 e aggiunge: “Bellezza in Europa è pressoché uno sconosciuto, ma il suo volume ha avuto<br />
ben dodici traduzioni.” 15 In realtà il lavoro di Bellezza appartiene alla cerchia/conventicola degli amici<br />
di Pasolini e vuole proporre una originale interpretazione della drammatica morte del poeta, all’interno<br />
di un contesto di corretto approfondimento dei fatti. Sgorlon si rammarica invece perché, rispetto alla<br />
grande e per lui abnorme attenzione per Pasolini, ci sia ancora scarsa attenzione per due autorevoli e<br />
prestigiosi narratori come Elsa Morante e Stefano D’Arrigo.<br />
Credo che qui il problema vada scomposto: da una parte indubbiamente la critica ha dedicato<br />
una grande attenzione all’opera di Pasolini, anche quando lo scrittore era in vita: basti ricordare i due<br />
ampi e organici lavori di Gian Carlo Ferretti e di Alberto Asor Rosa. 16 Il singolare intreccio di passione<br />
e di ideologia, di poetica e di stile ha certo favorito le letture e gli scavi. Le circostanze della morte e il<br />
permanere e il consolidarsi dell’immagine di un Pasolini ‘intellettuale del dissenso’ hanno poi favorito<br />
indubbiamente il proliferare degli studi. Ma, come giustamente osservava Luciano Morandini, 17 anche<br />
il proliferare è segno di una reale e concreta vitalità ed attualità dell’autore. Il caso invece di Elsa Morante<br />
e soprattutto di Stefano D’Arrigo si configura come un topos per chi si occupa di letteratura italiana<br />
del Novecento: la tabula presentiae et absentiae punteggia un po’ l’iter e le scale di valori della<br />
letteratura contemporanea. Le ragioni degli scompensi e delle sproporzioni sono naturalmente le più<br />
diverse: nella nozione ‘latineggiante’ e ambivalente di fortuna sono nascoste le casistiche più singolari<br />
e sfuggenti. 18<br />
Se il giudizio complessivo di Sgorlon sulla critica pasoliniana è tendenzialmente negativo, si<br />
salvano invece interpreti come Enzo Siciliano, Andrea Zanzotto e Nico Naldini. 19 Di grande interesse<br />
appare la recensione che Sgorlon dedica alla Vita di Pasolini scritta da Siciliano: 20 il narratore friulano<br />
sottolinea come sagacemente Siciliano abbia evitato la tentazione del ‘romanzesco’, proponendoci una<br />
14 dario Bellezza, Morte di Pasolini, Milano, Mondadori, 1981.<br />
15 Carlo Sgorlon, Pasolini è a pezzi e dappertutto, cit.<br />
16 gian Carlo ferretti, Letteratura e ideologia, Roma, Editori Riuniti, 1964, e alBerto aSor roSa, Scrittori e popolo, Roma, Samonà<br />
e Savelli, 1965.<br />
17 luCiano morandini, Sete inesausta di conoscenza, in «Messaggero Veneto», 23 ottobre 1993.<br />
18 Anche il caso di Cesare Pavese, polemicamente sottolineato da Sgorlon, ricade a mio avviso in quest’ambito: cfr. Carlo<br />
Sgorlon, Pasolini e il pasolinismo, cit.<br />
19 Cfr. in particolare Carlo Sgorlon, Pier Paolo era anche friulano, cit.<br />
20 enzo SiCiliano, Vita di Pasolini, Milano, Rizzoli 1978.<br />
57
58<br />
ricognizione dell’universo pasoliniano “rigorosa e tagliente come un commentario di Cesare.” Siciliano<br />
si accosta al magma pasoliniano “con razionalità illuministica, marxista e freudiana,” che riesce ad<br />
esaminare lucidamente ogni piega, ogni sequenza, ogni contraddizione. Enzo Siciliano presenta inoltre<br />
una serie di testi (al tempo inediti) che completano ed arricchiscono il profilo dello scrittore. Sgorlon,<br />
lungo la linea di una sua esplicita e motivata preferenza, privilegia la ricostruzione della stagione friulana<br />
di Pasolini, incentrata su un cristianesimo “che era, in sostanza, sentimento della sacralità della<br />
vita, della corporeità, dell’eros, santificati dalla caritas, da un’affettuosa gentilezza e pietà per ogni vivente,<br />
e una profonda partecipazione al dolore universale e al ‘male di vivere’.” 21 Anche nella sua fase<br />
‘corsara’ Pasolini resterà in qualche modo fedele al Friuli, al suo Eden perduto.<br />
Uno degli interventi più fini ed efficaci che Sgorlon ha dedicato alla figura e all’opera di Pasolini<br />
è certo Una mater dolorosa. 22 In quelle pagine Sgorlon fa emergere tutte le sue doti di scrittura e di<br />
costruzione narrativa. Rileggiamo l’incipit:<br />
In un tranquillo pensionato per anziani, a <strong>Udine</strong>, v’è una signora di quasi novant’anni, alla quale<br />
mi accade ogni tanto di pensare. Com’è destino di molti vecchi che vivono oltre la misura consueta, ella<br />
ha quasi tutti i suoi cari sottoterra. Ma la sorte con lei è stata particolarmente crudele. Sotto le lapidi<br />
del cimitero di Casarsa, infatti, non sono soltanto i parenti e gli amici della sua generazione, ma anche<br />
i suoi due figli. E, ciò che è ancora più tremendo, essi non le sono stati portati via da una morte naturale,<br />
cui si china il capo con maggiore rassegnazione perché appartiene all’ordine di cose che ci sovrasta,<br />
e cui diamo il nome generico di destino o di Dio. Sono stati, ambedue, barbaramente assassinati dagli<br />
uomini, e la signora è una mater dolorosa. 23<br />
Sgorlon ripercorre il lungo e travagliato iter della vita di Susanna Colussi, la madre di Pasolini,<br />
cogliendone con acutezza ed efficacia il carattere, la psicologia, la personalità. Su un’esistenza che<br />
poteva essere aperta e serena incombe l’ombra di Atropos. La drammatica morte del figlio Guido, ucciso<br />
a Porzûs in un complesso episodio che ha drammaticamente marcato il percorso e l’immagine della<br />
Resistenza in Friuli, segna in modo indelebile i giorni e gli anni di Susanna. Da questo momento essa<br />
incarna per sempre la figura, carica di risonanze, della mater dolorosa. Il difficile rapporto con il marito<br />
Carlo “autoritario, militaresco, non immune da una certa alterigia comitale” 24 segna lo scorrere del<br />
tempo. Sotto il segno di Edipo matura il rapporto con Pier Paolo, legato a lei da “una intesa istintiva,<br />
profondissima, un corto circuito sentimentale in cui si è cercata la radice della diversità pasoliniana.” 25<br />
L’ombra di Atropos e l’ombra di Edipo assumono così un significato e delle risonanze particolari nella<br />
stessa scelta esistenziale di Pasolini regista di far interpretare proprio alla madre il ruolo della Madonna<br />
ai piedi della croce ne Il Vangelo secondo Matteo, anche all’interno di un gioco ricorrente di<br />
identificazione con la figura del Cristo perseguitato, che si fa carico di tutti i peccati del mondo, in una<br />
tesa contaminazione tra sacro e profano. Ha scritto Carlo Sgorlon: “Così Susanna, la donna ilare, fan-<br />
21 Carlo Sgorlon , Un monumento per Pier Paolo, cit.<br />
22 id., Una mater dolorosa, cit.<br />
23 Ibidem.<br />
24 Ibidem.<br />
25 Ibidem. Pasolini ha più volte sottolineato, in dichiarazioni, confessioni e interviste, questo rapporto con la madre. Credo che<br />
raramente uno schema freudiano possa applicarsi con tale linearità e pertinenza. Questa interpretazione di fondo, ribadita<br />
anche da Sgorlon, resta pienamente valida e convincente, anche in presenza di una sorta di ‘correzione di tiro’ da parte dello<br />
stesso Pasolini in alcune interviste: cfr. Pier Paolo PaSolini, Il sogno del centauro, a cura di J. Duflot, Roma, Editori Riuniti, 1983,<br />
in particolare p. 19-25; Pasolini su Pasolini. Conversazioni con J. Halliday, Parma, Guanda, 1992, p.27-30.
tasiosa, ironica, un tantino narcisista, diventò una madre tragica, una figura da teatro greco o da lauda<br />
jacoponica.” 26 Nell’attaccamento profondo e nell’intesa perfetta e complice con il figlio Pier Paolo scorrono<br />
le stagioni della vita della mater dolorosa, fino alla drammatica morte del 2 novembre 1975. Con<br />
riconosciuta abilità di narratore Sgorlon si sofferma sulla condizione di Susanna, forse non più lucida<br />
al momento dell’uccisione di Pier Paolo. Prevale la cortina di nebbia, vince il mistero: ma l’oscurità può<br />
essere impietosamente squarciata dal lampo del presagio o dell’intuizione. 27<br />
Nella folta schiera degli interpreti di Pasolini un discorso a parte va fatto per le organiche e<br />
originali analisi del pittore Giuseppe Zigaina. Anche Sgorlon si sofferma con attenzione e interesse sui<br />
libri di Zigaina. Come è noto, il pittore Giuseppe Zigaina, legato da una antica e profonda amicizia (che<br />
data 1946) a Pasolini, è rimasto, come molti, traumatizzato dalla tragica morte dello scrittore a Ostia;<br />
anche sulla base di quell’emozione/trauma ne rilegge e rianalizza le opere, avviando un processo di<br />
reinterpretazione globale. Zigaina si è progressivamente convinto di aver scoperto da solo la chiave<br />
unica per comprendere tutto Pasolini, la vita, le poesie, il teatro, i romanzi, i quadri, i disegni, i saggi, i<br />
film. L’opera (e la vita) dell’autore vengono così abbracciate sincronicamente come un tutto unico che<br />
non ammette sfumature, contraddizioni, regressioni, trasformazioni, fughe in avanti, ripetizioni. Zigaina<br />
respinge drasticamente e perentoriamente il profilo generale di un Pasolini “bestia da stile”, 28 scalzando<br />
con violenza l’essenziale componente ‘sperimentale’ del lavoro di Pasolini (pensiamo a tutte le persuasive<br />
analisi critiche che parlano di sperimentalismo, neo-sperimentalismo, ecc., anche con concreti<br />
riferimenti a tendenze e a un generale clima culturale e letterario). Zigaina non ammette una diacronia<br />
di qualunque genere nei testi e nelle opere dell’autore: tout se tient e il pittore ha l’unica chiave in mano<br />
per spiegare e capire tutto.<br />
Colpisce il fatto che Zigaina rifiuti aprioristicamente e sdegnosamente il dialogo con la critica<br />
pasoliniana: e dire che gli interpreti hanno lavorato con metodo, rigore e acutezza, anche quando<br />
Pasolini era in vita. Lo scrittore è certo uno degli autori più analizzati e studiati del nostro Novecento<br />
letterario e registra un impegno eccezionale anche da parte di lettori e critici stranieri. Ma, sembra dire<br />
Zigaina, nessuno ha capito niente. In un quadro generale di sostanziale sopravvalutazione di alcune<br />
opere (Empirismo eretico, il teatro), Zigaina ci propone di volta in volta il ritratto di un Pasolini alchimista,<br />
mago, profeta, che ha scientemente ‘costruito’ la propria morte (il “nulla lucente”) come un montaggio,<br />
che dà significato autentico alla vita (e naturalmente all’opera).<br />
Carlo Sgorlon è intervenuto con prudenza ed equilibrio sui saggi di Zigaina. Il primo intervento<br />
del narratore friulano è incentrato su un’ampia e articolata recensione al volume di Zigaina Pasolini e<br />
26 Carlo Sgorlon, Una mater dolorosa, cit.<br />
27 Molto significativo è questo episodio raccontato da Sgorlon: “Una volta una sua pronipote, Graziella Chiarcossi, che per anni<br />
fece da segretaria a Pier Paolo, la condusse in campagna con l’auto nelle vicinanze di <strong>Udine</strong>. Era il tramonto. Era uno di quei<br />
tramonti in cui il sole discende in un mare di nuvole tragiche e disfatte; uno di quei tramonti che paiono incendi apocalittici,<br />
sfaceli cosmici in cui tutto l’occidente si consuma. Susanna guardò. Qualcosa si mosse dentro di lei. Il suo buio interiore<br />
fu attraversato dal guizzo livido di un fulmine. Si spaventò, gridò, alzò le braccia come a difendersi da un pericolo. La sua<br />
coscienza tragica si era risvegliata di colpo” (Ibidem).<br />
28 La definizione di “bestia da stile” rimanda naturalmente al dramma omonimo, pubblicato postumo nel 1979 (Pier Paolo<br />
PaSolini, Porcile, Orgia, Bestia da stile, con una nota di Aurelio Roncaglia, Milano, Garzanti, 1979). Sulle tre stesure del testo<br />
cfr. Pier Paolo PaSolini, Teatro, a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, Milano, Mondadori, 2001, p. 1195-1200. In quest’ultimo<br />
volume, nelle Note e notizie sui testi, leggiamo: “Il punto di svolta, per quel che riguarda il titolo, può essere fissato in una<br />
conversazione che Pasolini tenne con Adriano Aprà e Luigi Faccini nel dicembre 1966, pubblicata come Dialogo I su ‘Cinema<br />
e film’, a I, n.1, inverno 1966-1967 (poi, con modifiche, in Empirismo eretico): in essa, ai due che ipotizzano che le sue teorie<br />
cinematografiche siano legate alla sua poetica, a un certo punto Pasolini risponde: «Voi siete matti. È molto spiacevole,<br />
sapete, per un autore, sentirsi sempre considerare come una ‘bestia da stile’.» ” (Pier Paolo PaSolini, Teatro, cit., p. 1200).<br />
59
60<br />
la morte. 29 Sgorlon, dopo aver registrato il giudizio implicito del pittore sul valore e sulla grandezza incontestabili<br />
di Pasolini, ci delinea l’efficacissima immagine dell’opera di Pasolini, sterminata, contraddittoria,<br />
affascinante come “un labirinto pronto a inghiottirci”. Zigaina sarebbe uno dei pochi in grado<br />
di muoversi all’interno del labirinto con un valido filo di Arianna. Secondo Zigaina, già a partire dalla<br />
metà degli anni ’50, Pasolini ‘costruisce’ la strada che porta alla scelta della propria morte, seguendo<br />
vie “allusive, criptiche, iniziatiche, alchemiche, mitiche, religiose”.<br />
In Zigaina l’allineamento di prove, tracce, indizi secondo Sgorlon è lucidissima, ma spesso inverificabile:<br />
il pittore ci propone una mappa che deve essere accettata in blocco. Se un tassello non tiene,<br />
Zigaina lo allontana attraverso il metodo dell’ambivalenza o della rimozione. 30 Il filo della ricerca e della<br />
narrazione di Zigaina consiste in un sapiente gioco di specchi: dalla sua angolazione di lettura, Pasolini<br />
spesso senza sfumature, senza distanze, ‘incarna’ i suoi personaggi; proprio il fervore di aperta, nuova<br />
e inquieta ricerca linguistico-stilistica di Pasolini in questo modo viene obliterato, seguendo invece i<br />
rigidi parametri di un mosaico già predisposto. Zigaina costruisce, basandosi su estrapolazioni o forzature,<br />
il ritratto pur suggestivo di un Pasolini alchimista e profeta. Al centro della riflessione di Zigaina la<br />
considerazione quasi mitica di una semiologia applicata direttamente alla realtà. I saggi di Empirismo<br />
eretico dedicati al cinema non vanno, secondo me, assolutizzati (come fa invece Zigaina) ma ricondotti<br />
a un preciso contesto e a una concreta prospettiva, che è quella di un Pasolini che, con la passione e la<br />
tensione del neofita, ‘scopre’ un nuovo linguaggio e un nuovo mondo e vuole saggiarne i significati, la<br />
consistenza, i temi e i limiti. Ma, come altre volte, Pasolini travolge le riflessioni passate e gli studiosi<br />
della tradizione con il fervore (a tratti ingenuo) del neofita. 31<br />
Certamente l’ipotesi e il fantasma di una semiologia totale della realtà, come impostata e in<br />
parte attuata da Zigaina, ripropone in qualche modo l’eterna questione del rapporto tra vita e opera.<br />
Osserva Sgorlon, analizzando il libro di Zigaina:<br />
Soltanto attraverso il sacrificio il profeta acquista totale credibilità, e s’inserisce stabilmente<br />
nella coscienza collettiva. Pasolini dunque cercò il martirio. Non voleva morire né di morte naturale, né<br />
di suicidio, perché ciò l’avrebbe condotto o all’accettazione casuale delle cose, o allo svuotamento di<br />
tutta la sua azione vitale. Provocò invece il proprio assassinio vivendo costantemente ‘sulla linea del<br />
fuoco’. Chi cerca la morte finisce per trovarla. 32<br />
Sgorlon, alla fine dell’articolo, si chiede per quale ragione Pasolini avrebbe scientemente costruito<br />
il ‘mito’ della sua morte:<br />
Per la glorificazione di se stesso? O per testimoniare, in qualche modo, la sacralità della vita,<br />
che la società irreligiosa del nostro tempo ha dissolto dentro di sé, con la conseguenza di distruggerla<br />
anche nei suoi rapporti con l’universo? 33<br />
Zigaina farebbe balenare entrambe le ipotesi, mentre Sgorlon, per ragioni di affinità elettive,<br />
per il ruolo del mito e degli archetipi e per la circolarità del tempo, propende nettamente per la seconda<br />
29 giuSePPe zigaina, Pasolini e la morte, Venezia, Marsilio, 1987, poi in ID, Hostia, Venezia, Marsilio, 1995, p.11-99.<br />
30 Sintomatico è il caso del modo con cui Zigaina affronta il rapporto tra Pasolini e Eliade: cfr. giuSePPe zigaina, Hostia, cit., p.<br />
51-53.<br />
31 Si veda, ad esempio, tutta la polemica con Umberto Eco: cfr. Pier Paolo PaSolini, Il codice dei codici, in ID. Empirismo eretico,<br />
Milano, Garzanti, 1972, p.281-288.<br />
32 Carlo Sgorlon, Pasolini, il labirinto, cit.<br />
33 Ibidem.
ipotesi. Si tratta di uno spunto molto interessante che apre una sorta di ‘passerella’ tra i due opposti<br />
mondi di Sgorlon e di Pasolini, proprio nel segno del mito.<br />
Sgorlon torna alcuni mesi dopo sulle interpretazioni di Zigaina, in occasione della pubblicazione<br />
del nuovo volume Pasolini tra enigma e profezia. 34 Come chiarito preliminarmente, Sgorlon nell’intervento<br />
questa volta dà meno credito alle tesi di Zigaina, anche perché di fatto esse costituiscono una<br />
oltranzistica e secca riproposizione delle vecchie argomentazioni. E giustamente Sgorlon coglie nelle<br />
risentite e assolutistiche pagine del pittore una certa asprezza nei confronti di alcuni critici pasoliniani,<br />
restii ad accettare in toto le formulazioni dello stesso Zigaina. Sgorlon correttamente rileva che l’opera<br />
di Pasolini deve essere considerata nel quadro complessivo della letteratura italiana del Novecento;<br />
da questo punto di vista Pasolini è un “artista tra molti”, che deve essere affrontato serenamente e attentamente<br />
con i tradizionali ferri del mestiere del critico: non può ricevere un trattamento privilegiato,<br />
quasi si trattasse di un unicum.<br />
A ragione Sgorlon coglie le motivazioni personali e autobiografiche di Zigaina che condizionano<br />
le sue ricerche, con la ferrea convinzione di aver scoperto “la vera chiave per leggere Pasolini”. Il narratore<br />
friulano parla del libro di Zigaina come di un “giallo interpretativo”, in cui però le dimostrazioni<br />
“sono tanto suggestive quanto, in pari tempo, soggettive.” 35 I tasselli e le tracce proposti da Zigaina<br />
sono spesso affascinanti ma inverificabili: Sgorlon, pur riconoscendo l’abilità straordinaria del pittore,<br />
osserva che il grande quadro (per la sua intima fragilità) somiglia alla “costruzione di un castello di<br />
carte.” 36 Sgorlon propone allora un’osservazione molto interessante. Pasolini, secondo una dichiarazione,<br />
avrebbe manifestato ‘fastidio’ (o malessere) per il fatto che dopo la sua morte gli uomini, la storia,<br />
la vita avrebbero tranquillamente continuato ad esserci. Questa osservazione ricorda un passo di alto<br />
valore tematico, psicologico e strategico del romanzo di Ferdinando Camon Occidente (1975). Sono di<br />
fronte Franco, il leader della Cellula Nera e lo psicoanalista:<br />
«Ecco, è questo il mio problema. Io... non riesco a sopportare di morire... naturalmente. Voglio dire<br />
che la morte naturale, mia o degli altri... ma mia specialmente, mi è intollerabile. Non riesco a rassegnarmi<br />
all’idea della morte... del mio corpo morto... fermo... mentre tutti gli altri vivono, e si muovono.»<br />
«Mi precisi bene questa idea... anche se le è doloroso,» aggiunse questa riserva perché in verità<br />
adesso Franco aveva ripreso ad agitarsi torcendosi le mani o coprendosi la bocca con la mano destra,<br />
sicché parlava come nascosto; in certi momenti, sembrava sul punto di alzarsi e camminare, come<br />
se l’immobilità del proprio corpo gli fosse insopportabile come un’improvvisa paralisi. «Cioè mi dica, se<br />
lo sa... giacché mi pare che lei abbia pensato a queste cose più di cento volte al giorno... qual è il peso<br />
che non regge, del dopo-morte... l’idea che gli altri – il mondo insomma – vivranno ancora?»<br />
«No, non il mondo... il mondo no. Voglio dire che sparire, così... essere calato... dentro un mondo<br />
che vive, mi è piacevole. Riesco a pensarci, vede, senza che il pensiero balzi indietro. Ma gli uomini...<br />
anche gli uomini, che vivano, mi fa piacere... mi commuove. Ma che facciano qualcosa... questo<br />
no, questo è assurdo.»<br />
«Quali cose, per esempio?»<br />
«Che comprino i giornali, ecco. Che i giornali abbiano la data del giorno successivo a quello<br />
della mia morte. Che tutto ciò che ci sarà scritto, sarà sempre ignoto a me. I giornali, da quel giorno, e<br />
34 giuSePPe zigaina, Pasolini tra enigma e profezia, Venezia, Marsilio, 1989.<br />
35 Carlo Sgorlon, Pasolini è a pezzi (e dappertutto), cit.<br />
36 Ibidem.<br />
61
62<br />
per tutti i giorni dell’avvenire, parleranno di infinite avventure, sempre diverse... e non di me. Quando<br />
leggo i giornali, in questo tempo in cui sono vivo, in un certo senso leggo di me. In un certo senso parlano<br />
di me...» 37<br />
Secondo Sgorlon, la frase di Pasolini, riguardante il ‘malessere’ per tutto quello che sarebbe<br />
accaduto dopo la sua morte, distrugge tutta la costruzione di Zigaina. Giustamente il narratore friulano<br />
osserva che nessuna frase di Pasolini (le famose ‘tracce’ disegnate da Zigaina) andrebbe assolutizzata<br />
e ritagliata dal contesto. Bisogna riconoscere margini di irregolarità e di contraddizione, inversioni di<br />
tendenza, mutamenti di opinione, oscillazioni. Questa, a mio avviso, è la ‘realtà’ dell’opera di Pasolini,<br />
questo è il suo ‘sapore’ autentico, il suo fascino.<br />
È così vano e controproducente ogni pur abile tentativo di reductio ad unum. Certamente il fantasma<br />
o la prefigurazione del “giorno della propria morte” è presente in Pasolini: ma questo fa parte<br />
della sua fondamentale tematica della ‘disperata vitalità’, come più volte è stato rilevato. Da questo<br />
punto di vista non enfatizzerei o assolutizzerei nemmeno il testo de Il dí de la me muart, 38 che va inserito<br />
nel quadro degli anni friulani dell’autore, senza fughe in avanti. Naturalmente nessuno nega l’incupirsi,<br />
anche ‘antropologico’ di Pasolini, ma questo fenomeno non va retrodatato addirittura alla metà<br />
degli anni ’50, come vorrebbe Zigaina. Del resto per cogliere la corposa dialettica presente nell’opera<br />
di Pasolini basterebbe pensare alla relazione fra la ‘Trilogia della vita ’ (i film Decameron, I racconti di<br />
Canterbury, Il fiore delle Mille e una notte) e l’Abiura dalla Trilogia della vita: 39 sono le due facce di Pasolini.<br />
Rispetto alla figura di Zigaina come “critico detective”, Sgorlon esprime, alla fine del suo articolo,<br />
la preferenza verso un modello ben presente nel Novecento letterario, il critico-narratore (e Sgorlon<br />
allinea significativamente i nomi di Sainte Beuve, Cecchi, Debenedetti e Citati). “In tal modo – scrive<br />
il narratore friulano – le sue tesi avrebbero acquistato, per così dire, un valore autonomo, indipendentemente<br />
dalla loro verità.” 40 E aggiunge, a conclusione del suo intervento questo saggio e illuminante<br />
aneddoto:<br />
Ricordo ancora con entusiasmo un libro di Daniel Rops su Kafka, che lessi quando preparavo la<br />
mia tesi di laurea, nel ’51. Non utilizzai neppure una delle affermazioni di Rops, perché non mi convincevano.<br />
Rops voleva spingere a forza Kafka dentro una chiesa cristiana, come Brod dentro la sinagoga.<br />
Ma che libro affascinante! 41<br />
L’attenzione di Sgorlon torna sulle tesi di Zigaina e sulla morte di Pasolini il 21 giugno 1995.<br />
Nell’articolo Quel teorema fascista il narratore friulano rievoca il trauma seguito alla notizia della terribile<br />
morte di Pasolini, per mano di un ragazzo che sembrava uscito dalle pagine dei romanzi romani.<br />
37 ferdinando Camon, Occidente, Milano, Garzanti, 1975, p.178-179; e cfr. anche giamPaolo BorgHello, Linea rossa, Venezia,<br />
Marsilio, 1982, p.180-187, in part. p.183.<br />
38 La poesia fu pubblicata per la prima volta sulla rivista «Botteghe Oscure», novembre 1950; poi in Pier Paolo PaSolini, La meglio<br />
gioventù, Firenze, Sansoni, 1974, p.71; in seguito cfr. anche ID., La nuova gioventù, cit., p.65.<br />
39 Pier Paolo PaSolini, Abiura dalla Trilogia della vita, in «Corriere della sera», 9 novembre 1975 (con il titolo Ho abiurato la<br />
‘Trilogia della vita’ ); il testo, pubblicato postumo, risulta scritto il 15 giugno 1975. L’Abiura figura in seguito come Introduzione<br />
al volume Trilogia della vita (Bologna, Cappelli, 1975), che raccoglie le sceneggiature dei film Decameron, I racconti di<br />
Canterbury, Il fiore delle Mille e una notte, trascritte da Giorgio Gattei. L’Abiura si legge poi in Pier Paolo PaSolini, Lettere<br />
luterane, Torino, Einaudi, 1976, p.71-76.<br />
40 Carlo Sgorlon, Pasolini è a pezzi (e dappertutto), cit.<br />
41 Ibidem.
Zigaina in particolare, traumatizzato dall’evento, da lì inizia quel processo di reinterpretazione globale<br />
della vita e dell’opera di Pasolini.<br />
Come valutare e interpretare la morte di Pasolini? Da una parte Zigaina, ricostruendo minuziosamente<br />
tutte le occasioni e i tasselli in cui lo scrittore prepara, disegna e ‘costruisce’ la propria fine, di<br />
fatto propone “l’apoteosi più suggestiva e ricca di risonanze; la più adatta a trasformare la vita, l’opera<br />
e la morte di Pasolini in un mito destinato a durare.” 42 L’apoteosi, in realtà, come aveva già rilevato in<br />
passato Sgorlon, è fondata (al di là delle suggestioni) su “un castello di carte.” Contro questa ipotesi<br />
‘mitica’ si vien delineando a sinistra una sorta di ‘teorema’ che attribuisce l’uccisione dello scrittore a<br />
un complotto fascista. Ancora una volta, come spesso nella storia, l’opinione pubblica si divide faziosamente<br />
in due. Quasi paradossalmente gli amici più stretti di Pasolini (Moravia, Siciliano, Dario Bellezza,<br />
la Maraini, Camon) non accettano la tesi ‘politica’ del complotto fascista. Sgorlon propone una<br />
contrapposizione tra destra e fascismo, cultura della destra e ideologia fascista, per ricondurre in un<br />
alveo storicamente ragionevole sospetti, ipotesi, deduzioni. Da questo punto di vista l’uccisione dello<br />
scrittore resta, anche ma non solo, un fatto di cronaca nera.<br />
Rimane la drammatica e traumatica realtà della morte di Pasolini, un episodio che in qualche<br />
modo lo stesso Sgorlon riconosce di voler dimenticare (o rimuovere) e che invece viene quasi ossessivamente<br />
riproposto. È un episodio in cui si scaricano tutte le tensioni, le inquietudini, i sensi di colpa, le<br />
contraddizioni della cultura e della società italiane. Verrebbe fatto di pensare, si parva licet componere<br />
magnis, al sequestro e all’uccisione di Aldo Moro. Le piccole e grandi domande sulla morte di Pasolini<br />
riguardano e coinvolgono non a caso i temi della violenza, del fascismo, dell’omosessualità, della ‘disperata<br />
vitalità’, del fato. Anche questo continuo e ossessivo riproporsi dello scenario del campetto di<br />
Ostia è storicisticamente il sintomo di un costante malessere, di una profonda inquietudine.<br />
Da questa angolazione affronterei la già accennata questione del profetismo. Il tema è affrontato<br />
in modo lucido e attento da Sgorlon in due articoli del 1993, cui segue, dopo l’accendersi di un<br />
vasto dibattito in Friuli, un terzo intervento di bilancio. Rispetto a un atteggiamento complessivo della<br />
critica che deborda da ogni lato, il narratore friulano sottolinea l’importanza della misura. E come significativo<br />
segnale di un metodo, Sgorlon a buon diritto rivendica il merito di aver parlato di Pasolini (analizzando<br />
soprattutto il romanzo giovanile Il sogno di una cosa) nel 1967, quando in Friuli vigeva ancora<br />
una sorta di ostracismo. 43 Sgorlon riconosce e sottolinea la grandezza dell’autore in tutta una serie di<br />
opere ma vuole, come è suo diritto, distinguere senza cadere nel vortice dell’apologetica. Il narratore<br />
42 Carlo Sgorlon, Quel teorema fascista, cit.<br />
43 Dal 9 al 13 settembre 1967 si tenne a Gorizia, per gli Incontri <strong>Cultura</strong>li Mitteleuropei, un significativo Convegno (organizzato<br />
dalla rivista «Iniziativa Isontina») sul tema La narrativa, oggi: vi parteciparono nutrite delegazioni di scrittori e critici<br />
provenienti dall’Austria, dalla Cecoslovacchia, dalla Germania, dalla Jugoslavia, dall’Ungheria e naturalmente dall’Italia.<br />
Eravamo nel 1967 e si trattava di aprire serenamente e costruttivamente un concreto dialogo tra intellettuali dell’Est e<br />
dell’Ovest. In questo contesto fu affidato a Carlo Sgorlon l’impegnativo compito di tenere una relazione su La narrativa in<br />
Friuli nel secondo dopoguerra (cfr. La narrativa, oggi. Atti, Gorizia, ICM 1968, p. 71-80). Il suo intervento, lucido, approfondito<br />
e circostanziato, aveva in quel momento un carattere quasi pionieristico, poiché si trattava di trarre un primo bilancio delle<br />
tendenze della narrativa in Friuli, anche a confronto con altre più mature e più consolidate esperienze (basti pensare alla<br />
letteratura triestina). In tale occasione Sgorlon aveva assegnato il giusto rilievo al romanzo friulano di Pasolini Il sogno di una<br />
cosa (scritto negli anni 1948-1950 e pubblicato solo nel 1962; cfr. ora Pier Paolo PaSolini, Il sogno di una cosa, Milano, Garzanti<br />
1962: sulle stesure del testo cfr. in particolare gian Carlo ferretti, Letteratura e ideologia, cit., p.194, nota 2). Sgorlon aveva<br />
messo in luce le differenze e le analogie tra quel testo e i più noti romanzi romani, ponendo l’accento sulla vocazione dello<br />
scrittore a rappresentare i caratteri e la totalità di un milieu. L’intervento di Sgorlon, acuto e pertinente, affrontava in modo<br />
aperto e costruttivo Il sogno di una cosa e gli altri romanzi, senza pregiudizi di nessun genere, superando d’un balzo quella<br />
sorta di ‘ostracismo silenzioso’ nei confronti di Pasolini che in qualche modo percorreva allora la cultura friulana.<br />
63
64<br />
friulano prende così nettamente le distanze (come fa altre volte) da Teorema, di cui sottolinea il carattere<br />
rigidamente e vetustamente classista. Ma io credo che l’angolazione da cui affrontare questa<br />
complessa opera (film e libro) sia quella stilistica: Pasolini voleva presentare proprio un ‘teorema’, teso<br />
e schematico, stilisticamente e culturalmente diverso da molte sue opere precedenti. Anche il discorso<br />
sul marxismo di Pasolini dovrebbe tener conto del lungo, tortuoso e a volte contraddittorio iter del suo<br />
populismo. Sgorlon, dopo aver stigmatizzato l’esibizione dell’omosessualità in Pasolini, individua un fenomeno<br />
di totale perdita della misura e dell’autocontrollo che segna gli ultimi anni dell’attività dello<br />
scrittore: anche in questo quadro credo che si palesi un fenomeno reale, su cui si sono efficacemente<br />
soffermati altri interpreti. 44<br />
In questo contesto e rispetto a questi parametri si presenta la questione del ‘profetismo’, tema<br />
delicato, sottile e (a mio avviso) distorcente. La questione sembra riguardare gli interpreti di Pasolini<br />
(più che l’autore stesso), che hanno spesso, volutamente o ambiguamente, enfatizzato un aspetto dello<br />
scrittore, estrapolando a forza una frase o un’osservazione dalla sua sterminata, magmatica e contraddittoria<br />
opera. Attraverso quest’operazione, metodologicamente scorretta, si creano allora le immagini<br />
‘mediatiche’ di un Pasolini “mago, alchimista, santo, profeta.” Il problema è dunque quello di un approccio<br />
critico che inserisca anche la figura e l’opera di Pasolini nel flusso e nel contesto della letteratura<br />
italiana ed europea del Novecento: uno scrittore accanto ad altri scrittori. Naturalmente l’iter stesso<br />
artistico, culturale e ideologico di Pasolini va opportunamente scandagliato nelle sue fratture, nelle<br />
sue nuance, nelle sue discontinuità.<br />
L’occasione di parlare a un vasto pubblico da un pulpito di particolare rilievo come quello del<br />
«Corriere della Sera» ha determinato toni, temi, linguaggi, accentuando gli elementi di provocazione.<br />
Del pari è indubbio che negli ultimi anni e negli ultimi mesi si è accentuato vistosamente l’incupimento,<br />
anche antropologico, dello scrittore. Ma l’etichetta del ‘profeta’, al di là dei toni, è in parte distorcente.<br />
Il profeta, nelle varie tradizioni religiose, parla a nome di Dio e in ogni caso di un’Autorità Superiore. La<br />
posizione di Pasolini è invece diversa. Si ricordino le sue parole in Scritti corsari:<br />
Io non ho alle mie spalle nessuna autorevolezza se non quella che mi proviene paradossalmente<br />
dal non averla o dal non averla voluta; dall’essermi messo in condizione di non aver niente da perdere,<br />
e quindi di non essere fedele a nessun patto che non sia quello con un lettore che io del resto considero<br />
degno di ogni più scandalosa ricerca. 45<br />
La questione del profetismo rientra dunque, a mio avviso, in un ambito tipicamente linguistico-stilistico.<br />
Da un altro punto di vista l’immagine geniale del ‘Palazzo’ o lo stesso titolo del romanzo<br />
(a lungo inedito) Petrolio 46 dimostrano, più che un’attitudine profetica, l’acutezza e la lungimiranza del<br />
giudizio di Pasolini sul presente.<br />
Sgorlon attribuisce all’insuperato ‘narcisismo’ di Pasolini il carattere pervasivo della sua pre-<br />
44 Valga per tutti l’esempio di Gian Carlo Ferretti e della tematica dell’ ‘universo orrendo’; cfr. in particolare gian Carlo ferretti,<br />
Pasolini: l’universo orrendo, Roma, Editori Riuniti, 1976.<br />
45 Pier Paolo PaSolini, Scritti corsari, Milano, Garzanti, 1975, p. 105. Pasolini era stato duramente attaccato dall’ «Osservatore<br />
romano» e curiosamente accusato di “non avere autorevolezza”. Sui caratteri di Scritti corsari rinvio al mio intervento<br />
Intemperanze e provocazioni di Pasolini, in «Problemi» (1976) n. 45, p. 119-123 (ora in giamPaolo BorgHello, Il simbolo e la<br />
passione, Milano, Mursia, 1986, p.134-141).<br />
46 Pier Paolo PaSolini, Petrolio, Torino, Einaudi, 1992. Per una curiosa coincidenza il tema del petrolio (nelle sue valenze metafisiche,<br />
storiche e politiche) percorre il recente romanzo di Carlo Sgorlon, L’alchimista degli strati, Milano, Mondadori, 2008.
senza, l’inesausto bisogno di ‘essere sulla scena’. La pubblicazione dei due articoli di Sgorlon sul profetismo<br />
di Pasolini suscita un vivace dibattito e anche alcune lettere di protesta, che sono evidentemente<br />
segno di una grande attenzione e di una particolare sensibilità: Sgorlon ha forse toccato dei nervi scoperti<br />
della cultura e della società friulane. In seguito a queste discussioni il narratore friulano sente il<br />
bisogno di proporre un ‘Pasolini ter’, in cui fa ancora una volta il punto della situazione. L’attenzione ai<br />
caratteri del profetismo si sposta così sui lettori, sugli ‘eredi’: e Sgorlon cerca di analizzare le ragioni<br />
per cui Pasolini “è diventato per tanti il profeta di una moderna religione della disperazione.” 47 E Sgorlon<br />
aggiunge: “Come Kafka, dunque, anche se Pasolini è abissalmente diverso dall’allucinato impiegato<br />
praghese.” 48<br />
In questo contesto l’attenzione si sposta poi doverosamente sulle nuove generazioni che leggono<br />
Pasolini, accentuandone il carattere di profeta, ritrovandosi (anche emotivamente) nelle sue analisi<br />
e nelle sue opere. In questo modo il discorso investe le trasformazioni e il degrado della società italiana<br />
dopo il 1975, l’anno della morte di Pasolini. Qui naturalmente opinioni, analisi e interpretazioni divergono,<br />
come è giusto che sia. Sgorlon, in questo quadro, denuncia il fatto che Pasolini venga spesso<br />
proposto ai giovani come una sorta di ‘modello’.<br />
L’intervento del 31 ottobre 2000 Un innovatore in Friuli 49 costituisce una sorta di conclusione<br />
provvisoria delle riflessioni di Sgorlon sulla figura e sull’opera pasoliniane. Il narratore friulano muove<br />
dalla constatazione della prodigiosa ‘vitalità’ dell’opera di Pasolini, dalla qualificante presenza dei<br />
‘mille volti’ dell’autore e dal preciso riconoscimento critico della estrema complessità del ‘fenomeno<br />
Pasolini’. La citazione strategica della celebre affermazione di Dostoevskij “L’uomo è troppo vasto. Io<br />
lo restringerei” esprime con grande efficacia la sensazione di inquietudine e di smarrimento di chi deve<br />
trovare un filo di Arianna per muoversi all’interno del ‘labirinto Pasolini’. Sgorlon dà il giusto risalto a<br />
una possibile chiave di lettura psicologica: “Forse fu la fame e la sete sterminata di vita e di realtà; fu<br />
un ribollire magmatico che era al centro di lui, e che bruciò in modi sempre più appassionati, ma anche<br />
sempre più feroci e autolesionistici.” 50 Accanto a questa chiave di interpretazione, Sgorlon propone e<br />
illustra la “chiave friulana.” Resta come punto di riferimento obbligato e suggestivo la celebre affermazione<br />
dello stesso Pasolini: “Una formazione letteraria ipoteca un’intera esistenza letteraria.” 51 Da<br />
questa angolazione Sgorlon propone un nitido e preciso quadro dell’ampia attività letteraria di Pasolini<br />
in Friuli (poesia, prosa, teatro) sottolineando il valore di rottura dell’esperienza pasoliniana rispetto alla<br />
chiusa tradizione imperante. Pasolini mette, di fatto, concretamente in contatto il chiuso mondo friulano<br />
con vive e organiche sequenze di varie letterature europee. Lo stesso dramma della ‘diversità’ è letto<br />
da Sgorlon anche in relazione al rapporto spezzato con il mondo friulano-materno, tra fedeltà e rifiuto.<br />
“La discesa progressiva di Pasolini verso i territori dell’esasperazione e della furia” è intesa da Sgorlon<br />
come il graduale passaggio a una figura di “scrittore mitico.” Contribuiscono a questo passaggio e<br />
alla costruzione di questa immagine gli interventi di intellettuali e scrittori amici come Zigaina, Zanzotto,<br />
Naldini. Il rilievo della stagione friulana di Pasolini e il suo forte ruolo di rinnovatore fanno dell’artista,<br />
per molti intellettuali friulani di oggi, un ‘gigante’ in mezzo ai ‘lillipuziani’, che sono venuti prima e<br />
anche dopo di lui. Rispetto alla ciclica battaglia, in Friuli e in Italia, tra ‘pasoliniani’ e ‘antipasoliniani’<br />
47 Carlo Sgorlon, Pier Paolo profeta? E sia... , cit.<br />
48 Ibidem .<br />
49 Carlo Sgorlon, Un innovatore in Friuli, cit.<br />
50 Ibidem.<br />
51 Pier Paolo PaSolini, La posizione, in «Officina», 6 (1956), p.249 (ora anche in gian Carlo ferretti, «Officina». <strong>Cultura</strong>, letteratura<br />
e politica negli anni cinquanta, Torino, Einaudi, 1975, p. 246).<br />
65
66<br />
Sgorlon, con le sue serene riflessioni e le sue attente analisi, rivendica in conclusione una posizione<br />
mediana ed equilibrata, “la più ricca di verità.”<br />
Sorge a questo punto spontanea la domanda “Esiste qualche intervento di Pasolini su Sgorlon?”<br />
La risposta è sì: registriamo una recensione al romanzo di Sgorlon Il trono di legno, apparsa su<br />
«Tempo illustrato» del 19 agosto 1973 e poi ripubblicata postuma in Descrizioni di descrizioni. 52 Per impostare<br />
una lettura corretta della recensione di Pasolini bisogna fare alcune semplici precisazioni: innanzitutto<br />
non si tratta di porre su un piatto della bilancia questo intervento di Pasolini per compararlo<br />
e confrontarlo con l’ampia sequenza degli articoli che Sgorlon ha dedicato allo stesso Pasolini. L’arco<br />
temporale è molto diverso: nel narratore friulano si spazia dal 1967 al 2000. Se escludiamo la relazione<br />
di Sgorlon agli Incontri <strong>Cultura</strong>li Mitteleuropei (1967), 53 si tratta di interventi post mortem, quando anche<br />
il quadro dell’attività della critica pasoliniana si è ulteriormente allargato fino a ingigantirsi. Inoltre<br />
l’articolo di Pasolini del 1973 riguardava anche altri due romanzi (Amore e psiche di Raffaele La Capria<br />
e I due allegri indiani di J. Rodolfo Wilcock) 54 che non hanno alcun rapporto con Il trono di legno: l’accostamento<br />
casuale fa parte del nobile mestiere di recensore. Bisogna quindi evitare di assolutizzare<br />
e di ingigantire la recensione a Sgorlon, inserendo invece l’articolo nel quadro che si delinea nel libro<br />
postumo di Pasolini.<br />
Descrizioni di descrizioni appare ancor oggi un testo di sottile fascino e di complessa decifrazione:<br />
l’impostazione, l’angolazione di giudizio, la tecnica di analisi di Pasolini appaiono molto diverse<br />
da un libro come Passione e ideologia. 55 Là prevaleva la sensazione di un grande quadro nel quale<br />
lo scrittore lucidamente e razionalmente inseriva le tessere del mosaico, secondo alcune precise linee<br />
guida. In Descrizioni di descrizioni prevale invece l’impressione del ‘mestiere di recensore,’ che consente<br />
all’autore interpretazioni acutissime e a volte affrettate, guizzi di ingegno estemporanei. Marco A.<br />
Bazzocchi ha parlato felicemente di un “corpo a corpo” di Pasolini con i singoli scrittori. 56<br />
In realtà come in Passione e ideologia colpiva l’individuazione sicura (e perentoria) di una bipolarità<br />
dialettica presente negli autori esaminati, qui colpisce il costante sforzo di scavare oltre la superficie,<br />
indagando soprattutto i meccanismi tecnici di scrittura, di composizione, di rielaborazione, procedendo<br />
a volte a vere e proprie vivisezioni. In questo contesto si deve, a mio avviso, analizzare lo stesso<br />
intervento di Pasolini su Il trono di legno. Sarebbe semplicistico e fuorviante parlare di ‘stroncatura’: in<br />
realtà le cose sono molto più complesse.<br />
Diciamo subito che Pasolini manifesta immediatamente la sua insofferenza per il successo del<br />
romanzo di Sgorlon, esprimendo così ancora una volta il suo radicale rifiuto di una certa società letteraria<br />
(quella dei Premi, per intenderci). Pasolini poi divide in due radicalmente il romanzo: la prima parte<br />
“un vasto e informe capitolone introduttivo a uno sterminato libro d’avventure, scritto in falsetto.” 57 La<br />
nozione di ‘falsetto’ è una delle chiavi di lettura per analizzare l’articolo di Pasolini: qui, tutto sommato,<br />
si ha l’impressione di un uso metaforico della categoria. Pasolini punta infatti l’accento su una silente<br />
presenza di un modello che è quello della narrativa di Elsa Morante. 58 Proprio l’ammirazione per la Mo-<br />
52 Pier Paolo PaSolini, Descrizioni di descrizioni, a cura di Graziella Chiarcossi, Torino, Einaudi, 1979, p. 149-151.<br />
53 Cfr. Supra, nota 43.<br />
54 Cfr. raffaele la CaPria, Amore e psiche, Milano, Bompiani, 1973 e Juan rodolfo WilCoCk, I due allegri indiani, Milano, Adelphi,<br />
1973.<br />
55 Pier Paolo PaSolini, Passione e ideologia, Milano, Garzanti, 1960.<br />
56 marCo antonio BazzoCCHi, Pier Paolo Pasolini, Milano, Bruno Mondadori, 1998, p. 84.<br />
57 Pier Paolo PaSolini, Descrizioni di descrizioni, cit., p. 149.
ante unisce significativamente due autori così diversi come Pasolini e Sgorlon. Il fascino della Morante<br />
resta in genere alto per Sgorlon, ma qui non credo che sia il vero bandolo della matassa. Mi sembra<br />
invece che il significato de Il trono di legno sia all’interno della stessa storia interiore del narratore friulano,<br />
marcando il rovesciamento totale dell’angoscia kafkiana de La poltrona 59 nella positiva scoperta<br />
della dimensione e della felicità del narrare, del puro narrare. La visibile tensione fantasmagorica che<br />
anima e percorre Il trono di legno è il tangibile risultato di quell’ardito bouleversement.<br />
L’ammirazione di Pasolini per la prima parte de Il trono di legno si condensa nella battuta ad effetto:<br />
“Poiché tutto è finto, tutto è anche vero.” 60 Osservazione suggestiva, ma spontaneistica, simpaticamente<br />
inverificabile. Pasolini forza un po’ le cose per individuare e concretizzare una vistosa frattura<br />
tra la prima parte de Il trono di legno e la seconda: dalla ‘prigione’ di Ontans alla ‘prigione’ di Cretis.<br />
Io credo invece che il filo conduttore del testo sia un altro e, dal punto di vista del piacere di raccontare,<br />
non c’è soluzione di continuità tra le due parti del romanzo: certo Sgorlon cambia taglio e tiro nella<br />
seconda parte del libro, ma fa questo scientemente, proprio per saggiare tecnica e mondo poetico del<br />
‘raccontare’. Non è naturalmente un caso che dalla kafkiana poltrona si passi al regale trono di legno<br />
(di legno, si badi bene). Acuta e pertinente mi sembra invece l’affermazione conclusiva di Pasolini: “Tutto<br />
il libro di Sgorlon è dunque la metafora di una carriera letteraria o – più ambiziosamente – di una<br />
vocazione narrativa.” 61<br />
Pasolini poi riconferma la distinzione/contrapposizione tra la prima e la seconda parte de Il trono<br />
di legno puntualizzando l’”affabulazione insieme intimistica ed estroversa” delle prime 104 pagine<br />
e stroncando invece le pagine restanti come pigre, generiche e risapute. Al di là di generali o parziali<br />
dissensi rispetto a questa pur acuta pagina critica, colpisce invece in positivo lo sforzo pasoliniano di<br />
non adagiarsi in una lettura/interpretazione di comodo, ‘neutrale’, misurandosi nettamente e appassionatamente<br />
con il testo: anche questo è un “corpo a corpo.”<br />
* Desidero esprimere un particolare e caloroso ringraziamento a Edda e Carlo Sgorlon per la<br />
loro disponibilità e generosità.<br />
58 Sui complessi e tortuosi rapporti tra Pasolini e la Morante, sia sul versante biografico che su quello artistico, cfr. il lucido e<br />
attento saggio di Walter Siti, Elsa Morante nell’opera di Pier Paolo Pasolini, (in Vent’anni dopo ‘La Storia’, a cura di Concetta<br />
D’Angeli e Giacomo Magrini, «Studi novecenteschi», n. 47-48, 1994, p.131-148); cfr. inoltre maSSimo fuSillo, «Credo nelle<br />
chiacchiere dei barbari». Il tema della barbarie in Elsa Morante e Pier Paolo Pasolini (Ivi, p. 97-129) ; ID., La Grecia secondo<br />
Pasolini, Roma, Carocci, 2007; marCo antonio BazzoCCHi, I fiumi perduti della storia, Prefazione a Carlo Sgorlon, L’armata dei<br />
fiumi perduti, Torino, UTET, 2006, p. IX-XXI.<br />
59 Carlo Sgorlon, La poltrona, Milano, Mondadori, 1968.<br />
60 Pier Paolo PaSolini, Descrizioni di descrizioni, cit., p. 150.<br />
61 Ibidem.<br />
67
La figura femminile nella narrativa di Carlo Sgorlon*<br />
di Fabiana Savorgnan di Brazzà<br />
Università degli Studi di <strong>Udine</strong><br />
Carlo Sgorlon, con la posizione privilegiata da lui rivendicata di “libero pensatore”, di “anarchico<br />
del cortile” (sua la definizione di sé), nutriva una grande considerazione per l’universo femminile.<br />
Basterebbe leggere la dedica che apre il libro Il velo di Maya, edito nel 2006 da Mondadori, per<br />
capire il posto che lo scrittore assegna alle donne: “Dedico questo romanzo agli appassionati di musica<br />
classica e in particolare a coloro che vivono di essa, agli alpini di ieri, di oggi e di domani, e alle<br />
donne, eterne protagoniste delle mie storie”. Un’attenzione, quindi, del tutto unica e privilegiata all’universo<br />
femminile, che si dispiega attraverso una moltitudine e una straordinaria varietà di personaggi<br />
fortemente ancorati a quegli archetipi che definiscono l’ossatura incrollabile delle sue trame narrative.<br />
Volendo delineare un quadro generale ma, nel contempo, puntato all’individuazione dei “tipi”<br />
femminili, devo subito dire che non poche sono state le difficoltà, sia per la vastissima produzione del<br />
nostro scrittore, sia per la multiforme e poliedrica varietà, per le sfumature e i cromatismi che Sgorlon<br />
ha impiegato per rappresentare l’immagine della donna.<br />
Tuttavia è possibile individuare dei tratti caratteristici e ricorrenti.<br />
Dall’esordio dei primi romanzi, da La notte del ragno mannaro del 1970, fino a giungere a L’alchimista<br />
degli strati del 2008, attraverso l’intelaiatura narrativa in cui si dipanano trame, eventi, azioni<br />
e dove i personaggi maschili assumono il ruolo di portavoce del mondo interiore dello scrittore e della<br />
sua concezione di vita, sembra di percorrere un ideale cammino spirituale e mistico in cui il ruolo assegnato<br />
alle donne da Sgorlon è quello di farsi “portatrici dell’anima del mondo”, mediatrici tra il mondo<br />
e l’irreale, il cosmo, la natura, il mistero stesso dell’esistere e dell’essere.<br />
Ciò trova conferma nella sua autobiografia La penna d’oro, in cui riassume la sua particolare<br />
visione: “I miei protagonisti femminili sono, come spesso nella concezione e nella letteratura romantiche,<br />
più istintivi e intuitivi dell’uomo, più naturali e più ricchi di un sentimento profondo della vita, più<br />
radicati nella natura e nell’Essere, ai quali non si ribellano mai, ma anzi vastamente si immedesimano<br />
e li partecipano.” 1<br />
Si tratta, quindi, di donne magiche, immaginose, volubili, visionarie, fortemente volitive, dotate<br />
di una capacità di comunicazione con la Natura, la Terra, le Forze cosmiche, depositarie di un mondo<br />
interiore profondo ed arcano, permeate dal senso del sacro, dotate di una sensibilità complessa e misteriosa,<br />
che permette loro una capacità d’amore compassionevole, unita ad una pietas religiosa che le<br />
* Ringrazio sentitamente Edda Agarinis Sgorlon per avermi messo a disposizione con grande generosità i materiali dell’Archivio<br />
Sgorlon, che mi hanno permesso di approntare questo contributo.<br />
1 Carlo Sgorlon, La penna d’oro, [s.l., ma Pezzan di Carbonera], Morganti editori, 2008, p. 81.<br />
69
70<br />
rende forti e capaci di superare il limite del conoscibile e del conosciuto. Tutti i suoi personaggi femminili,<br />
come Sgorlon afferma: “hanno qualche lato della fata e qualcuno della strega, e certo sono caratterizzati<br />
da un’atmosfera più o meno accentuatamente magica, la stessa che circonda la natura e che<br />
in genere sostiene la mia visione del mondo.” 2<br />
Emblematica in questo senso la figura di Roswitha ne La notte del ragno mannaro, a metà tra<br />
donna e creatura onirica, individuabile a tratti, mai definita, sfuggente e imprendibile, protagonista e<br />
antagonista insieme di un sogno fatto ai limiti dell’incubo e del grottesco. È una figura che compare e<br />
scompare con grande rapidità, come ha scritto Cesare De Michelis in un articolo apparso su «Il Gazzettino»:<br />
«una bruna zingara “coi capelli lunghi e neri, e due grandi cerchi di ottone alle orecchie”. È proprio<br />
lei che lo attrae e lo stuzzica in un gioco senza tregua, rivelando “occhi chiari come il vetro”, ma che<br />
hanno “una luce a volte ingenua, a volte stregata”. “In lei – si convince il protagonista, ammaliato dalla<br />
sua danza veloce e leggera – c’è il segreto del mio essere e del mio destino” e subito immagina che<br />
“vicino a lei possano accadermi allucinazioni, fenomeno di suggestione, sortilegi”. Ma anche Roswitha<br />
resiste soltanto per poco, prima di essere risucchiata “nel buco d’ombra che ci ruba continuamente<br />
le cose alle nostre spalle”». 3 La sua figura si inserisce in un dialogo con il protagonista che, come nel<br />
romanzo precedente La Poltrona, si situa fuori dalla storia, nella particolare visione antistoricista dello<br />
scrittore; la realtà si risolve in qualcosa di puramente fenomenico e vitalistico e il protagonista vive<br />
in una realtà onirica e inafferrabile, come lo è la donna che insegue e diventa la sua compagna, ma a<br />
tratti, per essere all’improvviso risucchiata nel vortice del sogno, perché per Sgorlon, la realtà è “apparenza,<br />
illusione, fenomeno, sogno”, in chiave kafkiana.<br />
In lei si riconoscono già i tratti caratteristici di molte donne dell’universo femminile dello scrittore,<br />
come la figura di Isabella nel romanzo La regina di Saba (1975), opera che dà inizio ad una galleria<br />
di personaggi femminili “amabili e misteriosi, sfuggenti e magici, singolarmente pietosi e ricchi di<br />
erotismo, ma sempre legati alla pietas per tutto ciò che è umano, anzi per tutto ciò che è entrato nel<br />
cerchio enigmatico della vita”; 4 la protagonista appartiene alla razza delle fate o delle agane, è depositaria<br />
di un’essenza musicale, dominata dal ritmo e dall’armonia, rappresenta il principio stesso della<br />
vita, l’amore per la vita stessa; è un personaggio che ha rapporti tutti suoi con il tempo, poiché non invecchia;<br />
è, scrive Sgorlon, una sorta di “Peter Pan in sottana” e gli anni invano cercano di corrodere la<br />
sua giovinezza, che però nulla riesce a scalfire.<br />
Isabella racchiude in sé tutte le donne, essa rappresenta “l’eterno femminino goethiano, il simbolo<br />
stesso della realtà, inconsumabile, perennemente giovane, che gli uomini possono ferire in mille<br />
modi diversi, ma non uccidere perché è immortale.” 5<br />
I personaggi femminili di Sgorlon, quindi, non sono ricavati dalla cronaca, sono simboli, rappresentano<br />
una categoria. Tutto è abilmente congegnato in un universo di profondi sentimenti che fanno<br />
tutt’uno con il paesaggio, spesso friulano, nel quale sono calate, determinando le azioni, le scelte e le<br />
riflessioni dell’uomo, in perenne contatto con l’Altro, il fuori da sé, quasi fossero demiurghe o tramiti,<br />
in senso sabiano, di un’elevazione spirituale che avvicina a Dio, al mistero del cosmo, provenienti da<br />
un “arcano altrove”, che sta aldilà delle apparenze. Sembra quasi che in un mondo attraversato dalla<br />
mancanza di valori, di una vera metafisica, la donna rappresenti, stilnovisticamente, in Sgorlon, “l’anello<br />
che tiene” unito l’uomo all’universo.<br />
2 Ivi, p. 87.<br />
3 CeSare de MiCHeliS, Il ragno mannaro, «Il Gazzettino», 22 dicembre 1984.<br />
4 Carlo Sgorlon, La penna d’oro, cit., p. 80.<br />
5 Ivi, p. 86.
Ne La contrada, romanzo ambientato a <strong>Udine</strong>, “un piccolo mondo antico friulano”, Tullia, la più<br />
giovane del gruppo della banda della Roggia, è descritta come “estrosa e bizzarra”, con l’abitudine a passeggiare,<br />
di notte, sui tetti della contrada: evidente la traccia del realismo magico di Buzzati o Landolfi.<br />
Ma cosa vuol dire essere maga? Da La fontana di Lorena (1990) possiamo ricavare forse il significato<br />
esatto, là dove descrive le paure che i bambini di Adegliano nutrivano nei confronti di Eva, la<br />
pittrice, e di Astrid, scrittrice per bambini:<br />
I bambini di Adegliano avevano ragione di essere esitanti, quando superavano la soglia di pietra della Suturne,<br />
temendo che lei e Astrid fossero due maghe. Essere maga voleva dire soltanto questo, conoscere la propria terrestrità<br />
e sapere di essere in colleganza enigmatica con la terra creatrice. Lei [Eva] era maga, senza dubbio; sentiva l’impulso a<br />
uscire di notte, e magari proprio di giovedì, come le antiche ragazze del paese, che scivolavano dal letto quando tutti i<br />
familiari si erano addormentati, si riunivano nella radura del bosco del forzato, e facevano il bagno nude nella pozza solo<br />
per la gioia di vivere, perché si sentivano invase dallo spirito della terra, ossia lo spirito della vita e quello di Dio. [...]. Era<br />
una forma dello spirito sciamanesco delle origini, che era passato da una generazione all’altra, era continuato fino a lei,<br />
ed ora si esprimeva nei suoi quadri. Quando dipingeva sentiva di collocarsi dentro all’interno di una cultura arcaica, che<br />
era sempre e comunque una forma di rapporto con la natura. Quella era la sua forza, il punto centrale, la cosa essenziale<br />
che la caratterizzava. Da lì traeva le sue energie. 6<br />
Eva rappresenta la “terrestrità”, è in rapporto con la natura, ha un sentimento magico, è stravagante<br />
come lo è con lei la vita.<br />
Le donne di Sgorlon, del resto, spesso hanno rapporti con la magia bianca, fanno del bene e<br />
usano se stesse per consolare, redimere, salvare; sullo stesso tema Sgorlon si rapporta ad altri autori,<br />
sostenendo le diverse interpretazioni: “oggi si parla molto di streghe. Ultimamente Carlo Ginzburg,<br />
Sciascia, Festa Campanile, Sebastiano Vassalli, Serena Foglia hanno scritto di streghe e di sabba. Ma<br />
ognuno ha una sua concezione delle cose, un modo particolare di sentirle.” 7<br />
Ma le sue streghe possiedono il sentimento della natura, come i maghi di un tempo, in stretto<br />
contatto con la terra e con i suoi misteri.<br />
Eva sente di essere un piccolo segmento della catena della vita, non possiede sentimenti individualistici,<br />
sa di essere stata anche tutte le sue antenate, di realizzare un archetipo femminile, un’idea<br />
platonica seppellita nei recessi misteriosi del reale, che si sono realizzati infinite volte in singole donne.<br />
Il modo di sentire è panteistico, sostiene Sgorlon, come quello di Telesio, di Campanella o Spinoza.<br />
Eva non possiede grandi conoscenze filosofiche, è carica d’istinto e di intuizione; è il personaggio di una<br />
nuova mentalità, quella che propone di abbattere lo storicismo e di entrare in contatto con la vita e la<br />
natura. Insomma, è una “beniamina della vita e della sorte” (come certi personaggi di Thomas Mann),<br />
simbolo della “terrestrità”; il bosco è la sua dimora, spazio incantato e misterioso.<br />
Ma Eva rappresenta anche la simbiosi che lega la donna al mondo dell’arte, alla cultura, nella<br />
concezione che l’arte non è una banale imitazione della natura, ma le sue radici vengono dalla terrestrità,<br />
in una visione antropocentrica, che pone l’uomo in contatto con quello che Sgorlon chiama “un<br />
feudo remoto”.<br />
Eva dipinge, guidata da un istinto pittorico, seguendo i maestri come Van Gogh, Chagall, Ligabue;<br />
possiede una biblioteca ricca di volumi di autori del Quattro e Cinquecento (Teofrasto Paracelso,<br />
Nicola Cusano, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, ecc.), ereditata dal padre, tra cui soprattutto opere<br />
di Bernardino Telesio, come il De rerum natura, che apprezzava più di tutti per essere “osservatore<br />
6 Carlo Sgorlon, La fontana di Lorena, Milano, Mondadori, 1990, pp. 147-148.<br />
7 id., La fontana di Lorena, dattiloscritto conservato nell’Archivio Sgorlon.<br />
71
72<br />
della natura” e mago allo stesso tempo, come suo padre e suo nonno. Si tratta di una donna intellettuale,<br />
còlta, che si pone domande intorno al significato della vita e dell’essere:<br />
Vi erano regole fondamentali che sostenevano il mondo e la vita, ed Eva sentiva che tutte insieme formavano un<br />
grande codice, nel quale rientrava anche ciò che era successo a Giulia e l’aveva trasformata in signorina. Ma da dove venivano<br />
le regole? Qual era la fonte delle leggi che governavano la vita e l’essere nella sua totalità? Vi era una mente che<br />
le aveva pensate, oppure esse si formavano da sé, come dire che la mente, la legge e l’essere erano una cosa soltanto?<br />
Erano la terra e la natura che le avevano formate, in milioni e milioni di anni, o dietro di esse vi era un’entità più sottile,<br />
di sostanza misteriosa, che le aveva concepite e mutate in realtà. 8<br />
Altre donne in Sgorlon sono legate alle arti, alla musica, ad esempio Arletty ne Il velo di Maya,<br />
così nello stesso romanzo Alice Donadon, docente al liceo musicale, o Desirée, la ragazza che suona<br />
il flauto come lui, o ancora Marisol, per citare alcuni esempi. Vi sono donne che si dedicano alla danza,<br />
come Annette ne Le sorelle boreali, oppure Olga, nello stesso romanzo, quella più creativa fra le<br />
sorelle, la più ricca di temperamento, capace di prendere drastiche decisioni, schietta e priva di tabù.<br />
Grande l’acutezza con cui Sgorlon ritrae i suoi personaggi femminili, sì che emerge la profonda<br />
ammirazione dello scrittore e dell’uomo in quanto tale nei confronti della donna, che, pur nella poliedricità<br />
dei ritratti forniti, rimane sempre coerente e fedele agli assiomi portanti della sua narrativa. Certamente<br />
l’amore e il rispetto per la figura femminile gli derivano dalle donne che hanno accompagnato la<br />
sua esistenza: la madre, “l’anello forte” della famiglia, 9 Cristina Moretti Rismondo, che alla sua nascita<br />
gli regalò la “penna d’oro”, simbolo ed iniziazione al mestiere di scrittore, la nonna Eva “dal carattere<br />
d’acciaio”, 10 moglie di Pietro Mattioni, poeta e scrittore in friulano che tanta parte ebbe nella formazione<br />
di Sgorlon, l’insegnante delle scuole medie Maria Ragni, che come scrive Sgorlon fu un’“insegnante<br />
straordinaria che mi aveva rivelato a me stesso.” 11 Non certo di minor rilievo la donna che sposò, Edda<br />
Valentina Giovanna, nata la notte di San Giovanni, la più magica di tutta l’annata, la notte dei fuochi e<br />
degli incantesimi, pagani e cristiani insieme:<br />
Era molto inclinata alle cose magiche, attirata dai miti, dagli archetipi, le fantasie, le leggende; di mentalità<br />
arcaica, tendeva a dare ad ogni cosa spiegazioni favolose e improbabili, tipiche della cultura ancestrale. Così trovai sintetizzate<br />
nella donna che avevo sposata molte di quelle strutture mentali che formavano il supporto della mia poetica,<br />
ormai pienamente definita. 12<br />
Solo così si può spiegare ne Il velo di Maya, ad esempio, il rispetto per la donna nel rapporto<br />
tra il protagonista, Jacopo d’Artegna e la madre di lui, Agnes:<br />
Jacopo cercava di obbedire ad Agnes non solo perché era sua madre, ma anche perché era una donna. Ranieri<br />
gli aveva insegnato che con le donne bisognava essere rispettosi, gentili e condiscendenti, e lui era cavalleresco, in un<br />
certo senso, anche con la madre. 13<br />
L’ammirazione per la donna e per il suo mondo culturale include, in Sgorlon, anche scrittrici come<br />
8 Carlo Sgorlon, La fontana di Lorena, cit., p. 37.<br />
9 id., La penna d’oro, cit., p. 10.<br />
10 Ivi, p. 16.<br />
11 Ivi, p. 29.<br />
12 Ivi, p. 51.<br />
13 Carlo Sgorlon, Il velo di Maya, Milano, Mondadori, 2006, p. 14.
Elsa Morante, con la quale si sentiva in sintonia nella concezione della poesia come fondata sulla realtà<br />
e da cui mutuò “la predilezione per il mondo feudale e nobiliare, e per le qualità signorili e cavalleresche<br />
di certi personaggi”, 14 autrice che ammirava e considerava “uno dei più importanti scrittori italiani”.<br />
Le donne di Sgorlon possiedono anche un forte senso della comunione con gli uomini, spesso riuniscono<br />
in sé etnie diverse, sono portatrici di un sentimento di fratellanza, o meglio di “sororità”, come<br />
dice in forma originale e dotta Veronica nel romanzo La tredicesima notte (2001): “Sono convinta che il<br />
sentimento di fratellanza delle donne è più ampio di quello degli uomini. Meriterebbe d’essere chiamato<br />
come dico io [sororità].” 15 Il sentimento di “accoglienza” si accompagna a quello della natura. Non a<br />
caso Veronica vive e si sente a suo agio tra i boschi, gli animali, gli uccelli, riconoscendo la presenza di<br />
un’intelligenza universale, riflesso di una forza cosmica che piega la natura ai suoi fini:<br />
In nessun luogo come nel bosco Veronica era sorpresa dalla sensazione di partecipare della sostanza impenetrabile<br />
delle maghe di Monterosso, sorelle misteriose che l’avevano preceduta dentro lo spessore inconoscibile del tempo.<br />
Cominciava a provare il sapore di una potenza ignota, radicata in lei. Sentiva concentrare in sé un’energia carica di facoltà<br />
esplosive, e vedeva se stessa un po’ come Erittone, la maga tessala che riusciva a riportare l’anima dentro i corpi dei<br />
soldati morti nella battaglia, incontrata nei versi della Farsaglia. 16<br />
È dotata di una sensibilità non comune, una capacità di comunicare con le cose, gli oggetti, di<br />
mettersi in ascolto per recepire il non detto: “sentiva delle ‘voci’, ma non con l’udito. Le sentiva dentro<br />
di sé, quando si trovava da sola, concentrata e silenziosa, nella solitudine assoluta dell’alta montagna.<br />
17<br />
Ma l’interesse per le donne in Sgorlon è anche interesse per il sacro. Nei suoi Racconti della<br />
terra di Canaan lo scrittore ha creato una serie di personaggi femminili riconosciuti dalla critica come<br />
straordinari. 18 Per Sgorlon<br />
essi per lo più derivano da un archetipo che forse non può essere definito biblico, ma ha qualcosa di religioso<br />
nel fondo. Le mie donne sono un po’ sempre, per un verso o per l’altro, legate al grande modello della Terra madre. Sono<br />
in contatto profondo con la natura e la vita, in modi molto più accentuati rispetto agli uomini. Spesso esprimono l’eros,<br />
che è l’istinto a continuare la vita. Ma l’eros, più che esprimere la concezione laica e borghese dell’amore, è inteso in modi<br />
sacrali e viene trasformato in uno strumento della pietà per l’uomo, perduto all’interno delle contingenze del mondo,<br />
sentito come un ‘naufrago cosmico’ che ‘stenta a scorgere la sua stella polare e ad usare le bussole che gli sono state<br />
fornite dall’antica cultura religiosa.’ 19<br />
Eros, quindi, come sacralità e come rimedio alla solitudine cosmica dell’uomo. Eros come pietas,<br />
forza cosmica, come sostiene Marianna Novak ne La malga di Sir (1997):<br />
Era l’attrazione per l’altro, di un uomo per una donna, di un mistico per il Creatore, di un atomo per il suo vicino:<br />
l’amore dominava il mondo in ogni lato, ad ogni livello, e tutti e tutto, in modi diversi, ne sentivano l’influsso. Lo Spirito<br />
Santo era lo spirito del mondo. 20<br />
14 Ivi, p. 80-81.<br />
15 Carlo Sgorlon, La tredicesima notte, Milano, Oscar Mondadori, 2001, p. 112.<br />
16 Ivi, p. 93; marCuS AnnaeuS LuCanuS, Belli civilis liber VI, pp. 508, 519, 628, 640, 725, 762, 826.<br />
17 Ibidem<br />
18 Carlo Sgorlon, Racconti della terra di Canaan, Milano, Mondadori, 1989.<br />
19 id., Il personaggio femminile nei miei racconti biblici, dattiloscritto conservato nell’Archivio Sgorlon.<br />
20 id., La malga di Sir, Milano, Mondadori, p. 53.<br />
73
74<br />
Nel proporre di seguito le figure di Sara, Dalila, Ruth, Micòl, Regina di Saba, Ester e Giuditta,<br />
Sgorlon rappresenta figure legate al mistero del mondo, al sacro, donne che colgono e intuiscono l’essenza<br />
e il determinismo. Ester rappresenta la femminista ante litteram, da un lato, che salva il suo popolo;<br />
dall’altro insieme con Ruth considera la possibilità di giungere a Dio solo attraverso l’amore e la<br />
religione, forza cosmica che tutto governa; Sara, ormai vecchia, accetta di mettere la giovane schiava<br />
egiziana Agar nel letto di Abramo; Dalila, moglie di Sansone, la meretrice della valle di Sorec, traditrice,<br />
simulatrice, obbedisce solo al richiamo del denaro, o. Gli esempi potrebbero continuare, ma il tratto<br />
che accomuna donne così diverse, anche per religione (si tratta di ebree, filistee, moabite) sta nel<br />
fatto che Sgorlon riconosce a tutte la possibilità di disporre di “arti” seduttive e insieme di saggezza.<br />
Nella Conchiglia di Anataj, ad esempio, c’è una donna che vive in un villaggio vicino al quale si<br />
costruisce una ferrovia ed essa diventa una prostituta, ma per Sgorlon nemmeno in questo caso essa<br />
degrada moralmente, poiché le riconosce la capacità di provare pietà: è, quindi, una creatura pietosa.<br />
Ajdym, ne La conchiglia di Anataj è la giovane chirghisa salvata da Anataj all’epoca della grande siccità,<br />
è la donna degli operai della Transiberiana, allevia la loro solitudine, è la loro consolatrice.<br />
Le donne di Sgorlon sono donne di pace, appartengono a etnie diverse, possiedono il dono<br />
dell’accoglienza, nella visione tolstoiana. Esempio lo è ancora Marianna (La malga di Sir), che diviene<br />
partigiana, che accetta nel suo grembo un figlio non suo, che cerca di restare lontana dalla guerra;<br />
stesso ruolo lo ricoprono le cinque sorelle ne Le sorelle Boreali. Sgorlon ama anche la visione quotidiana<br />
e casalinga della donna: Ludmilla ne Le sorelle boreali è colei che “regge la casa”, si occupa della<br />
famiglia e degli affetti familiari.<br />
Nell’Alchimista degli strati la figura di Leni Rosenkrug, agli occhi del protagonista Martino Senales,<br />
un geologo trentino impegnato alla ricerca di fonti alternative al petrolio, è la “metafora del suo<br />
desiderio, ma anche una sorta di nostalgia dell’irraggiungibile”. La concezione magica è caratteristica<br />
anche di Leni:<br />
Certe vecchie di Alpendorf bisbigliavano che Leni di Rosenkrug, la Grafin amazzone, fosse una<br />
specie di Circe in qualche modo responsabile della morte di suo marito, il quale l’avrebbe fuggita per<br />
la disperazione di non poter frenare la sua ninfomania; Leni incantava gli uomini come le civette fanno<br />
con i piccoli uccelli. Capiva su quali agganci si arrampicassero e si sostenessero quelle voci, che lei<br />
non si curava di smentire e di dissipare. Era definita una strega perché possedeva richiami magici, come<br />
gli uccelli notturni da cui quel nome veniva, le strigi, perché era in contatto con le forze primordiali<br />
del mondo. Leni era certo tutto questo, perché aveva catturato anche lui. 21<br />
Non di minor effetto la concezione dell’amore di Martino nei confronti della cultura araba:<br />
Qui nessuno concepiva la donna come faceva lui, nessuno sentiva che l’amore era sacro, perché era una delle<br />
forze misteriose dell’universo e conteneva per intero l’arcano della vita. L’amore per loro era solo un divertimento con una<br />
donna sottomessa e costretta a subire. 22<br />
Nei romanzi di Sgorlon ci sono anche le femministe, ad esempio Patrizia, pittrice, ne Il regno<br />
dell’uomo (1994), a cui Sgorlon affida al sua visione del mondo moderno e dell’uomo di oggi che si ribella<br />
al proprio destino, che vive imprigionato nell’angoscia. Patrizia, proveniente da una civiltà contadina,<br />
è l’“ostinata ricercatrice di forme nuove, laica, femminista, testardamente legata e attratta alle<br />
21 Carlo Sgorlon, L’Alchimista degli strati, Milano, Mondadori, 2008, p. 202.<br />
22 Ivi, p. 159.
forme più precarie dell’effimero contemporaneo, finisce vittima di quel nichilismo verso il quale l’arte<br />
moderna corre pericolosamente incontro.” 23<br />
Nei romanzi di Sgorlon, come ne La foiba grande, trovano spazio anche le donne soldatesse,<br />
slave, che non hanno paura, che combattono come gli uomini, che partecipano alla Resistenza, che sono<br />
«attraenti e nello stesso tempo micidiali», 24 che utilizzano le armi seduttive per combattere il nemico.<br />
Altrettanto importante la donna friulana, dal carattere forte e volitivo, abituata alla sopportazione,<br />
alle fatiche, resiste come la terra cui appartiene.<br />
Ma la donna friulana, così cara a Sgorlon, perché rappresentante di quel Friuli da lui tanto amato<br />
e presenza costante nei suoi romanzi, è la donna ancestrale e antica, che proviene da luoghi remoti e<br />
misteriosi: così le vecchie di Fajet, nel Calderas, le donne friulane, le vecchie specialmente, assumono<br />
una dimensione mitica, metafora della “Gran Madre friulana”, rappresentano la civiltà contadina, così<br />
ben delineata nella straordinaria figura della sedonera, la Clautana (da Claut, il paese di provenienza)<br />
ne Gli dei torneranno (1977); la sedonera è la “venditrice nomade di oggetti di legno, cucchiai, mestoli,<br />
portauova, frullini, che gli uomini della sua valle fabbricavano durante l’inverno” che trasportava con<br />
la sua gerla sulle spalle, immersa in quella pensosità e silenzio che provenivano da un indistinto mondo<br />
lontano; 25 Simone, il protagonista, la descrive: “una donna sotterranea e aggrovigliata, abituata alla<br />
rinuncia e al sacrificio, ma anche capace di esplosioni improvvise, come un vulcano spento.” 26 Si veda<br />
anche l’emblematica figura di Margherita de Crignis, depositaria delle memorie familiari.<br />
Altre donne da ricordare sono Marta, nell’Armata dei fiumi perduti (1985), che ricopre il ruolo di<br />
domestica friulana, oppure Wilma, ne l’Alchimista, di mentalità pratica e realistica:<br />
Abramo venne un giorno dai Senales e portò a Wilma un servizio di bicchieri di cristallo. La donna ne fu così felice<br />
che fu sul punto di abbracciare l’effendi arabo. Lei, da vera friulana, non se la sentiva di buttar soldi in spese futili,<br />
ma era felicissima quando le facevano un regalo di quella natura. 27<br />
Solo alcuni degli esempi che attestano l’importanza che Carlo Sgorlon ha assegnato alla figura<br />
femminile, còlta nelle sue diverse sfaccettature, mutevole e mutante, friulana nell’animo, specchio in<br />
cui si riflettono culture diverse, legata agli archetipi della natura e in contatto con il mondo sovrannaturale,<br />
protettrice e messaggera della vera essenza della vita.<br />
23 Carlo Sgorlon, Il Regno dell’Uomo, dattiloscritto conservato nell’Archivio Sgorlon.<br />
24 id., La foiba grande, Milano, Oscar Mondadori, 2009, p. 102.<br />
25 id., Gli dei torneranno, Milano, Mondadori, 1977, p. 37.<br />
26 Ivi, p. 249.<br />
27 Carlo Sgorlon, L’Alchimista degli strati, cit., p. 192.<br />
75
Lo Sgorlon tedesco<br />
di Luigi Reitani<br />
Università degli Studi di <strong>Udine</strong><br />
Oggi parlerò di un aspetto particolare dell’opera di Carlo Sgorlon. Si tratta naturalmente di una<br />
prospettiva, come dire, eccentrica, una prospettiva insolita che parte da dati apparentemente marginali<br />
nell’opera di questo autore e che non affronta, invece, il centro della sua opera.<br />
Io non sono uno studioso di letteratura italiana, non sono un italianista, non sono nemmeno uno<br />
specialista di Sgorlon, e quindi la mia ottica è dunque un’ottica che parte da argomenti che magari a<br />
chi si è occupato a fondo di questo scrittore possono sembrare a prima vista argomenti e temi secondari,<br />
ma forse talvolta proprio una prospettiva particolare serve a mettere in luce aspetti e temi che poi<br />
risultano essere significativi.<br />
Devo dire che in questa mia ricerca – perché si è trattato in fondo di una ricerca – sono molto<br />
grado alla signora Edda Sgorlon che mi ha messo a disposizione con grande generosità tutta una serie<br />
di materiali, anche in parte inediti, che documentano il rapporto che Carlo ha avuto con la letteratura<br />
tedesca.<br />
Dunque, che cosa è stata la letteratura tedesca per Carlo Sgorlon? Che ruolo ha avuto nella sua<br />
opera? In che senso ci aiuta a capire i suoi romanzi, i suoi racconti, la sua poetica?<br />
Bene, l’incontro di Sgorlon con la letteratura tedesca è un incontro che risale agli anni universitari,<br />
quando appunto, come è stato ricordato, il giovane studente friulano della Normale di Pisa – siamo<br />
all’inizio degli anni ‘50 – decide di laurearsi con Giovanni Vittorio Amoretti. Decide di laurearsi con il<br />
professore di letteratura tedesca perché il professore di letteratura italiana, che era il grande Luigi Russo,<br />
gli appare una persona dagli scatti imprevedibili d’ira, e infatti era noto per le sue terribili sfuriate<br />
nella Normale, e anche Borghello ricorda episodi simili. Probabilmente c’era qualcosa di più di un’incompatibilità<br />
caratteriale, probabilmente c’era quella diffidenza che Sgorlon sentiva e che ha sempre<br />
espresso anche, come dire, verso un certo conformismo della cultura accademica e anche verso certe<br />
prese di posizione di carattere politico-culturale che Sgorlon non sentiva di condividere. Quindi, rispetto<br />
a Luigi Russo, che è orientato anche politicamente in un certo modo, che è schierato, Sgorlon preferisce<br />
guardare oltre, preferisce scegliere una materia in fondo non centrale, non cardine nel suo indirizzo di<br />
studi – studia letteratura, dunque nel piano di studi i suoi esami sono di letteratura – ma sceglie invece<br />
una materia, come si diceva allora, “complementare”: la letteratura tedesca. E si imbatte in questa<br />
grande figura che è Giovanni Vittorio Amoretti. Chi era Amoretti? Amoretti era, all’epoca, una delle figure<br />
più illustri della giornalistica italiana, aveva già una certa età: Amoretti era nato nel 1888 e morirà<br />
vecchissimo all’età di 96 anni, un vegliardo dell’accademia italiana ancora lucidissimo. Magris nel<br />
suo Microcosmi ricorda come Amoretti a 90 anni avesse iniziato a collaborare con un quotidiano, con<br />
«La Gazzetta di Parma», che era stata l’ultima delle sue collaborazioni, dopo aver iniziato a collabora-<br />
77
78<br />
re a «La Stampa» di Torino negli anni ‘20. Quindi una lunghissima carriera a suo tiro, e probabilmente<br />
molti di voi hanno a casa dei libri su cui compare nel frontespizio il nome di Amoretti, perché Amoretti<br />
era stato il curatore di una delle collane più illustri dell’editoria italiana, la collana degli scrittori stranieri<br />
della Utet: questi volumi che ancora oggi circolano, in cui furono stampati moltissimi classici di<br />
letterature straniere, e Amoretti ne era il curatore non solo per la sezione di letteratura tedesca, ma in<br />
generale. [questi volumi, in cui furono stampati moltissimi classici di letterature straniere, ancora oggi<br />
circolano, e Amoretti ne era stato il curatore non solo per la sezione di letteratura tedesca, ma in generale].<br />
Egli stesso aveva tradotto alcuni dei capolavori: c’è una sua edizione del Werther di Goethe e<br />
c’è soprattutto, uscita nel 1950, una sua versione integrale del Faust e della prima versione del Faust.<br />
Un’edizione che poi, in versione tascabile da Feltrinelli, ha continuato e continua ad avere una lunga vita,<br />
e si trova tutt’ora in commercio. Quindi molti hanno conosciuto Goethe, e il Faust in particolare, nella<br />
traduzione di Amoretti. Dunque una figura all’epoca illustre, un vegliardo degli studi di letteratura in<br />
Italia, persona, come lo dipinge Magris, anche di una certa ironia, molto simpatica: Magris scrive che,<br />
ricoverato all’ospedale delle Molinette di Torino, all’età di 96 anni, fa pervenire a Magris un biglietto<br />
in cui dice: “Se mi dovesse capitare qualcosa, beh, la prego di ricordarsi di me sulle pagine del «Corriere<br />
della Sera»”. Magris, infatti, pubblicherà questo biglietto molto autoironico quando poi in effetti<br />
l’evento previsto da Amoretti si verifica. Dunque, è un grande degli studi della letteratura, non soltanto<br />
della germanistica, un grande traduttore, un giovane studente friulano.<br />
E che cosa propone questo giovane studente al grande studioso di letteratura? Propone, nientemeno,<br />
di fare una tesi sull’opera di Kafka. La signora Edda mi ha raccontato poco fa che, tra l’altro,<br />
c’è stato un percorso abbastanza complicato prima di arrivare a questa tesi, perché prima Sgorlon si rivolge<br />
al professore di storia dell’arte. Gli dice: “Io dovrei fare una tesi in tedesco”, allora il professore<br />
di storia dell’arte dice: “Dimostrami di sapere prima la lingua”, e gli fa tradurre un libro, che poi sarà<br />
pubblicato da Einaudi nel ‘61. È un libro di storia dell’arte, un libro di un grandissimo nome della storia<br />
dell’arte, Julian von Schlosser, e questo suo libro sull’arte medioevale esce appunto qualche anno<br />
dopo, nel ‘61, da Einaudi. Non sarà peraltro l’unica traduzione di Sgorlon dal tedesco: Sgorlon traduce<br />
anche gli scritti di estetica di Fiedler. E dunque cosa propone il giovane studente, con una certa ribers/<br />
ribris (perché, si sa, gli studenti, quando cercano un oggetto di tesi, in genere non si accontentano di<br />
studiare i piccoli autori, ma arrivano sempre con grandi proposte)? Chiede di scrivere nientemeno che<br />
una tesi su Franz Kafka, e guardate che non è una cosa da poco, perché già in quel momento Kafka –<br />
siamo nel ‘52 – non è soltanto [è un] un nome che fa tremare le vene ai polsi per la complessità dell’opera,<br />
e all’epoca non la si conosceva ancora tutta: si conoscevano le versioni, le lezioni che Max Brod<br />
aveva dato dei suoi tre grandi romanzi pubblicati postumi (sapete che Kafka voleva che fossero bruciati,<br />
e questo suo amico praghese invece insiste, o meglio, dopo la morte contro la volontà dell’autore pubblica<br />
Il processo, Il castello e l’altro romanzo che ha il titolo nell’edizione di Brod America, e che oggi<br />
noi più correttamente chiamiamo Disperso sulla base del manoscritto originale). Ma in quel momento,<br />
negli anni ‘50, Kafka lo si conosce attraverso Max Brod per questi tre grandi romanzi, e per gli altri racconti<br />
che Kafka aveva pubblicato in vita, La metamorfosi, Il verdetto e Il medico in campagna, e poi per<br />
i racconti trovati nel lascito, prima di tutti La tana, su cui ritornerò, che è uno dei racconti a cui Sgorlon è<br />
più affezionato. Dunque un grande autore di una complessità enorme, di una ricchezza anche stilistica.<br />
E che cosa c’è da scoprire in questo autore in quel momento? Intanto pensate che Kafka è diventato<br />
il nume tutelare di tutto un movimento, di tutta una generazione di nuovi scrittori, anche di una<br />
nuova filosofia: la nuova letteratura e la nuova filosofia europea trovano in Kafka un punto di riferimento<br />
fondamentale, e Camus soprattutto aveva fatto di Kafka il grande vessillo. Quindi se si parla di esistenzialismo,<br />
se si parla di una nuova letteratura negli anni ‘50 è inevitabile imbattersi nel nome di Kafka, e
quindi a Kafka Sgorlon si rivolge. È affascinato dalla scrittura di questo autore, e su Kafka Sgorlon dunque<br />
scrive la sua tesi di laurea con il titolo Kafka narratore. Può sembrare un titolo banale, ma non lo è.<br />
Perché non è banale questo titolo? Perché mette l’accento su qualcosa: non è il Kafka esistenzialista,<br />
non è Kafka come uomo, quindi non si tratta di una biografia di Kafka o di un’analisi psicologica di Kafka,<br />
ma si tratta invece di mettere l’accento sui racconti e sui romanzi, anche sulla tecnica di scrittura di<br />
Kafka, e dunque è un approccio che già individua all’interno dell’opera un tema particolare.<br />
Questa tesi esce qualche anno dopo, non venne pubblicata subito, uscirà nel 1961 da una casa<br />
editrice abbastanza importante, Neri Pozza: la tesi piacque, ebbe la dignità di stampa, quindi Sgorlon<br />
poté pubblicarla. Ma questa tesi apre anche le porte a Sgorlon per una borsa di studio in Germania,<br />
dove il giovane studente, venuto da Cassacco e andato a Pisa, arriva nel 1953 – credo esattamente, da<br />
quello che si intuisce leggendo la sua autobiografia La penna d’oro, nel semestre invernale del 1952<br />
e nel semestre estivo del 1953 – e arriva a Monaco di Baviera. Siamo soltanto qualche anno dopo la<br />
guerra, la Germania è la Germania che sta uscendo fuori dagli anni della ricostruzione, è la Germania<br />
che presto entrerà nel cosiddetto “miracolo economico”, è una Germania dove i rapporti con l’Italia non<br />
sono ancora ben chiari e definiti, dove ci sono molti stereotipi degli italiani, dove gli italiani qualche<br />
volta vengono visti come dei latin lover, qualche volte vengono visti come dei traditori dal punto di vista<br />
storico, dove c’è attrazione ma anche diffidenza verso l’Italia. E in questa città, che è una città anche<br />
con un passato letterario illustre (è la città di Thomas Mann, in effetti quella dove Thomas Mann,<br />
dopo essere nato a Lubecca, ha vissuto negli anni ‘20), è una città in cui il giovane Sgorlon compie due<br />
semestri di studio. E qui ci sono altre letture che l’influenzano. Allora è particolarmente interessante<br />
vedere come nella sua autobiografia, molti anni dopo, ne La penna d’oro, che come sapete è uscita 2<br />
anni fa, Sgorlon rievochi tutto questo momento: l’incontro con Amoretti, la tesi di laurea su Kafka, l’anno<br />
in Germania, la scoperta di altri autori tedeschi. Due anni densi di avvenimenti, un inizio potenziale,<br />
perché no?, di una carriera come giornalista, perché un laureato della Normale di Pisa che fa un anno<br />
con una borsa di studio in Germania potrebbe essere avviato su questa strada, un anno di scoperte intellettuali,<br />
un anno in cui si maturano molte cose.<br />
Cosa rimane, dopo molti anni, di questa esperienza di Sgorlon, ce lo legge adesso Titti Bisutti<br />
da La penna d’oro:<br />
Decisi di non laurearmi in letteratura italiana, perché il professore di quella materia era un grande critico, ma<br />
facile all’ira e alle sfuriate. Perciò ripiegai sulla letteratura tedesca, dove il professore Vittorio Amoretti, molto più trattabile<br />
e umano, mi lasciò scegliere un autore difficile ma appassionante come Franz Kafka. La tesi ebbe molti consensi, la<br />
lode e la dignità di stampa, e infatti fu pubblicata pochi anni dopo dall’editore Neri Pozza.<br />
L’anno successivo ottenni una borsa di studio annuale in Germania, a Monaco di Baviera. Il mio scopo era quello<br />
di apprendere bene il tedesco, ma purtroppo la struttura della mia mente non era della qualità migliore per imparare<br />
le lingue.<br />
A Monaco gli studenti tedeschi, come pure gli amministratori e i professori, non avevano ancora dimenticato che<br />
l’Italia era stata alleata della Germania e poi l’aveva ‘tradita’, concludendo un armistizio con gli alleati, e quindi dichiarandole<br />
guerra. Ricordi di quel genere sono difficile da smaltire dovunque, e in particolare da quelle parti. Spesso i tedeschi<br />
erano molto formali e ignoravano toni e modi espressivi ambigui, come l’ironia, l’umorismo, il sarcasmo, la parodia,<br />
la cèlia, mentre alla Scuola Normale essi erano assolutamente dominanti in tutti i rapporti umani.<br />
Andavo a teatro, ai concerti, che tra l’altro in Germania costano pochissimo agli studenti, ma cominciai a dedicarmi<br />
alle passioni di sempre, la pittura e la letteratura. I risultati del mio lavoro non mi entusiasmavano, e iniziai ben<br />
presto a rendermi conto che non era sufficiente amare le arti; bisognava anche impararne il ‘mestiere’ in modi eccellenti.<br />
I due semestri trascorsi in Germania furono certo decisivi per le mie scelte future. Avrei fatto lo scrittore, anzi il<br />
narratore, perché in pittura restavo sempre troppo legato all’imitazione di altri artisti, come De Chirico e Carrà, e dubitavo<br />
di possedere una disposizione istintiva, forte e autentica.<br />
Con gli studenti tedeschi mi recavo nelle birrerie e nei locali pubblici, per cantare con loro al suono delle orche-<br />
79
80<br />
strine che eseguivano la Biermusik. Sui Theresienwiesen vidi l’Oktoberfest, e il gusto di scatenarsi, in occasioni precise,<br />
che caratterizza i tedeschi e in particolare in bavaresi. Giovani signore, madri di famiglia, che per tutta l’annata si dedicavano<br />
alle tre famose ‘K’ tradizionali della donna tedesca – Kirche, Küche, Kinder – sembravano diavolesse dell’eros, in<br />
costumi succinti, calze di rete e reggicalze vertiginosi. V’è una cospicua tendenza all’orgia erotica nei tedeschi, mentre<br />
io già allora consideravo l’eros sempre più come un fatto privato, intimo, sacrale, in cui agiscono sentimenti e istinti che<br />
rappresentano aspetti universali del mondo e della sua essenza misteriosa. L’eros esibito,e soprattutto quello che si rivelava<br />
nelle feste collettive, mi respingeva decisamente.<br />
Notai che per me vivere era più difficile che per gli altri, perché ero un potenziale scrittore, nato più per osservare<br />
e raccontare la vita che per aderirvi con immediatezza. Capii definitivamente questo lato di me stesso durante il carnevale<br />
del 1953, il famoso Fasching, quando tutta la città, e i giovani in particolare, si abbandonano al divertimento più<br />
sfrenato. In quella città di Baviera, dicono le statistiche maliziose, nove mesi dopo il Carnevale le nascite dei bambini<br />
conoscono una cospicua impennata.<br />
Io tentati di inserirmi nel clima chiassoso universale, ma con la sensazione di uscire da me stesso e di seguire<br />
un binario che non mi apparteneva. Non ero nato per divertirmi, e meno che mai per abbandonarmi alla trasgressione. Per<br />
me erano fatti innaturali. Così voltai le spalle al Carnevale, e tornai nella mia camera del Maximilianeum, il collegio universitario<br />
che mi ospitava, a leggere i miei autori prediletti. Tra essi v’era soprattutto Thomas Mann. Quando lessi Tonio<br />
Kröger ebbi una sorta di rivelazione, perché Tonio ero io. Era mio fratello gemello. 1<br />
Sgorlon va a Monaco fresco di una tesi su Kafka e trova ad aspettarlo, invece, un altro autore<br />
di lingua tedesca, in qualche modo opposto a Kafka, cioè Thomas Mann. In queste pagine è come<br />
se noi avessimo una specie di percorso che parte da Kafka e arriva a Mann, delineato questo percorso<br />
in estrema sintesi. Ora, la cosa interessante è che Sgorlon dedica a questa esperienza monacense,<br />
in fondo, due pagine della sua autobiografia, abbastanza ricche di dettagli e particolari. E chi ha letto<br />
La penna d’oro sa che in realtà La penna d’oro non è un’autobiografia molto generosa da questo punto<br />
di vista, anzi è un’autobiografia abbastanza vaga nel fornire notizie su che cosa Sgorlon ha fatto, sui<br />
momenti di vita esteriore. Si tratta in un certo senso di una biografia interiore, cioè del delineare un<br />
percorso personale, un percorso di maturazione spirituale, molto spazio è dedicato ai libri: in qualche<br />
modo questa autobiografia è anche un compendio dell’opera di Sgorlon perché su ogni su opera si dice<br />
qualcosa. Ma poco si dice, invece, sui fatti personali: per esempio, su alcuni avvenimenti privati, il<br />
matrimonio, si dice pochissimo. E due pagine su questa esperienza monacense rivelano che questa è<br />
stata in realtà abbastanza importante.<br />
Il Carnevale di Monaco del 1953: quali tracce ha lasciato questo Carnevale all’interno dell’opera<br />
di Sgorlon? Se ci fate caso, Carnevale appare in diversi luoghi dell’opera. Anche ne Il trono di legno<br />
in un certo momento si parla del Carnevale, e c’è un’opera inedita di Sgorlon che aveva il titolo Il<br />
grande Carnevale<br />
(dal minuto 31:21 a 31:25 manca l’audio)<br />
e da questo Grande Carnevale e l’esperienza del carnevale di Monaco del 1953.<br />
In che senso questa esperienza biografica diventa, per così dire, un archetipo, un momento che<br />
poi genera altri racconti? Queste pagine di Sgorlon ci dicono appunto che c’è qualcosa in lui che lo porta<br />
non solo a scoprire Thomas Mann, ma anche a identificarsi perfino in una delle sue figure, che è quella<br />
di Tonio Kröger. E questo è molto interessante. Chi è il Tonio Kröger in cui Sgorlon può identificarsi? Chi<br />
ha letto questo stupendo racconto di Thomas Mann, sa che Tonio Kröger è l’artista, l’artista opposto<br />
e complementare alla vita, il sognatore, colui che non riesce a integrarsi nella società, ma che ha bi-<br />
1 Carlo Sgorlon, La penna d'oro, <strong>Udine</strong>, Morganti editori, 2010, pp. 41-43.
sogno per la sua poesia, in qualche modo, di esserne separato, di essere staccato dalla società. E, per<br />
usare un famoso binomio e una famosa dicotomia di Schiller a cui lo stesso Mann spesso si riferisce, è<br />
l’“uomo sentimentale”, non è l’uomo ingenuo, non è l’uomo che aderisce alla realtà, ma è l’uomo che<br />
invece si sente separato dalla realtà. E questo è il Kröger, il Tonio come lo leggiamo all’inizio del racconto,<br />
che non riesce ad appassionarsi delle storie dei cavalli, non riesce ad appassionarsi di sport, di<br />
equitazione, ma che invece preferisce leggere, cioè preferisce l’arte, la letteratura alla vita. Preferisce<br />
il mondo delle idee al mondo della cruda realtà. È un sognatore, vive nel mondo della musica. Non è<br />
soltanto questo, perché poi Tonio Kröger trova nella sua maturazione un equilibrio, riesce a modo suo a<br />
oltrepassare questa barriera, questo confine che lo separa dalla realtà, riesce a ritrovare un suo modo<br />
di vivere la realtà della vita. E dunque c’è una ricomposizione di questa frattura originaria, ma avviene<br />
attraverso l’arte, non avviene attraverso l’esperienza di vita. Che Sgorlon si identifichi in un personaggio<br />
simile è abbastanza interessante.<br />
Ma facciamo un passo indietro: che cosa aveva trovato Sgorlon in Kafka? Quali erano gli elementi<br />
che aveva sottolineato? Come leggeva Kafka lo studente friulano? La lettura che Sgorlon dà di<br />
Kafka è una lettura in quel momento, per alcuni versi, abbastanza diffusa. Kafka è per Sgorlon il creatore<br />
di un mondo con leggi proprie (Sgorlon parla di un “eterocosmo”, cioè di un cosmo che ha leggi<br />
proprie), è soprattutto l’autore di un mondo che non è interpretabile con la logica umana, un mondo<br />
dove la ragione viene fuori sconfitta, dove c’è uno scacco della logica tradizionale, dove c’è uno<br />
scacco dell’individuo con la sua soggettività, con il suo pensiero, con il suo logos. Di fronte a questo<br />
mondo enigmatico e misterioso, la ragione fallisce. Questa è una lettura abbastanza diffusa dell’opera<br />
di Kafka che viene fatta in quegli anni. Ma in Sgorlon c’è la sottolineatura che si tratta, appunto,<br />
di uno scacco della ragione: si può mettere l’accento sul mondo, sull’assurdità del mondo, ma si<br />
può mettere anche l’accento sul fatto che è la nostra ragione a non essere in grado di spiegare gli<br />
enigmi e, per così dire, la complessità del mondo. Si può andare in una direzione o nell’altra, e Sgorlon<br />
decisamente va in questa seconda direzione, cioè quella di mettere l’accento sulla inadeguatezza<br />
della ragione umana nel capire la complessità del reale, che resta un mistero. E poi ci sono delle<br />
pagine particolarmente interessanti in quest’opera su Kafka narratore, che allora è anche una delle<br />
prime a essere pubblicate in Italia su Kafka. Ancora [non era stata pubblicata] la grande monografia<br />
di Giuliano Baioni, che segna la nascita in Italia di un interesse scientifico per l’opera di Kafka. Baioni<br />
è stato un grande germanista, insegnando per molti decenni letteratura tedesca, da ultimo a Ca’<br />
Foscari a Venezia: su Kafka ha scritto due monografie, e la prima monografia di Baioni su Kafka cita<br />
anche Sgorlon, cita spesso anche un passo in particolare. Sgorlon quindi lo cita [viene citato] come<br />
uno studio di germanistica.<br />
E quali sono anche gli aspetti tecnici che Sgorlon mette in evidenza? Per esempio, il fatto che<br />
nell’opera di Kafka spesso ci siano delle situazioni in cui l’intimità dei personaggi viene violata, delle<br />
situazioni in cui i personaggi si trovano improvvisamente ad avere nel proprio spazio altre persone di<br />
cui non si sono rese conto. “Un senso” ̶ scrive Sgorlon – “di impunità violata, di molestia dovuta alla<br />
presenza di misteriosi occhi estranei percorre spesso le pagine kafkiane.” 2 Questo è un elemento<br />
che colpisce molto il futuro scrittore friulano. Ora se pensate a La poltrona, cioè il primo dei romanzi<br />
di Sgorlon, vi renderete conto di come proprio questo elemento ricorra frequentemente, questo elemento<br />
dell’intimità violata, fin dalla scena in cui il protagonista si trova in un cortile e pensa di essere<br />
osservato da occhi che sono celati dietro le varie serrande. Questa è una scena tipicamente kafkia-<br />
2 Carlo Sgorlon, Kafka narratore, Venezia, Neri Pozza editore, 1961, p. 16.<br />
81
82<br />
na, così come molte altre nel corso del romanzo: l’idea che non siamo soli, che c’è qualcosa che ci<br />
molesta. Spesso ci sono queste figure, appunto, anche nel racconto di Sgorlon, che improvvisamente<br />
provocano un’irruzione nel quotidiano di elementi grotteschi, di elementi quasi surreali. Questa è una<br />
tecnica usata costantemente da Sgorlon. Ma ancora di più si ritroveranno questi elementi nel secondo<br />
libro di Sgorlon, La notte del ragno mannaro, secondo libro ad essere riconosciuto da Sgorlon, perché<br />
il primo libro del ’58, Un’aurora per Penelope, in realtà Sgorlon lo disconosce, tanto che non ne parla<br />
nella sua Penna d’oro, non si troverà traccia di questo libro (non c’è nemmeno nella Biblioteca Joppi),<br />
ed è un libro che Sgorlon definisce un errore. Sarebbe interessante capire perché viene definito un errore:<br />
cosa c’è in questo libro? Ovviamente per quei curiosoni che sono gli studiosi di letteratura questa<br />
è materia abbastanza ghiotta. Ma nel secondo libro, dicevo, che viene riconosciuto da Sgorlon, La<br />
notte del ragno mannaro, questa situazione di un “eterocosmo”, cioè di un mondo che ha le sue leggi,<br />
che ha le sue regole, che è diverso da quello che è il nostro mondo reale, ma che in realtà coincide<br />
con il nostro mondo reale (e questa è una <strong>Udine</strong> misteriosa), si presenta palesemente. Quindi i primi<br />
due romanzi sono di matrice e di impianto abbondantemente kafkiano. Certo, non senza una qualche<br />
autoironia, non senza un certo giocare anche con le proprie conoscenze di letteratura tedesca: la pagina,<br />
diciamo, più comica da questo punto di vista ne La poltrona è quando il protagonista cerca un libro<br />
che non trova, che è finito chissà dove, e la cui lettura non va avanti, su cui si inceppa continuamente;<br />
e questo libro è L’uomo senza qualità di Musil, di cui si parla come di un libro dove appunto non si<br />
riesce ad andare avanti, un’esperienza che hanno fatto moltissime persone. E qui c’è una certa ironia<br />
nel descrivere la propria esperienza come germanista nella lettura di un libro così impegnativo come<br />
L’uomo senza qualità di Musil. Ma questo è un lato del suo ragionamento su Kafka. La cosa interessante,<br />
però, è che il confronto di Sgorlon con Kafka nasce come un confronto di uno scrittore verso un<br />
altro scrittore. C’è già il tentativo di un superamento delle posizioni di Kafka nel suo libro. E da questo<br />
punto di vista è interessante vedere che c’è una costante in Sgorlon, perché quando si occupa di<br />
altri autori, come abbiamo sentito anche nel caso di Pasolini (in realtà Borghello usava l’espressione<br />
di “corpo a corpo”), si tratta sempre di un confronto diretto in cui l’autore cerca di assimilare le posizioni<br />
dell’altro, ma anche di superarle, di andare avanti. E questo avviene anche nell’opera di Kafka.<br />
Qui non è più il critico che parla, ma alla fine di quest’opera parla lo scrittore, e ne parla nel modo in<br />
cui adesso sentiremo:<br />
Molti aspetti del pensare e vivere contemporaneo trovano nell’opera di Kafka una sintesi agghiacciante. Nonostante<br />
gli sforzi di alcune filosofie ottimistiche, fondate sull’uomo, il nostro mondo pare straziato da isterismi, angosce,<br />
ritorni di barbarie, terrori di distruzioni apocalittiche, senso di estrema precarietà dell’esistenza; è caratterizzato da<br />
strutture disumane, dalla sfiducia nella ragione, dall’insofferenza della norma, dalla mancanza di dialogo e di senso delle<br />
cose, dalla «disponibilità» non illuminata che può sfociare nel gesto gratuito, nella violenza e nella barbarie organizzata.<br />
Anche il motivo centrale dell’opera di Kafka, ossia l’impotenza della ragione e l’impossibilità di approdare a una soluzione<br />
qualsiasi e fermarsi in essa, è in fondo espressione indiretta ma potente del senso di precarietà spirituale del nostro<br />
tempo, dell’accavallarsi disordinato e a volte frenetico delle ipotesi e delle soluzioni, dal quale non può seguire che disagio<br />
spirituale irrimediabile.<br />
Tutti questi aspetti rendono l’opera di Kafka tragicamente attuale e inducono a considerare non del tutto paradossale<br />
l’opinione dello Anders, che Kafka sia uno dei pochi poeti veramente realisti del nostro tempo.<br />
Ma ad un esame più obbiettivo quest’opinione pare eccessiva e forse anche inattuale.<br />
Il nostro tempo, è vero appare tragico e dominato dall’irrazionalismo; ma in fondo ogni tempo è stato tragico, e<br />
può darsi che oggi la tragicità della «condizione umana» sia aumentata dalla maggiore consapevolezza che l’uomo ne ha.<br />
La tragedia del nostro tempo ci pare soprattutto di natura soggettiva, intellettuale e sentimentale. Non pochi indizi però<br />
rendono sperabile che l’umanità sappia ritrovare un nuovo equilibrio e una nuova serenità. Molti uomini di buona volontà<br />
lavorano per l’edificazione di un nuovo umanesimo, per un ritorno all’uomo reintegrato nella usa dignità, nella misura,
nella semplicità e pienezza delle sue risorse intellettuali e sentimentali. Forse non è lontano il tempo in cui Kafka diventerà<br />
un poeta di interesse non più attuale ma storico solamente. 3<br />
È abbastanza evidente che qui non parla più un critico germanista, ma parla lo scrittore, è lo<br />
scrittore che vuole superare questo tempo e che pensa a una nuova epoca in cui Kafka diventerà soltanto<br />
un autore con una qualità storica. Non sono queste parole più che appartengono alla critica letteraria<br />
[Sono parole che non appartengono più alla critica letteraria], sono parole invece che quasi preannunciano<br />
un manifesto di poetica di un nuovo umanesimo. E quindi in questa opera si forgia, dunque,<br />
non il critico germanista Sgorlon, ma si forgia lo scrittore Sgorlon, che infatti dice di aver trovato la sua<br />
vocazione di scrittore nel periodo successivo alla Germania.<br />
In realtà, il confronto con Kafka sarà un confronto serrato e per tutta la vita, perché Sgorlon<br />
ritornerà su Kafka in diverse occasioni, sempre molto puntuale, con articoli, con recensioni (per esempio,<br />
ancora negli anni ’80 la recensione del libro di Citati su Kafka), anche in occasioni polemiche in<br />
cui utilizza degli assunti kafkiani, e anche per alcuni progetti editoriali, il più importante dei quali è la<br />
postfazione al romanzo America, uscito nel 1981. Ma c’è anche un progetto, poi non andato in porto,<br />
molto interessante – devo queste indicazioni alla cortesia della signora Edda – perché la casa editrice<br />
Mondadori, in un certo momento – siamo nel ‘75-’76 – decide di realizzare un’audiocassetta, quindi un<br />
libro audio, con un racconto di Kafka, e affida il compito di una riduzione di questo racconto proprio a<br />
Sgorlon. L’allora direttore editoriale di Mondadori, il poeta Vittorio Sereni, chiede a Sgorlon di realizzare<br />
un’audiocassetta con il racconto di Kafka. E quale racconto propone Sgorlon? Propone La tana, che è<br />
un racconto dei più suggestivi, in cui un animale (non si riesce a identificare, non sapremo esattamente<br />
chi è) costruisce un proprio spazio, costruisce un proprio luogo geometrico nel quale si difende e si<br />
nasconde. Già nella tesi di laurea questo racconto viene considerato come un racconto centrale per la<br />
comprensione della poetica di Kafka. Ora Sgorlon non solo riduce questo racconto, ma credo anche che<br />
lo traduca, perché il manoscritto che ho potuto visionare sembra una traduzione diversa da tutte quelle<br />
altre che ci sono in quel momento in giro del racconto di Kafka. Quindi c’è un corpo a corpo che continua<br />
negli anni. Si potrebbe dire che il fantasma di Kafka accompagni Sgorlon fino alla tarda età, anche<br />
perché poi i luoghi kafkiani, Praga ad esempio, ritornano fin dai titoli nei suoi romanzi. Dunque questo<br />
interesse nato con la tesi di laurea si potrebbe considerare poi una traccia sotterranea che produce un<br />
impulso costante a fare i conti con questi, come dire, fantasmi kafkiani, con il fantasma dell’angoscia,<br />
con il fantasma di un mondo irrazionale, con lo scacco della ragione di fronte all’incomprensibilità del<br />
mondo. Ma nello stesso tempo Sgorlon ne ha fatto una sfida, la sfida di un nuovo umanesimo. È come<br />
per venire a una nuova poetica che superi questa poetica kafkiana. E, abbiamo sentito, qui c’è l’apertura<br />
ad un nuovo orizzonte dovuta a un altro grande tedesco che è Thomas Mann. E non sarà soltanto il<br />
Thomas Mann di Tonio Kröger, e non sarà ovviamente soltanto il Thomas Mann dei primi romanzi, del<br />
Buddenbrook. Sarà soprattutto il Thomas Mann della grande tetralogia Giuseppe e i suoi fratelli: un’opera<br />
colossale, sono oltre 2500 pagine, ispirata al rapporto biblico, e in cui Thomas Mann, negli anni<br />
’20 e ’30, prima e dopo il suo esilio dalla Germania nazista nel 1933, si misura con il grande testo biblico,<br />
con la storia anche dell’ebraismo; ma si è occupato a fondo anche di problemi di psicologia del profondo,<br />
e ha anche uno spiccato interesse verso Jung, verso il mito e verso l’archetipo (c’è un carteggio<br />
con Kerényi, uno studioso ungherse del mito), c’è un interesse verso la psicologia junghiana. Ora, che<br />
cosa impressiona Sgorlon di questa grande psicologia? Qui c’è uno scritto molto interessante sulla te-<br />
3 Ivi, pp. 110-111.<br />
83
84<br />
tralogia di Giuseppe e i suoi fratelli, che appare in una rivista, dopo essere stato in parte stampato su<br />
dei quotidiani: si tratta di un saggio abbastanza lungo dal titolo Nel pozzo del passato (è una citazione<br />
della prima parte della tetralogia di Mann), e questo saggio esce nel ‘75- ‘76 su «<strong>Cultura</strong>», una rivista<br />
udinese edita dalla Scuola Cattolica di <strong>Cultura</strong> di <strong>Udine</strong>. Siamo in un momento (ma probabilmente, per<br />
quanto riguarda la riduzione, il testo è stato per lo meno elaborato due anni prima), siamo in un momento<br />
centrale, nella svolta della poetica e della narrativa di Sgorlon; siamo in quel momento di passaggio<br />
che porta dai personaggi nevrotici dei primi romanzi, da quelli appunto de La poltrona e de La<br />
notte del ragno mannaro, ai personaggi de Il trono di legno, ma soprattutto ad una diversa concezione<br />
del mondo e del cosmo.<br />
E che cosa trova questa volta Sgorlon in Mann? Trova, a mio avviso, due cose fondamentali: la<br />
prima, che i personaggi sono declinazione di archetipi, cioè che i personaggi non sono delle individualità,<br />
ma risalgono in sostanza a figure che sono figure non storiche, non individuali, non soggettive, ma<br />
eterne. I personaggi, noi stessi in fondo, siamo declinazioni di grandi archetipi, grandi figure con delle<br />
determinate funzioni, con determinati sentimenti e psicologie. E la seconda cosa che trova è l’idea di<br />
un vivere nel mondo che non segue l’ambizione, la logica della comprensione razionale a tutti i costi<br />
del mondo, perché il mondo è incomprensibile – questo ce l’ha insegnato Kafka. Ma allora se il mondo<br />
è incomprensibile, qual è l’atteggiamento da avere verso il mondo? L’atteggiamento, questo quello che<br />
a mio avviso Sgorlon trova in Mann, è quello di avere la fiducia invece, l’apertura verso il mondo, verso<br />
leggi segrete e non rivelabili che determinano il governo nel mondo, a cui occorre abbandonarsi. Non<br />
occorre cercare, insomma, di capire il mondo, ma lo sforzo deve essere fatto nell’accettare una propria<br />
esistenza all’interno del mondo. Questo è un passaggio decisivo e questo passaggio, il salto, lo scatto,<br />
è determinato – e questa è la mia tesi – dalla lettura di questa grande opera di Thomas Mann. E in<br />
effetti, al di là di questi scritti di Mann, che sono molto interessanti, e che peraltro non coprono tutto<br />
ciò che Sgorlon ha scritto sulla letteratura tedesca, [Questi scritti di Mann sono molto interessanti, per<br />
altro non coprono tutto ciò che Sgorlon ha scritto sulla letteratura tedesca] perché ci sono anche altri<br />
interventi oltre a Kafka e a Mann: Sgorlon si era occupato, ad esempio, di un autore a lui quasi contemporaneo,<br />
cioè di Heinrich Böll, autore che, come sapete, poi fu insignito del premio Nobel, l’autore<br />
della Germania del dopoguerra. E anche a Böll Sgorlon dedica delle pagine molto interessanti in quel<br />
momento, sempre su questa rivista udinese. Qui mette in luce alcune cose a mio avviso ancora oggi<br />
molto esatte: intanto parla di quanto la Germania sia cambiata, parla del cattolicesimo di Böll, ma anche<br />
del suo antidogmatismo, parla del suo essere un outsider, fuori dagli schemi. Insomma è una lettura<br />
molto interessante e molto puntuale dell’opera di Böll, che viene fatta in particolare di uno dei suoi<br />
romanzi più noti, Opinioni di un clown. E quindi, dicevo, in qualche modo questo interesse germanistico<br />
di Sgorlon continua negli anni, non si ferma a Kafka e non si ferma nemmeno a Thomas Mann, ma<br />
non c’è dubbio che questa lettura di Thomas Mann sia fondamentale e i segni si trovino in moltissime<br />
sue opere, e sono segni nascosti, un po’ sotto traccia, delle cose che non si notano magari a prima vista,<br />
ma che ci sono.<br />
Uno di questi segni sicuramente è una delle opere più ambiziose dell’ultimo Sgorlon, che è Il<br />
velo di Maya, e che è una sorta, secondo me, di inversione programmatica del Doctor Faustus di Thomas<br />
Mann, che, come forse sapete, è un grande romanzo di Mann, in cui c’è una sorta di patto con il<br />
diavolo di un compositore che per trovare la sua vena creativa, appunto, stringe un patto col diavolo, e<br />
viene adombrata in questo romanzo anche la figura del fondatore della dodecafonia, Arnold Schönberg.<br />
E qui Mann parla della nuova musica, parla della dodecafonia, parla della musica atonale, ed è un romanzo<br />
che problematizza anche la musica del ‘900. Ora, per Sgorlon questo romanzo è un problema. È<br />
un problema perché Sgorlon lo riteneva essere un romanzo che non collimava con la sua idea dell’opera
di Mann. E in qualche modo Il velo di Maya è una sorta di risposta, se volete anche un po’ ingenua, al<br />
Doctor Faustus, perché qui c’è un personaggio che non fa nessun patto, che non cerca sperimentalismo,<br />
che non cerca nuove geometrie musicali, ma che nella riscoperta della musica popolare ridà, invece,<br />
come dire, ispirazione e autenticità alla musica. Se si tiene presente questo sfondo del Doctor Faustus,<br />
la lettura de Il velo di Maya è, credo, abbastanza diversa da quella che può essere una prima lettura.<br />
Dunque veramente un romanzo programmatico. E infatti Sgorlon ci teneva molto, lo considerava, almeno<br />
è quello che si dice ne La penna d’oro, una delle sue opere più significative.<br />
Ma delle tracce della lettura di Thomas Mann si ritrovano anche in uno dei romanzi più programmatici<br />
di Sgorlon. Un po’ tutti i romanzi di Sgorlon tematizzano anche il problema dello scrivere,<br />
il perché si scrive, il perché si narra, il perché si è artista. Ma Il regno dell’uomo è un romanzo che in<br />
particolare tratta di questo. C’è un’ambientazione anche particolare, milanese, c’è un personaggio che<br />
ricalca il personaggio dell’editore Feltrinelli in un modo, direi, assolutamente palese, anche qui forse un<br />
po’ ingenuo, ma Il regno dell’uomo è un romanzo in cui si parla in modo sotterraneo di Thomas Mann.<br />
Non si parla in realtà di Thomas Mann, ma si parla di due personaggi di Thomas Mann, cioè di Hans<br />
Castorp (da 1.02’.31” a 1h.02’.34” sparisce audio) ... personaggio di cui si parla è, guarda caso, Giuseppe<br />
il Nutritore, cioè il personaggio fondamentale della tetralogia di cui parlavamo prima. Questi due<br />
personaggi sono i personaggi in cui il protagonista de Il regno dell’uomo si identifica, si sente uno di<br />
loro. Così come il giovane Sgorlon a Monaco si identifica in Tonio Kröger, il personaggio palesemente<br />
autobiografico, che è in parte?? Sgorlon, ne Il regno dell’uomo si identifica nei più tardi personaggi di<br />
Thomas Mann. E qui ascoltiamo un terzo passo da Il regno dell’uomo:<br />
Cominciò a scrivere un romanzo, una storia ambientata una sessantina di anni prima, piena di colori, sapori,<br />
suoni, sentimento del mondo, ma anche di risonanze metafisiche e di spessori cosmici. Quando lo rilesse, molti mesi dopo<br />
averlo finito, gli parve di aver sottomano il libro di un altro, che gli comunicava l’impressione di un grande aumento<br />
di vitalità.<br />
Si sentiva che era un libro scritto in uno stato di grazia e di ispirazione, anche se quelle erano parole oggi proibite,<br />
che nessuno poteva usare, se non col rischio di vedere fiorire dei sorrisi intorno a sé. Ma era così. Era verissimo.<br />
Lo stato di grazia esisteva, e lui, scrivendo quel libro, si era sentito come un mezzo usato da una forza più vasta di lui.<br />
Com’era possibile? Non lo sapeva. L’autore era lui, ma non lui soltanto, perché Basilio non si era fatto da sé, ma al contrario<br />
era il risultato di un’evoluzione infinitamente complessa della vita, che a sua volta era un’evoluzione dell’energia<br />
cosmica senza fine.<br />
Capì subito che, anche come scrittore, era un’anomalia preoccupante, del tutto fuori dagli schemi. La cultura<br />
moderna non prevedeva individui come lui. Non raccontava il disagio, l’ansia, ossia la sua età, perché lui non sentiva angoscia<br />
nella compagine e negli strati molteplici dell’io. Anche come scrittore era simili ad Hans Castorp e a Giuseppe il<br />
Nutritore. Si mise in sospetto. Diffidò del suo libro, di se stesso e della sorte amica e compiacente. Era evidente che stava<br />
facendosi beffe di lui, ed era occupata a edificare attorno a Basilio i lineamenti di un uomo ridicolo. Ma non riusciva a<br />
manipolare il suo racconto, perché non poteva ingannare se stesso, né essere quello che non era.<br />
Non poteva mutare perché la storia che aveva scritto produceva l’effetto di piacergli. Mandava un suono che<br />
durava a lungo, come una campana di bronzo. Per scriverla era ricorso a strane alchimie, bizzarrie storiche, mescolato il<br />
reale con l’immaginario, ed evocato personaggi di tutti i luoghi e di tutti i tempi, come li avesse invitati al fantastico tè<br />
del cappellaio matto. Per scriverlo era salito sopra un tappeto volante, che l’aveva portato in cento luoghi diversi, e aveva<br />
chiamato geni che uscivano da una lampada di rame alla sua più fievole invocazione. 4<br />
In Thomas Mann, Sgorlon e i personaggi di Sgorlon hanno trovato dunque una sorta di antidoto<br />
contro l’angoscia, l’angoscia dei tempi moderni, e hanno trovato quel superamento dell’inquietudine<br />
4 Carlo Sgorlon, Il regno dell'uomo, Milano, Arnoldo Mondadori editore, 1996, pp. 135-136.<br />
85
86<br />
della modernità espresso da Kafka, che veniva rivendicato alla fine del volume su Kafka narratore, come<br />
un’esigenza del nuovo tempo che sarebbe venuto. Sgorlon si fa interprete di questa esigenza, pone<br />
a se stesso questa sfida e dopo molti anni, dunque, la supera. C’è da osservare che questo percorso<br />
che va da Kafka fino a Mann è egualmente un percorso condiviso da altri intellettuali. Stranamente è<br />
anche un percorso condiviso da un filosofo che probabilmente a Sgorlon non piaceva, o piaceva poco,<br />
cioè il filosofo ungherese marxista Lukács, che appunto, scrisse un critico, “aveva combattuto l’angoscia<br />
di Kafka con l’amuleto di Thomas Mann”. 5 Queste parole bellissime relative a Lukács che combatte<br />
l’angoscia di Kafka con l’amuleto di Thomas Mann credo che potrebbero valere anche per Sgorlon.<br />
Cosa c’è da dire al termine di questa conversazione che ci ha portato verso, credo, nuovi sentieri,<br />
in qualche modo forse su sentieri già battuti, ma in un altro modo? Sicuramente la letteratura tedesca<br />
non è l’unica ad accompagnare Sgorlon, che è uomo dalle molteplici letture, che si interessa in particolare<br />
di letteratura sudamericana, ed alla letteratura sudamericana, a Borges in particolare, dedica<br />
questi scritti; che vede anche in Elsa Morante una figura significativa: ad Elsa Morante, come sappiamo,<br />
dedica anche uno scritto interpretativo. Quindi sicuramente la letteratura tedesca non è l’unica ad<br />
accompagnare Sgorlon nel suo lungo itinerario di scrittore, di narratore, di critico e di intellettuale, ma<br />
sicuramente la letteratura tedesca svolge un ruolo importante. Svolge un ruolo importante nel segnare<br />
certe ambientazioni, nel determinare la psicologia di alcuni personaggi, nel disegnare certe trame e<br />
svolge soprattutto un ruolo importante nel determinare la poetica dell’autore. Sgorlon è riuscito sicuramente<br />
a combattere l’angoscia di Kafka con l’amuleto di Thomas Mann, ma forse, come tutti i fantasmi,<br />
anche Kafka non si lascia completamente sconfiggere. E probabilmente, anche nei suoi romanzi<br />
più cosmici e armonici, qualcosa di questa sottile inquietudine permane sempre. Questo rende, credo,<br />
oggi, l’autore così interessante, lo rende così, credo, significativo, perché ogni grande autore non è mai<br />
un autore che sappia sciogliere tutte le contraddizioni e l’ambiguità. E le contraddizioni sono invece le<br />
ragioni per il fascino e per la vita di uno scrittore. Fin quando troveremo queste ambiguità e queste contraddizioni,<br />
credo l’opera di Sgorlon possa continuare a esistere.<br />
5 ????????
I racconti di Carlo Sgorlon<br />
di Mario Turello<br />
Fu nelle riunioni della redazione dei Quaderni della FACE che feci la conoscenza di Carlo Sgorlon.<br />
Allora quella era una rivista di cultura friulana e non ancora una rivista friulana di cultura, come<br />
iniziò ad essere quando Sgorlon ne divenne il direttore responsabile. A quel tempo egli aveva già scritto<br />
sei romanzi, e per molti anni e molti romanzi ancora ebbi modo di incontrarlo sempre più amichevolmente.<br />
Il ricordo di questa esperienza comune mi dà lo spunto per introdurre la mia relazione sui racconti<br />
di Sgorlon: ricordo infatti la sera in cui ci lasciò sorpresi, perplessi addirittura, noi della famiglia<br />
degli artisti cattolici, dichiarandosi non tanto cattolico, e neppure cristiano, ma piuttosto panteista o<br />
semplicemente, ma profondamente, religioso. In quella stessa occasione disse di considerarsi non tanto<br />
uno scrittore quanto un narratore, e anche questo ci sorprese. Oggi, dopo altri trentacinque romanzi,<br />
queste sue affermazioni riescono assai più chiare e definite ai suoi lettori; in ogni caso, appuntare l’attenzione<br />
sulla narrativa breve di Sgorlon offre anche l’opportunità di illuminare quegli aspetti.<br />
Sono due le raccolte di racconti di Sgorlon: Il quarto re mago e Racconti della Terra di Canaan<br />
(ci sarebbe anche Il paria dell’universo, ma si tratta di due racconti per ragazzi che meglio andranno<br />
collocati accanto ai romanzi I sette veli e Lo stambecco bianco. E certamente altri saranno ancora da<br />
raccogliere). Il quarto re mago e i Racconti della Terra di Canaan furono pubblicati nella seconda metà<br />
degli anni ’80, quando la poetica e la metafisica di Sgorlon erano già compiutamente elaborate, e tutti<br />
e due hanno un’introduzione dell’autore: sono due testi di grande chiarezza che citerò ampiamente.<br />
Invertendo la cronologia, mi soffermerò dapprima sui Racconti della Terra di Canaan, del 1989,<br />
poi su quelli de Il quarto re mago che li precedette di tre anni (andrebbero datati singolarmente, mentre<br />
i Racconti della Terra di Canaan furono concepiti come serie unitaria e scritti in breve arco di tempo).<br />
Inizio da questi perché ebbi il piacere di presentarli poco dopo la loro uscita.<br />
In quegli anni seguivo con interesse due correnti di studio convergenti: sulle riviste di teologia<br />
si andava auspicando, da parte di teologi, biblisti e filosofi del calibro di Weinrich, Metz, Ricoeur,<br />
Molari, Halbfas, il ritorno a una “teologia narrativa” in luogo di quella argomentativa: gran parte, o la<br />
parte religiosamente più significativa, dei testi canonizzati come Bibbia, si osservava, sono narrazioni;<br />
narratore fu Gesù e comunità narrante fu la chiesa nascente. La narrazione, sosteneva Molari, può avere<br />
efficacia salvifica, quasi sacramentale, e portava ad esempio i racconti chassidici (raccolti da Martin<br />
Buber), romanzi come Il vecchio e il funzionario di Mircea Eliade (autore molto caro a Sgorlon, che<br />
ancora lo cita nel Circolo Swedenborg) o libri come Uno psicologo nel lager di Victor Frankl. Proposte<br />
e auspici che purtroppo non hanno avuto ricadute nella pratica teologica, e direi neppure in quella catechetica<br />
o omiletica.<br />
Intanto, sul versante degli studi letterari, critici come Northrop Frye, Robert Alter, Frank Kermo-<br />
87
88<br />
de, Harold Fish proponevano un approccio alle sacre scritture in quanto testi letterari (o macrotesto) e<br />
uscivano opere come la monumentale Literary Guide to the Bible (mai tradotta in italiano) di Alter e Kermode,<br />
L’arte della narrativa biblica di Alter, Un futuro ricordato di Fish, o il magnifico Dio. Una biografia<br />
di Jack Miles. Anche questi autori sottolineavano la potenziale rilevanza teologica della letteratura e<br />
dell’arte in generale. Tra i nomi che ho citato, il più noto è quello di Northrop Frye che in un saggio celeberrimo,<br />
Il grande codice, considera la Bibbia come il grande repertorio da cui hanno tratto ispirazione<br />
innumerevoli scrittori, poeti, musicisti, artisti d’ogni epoca. [Tra l’altro, questi approcci offrivano ottimi<br />
argomenti ai fautori della introduzione della Bibbia tra le letture scolastiche imprescindibili. Anche di<br />
questo non si è vista attuazione alcuna.]<br />
All’epoca, tentai di verificare se qualcuno avesse fatto la storia delle creazioni artistiche che<br />
hanno tratto ispirazione dalla Bibbia, ma non trovai altro che le voci “Bibbia e cultura”, “Bibbia e letteratura”,<br />
“Bibbia e musica” nel Nuovo dizionario di teologia biblica delle edizioni Paoline: voci sintetiche,<br />
parziali, poco più che elencazioni. Oggi disponiamo di un’opera ben più utile: I personaggi biblici.<br />
Dizionario di storia, letteratura, arte e musica pubblicato da Bruno Mondadori nel 1997, che di ogni personaggio<br />
traccia la presenza nella tradizione e nelle diverse arti, ma soprattutto abbiamo uno splendido<br />
saggio di Piero Boitani, Ri-Scritture: con questo conio Boitani ha indicato il genere letterario che consiste<br />
nelle riscritture della (sacra) Scrittura. I racconti della Terra di Canaan sono appunto ri-Scritture;<br />
en passant osservo che in Friuli abbiamo avuto almeno altri due casi notevoli di ri-Scrittori: Siro Angeli<br />
autore del romanzo Figlio dell’uomo e Tito Maniacco autore dei sei racconti di Genesi. Un’analisi comparata<br />
di questi due libri e di quello di Sgorlon sarebbe quanto mai interessante.<br />
Vediamo allora come si presenta Sgorlon in quanto riscrittore di storie veterotestamentarie (è<br />
il caso di ricordare che i Racconti della Terra di Canaan sono nati da un progetto editoriale: gli furono<br />
“commissionati” da Mondadori). Sono dieci i racconti incentrati su altrettante figure: Abramo, Sansone,<br />
Ruth, Saul, Assalonne, Salomone, Tobia, Daniele, Ester, Giuditta. Come dicevo, mi servirò della sua<br />
introduzione, cominciando da questo passaggio:<br />
...apparirà chiaro che il mio risalire alla Bibbia, il Libro dei Libri, con le sue storie esemplari, che<br />
hanno modellato centinaia di generazioni, è un fatto naturale, anzi necessario. Poiché ho sempre avuto<br />
la tendenza a risalire al passato, era prevedibile che prima o poi mi occupassi di quella che è, per<br />
l’inconscio dei Cristiani e degli Ebrei, la Fonte stessa delle antiche storie. La Bibbia l’abbiamo tutti nel<br />
fondo della psiche e nel sangue, credenti e non credenti.<br />
Qui Sgorlon esprime, senza citare Frye, il concetto di Bibbia come grande codice, intendendo Libro<br />
dei libri non solo come forma di superlativo (come Cantico dei cantici, Re dei re...), e non solo come<br />
raccolta di libri (tà biblía), ma appunto come libro generatore di libri. Un riferimento preciso a Northrop<br />
Frye si trova invece in un testo (inedito, credo) che mi è stato fornito dalla signora Edda Sgorlon, che<br />
porta il titolo Il personaggio femminile nei miei racconti biblici - ma non toccherò questo argomento.<br />
Osservo soltanto che se solo tre sono le donne protagoniste dei Racconti della Terra di Canaan (Ruth,<br />
Ester, Giuditta), in realtà la presenza femminile (Sara, Agar, Dalila, Micòl, Tamar, la regina di Saba,<br />
un’altra Sara, quella del Libro di Tobia) è in tutti rilevantissima, e costituisce un tratto caratterizzante<br />
della ri-Scrittura di Sgorlon. Ma vediamo perché Sgorlon dice che la sua ri-Scrittura era prevedibile.<br />
La religiosità di fondo, il forte sentimento del sacro avevano già impresso nella mia narrativa<br />
precedente segni ben visibili. L’archetipo biblico già esisteva in essa, al punto che è stato oggetto di ricerche<br />
e di una tesi di laurea da parte di suor Maria Teresa Nazzari. Ma in questo libro di racconti l’ar-
chetipo religioso non è soltanto una direzione, una traccia: è la sostanza stessa della narrativa. Il mio<br />
romanzo da sempre tendeva all’arcaico, al mito, alla saga. Io sono innanzitutto un narratore di storie,<br />
che ha plasmato la propria figura sopra un modello, quello dello sciamano dotato di fantasia e della magia<br />
del racconto, che aveva avuto un ruolo definito presso le società primordiali. A quel modello sono<br />
rimasto sempre fedele, anche se poi ho raccontato tematiche moderne, o meglio esistenziali ed eterne.<br />
Perciò le mie storie non sono mai delle cronache, nel senso pratoliniano della parola. Non sono neppure<br />
delle vicende inserite semplicemente in un contesto storico. Esse tendono sempre a divenire apologhi<br />
dotati di un significato universale. Tendono al mito e all’archetipo, nel senso junghiano dei termini.<br />
Ci sarebbe molto da dire; sottolineo soltanto che qui Sgorlon parla prima di archetipo biblico,<br />
poi di archetipo nel senso junghiano del termine. Mi sono chiesto in che rapporto stiano questi due<br />
archetipi. Intanto osservo che, come ci ha ricordato Luigi Reitani a proposito dello Sgorlon tedesco e<br />
del suo itinerario da Kafka a Mann, il nostro scrittore è approdato alla psicologia junghiana proprio<br />
per il tramite di Thomas Mann, autore della più imponente ri-Scrittura di tutti i tempi: Giuseppe e i<br />
suoi fratelli.<br />
Per il cristiano i personaggi veterotestamentari hanno valore esemplare in virtù della struttura<br />
tipologica della Bibbia, per cui figure ed accadimenti del Vecchio Testamento sono interpretati come<br />
“tipi” o adombramenti o prefigurazioni (“antitipi”) di eventi e personaggi del Nuovo Testamento.<br />
Da questo punto di vista ha ragione Boitani nel considerare il Nuovo Testamento come una riscrittura<br />
dell’Antico. I tipi prefigurano ciò che gli antitipi realizzano. L’antitipo per eccellenza è Cristo (per gli<br />
Ebrei il Messia) e su lui converge tutta la tipologia. Poiché a nostra volta, se cristiani, siamo chiamati<br />
ad essere antitipi di Cristo, il carattere esemplare dei personaggi biblici è per noi mediato dal modello<br />
perfetto e veramente universale di Cristo. Ma ciò non toglie loro quell’autonomia che spiega come essi<br />
possano conservare la loro carica esemplare anche per il non credente, come Sgorlon stesso sostiene.<br />
Rileggiamo: “le mie storie... tendono sempre a divenire apologhi dotati di un significato universale,<br />
tendono al mito e all’archetipo, nel senso junghiano dei termini”. Ricordiamo che Jung ha definito<br />
come archetipi le “forme o immagini collettive che occorrono press’a poco su tutta la terra come costituenti<br />
dei miti, e allo stesso tempo come prodotti individuali autoctoni di origine inconscia”. Gli archetipi<br />
sono insomma le costanti dell’immaginazione, le categorie a priori del pensiero simbolico. Potremmo<br />
allora identificare l’universalità dei personaggi biblici con la loro natura archetipica: “Se è vero che<br />
vi è così poco nella Bibbia che non possa essere trovato altrove, è anche vero che vi è altrettanto poco<br />
altrove che non possa rinvenirsi nella Bibbia” (Frye).<br />
Più utile però è il concetto di “archetipo storico” elaborato da Harold Fish. Fish osserva che l’archetipo<br />
è per sua natura astorico, mentre la narrativa ha struttura temporale. Rifacendosi a Cassirer<br />
per cogliere un’opposizione tra la coscienza del mito e la coscienza della storia, tipica quest’ultima dei<br />
profeti ebraici, e a Ricoeur per sottolineare il legame storico e fisico con la realtà tipico della parola biblica,<br />
sottolinea che la storia, contrariamente al mito, ha in sé potenzialità di cambiamento. E appunto<br />
la narrazione biblica, secondo Fish, è caratterizzata dalla contingenza e dall’imprevedibilità umana, e<br />
racconta “di compiti imposti nel presente, di giudizi accidentali e di scopi fraintesi”. La storia biblica è<br />
una storia di patti, dinamica, aperta:<br />
L’essenza del patto è drammatica... la responsabilità e le promesse restano con noi tutta la vita<br />
e oltre. Possiamo tentare di sfuggire alle prime e le seconde si possono tenere nascoste (come all’inizio<br />
della storia di Ruth), esse però sono potenzialmente presenti e un giorno si riaffermeranno. Ci saranno<br />
ostacoli imprevisti, ma anche opportunità impreviste. Il percorso in avanti non è mai ben delineato, dal<br />
89
90<br />
momento che, se da un lato siamo vincolati ai termini del patto, dall’altro agiamo liberamente. Possiamo<br />
scegliere, e questa scelta conferisce ad ogni momento un carattere di pericolo e di incertezza.<br />
Insomma Fish tenta di conciliare il valore archetipico con la dinamicità della storia e con la libertà<br />
dell’uomo: la peculiare universalità dei personaggi biblici sta nell’essere “archetipi storici”, ove<br />
storicità implica indeterminatezza, imprevedibilità, incertezza ma anche libera iniziativa. In questo le<br />
indicazioni di Fish sono straordinariamente coerenti con quelle di Auerbach e di Alter.<br />
Auerbach in Mimesis mette a confronto lo stile omerico con quello veterotestamentario e riscontra<br />
che il primo è caratterizzato dalla completezza, dal dettaglio, dall’esattezza, dalla precisa collocazione<br />
nel tempo e nello spazio, con una struttura sintattica in cui congiunzioni, avverbi, particelle<br />
ecc. fanno trascorrere il racconto in modo continuo, ritmico, vivace, senza lacune né oscurità né profondità<br />
inesplorate. Tutto è in primo piano, tutto ugualmente presente e nel presente. Lo stile ebraico<br />
invece presenta diverse oscurità, si svolge per proposizioni principali con nessi sintattici molto scarsi.<br />
Poverissima è l’aggettivazione; non c’è l’uso omerico dell’epiteto (che significa fissazione); l’informazione<br />
è solo quella necessaria a rendere il racconto comprensibile e drammatico. Lo stesso discorso diretto<br />
è più allusivo che dichiarativo: Dio comanda ma tace sui motivi e sui fini del suo volere. E ancora:<br />
dei fenomeni viene manifestato solo quel tanto che importa ai fini dell’azione, il resto rimane<br />
nel buio; vengono accentuati soltanto i punti culminanti e decisivi dell’azione; le cose interposte non<br />
acquistano esistenza; luogo e tempo sono indefiniti e bisognosi di chiarimento; i pensieri e i sentimenti<br />
restano inespressi, vengono suggeriti soltanto dal tacere e dal frammentario discorso; l’insieme, diretto<br />
con la massima e ininterrotta tensione a uno scopo, e perciò molto più unitario, rimane enigmatico<br />
e nello sfondo.<br />
Gli uomini biblici hanno pensieri quanto mai intricati, psichismi complessi, che pretendono<br />
analisi ed approfondimento e non sempre vi acconsentono (anche su ciò si è basata l’esegesi medievale).<br />
Eppure, se la composizione del Vecchio Testamento è “rappezzata” rispetto all’unitarietà dei poemi<br />
omerici, i singoli frammenti appartengono tutti a un’unità storica universale e a una cosmologia e, se<br />
sono privi di un legame orizzontale, fortissimo è il legame verticale della prospettiva religiosa:<br />
In ognuna delle grandi figure del Vecchio Testamento è incarnato un momento di questo collegamento<br />
verticale, Iddio si è scelto e si è formato queste persone al fine dell’incarnazione della sua<br />
essenza e della sua volontà, ma l’elezione e la formazione non coincidono, in quanto la seconda si forma<br />
a poco a poco, storicamente, durante la vita terrena delle persone elette. Da ciò deriva che i grandi<br />
personaggi del Vecchio Testamento sono assai più soggetti a uno sviluppo continuo, assai più gravati<br />
dalla storia della loro propria vita e hanno un’impronta individuale più profonda degli eroi omerici.<br />
Alter dal canto suo indaga con quali tecniche gli antichi scrittori ebrei abbiano prodotto l’indeterminatezza<br />
di significato che caratterizza il loro narrare. La reticenza degli autori biblici è selettiva e<br />
intenzionale e si avvale di tecniche straordinariamente flessibili nella rappresentazione dell’individualità<br />
umana. Naturalmente essa si rifà ad una concezione della natura umana implicita nel monoteismo<br />
biblico:<br />
Ogni persona è creata da un Dio onniveggente, ma è abbandonata alla propria ineffabile libertà,<br />
fatta ad immagine di Dio nel senso di un principio cosmogonico, mai però nel senso di un fatto etico
compiuto; ogni caso singolo di questo intreccio di paradossi, che abbraccia i due poli estremi del mondo<br />
creato, richiede un’attenzione particolarmente viva alla rappresentazione letteraria.<br />
I personaggi biblici ci sono dati a conoscere o per inferenza (dai loro atti) o attraverso il discorso<br />
diretto o attraverso le asserzioni dell’autore, e queste tecniche si alternano con grande abilità. Rimane<br />
però sempre un ampio margine di oscurità e quindi di interpretabilità. I moventi umani hanno sempre<br />
natura fluttuante e molteplice. Esempio: «Le mogli di Davide erano state condotte via, e Davide era in<br />
grande angoscia, perché la popolazione voleva lapidarlo». Dal libro di Alter, che raccomando vivamente,<br />
traggo due citazioni conclusive:<br />
C’è un mistero nel personaggio così come lo concepiscono gli scrittori biblici, un mistero che<br />
essi esprimono attraverso i loro tipici metodi di presentazione. Forse il modo più facile per osservare<br />
la presenza di questo approccio al personaggio è quello di notare la capacità di mutazione manifestata<br />
dai personaggi che vengono trattati con qualche ampiezza. L’idea biblica dei personaggi come di qualcosa<br />
che si sviluppa nel tempo ed è trasformata dal tempo comporta un senso del personaggio stesso<br />
come di un centro di sorprese.<br />
Le tecniche narrative della Bibbia pongono in una doppia luce, paradossale, il rapporto stesso<br />
di causa ed effetto nelle faccende umane. Gli scrittori biblici manifestano, da un lato, una profonda fede<br />
in un modello consistente, chiaramente delineato, di causa ed effetto, operante nella storia e nell’esistenza<br />
individuale, e molti degli espedienti ai quali ricorrono per incorniciare le loro vicende, molte<br />
delle strutture-motivo, delle simmetrie e delle ripetizioni nei loro racconti, riflettono quella credenza.<br />
Dio ordina, la storia obbedisce; una persona pecca, quella persona soffre; Israele tradisce la fede, Israele<br />
cade. D’altro canto la stessa percezione di profondità divine, di insondabili capacità di bene e di<br />
male, presenti nella natura umana, conduce gli scrittori biblici a rendere questi protagonisti in modi che<br />
destabilizzano qualsiasi sistema monolitico di causa ed effetto, dando vita ad un passaggio fluido tra<br />
differenti ordini di causalità, alcuni dei quali si rafforzano a vicenda in maniera complementare, mentre<br />
altri sono tra loro contraddittori. La semplice possibilità che possa mancare una connessione causale<br />
chiara, anche se marginale, tra l’ira di Michal contro Davide e la sua sterilità, serve a scombinare il senso<br />
di consequenzialità diretta, unilineare, che consuetudini mentali pigre - antiche e moderne - ci suggeriscono.<br />
I fatti che accadono e le azioni compiute dall’uomo come agente libero creato a immagine di<br />
Dio, sono disposti in maniera più stratificata, sono ramificati in forme più intricate, più antiche e contrapposte,<br />
e la tecnica narrativa delle reticenze studiate che generano un gioco di ambiguità strutturate<br />
in modo significativo, costituisce una fedele traduzione, sul piano artistico, di questa visione dell’uomo.<br />
Le conclusioni di Alter concordano con quelle di Milton che definì la Bibbia “manifesto della libertà<br />
umana”: le storie ed i personaggi biblici sono caratterizzati da dinamicità, profondità, apertura,<br />
mutevolezza, libertà, e anche da ambiguità ed enigmaticità. Sono, in altri termini, sommamente aperte<br />
alla riscrittura. In essa interagiscono così due libertà: quella dei personaggi e quella dell’autore, delle<br />
figure mitiche e del mitologo o rimitologizzatore (ovviamente è chiamata in gioco anche la terza libertà,<br />
quella del lettore). Ecco come Sgorlon ha esercitato la sua libertà rispetto alla Scrittura:<br />
Non ho seguito la Bibbia con scrupolo filologico; pur rispettando le linee fondamentali del suo racconto,<br />
e, ciò che più conta, lo spirito religioso, ho obbedito a quelle che a me parevano le necessità fondamentali<br />
del narrare, riservandomi la libertà di modernizzare i temi, inventare, spostare, fondere, omet-<br />
91
92<br />
tere, e così via. Perché, anche in questa serie di racconti sacri, forniti di una loro particolare suggestione,<br />
mi sono lasciato guidare dall’istinto di fondo, cui non potrò mai rinunziare: quello del narratore di storie.<br />
Così i personaggi biblici senza nulla perdere del loro carattere originale entrano a pieno titolo<br />
a far parte della galleria delle creazioni (creature) più propriamente <strong>sgorlon</strong>iane. Ne dò solo qualche<br />
esempio.<br />
Nel suo Abramo mi pare di scorgere un alter-ego di Sgorlon: uomo religioso, dominato dal senso<br />
del sacro, intuitivo ed istintivo, convinto che il problema della divinità non sia dominato dalla complessità,<br />
ma dalla semplicità. Uomo in continua cerca nel territorio del sacro e del divino in cui enigmaticamente<br />
rientrano le origini di tutte le cose e la pietà per i mali del mondo e degli uomini, di quella<br />
Forza creatrice che gli parla dentro: “Di chi era quella voce? Era quella di un Abramo strano e insoddisfatto...?<br />
O era una voce che veniva da infinitamente più lontano? Del resto, in qualche modo, non era<br />
la stessa cosa?”.<br />
Mi pare di scorgere qui il narratore Sgorlon che si chiede da dove venga la sua pulsione a narrare,<br />
se da lui stesso “strano e insoddisfatto” o da un Dio grande poeta di cui egli è strumento, e se non<br />
sia poi la stessa cosa. Il concetto di Dio di Sgorlon è generalissimo, ipotesi minima, e in questo è assai<br />
ecumenico. Il suo Abramo concepisce un Dio unico piuttosto che un unico Dio, un Dio che si cela e<br />
verso il quale eternamente ci muoviamo. La rivelazione è un processo, una lunga strada da percorrere,<br />
un’iniziativa divina che richiede la collaborazione umana: Abramo è un eletto perché è un ricercatore<br />
e la rivelazione è l’approdo di un viaggio nel buio, durante il quale i dubbi riducono l’iniziativa di Dio a<br />
proiezione dell’eterno desiderio dell’uomo. Quello che ho definito atteggiamento ecumenico di Sgorlon<br />
si traduce anche in un certo relativismo etico: Abramo non approva Sara, ma comprende che pure lei ha<br />
agito con un fine morale, e che vi sono scopi etici di natura diversa che a volte si scontrano tra di loro;<br />
relativismo che va letto positivamente come stimolo alla tolleranza e alla reciprocità. Ma soprattutto<br />
Abramo ci dice che alla fine anche il silenzio di Dio, anche l’ordine apparentemente crudele rientra in<br />
un disegno sensato e positivo.<br />
Oltre all’identificazione, l’attualizzazione. Il racconto su Daniele, ad esempio, presenta Babilonia<br />
come “tipo” del mondo moderno:<br />
Babilonia era una città che mescolava le genti e tendeva a cancellare i dislivelli, come se ci<br />
fosse una convinzione di fondo che tutte le lingue, le credenze, le leggi, le costumanze, le religioni si<br />
equivalessero, e che tra il bene e il male, la virtù e il peccato ci fosse una differenza molto relativa.<br />
Città viziosa ed insaziabile, divorata dalla sua stessa ingordigia, Babilonia pare una metropoli<br />
del mondo consumistico d’oggi. Su questo sfondo seguiamo Daniele, la cui giovane mente è come una<br />
spugna. Desideroso di sapere, affascinato dalla sapienza misteriosa dei Caldei, egli coltiva il gusto di<br />
capire fino alla saggezza della maturità, ed avrà una lunga vita, mentre gli imperi sorgono e si disfanno<br />
in vicenda assidua. Non si può leggere l’episodio della fornace se non alla luce sinistra della storia<br />
recente. Dice Nabucodonosor degli ebrei: “Per gente simile non c’è che la fornace!”. E Sgorlon ci presenta<br />
i fuochisti che alimentano le fiamme “allegramente perché qualcosa si era incrinato nel loro cuore<br />
ed essi si accingevano a dare libero sfogo al sentimento truce che sta nella parte tenebrosa di ogni<br />
spirito umano, come una belva in agguato, che gode della crudeltà consumata contro uomini o animali”.<br />
E la trasfigurazione poetica. Ruth, l’incantevole fanciulla dalle labbra di papavero, è la figura<br />
della contemplazione. Anche lei sente che tutti gli dei non sono che manifestazioni di un unico creatore,<br />
del Dio immenso che è in tutte le cose, in ogni angolo della natura e nelle stelle del cielo. Nel suo
incantato panteismo l’ecumenismo di Sgorlon ha una portata anche ecologica. Ciò che mi colpisce nella<br />
storia di Ruth è il modo in cui Sgorlon introduce l’intervento divino: “l’inventiva dell’Altissimo pensò<br />
per lei questa trovata, che il campo fosse proprio quello di Booz”; all’inventiva di Dio che narra la storia<br />
umana, la storia di ciascun uomo, risponde l’iniziativa di Ruth, su suggerimento di Noemi: uomo e<br />
Dio si fanno coautori di una favola a lieto fine. Significativa la nascita del piano nella mente di Noemi:<br />
“Noemi, esperta del mondo e della vita, avvicinò nel pensiero le immagini di Ruth e di Booz, e si avvide<br />
di essere soddisfatta da quella vicinanza. Le pareva una cosa ben fatta, come quelle che avvengono<br />
in natura per volere dell’onnipotente”. Stupenda catena analogica (metafora della creazione artistica)<br />
per cui l’immaginazione umana trova la pietra di paragone nella natura, frutto a sua volta dell’immaginazione<br />
divina.<br />
I racconti della Terra di Canaan formano un ciclo unitario. Il quarto re mago è invece un’antologia<br />
che comprende 23 racconti (scritti per lo più su richiesta), di diversi periodi e molto diversi tra loro<br />
per lunghezza e contenuto. Anche in questo caso è importante citare Sgorlon stesso.<br />
Non c’è dubbio che esista qualche differenza tra la mia narrativa romanzesca e quella novellistica...<br />
Io sono uno scrittore che ha bisogno di grandi spazi; perciò la mia misura ideale è il romanzo,<br />
concepito come unitaria sinfonia, come uno sviluppo narrativo dotato di un suo arco parabolico ben calcolato.<br />
I racconti per me sono un po’ l’equivalente dei Lieder o dei madrigali per un compositore. Nel<br />
racconto lo spazio si restringe, e il ritmo narrativo deve farsi veloce... Rispetto alla narrativa romanzesca<br />
vi è anche un’altra differenza fondamentale. I romanzi sono tutti di ambientazione friulana, sia<br />
pure vaga e leggendaria. Esprimono, con una loro geografia fantastica, la sostanza della mia visione<br />
della vita, ma sempre collocata dentro una cornice friulana... Nei racconti rinunciai anche alla identità<br />
friulana. Abbandonai anche quel sottile filo di Arianna che sembra offrirci la salvezza mediante il riconoscimento<br />
di noi stessi dentro le linee di una cultura e di un’etnia. L’identità friulana era per me una<br />
specie di zavorra di Martin Numa; era il sasso in tasca che legava il simpatico personaggio del «Corriere<br />
dei Piccoli» a un posto preciso del mondo. Così la mia fantasia, non legata più nemmeno al Friuli,<br />
si lasciò trasportare liberamente attraverso tutti i luoghi e tutti i tempi, come un palloncino colorato...<br />
In generale questi racconti possono dare la misura della mia religiosità, che vive per intiero nell’ambito<br />
della cultura e dell’etica cristiane. Ma essa non è possesso né certezza. È piuttosto eco e nostalgia;<br />
sente nei miti biblici e cristiani una suggestione ancor viva, il cui rimpianto agisce con voce di sirena a<br />
rendere inquieto un agnosticismo di fondo, che cerca senza trovare... La mia metafisica somiglia assai<br />
più a quella di Kafka, di Borges o di Schopenhauer che a quella di Novalis... Ma se la vita è miraggio,<br />
sogno, favola babelica, sempre subita, anche quando si crede di possederla, pur v’è in questi racconti<br />
anche il momento attivo e felice. È il piacere di narrare, che è e rimarrà in me sempre più forte di ogni<br />
poetica contraria, proclamata dalla cultura del nostro tempo che cerca di vincere le proprie ansie con i<br />
frigidi artifici dell’intelletto.<br />
Cinque di questi racconti potrebbero rientrare nel gruppo delle ri-Scritture: Il quarto re mago,<br />
Voci da Jerushalajim, La stanchezza di Mosè, La fuga di Istaar; La fibbia di rame. Tre di essi riguardano<br />
i Vangeli, e più precisamente la figura di Gesù, che i rispettivi protagonisti sfiorano o cercano senza incontrarlo:<br />
una giovane prostituta, Istaar, trova alloggio a Maria e Giuseppe; il quarto re mago arrivato<br />
troppo tardi a Betlemme si aggira inutilmente per l’Egitto in cerca del bambino «per la cui nascita si è<br />
mossa una stella»; un viaggiatore greco, Dione, giunto a Gerusalemme ha conoscenza indiretta (voci,<br />
appunto) della morte e resurrezione di Jeshua:<br />
93
94<br />
La vicenda del profeta sembrava aver consumato la sua parte terrena e contingente. Aveva cessato<br />
di essere un semplice fatto ed era diventata veramente una storia, sussurrata da orecchio a orecchio<br />
in chissà quanti luoghi; una grande storia che, Dione lo capiva, lo sentiva, sarebbe cresciuta nel<br />
tempo, e avrebbe riempito di sé lo spirito degli uomini e le pagine dei poeti.<br />
Mi azzardo a dire che in essi Sgorlon esprime l’idea dell’irraggiungibilità della figura del Cristo,<br />
che potrebbe soddisfare quel bisogno di assoluto che, come dirò tra poco, emerge da altri di questi<br />
racconti. Nella loro brevità, essi presentano singulatim i temi tipici – il viaggio, la festa, lo straniero,<br />
l’enigma – che nella narrativa di Sgorlon sono sempre compresenti. E in essi meglio si riconoscono<br />
echi e suggestioni di Kafka, Buzzati, Borges; a quest’ultimo Sgorlon dedica un racconto che termina<br />
con una sorta di sua identificazione col grande argentino, visionario cieco. Ma mi limito a estrarre da<br />
tre racconti altrettanti passaggi che pure mi sembrano applicabili a Sgorlon come dichiarazioni della<br />
sua poetica e della sua religiosità. Apologo decisamente kafkiano, Il Re racconta del suddito che, dopo<br />
anni di preparativi, riesce a penetrare nella reggia-labirinto in cui vive, invisibile e inaccessibile a tutti,<br />
il Re, sovrano “potente e straordinario” della cui sapienza e giustizia tutti favoleggiano, e altro non<br />
scopre che un manichino in trono. “Aveva inseguito per tutta la vita la verità sul Re, per capire questo,<br />
che la verità era il nulla. Solo il mito esisteva.” Simile il racconto La Valle proibita, con echi di Mille e<br />
una notte: una grotta, oggetto di molte leggende, viene avventurosamente raggiunta e trovata vuota.<br />
Alì, il protagonista,<br />
diventò malinconico... gli pareva che la sua vita fosse deserta come la caverna violata. Con gli<br />
anni si fece un uomo grave e saggio... Eppure qualcosa rendeva la sua vita insipida come un pane senza<br />
sale. Era (lui solo lo sapeva, era il segreto dei segreti) il fatto che non possedeva più come gli altri<br />
un Luogo proibito.<br />
Ambientato nella Spagna del XIII secolo, La biblioteca di Cordova narra del giovane bibliotecario<br />
arabo che, morto il suo maestro, bruciati tutti i libri nel rogo appiccato dai soldati di Ferdinando di<br />
Castiglia, si ritira in un remoto villaggio ai piedi della Sierra Nevada:<br />
Il suo animo era cupo e pensoso. Ma appena ebbe aggiunto la novella cinquecentonovantuno<br />
al manoscritto del suo maestro, gli parve che narrare delle storie lo compensasse di tutti i crolli e di<br />
tutti gli incendi del mondo.<br />
E in omaggio a Sgorlon narratore concludo con un apologo chassidico:<br />
Quando Baalschem aveva qualche difficoltà da risolvere, doveva compiere qualche opera segreta<br />
per il bene delle creature, si recava in un certo posto nel bosco, accendeva un fuoco e pronunciava<br />
preghiere, immerso in mistiche meditazioni: e tutto accadeva come egli aveva voluto. Quando, una<br />
generazione dopo, il Maggid di Meseritz doveva fare la stessa cosa, si recava in quel posto nel bosco<br />
e diceva: «Noi non sappiamo più accendere il fuoco, ma possiamo dire le preghiere», e tutto andava<br />
secondo il suo volere. La generazione successiva, Rabbi Moshe Leib di Sassow si trovò anch’egli nella<br />
necessità di adempiere quell’opera. Si recava allora nel bosco e diceva: «Non sappiamo più accendere<br />
il fuoco, e non conosciamo più le segrete meditazioni che animano la preghiera; ma conosciamo il luogo<br />
nel bosco che era destinato a tutto ciò, e questo deve bastare», e di fatto bastava. Ma quando, ancora<br />
una generazione dopo, Rabbi Israel di Rischin doveva eseguire quell’azione, sedeva nel suo castello
su di un seggio d’oro e diceva: «Non sappiamo accendere il fuoco, non sappiamo dire le preghiere, non<br />
conosciamo più il luogo, però di questo possiamo raccontare la storia». E il suo solo racconto aveva lo<br />
stesso effetto delle azioni degli altri tre.<br />
95
Sgorlon e il sacro<br />
di Franco Fabbro<br />
Università degli Studi di <strong>Udine</strong><br />
Ho avuto la fortuna di diventare amico di Carlo Sgorlon negli ultimi anni della sua vita. Mi sono<br />
messo in contatto con lui in occasione della pubblicazione del mio libro il Cjâf dai furlans. 1 Volevo citare<br />
un suo articolo, che avevo letto in aereo, dove descriveva in maniera magistrale alcune caratteristiche<br />
dei friulani. Nel primo incontro abbiamo parlato di tutto. Carlo era un uomo semplice, vero, coraggioso.<br />
Pienamente consapevole dei limiti e delle possibilità della civiltà contemporanea. Mi è subito sembrato<br />
una persona lucida in un mondo di addormentati. Ho cercato di diventare suo discepolo. Mi sono recato<br />
da lui tante volte a chiedere consigli su come scrivere, pareri letterari, considerazioni sulla vita e sul<br />
mondo. Siamo diventati amici. Lui addirittura riteneva che fossimo fratelli spirituali. Ciò che ci univa era<br />
una particolare sensibilità per il sacro, una caratteristica, che penso, sia distintiva della nostra terra.<br />
1. L’incontro con un maestro<br />
Ho visto Carlo Sgorlon per la prima volta a metà degli anni Settanta. Da poco avevo letto La<br />
luna color ametista. Il libro mi era piaciuto molto e avevo deciso di andare ad ascoltare una sua conferenza<br />
alla Scuola Cattolica di <strong>Cultura</strong> di <strong>Udine</strong>. Quella sera Sgorlon ha parlato della sua visione del<br />
mondo. Del suo debito verso la realtà contadina del Friuli. Della iniziazione al piacere della letteratura,<br />
sia italiana che friulana, da parte del nonno materno Pietro Mattioni, con il quale ha trascorso l’infanzia<br />
e dal quale, insieme alla nonna e alle donne della casa, è stato educato. Poiché Sgorlon, com’è noto,<br />
non ha frequentato le elementari.<br />
In quella conferenza Sgorlon m’impressionò molto. Oltre che dalla chiarezza e dalla semplicità<br />
rimasi colpito dall’autenticità e dal coraggio nell’esposizione delle sue convinzioni. Già allora, in un<br />
ambiente decisamente confessionale, come quello della Scuola Cattolica, precisò che la sua posizione<br />
filosofica era molto diversa da quella cristiana. Provava simpatia e rispettava molto il cristianesimo,<br />
soprattutto per quanto riguarda i precetti etici, ma la sua religiosità era molto più generale e antica.<br />
Io allora avevo diciassette anni, mi sarebbe molto piaciuto conoscere Carlo più da vicino. Parlare<br />
con lui della mia passione per la letteratura e i romanzi. Discutere della psiche umana e della religione.<br />
Chiedere consigli e prendere rifugio in un vero maestro. Ma allora lui mi sembrava davvero irraggiungibile.<br />
Temevo di fargli perdere tempo con le mie domande. Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi<br />
e rivolgergli la parola. Mi sono limitato a osservarlo da una giusta distanza.<br />
1 franCo faBBro, Il Cjâf dai furlans. Neuropsicologjie dai sentiments, <strong>Udine</strong>, Edizions Kappa Vu, 2000.<br />
97
98<br />
Tuttavia ciò che non ho smesso di fare è stato leggere i suoi romanzi quando venivano pubblicati.<br />
Nei suoi romanzi trovavo le radici profonde del pensiero e della cultura friulana, alla quale intimamente<br />
appartengo, e una costante tensione verso il sacro che pure mi appartiene. Più tardi, come<br />
ho argomentato nel libro Il Cjâf dai furlans, questi due aspetti: il sentimento di appartenenza al nucleo<br />
profondo della cultura friulana e la tensione verso il sacro, mi sono apparsi come due componenti non<br />
separabili.<br />
Il radicamento profondo delle opere di Carlo Sgorlon al mondo friulano e ai suoi archetipi era<br />
per me immediato e allo stesso tempo sbalorditivo. Quando conobbi e divenni amico di uno dei più affermati<br />
neuroscienziati italiani, il professor Salvatore Aglioti e questi mi chiese che cosa significava<br />
essere friulano, gli regalai come risposta il libro Gli dèi torneranno. Alla stessa domanda, con altre persone,<br />
ho risposto regalando Il vento nel vigneto o Prime di sere. Romanzi che, come l’Iliade e l’Odissea<br />
per la cultura greca, definiscono i contenuti e il perimetro del pensiero friulano più profondo. In questo<br />
senso si può dire che Sgorlon ha, in maniera magistrale, rivestito di parole i principali archetipi della<br />
civiltà friulana.<br />
2. Ritornare al sacro<br />
Desidero iniziare questa seconda sezione con un aneddoto per me molto significativo. Qualche<br />
anno fa, qui in Sala Aiace, ho avuto modo di vedere in azione l’onestà e il coraggio intellettuale di Carlo.<br />
Subito dopo la presentazione di uno dei suoi ultimi romanzi, un sacerdote è intervenuto dicendo che<br />
aveva letto i suoi principali scritti e che lo ammirava moltissimo. Disse inoltre che a suo parere Carlo<br />
era un vero cristiano, più cristiano di lui. Sgorlon ha prima ringraziato cortesemente e quindi ha detto<br />
“no”, non sono cristiano sono piuttosto panteista. Non ho mai sentito, prima di lui, qui in Friuli qualcuno<br />
dire: “purtroppo, non sono cristiano!”.<br />
Per Carlo Sgorlon le concezioni ideologiche del nostro tempo, appaiono multiformi, ma, in realtà,<br />
sono riconducibili soltanto a due: quella religiosa e quella laica, che io preferisco chiamare non-religiosa<br />
o egoica. 2 Secondo Sgorlon “la nostra coscienza si colloca da una parte o dall’altra per motivazioni<br />
istintive, profondissime, viscerali, che vengono prima della ragione e delle sue scelte meditative.” 3<br />
La base fondamentale di tutte le religioni, è secondo Sgorlon, il sentimento del sacro. Questo sentimento<br />
consiste nella consapevolezza che l’Essere, di cui gli uomini fanno parte, è qualcosa di enorme<br />
e di infinitamente misterioso. Le persone religiose accettano umilmente di dipendere da una Realtà<br />
che è immensamente più vasta di loro. Chinano la fronte d’innanzi all’aspetto misterioso e indecifrabile<br />
dell’Essere.<br />
Le persone non religiose, che Sgorlon chiama anche laiche, storiciste o materialiste, presentano<br />
invece la convinzione fondamentale della loro totale autonomia e libertà. Per queste persone la<br />
realtà assoluta è l’Io. Esse hanno sostituito l’Essere con l’Ego. Per diventare veramente irreligiosi c’è<br />
un solo modo: arrivare ad affermare che Dio siamo noi stessi, che ci siamo fatti da soli e abbiamo creato<br />
il mondo. 4<br />
Indipendentemente dalle dichiarazioni personali, la maggior parte degli individui del mondo occidentale<br />
ha scelto di vivere in una dimensione non religiosa. Le società moderne si sono “reificate”.<br />
2 Cfr. karen Horney, Nevrosi e sviluppo della personalità. Roma, Astrolábio, 1981.<br />
3 Carlo Sgorlon, Necessità del sacro nella cultura moderna, xxxx, 1991.<br />
4 id., Ethos e sacralità, xxxxx
Oggi, l’uomo comune in Europa, in America e in numerosi paesi asiatici, si realizza accumulando oggetti<br />
e prodotti dell’industria. La società laica e consumista produce fenomeni di individualismo mostruoso,<br />
finalizzati alla ricerca di un forsennato successo attraverso i mass media, nella quale non c’è più posto<br />
per le virtù e i valori etici ma soltanto per gli interessi individuali ed egoistici.<br />
Il costo di aver abbandonato una concezione sacrale dell’Essere è stato molto salato. La società<br />
laica e opulenta è passata rapidamente dall’umanesimo, all’assurdo, alla noia, all’indifferenza, alla<br />
nausea, al rifiuto della vita come non senso. “Chi si allontana da una concezione sacrale e religiosa<br />
dell’esistenza fatalmente infila quella via cupa e squallida che lo conduce alla celebrazione del nulla e<br />
della morte, del vuoto e della disperazione, del non essere e dell’assurdo.” 5<br />
La cartina al tornasole del fallimento della cultura irreligiosa contemporanea è la diffusione dei<br />
formidabili problemi esistenziali ed ecologici. La cultura dell’opulenza è fondamentalmente una cultura<br />
della distruzione. L’idea metafisica è che l’essere umano sia completamente indipendente, che l’Io sia<br />
autonomo e non debba rispondere delle sue azioni a nessuno. Cioè il nucleo principale dell’essere non<br />
religioso è alla base della civiltà contemporanea materialista e consumista. Questa civiltà ha un prezzo<br />
altissimo. “Più si produce e più si distruggono gli equilibri ambientali, i sistemi ecologici, e di conseguenza<br />
si manomette e si altera la natura, e si corre verso la catastrofe ambientale.” 6<br />
Sgorlon amava ricordare una frase del grande scrittore francese André Malraux: “Il prossimo<br />
secolo, (il ventunesimo), o sarà religioso, o non sarà.” 7 Gli esseri umani per salvarsi e salvare la natura<br />
devono riconoscere di essere delle creature limitate, che dipendono dalla terra e dall’universo in cui<br />
sono ospitati. 8 Le donne e gli uomini devono tornare a muoversi nel mondo con umiltà, attenzione ed<br />
equilibrio. Devono inoltre riconoscere che la vita è un mistero; e quindi lo studio, la ricerca e la trasformazione<br />
del mondo richiedono estrema cautela. Gli esseri umani devono ritornare al sacro, una visione<br />
del mondo tipica della civiltà contadina e artigiana. Non si tratta di rinunciare alla scienza o alle ricadute<br />
tecnologiche moderne ma di orientare questi contributi verso la vita e non verso l’autodistruzione.<br />
Chi possiede e nutre il sentimento del sacro “non uccide, non ruba, non mente, non seduce le<br />
donne degli altri, rispetta il prossimo, non è servile, né conformista”. 9 Sgorlon non solo ha aderito profondamente<br />
alla visione sacrale del mondo ma ha considerato la sua attività di scrittore come un’azione<br />
per la riconsacrazione del mondo. “Io ho sempre sentito come compito primario del mio lavoro di<br />
scrittore quello della riconsacrazione del mondo. In un mio romanzo, Il trono di legno, c’è una frase che<br />
afferma esattamente questa intenzione. Riconsacrare il mondo significa ripristinare modernamente il<br />
sentimento arcaico della sacralità; significa avere un rispetto sacrale dell’Essere, significa capire che<br />
esso non ci appartiene, che possiamo soltanto usarlo con estremo rispetto; c’è soltanto prestato per<br />
breve tempo, e dobbiamo lasciarlo in eredità a quelli che verranno dopo di noi. Possedere il sentimento<br />
della sacralità significa vivere con rispetto e con estrema cautela. Significa vivere col timore di poter<br />
recare danni alla natura, al mondo, agli altri uomini.” 10<br />
La riconsacrazione del mondo in ambito narrativo passa attraverso il recupero e la valorizzazione<br />
dei miti, degli archetipi, delle saghe, delle leggende, delle tradizioni arcaiche e ancestrali. Sono<br />
tutte cose che abitano dentro la zona del sacro. Per Sgorlon “La sacralità si nutre di due cose soprat-<br />
5 id., Necessità del sacro..., cit.<br />
6 id., Necessità del sacro..., cit.<br />
7 id., Ricollocare l’uomo nella natura, «Nuova Antologia : rivista di lettere, scienze ed arti», 125 (1990), n. 2176, p. 273-282.<br />
8 Op. cit.<br />
9 id., Il ritorno del sacro, xxxxxx 2004.<br />
10 id., La mia religiosità, «Nuova Antologia : rivista di lettere, scienze ed arti»,<br />
99
100<br />
tutto del senso del divino e del mito. Perciò anche il mito ha lungo corso nella mia narrativa. Non mi<br />
scoraggia il fatto che il mito è favola, secondo il suo etimo greco, e che quindi si colloca in uno spazio<br />
fantastico. (...) Tutto ciò che noi sappiamo, che abbiamo appreso in qualunque modo, è in buona parte<br />
mitizzato. La mente umana è per sua natura mitopoietica, perché non si contenta della cosiddetta realtà,<br />
che non si sa bene cosa sia, e ha sempre la tendenza ad abbellirla, a fantasticare su di essa, a renderla<br />
insomma più ricca d’interesse e di fascino.” 11<br />
3. Dare un volto al sacro<br />
L’atteggiamento di Sgorlon nei confronti della vita e della natura era indubbiamente religioso.<br />
Tuttavia si trattava di una forma molto generale di sensibilità religiosa che egli chiamava “il primo gradino<br />
della religiosità”, comune a tutte le religioni del mondo. 12 Questa religiosità consiste in un atteggiamento<br />
di riverenza e devozione verso la sacralità della natura, riassunto in maniera esemplare in<br />
una poesia indiana che Carlo amava citare: “Dio dorme nella pietra, sogna nel cane, acquista coscienza<br />
di sé nell’uomo.” 13<br />
Ciò che non è più possibile, secondo Sgorlon, è dare un volto, un’intenzione, una volontà, un<br />
pensiero a Dio. “Dio esiste, e ciascuno lo può attingere e sentire dentro di sé nei modi più semplici.<br />
Il Dio che non riusciamo più a concepire è quello personale, che giudica, provvede, ama, modellato<br />
sull’uomo e la sua intelligenza. Ha ragione Feuerbach, mi pare, questo Dio non è che una proiezione<br />
dell’uomo, un’invenzione dei profeti vocati a scrivere bibbie, vangeli, veda o corani. Ma se non si può<br />
più credere in questo dio mitico, giustiziato da Nietzche e da infiniti prima di lui, non si può non credere<br />
nel dio dei panteisti, che è la somma delle forze cosmiche: dei campi magnetici, della gravitazione, delle<br />
affinità chimiche tra gli elementi. Di tutto ciò, insomma, che fa vivere la materia ed ha fatto scaturire<br />
la vita da essa. Possiamo chiamarlo come vogliamo: Dio, Forza Cosmica; Forza della vita (come Thomas<br />
Mann), natura (come Baruch Spinoza), natura naturans (come Giordano Bruno). La sostanza non cambia.<br />
Se dietro la materia vivente non c’è uno spirito che la rende tale, la materia stessa è Dio, perché<br />
ha creato il mondo, la vita e la nostra stessa intelligenza.” 14<br />
Sgorlon aderiva dunque a una posizione filosofica panteista. Nei personaggi dei suoi romanzi<br />
“l’antico Dio, personale e paterno, è stato sostituito da un Dio più concepibile e più vago, quello dei<br />
panteisti. (...) Da ciò l’impressione di sacralità e di religiosità indefinita che i miei libri emanano. Non<br />
è una religiosità cattolica o luterana, o ebraica, ma panteistica. Non c’è dubbio, comunque, che anche<br />
per questa via i miei libri vadano in una direzione contraria a quel complesso d’idee che dominano la<br />
nostra cultura” 15 . Per Sgorlon questa religiosità è tipica della cultura contadina, come in Friuli fino a<br />
cinquant’anni fa, “in apparenza cattolica, ma nella sostanza panteista.” 16<br />
In numerose occasioni ho cercato di discutere con Sgorlon intorno al problema del “volto di<br />
Dio”. Condivido l’idea di Carlo che sia molto difficile credere ai contenuti di numerose religioni contemporanee,<br />
nelle quali Dio non sembra altro che una proiezione delle nostre paure e dei nostri desideri.<br />
11 id., Tra epos e metafisica, 2007.<br />
12 id., Necessità del sacro..., cit.<br />
13 id., La mia religiosità, cit.<br />
14 id., Ethos e sacralità, cit.<br />
15 id., Perché narrare<br />
16 id., Ricollocare l’uomo nella natura, cit.
Tuttavia ritengo aperta la questione di una possibile “entità consapevole” all’origine e al di là del cosmo.<br />
Un’entità indescrivibile con le nostre parole e irraggiungibile con il nostro intelletto, 17 che tuttavia<br />
è presente nella natura e nel nostro cuore. Riconoscere a questo proposito la nostra perenne ignoranza<br />
mantiene aperto uno spiraglio, poco probabile, ma possibile.<br />
17 raimon Panikkar, Il silenzio del Buddha, Milano, Mondadori, 2006.<br />
101
102
Il friulano nei romanzi di Sgorlon<br />
Gianfranco Ellero<br />
Prima di dire qualcosa sul friulano in Carlo Sgorlon – dopo lo Sgorlon tedesco, lo Sgorlon italiano,<br />
adesso tocca allo Sgorlon friulano – vorrei dire che l’invito, che mi onora naturalmente, di essere qui<br />
presente a questo tavolo mi ha creato degli imbarazzi, e dico subito perché. Intanto non sono un critico<br />
letterario, ma questo non vuol dire che ignori gli strumenti del mestiere: diciamo che non li adopero<br />
professionalmente. Insomma, è come se vedessi il bisturi di un chirurgo: so a che cosa serve, conosco<br />
gli effetti che può produrre, ma io non lo adopero, e quindi non mi addentrerò in questo campo. E poi<br />
c’era il problema di parlare, in sostanza, di tre romanzi, e cioè Prime di sere, Il Dolfín e Ombris tal infinît;<br />
oppure di parlare anche d’altro, o soprattutto d’altro, con il rischio di parlare troppo o troppo poco.<br />
Quando si dice “il friulano nei romanzi di Sgorlon”, come nel titolo del mio intervento, intendiamo<br />
l’uomo o la lingua? L’uomo e la lingua? Il popolo e le sue espressioni?<br />
Ho sentito parlare poco fa di archetipo, un termine che amo particolarmente, soprattutto quando<br />
parlo di Carlo Sgorlon.<br />
Prima di addentrarmici, però, devo dire che ero legato allo scrittore da una lunga amicizia – anche<br />
questo mi crea un certo imbarazzo, perché non è facile parlare degli amici – iniziata alla fine degli anni<br />
Sessanta, coltivata poi molto assiduamente, soprattutto negli anni Settanta-Ottanta, in seguito più raramente<br />
anche perché, sbalordito per la sua capacità produttiva, non volevo disturbarlo. Ma Lui anche<br />
si lamentava di questo: «Telefona più spesso almeno!», ma io me ne stavo un po’ a guardare.<br />
Prima di venire qui, proprio oggi, mentre stavo leggendo il libro Sagre friulane di Piero Mattioni,<br />
nonno di Carlo, pubblicato nel 1960, mi è capitato sul tavolo un volume illustrato, intitolato Cjassà, album<br />
fotografico del luogo nativo di Sgorlon: è un libro molto ben fatto dall’ex-sindaco di Cassacco, Baiutti,<br />
oggi consigliere regionale. Un libro capitolato, per così dire, per cui le fotografie non sono buttate<br />
là alla rinfusa, ma disposte in capitoli che diventano poi una microstoria visiva. Molto bravi sono stati<br />
sia Baiutti, il compilatore, che Carlo Sgorlon, autore di una lunga e stupenda prefazione al volume, che<br />
gli spettava, diciamo, per diritto di nascita.<br />
Se consideriamo che queste Sagre friulane di Mattioni, portano il 1960 come data di edizione, e il<br />
libro che ho citato è uno degli ultimi, potrei dire che Sgorlon parte e conclude la sua parabola proprio<br />
con due scritti introduttivi – su Sagre friulane e Cjassà, appunto – che entrano molto profondamente<br />
nell’archetipo friulano.<br />
Naturalmente non parlerò di queste due prefazioni. Dirò piuttosto un’altra cosa: quando si deve parlare<br />
di un autore in senso retrospettivo, si va a rileggere i libri, che magari si è già letto e riletto, o certe<br />
pagine particolarmente adatte al tema da trattare: io, invece, ho deciso di non rileggerli, i libri, perché<br />
ho preferito andare a vedere che cosa Sgorlon ha fatto per una cultura che possiamo chiamare “mino-<br />
103
104<br />
re”. Per esempio le prefazioni, sempre illuminanti, che Lui scrisse per autori locali, di solito editi dalla<br />
Filologica: Bortolussi, Iacumin, Maria Forte, Novella Cantarutti, Renato Appi... E ancora, per Siro Angeli<br />
e Dino Menichini, in una collana della Fondazione CRUP, da Lui stesso ideata. Ricordo che quando gli<br />
proposero di inaugurarla con una sua opera – rivelo molto probabilmente una novità – Carlo, generoso<br />
e riservato com’era, disse: «No. Io mi impegno a partecipare come consulente, se volete, come prefatore,<br />
ma non voglio approfittare di questa occasione. Preferisco che sia dedicata, per quanto possibile,<br />
ad autori friulani validissimi, che però, per varie ragioni, non hanno avuto il successo che meritavano».<br />
Detto questo a titolo introduttivo, vorrei brevemente illustrare il percorso di ricerca da me seguito<br />
per questo intervento.<br />
Può essere un nobile esercizio intellettuale quello di risalire alla personalità di uno scrittore attraverso<br />
la personalità dei personaggi dallo stesso creati nei romanzi, ma ho potuto verificare che si possono<br />
raggiungere gli stessi risultati percorrendo il sentiero degli scritti minori e della ricca produzione<br />
giornalistica, perché Sgorlon era sempre introspettivo e attento biografo di se stesso, e palesava chiaramente<br />
la sua visione del mondo e della storia umana: naturalmente mi sono poi impegnato a verificare<br />
la corrispondenza fra gli esiti della mia ricerca, e i suoi romanzi, i più archetipici, soprattutto Prime<br />
di sere, e Gli dèi torneranno.<br />
Il percorso da me seguito era anche, in qualche misura, inevitabile, perché nessun personaggio di<br />
nessun romanzo avrebbe potuto rivelare quel che l’Autore pensava, ad esempio, della grafia del friulano,<br />
mentre negli scritti “minori” o in qualche articolo di giornale possiamo trovare dichiarazioni esplicite<br />
al riguardo.<br />
Mi avvicinai a Carlo prima delle sue vittorie ai premi letterari e molto prima che le sue opere fossero<br />
tradotte in altre lingue e apprezzate a livello internazionale.<br />
La nostra amicizia nacque da una recensione su “Friuli d’oggi” per il romanzo Prime di sere nel<br />
1970, Premio della Società Filologica Friulana. Ero rimasto affascinato proprio dal suo bel friulano centro-collinare,<br />
dalla sua lingua narrativa, non soltanto dalla trama del romanzo, che trovai profondamente<br />
friulano anche in senso archetipico. E negli anni che seguirono ho sempre consigliato la lettura di<br />
quel romanzo a quanti volevano avvicinarsi al nostro mondo e imparare o reimparare la nostra piccola<br />
lingua.<br />
C’è una frase in Prime di sere, che l’ergastolano di ritorno pronuncia guardando il paesaggio, ma<br />
non già “la plere dal Quarnan” – splendida immagine, quella era sempre lì, chissà da quanto tempo<br />
– bensì guardando la società: «A ‘nd îsal ancjemò di cjaradôrs, vie pal mont?» 1 Questa frase mi aveva<br />
colpito perché diventa simbolo di un cambiamento totale, radicale, di una società in cui l’ex ergastolano<br />
ormai è spaesato<br />
dopo trent’anni di “non vita”, come scrive appunto Sgorlon. Ma non siamo tutti prigionieri di un passato<br />
che non riconosciamo più nel presente?<br />
Lui diceva che ero stato il suo primo recensore, e io rispondevo: “No, Carlo, ho fatto un pezzo giornalistico,<br />
non sono un critico”.<br />
Nella mia entusiastica recensione su “Friuli d’oggi”, scrissi che Prime di sere era senz’altro un dono,<br />
inaspettato, insperato, per la letteratura in friulano. Per quale letteratura? Non tanto per la poesia,<br />
posto che, com’è risaputo, la letteratura in friulano può vantare dei “pezzi da novanta” – basterebbe citare<br />
Pasolini, per esempio, Novella Cantarutti e altri eccellenti poeti – quanto per la produzione in prosa.<br />
Ebbene, nel 1970, un anno che io considero fondamentale anche per la pubblicazione della Storia<br />
1 Carlo Sgorlon, Prime di sere, <strong>Udine</strong>, Società filologica friulana, 1971, p. 67.
del Friuli di Gian Carlo Menis, che contiene l’etnogenesi del popolo friulano, e per altre ragioni, Sgorlon<br />
se ne esce con questo Prime di sere. E qui è interessante sentire che cosa Lui stesso dice del suo romanzo,<br />
perché fu chiamato in Filologica a render conto, si potrebbe dire tra virgolette, a render conto di<br />
questo suo exploit, in una memorabile serata del 1975.<br />
Per fortuna il direttore di «Sot la Nape» recuperò il testo (Sgorlon scriveva sempre i suoi interventi)<br />
e lo pubblicò. Ecco un breve passo: “Rifarlo in friulano – era già stato scritto in italiano Il vento nel<br />
vigneto – non fu un’impresa facile, perché il linguaggio nel quale mi viene spontaneo di esprimermi, il<br />
linguaggio in cui penso è l’italiano. Non vorrei essere frainteso su questo punto. A mano a mano che i<br />
miei anni passano, io mi sento sempre più friulano. Come i friulani d’antico stampo, ho un temperamento<br />
costruttivo, so fare tutti i mestieri.” 2<br />
E qui mi piace ricordare ciò che un giorno mi disse il compianto Piervincenzo de Vito: “Se te va in<br />
casa del Sgorlon e te vedi un Piero Della Francesca, lo gà piturà lù; se’l te dise: ‘Sentete su questa poltrona’,<br />
la gà fatta lù durante le vacanse de Nadal”.<br />
Ed ecco il suo autoritratto: “Non posso far altro che esprimere questa civiltà, e far risuonare nelle<br />
mie pagine una sorta di requiem, epico e nostalgico per la sua lenta scomparsa. Amo il lavoro, l’intimità<br />
familiare. Sono un introverso e un individualista, stento a fare amicizie, detesto la retorica. La mia perenne<br />
tentazione è quella di fuggire nei luoghi più solitari, di scavarmi una tana dentro la quale lavorare<br />
in pace. Persino la mia tendenza alla malinconia e alla solitudine, la profonda diffidenza nei confronti<br />
delle ideologie della politica e dello stato, la mia scarsa fiducia nella storia sono tipicamente friulane.” 3<br />
Non vi sembra di risentire Eliseo Bastianutti, il protagonista di Prime di sere, in un mondo non più<br />
suo?<br />
Pietro Citati, nei giorni del terremoto, scrisse, a conferma delle parole di Carlo, che la Storia è passata<br />
sopra la testa dei friulani, che sono rimasti tuttavia sotto la Storia con una loro straordinaria vitalità<br />
e personalità. 4<br />
“Potrei diffondermi a lungo su questo argomento – continua Sgorlon nella sua orazione nella sede<br />
della Filologica –. Mi limiterò ad aggiungere soltanto questo: che anche i miei libri più sfrenatamente<br />
fantastici, e in apparenza privi di riscontro ambientale, e nei quali i lettori friulani si sono meglio rispecchiati,<br />
in realtà sono straordinariamente friulani. In essi non v’è, ovviamente, il folclore, il colore locale,<br />
come del resto in nessuno dei miei romanzi. Ma v’è un’indagine del sottosuolo della psiche profonda,<br />
delle nevrosi e dei complessi del friulano”.<br />
Non vi sembra di risentire Pietro Citati quando scrive che noi friulani siamo sotto la storia?<br />
“Dirò di più – aggiunge Sgorlon –. Da quando le strutture dello stato italiano e il clima morale della<br />
nazione hanno cominciato a ruzzolare lungo una china pericolosa” – siamo nel 1975 – “in me si è fatta<br />
chiara la coscienza della mia non appartenenza alla civiltà italiana. Sono giunto alla convinzione che<br />
avevano ragione coloro che in Friuli da tempo sostengono essere la nostra una civiltà sostanzialmente<br />
alpina – e anche Pasolini scrive queste cose – ed avere riscontro soltanto con quelle delle popolazioni<br />
che vivono lungo l’arco delle montagne, al di qua e al di là di esse – insomma, l’antica metropoli<br />
di Aquileia, come io vi dicevo nei nostri colloqui. Con tutto ciò, il mio vero linguaggio non è il friulano.<br />
Tuttavia rifare in questa lingua il Vento nel vigneto non è certo stata un’impresa contro natura, poiché<br />
il libro è profondamente friulano da ogni punto di vista”. 5<br />
2 id., Presentazione di Prime di sere, in «Sot la nape», 27 (Aprile-Giugno 1975), n. 2, p. 66.<br />
3 Ivi, p. 66.<br />
4 Pietro Citati, Una gente sorpresa nei suoi segreti, in «Corriere della Sera», 8 maggio 1976.<br />
5 Carlo Sgorlon, Presentazione..., cit., pp. 66-67.<br />
105
106<br />
Ecco, qui ci siamo anche introdotti attraverso le sue stesse parole – che forse avrei potuto riferire<br />
tali e quali sulla base dei nostri colloqui privati – al significato che per Lui aveva la parola “friulanità”.<br />
Finite queste letture mi sono ricordato, e non è stata impresa facile, perché ho dovuto far appello<br />
alla mia memoria, di una straordinaria pagina che Carlo scrisse in morte di Andreina Ciceri, l’8 Agosto<br />
2000, significativamente intitolata Nostra Signora dell’archetipo. Carlo dichiara, in quel bellissimo articolo,<br />
tutta la sua ammirazione per Andreina Ciceri, studiosa profondissima e meritatamente celebre di<br />
tradizioni popolari, e ricorda che quando Lui chiese di poterle parlare per scrivere poi ‘un’articolessa’,<br />
lei rispose: «Parcé propit a mi?», e aggiunse: «Non sum dignus...» È un atteggiamento di umiltà evangelica,<br />
e anche il riflesso di un complesso tipico dei friulani, che troppo spesso si sentono sottani, e troppo<br />
raramente protagonisti.” 6 E così Carlo continua, in una specie di autoidentificazione, come voi capirete:<br />
“Amava profondamente il suo lavoro e negli ultimi anni sentiva una sorta di rimorso se si teneva<br />
lontana per poco dagli studi prediletti. Anche qui affiora in lei l’archetipo friulano della passione per il<br />
lavoro, che a volte può diventare una sorta di condanna”. 7<br />
E ancora, parlando della lingua friulana e della sua grafia: “La signora Ciceri invece si tenne lontana<br />
da ogni concezione limitata e troppo personale del Friuli. Non apparteneva né ai cultori del ‘celtismo’,<br />
né al gruppo degli ‘antiromani’, né a quello degli ‘antiveneziani’. Non sciupò il suo ingegno in sterili polemiche<br />
sulla grafia del friulano”. 8<br />
Qui bisogna aprire una parentesi per dire che la Filologica ristampò per cinque volte Prime di sere,<br />
e poi fece una sesta edizione per normalizzare la grafia, cosa che, personalmente, non avrei consentito.<br />
Gliene parlai, e Lui mi disse: «Ma cosa vuoi... non ha importanza.» Era, quindi, in consonanza con<br />
Andreina Ciceri.<br />
Ed ecco, infine, la conclusione: “non mi risulta che abbia mai scritto in friulano” – la Ciceri – “anche<br />
se leggeva tutto ciò che in quel linguaggio veniva pubblicato” – come del resto faceva Lui. “Era<br />
una cultrice del Friuli in tutti i suoi aspetti e le sue forme, come Giuseppe Marchetti, come i friulani più<br />
imparziali e illuminati. Non era uno spirito partigiano, ma universale. Non riteneva alieno da sé nulla<br />
che fosse friulano. Più volte si mostrò consapevole che avevo dato al Friuli un’epica” – a questo Carlo<br />
teneva moltissimo – “forma letteraria piuttosto rara da noi, mentre per la maggior parte degli intellettuali<br />
friulani io sono soltanto l’autore di una trentina di libri da lasciare in disparte perché conservatori.<br />
Era sostenitrice della grafia adottata dalla Società Filologica Friulana perché si rendeva conto, con<br />
saggezza e buon senso, che il friulano poteva essere difeso e diffuso molto meglio se veniva scritto in<br />
modi semplici e accettati da tutti”. 9<br />
Questo, dunque, è il ritratto di Andreina, ma io, che conoscevo Carlo molto bene, e da vicino, posso<br />
dire che in realtà Lui tracciò in quell’articolo il suo autoritratto psicologico. Leggendo la pagina de «Il<br />
Gazzettino» mi è venuta in mente la risposta di Flaubert alla domanda: «Chi è Madame Bovary?»: «Madame<br />
Bovary c’est moi!»<br />
Credo che in queste citazioni, tratte dai suoi scritti minori, ci sia la chiave che può guidarci per leggere<br />
anche, e soprattutto, i suoi tre romanzi in friulano, tra cui Ombris tal infinît.<br />
Quando Carlo diceva: “Mi ritengono conservatore”, intendeva dire che la sua dichiarata ostilità,<br />
ostentata ostilità, verso le ideologie e verso ciò che di falso e, soprattutto, di precario contengono non<br />
gli giovava, non gli procurava la simpatia della cultura di sinistra. Devo dire, però, che Lui godeva dell’a-<br />
6 id., Ciceri nostra signora dell'archetipo, in «Il Gazzettino del Friuli», 30 Agosto 2000.<br />
7 Ivi.<br />
8 Ivi.<br />
9 Ivi.
micizia e della stima di Tito Maniacco, che fu sempre un suo interlocutore, un suo ammiratore, una<br />
persona con cui Sgorlon si intendeva molto bene, anche se naturalmente Maniacco non aveva il suo<br />
stesso atteggiamento rispetto alle ideologie e alla Storia. Era però un uomo di grande spessore, di elevato<br />
intelletto, che sapeva capire e riconoscere la grandezza di coloro che incontrava sul suo cammino.<br />
Volevo dire, per concludere, che Carlo Sgorlon era sorprendente anche per la sua nascosta, rigorosamente<br />
nascosta, generosità; e io devo dire che sono rimasto molto colpito e commosso quando scoprii<br />
che sull’ultima pagina de Gli Dèi torneranno volle ricordare la mia Storia dei Friulani tra le opere<br />
che avevano acceso la sua ispirazione per quel romanzo.<br />
107
108
Appunti sui romanzi friulani di Sgorlon*<br />
di Laura Nascimben<br />
Carlo Sgorlon esordisce in lingua friulana con Prime di sere: il libro nel 1970 vince il concorso<br />
indetto dalla Società Filologica Friulana per un romanzo e viene subito pubblicato. Nel 1973 Sgorlon dà<br />
alle stampe la versione italiana del romanzo, intitolata Il vento nel vigneto, diffuso anche in edizione<br />
scolastica. Il secondo volume, Il dolfìn, dapprima steso in friulano nel 1982, viene poi edito in italiano<br />
nella riscrittura del 1986, con il titolo I sette veli; una seconda edizione friulana risale al 1996, contraddistinta<br />
dal sottotitolo Romanz, dalla soppressione del primo capitolo, Lis fiestis, e da una revisione della<br />
grafia. L’ultimo romanzo, Ombris tal infinît, viene pubblicato postumo nel 2010. 1 Dalle testimonianze,<br />
si definisce l’immagine di un autore di grande successo che scrive in friulano per soddisfare il pubblico<br />
locale, per portare un omaggio al Friuli che, com’è noto, diventa oggetto simbolico e metaforico in molte<br />
sue opere. 2 D’altra parte, proprio sulle soglie del secondo e del terzo volume, Sgorlon ricorda i nomi<br />
di due studiosi che hanno dedicato al friulano lavori di grande spessore: Giorgio Faggin nella nota di<br />
chiusura del Dolfìn e Gianni Nazzi Matalon nella dedica di Ombris tal infinît; si tratta di minime notizie<br />
che sottolineano un interesse per le vicende, anche linguistiche, del Friuli.<br />
1 Si cita dalle seguenti edizioni che, all’occorrenza, si abbreviano con alcune sigle: P = Carlo Sgorlon, Prime di sere, <strong>Udine</strong>,<br />
Societât Filologjche Furlane, 19975 [1971]; P1 = id., Prime di sere, <strong>Udine</strong>, Societât Filologjiche Furlane, 2005 [grafia aggiornata,<br />
a cura di Luca De Clara]; V = id., Il vento nel vigneto, Roma, Gremese, 199612 [1973]; V1 = id., Il vento nel vigneto, Roma,<br />
Gremese, 2006; D82 = id., Il dolfìn, <strong>Udine</strong>, La Panarie, 1982; D = id., Il dolfìn. Romanz, Tricesimo (<strong>Udine</strong>), Roberto Vattori editore,<br />
1993; S = id., I sette veli, Milano, Mondadori, 19872 * Ringrazio Rienzo Pellegrini per l’invito a scrivere questo contributo, Romano Vecchiet per averlo accolto e Antonio Daniele,<br />
Fabiana Fusco, Lisa Gasparotto e Carlo Londero per i loro preziosi suggerimenti.<br />
[1986]; O = id., Ombris tal infinît, <strong>Udine</strong>, Societât Filologjiche Furlane, 2010<br />
[revisione linguistica e grammaticale di Elena De Sanctis].<br />
2 Afferma Sgorlon: «ho scritto anche in friulano, [...] l’ho fatto per una forma di generosità nei confronti della mia terra»,<br />
nell’intervento stampato in liana niSSim, Sgorlon teste insolente. Materiali per un’ermeneutica e una dichiarazione di poetica<br />
di Carlo Sgorlon, [s. l.], Edizioni del Gamajun, 1985, p. 136. Cfr. mario turello, Il grande dolore del Friuli per la morte di Carlo<br />
Sgorlon, «Messaggero Veneto», 26 dicembre 2009; giorgio faggin, Traduzioni e storia della lingua: traduzioni in friulano, in<br />
Romanische Sprachgeschichte. Histoire linguistique de la Romania, 3 voll., herausgegeben von Gerhard Ernst, Berlin-New<br />
York, W. De Gruyter, vol. II, 2006, p. 1365 e le risposte dello scrittore a Inchiesta sulla narrativa italiana degli anni sessanta<br />
e settanta. Quattro domane per Arbasino, Bonura, Bruck, Camon, Debenedetti, Duranti, La Capria, Malerba, Maraini, Rigoni<br />
Stern, Sanguineti, Sanvitale, Sgorlon, a cura di Gillian Ania e John Butcher, «Contemporanea. Rivista di studi sulla letteratura<br />
e sulla comunicazione», 5 (2007), n. 5, p. 189-199, contributo che offre il panorama di letture e di modelli che Sgorlon colloca<br />
sullo sfondo della sua narrativa. Per un primo approccio all’autotraduzione <strong>sgorlon</strong>iana si veda Jean igor gHidina, Mito, società<br />
e scrittura nell’universo romanzesco di Carlo Sgorlon, <strong>Udine</strong>, La Nuova Base, 2006, p. 183-209; su questo argomento, è in<br />
corso uno studio di Fabiana Fusco. Su tale necessità d’indagine, con riferimento al primo romanzo, cfr. rienzo Pellegrini, Aspetti<br />
e problemi della letteratura in friulano nel secondo dopoguerra, <strong>Udine</strong>, Grillo, 1981, p. 91.<br />
109
110<br />
A Sgorlon non è mancata l’occasione di dire quello che pensava del friulano e del problema<br />
della grafia, rispetto alla quale, a partire dall’esperienza della riscrittura del Dolfin, suggerisce di adottare<br />
la norma grafica più diffusa, condivisa e approvata dalla Società Filologica Friulana. 3 Sulla scelta<br />
di scrivere in friulano, guardando alla sua autobiografia linguistica, così si esprime un mese prima della<br />
sua scomparsa, in un’intervista rilasciata a Stefano Damiani:<br />
Io ho scritto tanto in italiano e non sentivo l’assillo di scrivere anche in friulano. Siccome, però, si sentono tante<br />
voci sul fatto che il Friuli non ha scrittori, ho voluto dare il mio contributo. E sono contento di averlo fatto, perché è un<br />
contributo alla cultura della mia regione, un omaggio al Friuli. [...] Devo dire che non mi pongo come salvatore della lingua.<br />
Ho scritto in friulano punto e basta. Vero è che la mia lingua madre è l’italiano: io ero figlio di una maestra e in casa<br />
mia ho parlato l’italiano fino a che avevo due anni e mezzo. Il friulano l’ho imparato più tardi in campagna, quando sono<br />
vissuto con i nonni. Per solito, le mie opere sono ricordate perché contengono i valori della civiltà friulana, però io mi occupo<br />
soprattutto di valori di natura universale e, anche se non sono di moda, se non si ritrovano nella società, nella storia,<br />
a me, per così dire, non me ne importa niente. Io ho una certa formazione etica e quella rappresento, in tutti i modi. 4<br />
Nella stessa intervista, con riferimento al progetto di Ombris tal infinît, vale la pena leggere come<br />
lo scrittore si pone nei confronti della sua narrativa friulana:<br />
È un romanzo differente dai miei altri friulani, ma anche differente dalla narrativa friulana. Perché intanto ci sono<br />
giudizi e valori universali, in secondo luogo tratto alcune realtà storiche che nei miei precedenti lavori non c’erano.<br />
Per esempio in “Prime di sere” era raccontata più che altro la civiltà contadina, mentre il “Dolfin” era una storia adolescenziale<br />
di un ragazzo che perde le illusioni e finisce per capire che la vita è un dovere pesante. Questo romanzo invece<br />
ha molti temi, a partire dalla problematica mediorientale, fino alle Brigate rosse, all’alluvione di cui si parla alla fine, che<br />
potrebbe essere quella di Latisana (anche se io non cito alcun paese), fino al tema della solitudine cosmica dell’uomo,<br />
che affiora qua e là nel romanzo. 5<br />
Pur considerando che le tre prose sono autonome e distinte dal punto di vista della narrazione,<br />
al di là dalle prese di posizione dell’autore verso il friulano, l’unità di lingua e di genere sollecita qualche<br />
riflessione a cui si accompagnerà la catalogazione di alcuni dati. Innanzitutto bisogna presupporre<br />
in filigrana alle tre esperienze un’impronta unitaria riconducibile a quella che Sgorlon chiama la sua<br />
“formazione etica” 6 e un procedere stilistico che – lo si può dire subito perché riguarda anche la narrativa<br />
in italiano – pare poco orientato all’escursione sul piano linguistico. Del resto lo scrittore non crea<br />
divario tra la narrativa in italiano e quella in friulano; soprattutto non definisce campi d’espressione diversi<br />
per i rispettivi codici. Il friulano di Sgorlon è sostanzialmente aderente alla cosiddetta koinè che si<br />
aggancia alle varietà centrali. Si tratta di un’operazione in equilibrio con l’assenza di ricerca di qualsiasi<br />
spessore sociolinguistico. La prosa si pone sul piano privilegiato della lingua letteraria, senza evidenti<br />
impennate lungo le diverse varietà del repertorio. 7<br />
3 Carlo Sgorlon, Il mio parere sulla grafia friulana, «La Panarie», 26 (marzo 1994), n. 100, p. 29-31 (su cui si veda lelo CJanton,<br />
Lettera a “La Panarie”, «La Panarie», 27 (marzo 1995), n. 104, p. 79-80). Sull’uso del friulano nella scrittura letteraria, si legga<br />
quanto Sgorlon dichiara in liana niSSim, Sgorlon teste insolente, op. cit., p. 136-137.<br />
4 Stefano damiani, Il mistero del mondo nell’ultimo romanzo di Sgorlon, «La Vita Cattolica», 21 novembre 2009, disponibile in<br />
linea.<br />
5 Ibidem.<br />
6 Ibidem. Costantemente i testi risentono della concezione della storia, della natura e dell’uomo propri dell’autore.<br />
7 Manca uno studio sistematico sulla narrativa in friulano. Per un quadro di riferimento cfr. almeno rienzo Pellegrini, Tra lingua<br />
e letteratura. Per una storia degli usi scritti del friulano, <strong>Udine</strong>, Casamassima, 1987, p. 309-311, accanto id., Aspetti e<br />
problemi..., cit., p. 88-93 e giorgio faggin, La letteratura ladina del Friuli negli ultimi trent’anni, cit., p. 26-30. Per la narrativa in
Prime di sere, ambientato nella zona di Cassacco, si stacca dagli altri due libri, collocati in un<br />
Friuli trasfigurato e impegnati nel cogliere elementi della realtà per trasporli su un piano simbolico e<br />
allusivo. Questa è forse l’opera in cui affiora più nel dettaglio quella «provincia da raccontare» 8 che per<br />
Sgorlon costituisce alimento costante per la sua narrativa. La prosa tende maggiormente alla mimesi<br />
del parlato nei discorsi diretti e indiretti; qui l’autore ricrea, più che nei romanzi successivi, la dimensione<br />
storica e situazionale, e con ciò anche linguistica, dei personaggi. Basti pensare all’urlo del controllore,<br />
in italiano, nell’avvio del romanzo: «Tricesimo! Stazione di Tricesimo!» (P: 11), o alle formule<br />
vivaci contenute nei dialoghi (quali: «bocon di mone!» P: 105; «vecio bambeo!» ibidem). La lingua del<br />
narrato si pone alla portata dei personaggi, con la presenza di locuzioni comuni (“Eliseo al cjapave chel<br />
che j davin sence dî nancje bau” P: 36; “al stave cul cûr in man” P: 65), con brani che, a ogni modo, rimangono<br />
per la gran parte privi di affettazioni oralizzanti. Il lessico si allinea a queste dinamiche, per<br />
segnalare i caratteri di una società preindustriale mediante l’utilizzo di lessemi intrisi di corrispondenza<br />
con quello che poteva essere il vissuto quotidiano del Friuli degli anni ’60, ma che non assumono mai intenti<br />
documentari. Altri contributi realistici e concreti vengono offerti dai toponimi (si incontrano Reane<br />
P: 11; Fraelà P: 12; Tresesin P: 12; Cjassà P: 13; Buje P: 38; Mels, Pers, Susans, Sandenêl, P: 53; Vendoj<br />
P: 56, Raspan P: 94), che in qualche caso arricchiscono le descrizioni: “Eliseo al cjalave lis montagnis.<br />
Si viodeve il dint dal Canin ancjemò dut plen di nêf, e a ’nd’ere ancje tai canalons de mont di Musi e<br />
te plere dal Quarnan” (P: 88; tale brano in V: 90 è ridotto a “Eliseo guardava le montagne”). A queste<br />
caratteristiche si sovrappongono le velature letterarie date dall’uso dell’aggettivazione (“il cîl lavât de<br />
ploe al jere umit e clâr” P: 64; “L’operari al menave il cjâf, avilît e preocupât” P: 88), delle similitudini<br />
per la maggior parte tratte dal linguaggio quotidiano – si leggano i traslati che rendono le inquietudini<br />
di Eliseo: “j sbisiâ dentri come un lamp di dûl” (P: 24); “lui si sintive sgarfâ tal stomi di pore che lu<br />
cognossessin” (ibidem) e si osservino i paragoni che raccolgono un immaginario dedotto dal parlato di<br />
ogni giorno: “scur come in bocje” (P: 11 e ivi: 30); “la buere [...] ’e businave jenfri i ramaz dai morârs come<br />
un anime in pene” (ivi: 11); “la strade glazzade ’e sunave come un veri” (P: 12); “la piel [...] plene di<br />
crituris come un corean vecjo” (P: 13); “chê idèe si sfantave come il fun” (P: 14); “il cjan al tacà a uacâ<br />
come un spiritât” (P: 23); “il cjan [...] e al tacà a uacâ come un spiritât” (P: 55) – tutti espedienti che paiono<br />
concentrati sulla psicologia dei personaggi e sulla resa dell’ambiente. Così si consolida l’impianto<br />
realista e ad un tempo corale proprio di questo romanzo d’esordio. 9<br />
Ulteriori dati di supporto all’analisi vengono offerti dalla comparazione tra le versioni friulane, per cui pare opportuno<br />
qualche cenno su tale itinerario variantistico. Il passaggio da P a P 1 , accanto a modifiche che riguardano l’adeguamento<br />
di alcuni caratteri e la divisione delle parole agli usi grafici ufficiali, prevede interventi normalizzatori su luoghi di P<br />
che presentano fenomeni influenzati, tra l’altro, dal contatto con l’italiano, e ammessi dall’uso nel friulano parlato, che in<br />
P 1 vengono condotti al friulano (scritto) in linea con gli obiettivi editoriali della collana; questo nei singoli contesti ha ripercussioni<br />
sulla variazione stilistica. Per esempio: treno 11 diventa tren 3; Cristo 13 → Crist 5; impegno 126 → impegn 122<br />
(si elimina la vocale finale diversa da -a anche se il parlato può ammettere queste forme con la vocale finale -o) cilindro<br />
italiano si vedano elvio guagnini, Narrativa italiana in Friuli tra il 1968 e il 1969 (Sgorlon, Giacomini, Paolini), «Ce fastu?» 44-47<br />
(1968-1971), p. 147-157. id., Narrativa italiana in Friuli tra il 1976 e il 1977 «Ce fastu?» 53 (1977), p. 177-193; antonio de lorenzi,<br />
Narrativa friulana in lingua italiana nel Novecento, «Quaderni veneti», 9 (1993), n. 17, p. 87-97.<br />
8 Carlo Sgorlon, Il Friuli nella mia narrativa, 1982, conferenza inedita, si cita da Bruno maier, Carlo Sgorlon, Firenze, La nuova<br />
Italia, 1984 (Il castoro, 201), p. 116-124, p. 5.<br />
9 Scrive Claudio Toscani: “Il vento nel vigneto è concepito e scritto come esito di un sano e moderno naturalismo (di un realismo<br />
di sempre, in definitiva), dentro una colorita coralità di fondo, con psicologie seccamente sbalzate senza compiacenze<br />
sentimentali o ideali, condotto con asciutto descrittivismo e un vigore sintattico qua e là rinforzato [per la versione italiana] da<br />
cadenze o calchi dialettali”, cfr. Claudio toSCani, Invito alla lettura di Sgorlon, Milano, Mursia, 1994, p. 47.<br />
111
112<br />
39 → cilindri 31 (la forma è ricondotta alla norma che prevede la vocale d’appoggio -i); drenti 5 → dentri 5 (questo di P, se<br />
non si vede male, è l’unico caso in Sgorlon di metatesi di r, tratto che pertiene il parlato o il registro popolare, mentre per<br />
il resto si documenta dentri); poi mico 46 → migo 38; smerilio 70 → smeriliadore 63, oppure, si interviene sul nome del<br />
protagonista Eliseo → Eliseu. Con lo stesso obiettivo di livellamento formale, alcune sostituzioni invadono sia forme particolari<br />
come atomobil 57 → automobil 50, sia altre scelte lessicali: disè bielplanchinin 37 → disè planchinin 29; Mancomâl<br />
49 → Mancul mâl 42 (sempre dal terreno del discorso diretto, si recupera da D: 207 un altro esempio d’uso di Manco mâl;<br />
nello stesso contesto O: 47 presenta Mancul mâl); crepecûr 50 → sclopecûr 43; nell’àmbito della selezione dei termini:<br />
fanâi ‘fanali’ (11 del treno, 12 delle auto e dei camion) → ferâi 3, 4 (ma in P ferâl è impiegato col diminutivo ferâlut 26 che<br />
indica il «fanale a petrolio» V: 26, con diversa pertinenza semantica rispetto all’uso di ‘fanâl’); tra 39 → jenfri 31 (entrambe<br />
le preposizioni sono usate in P); in curtîl 64 → tal curtîl 57; ancora, triciclo 61 (usato in alternativa a biroz 62) → biroç<br />
54; rulo 84 → rodul 78; di lusso 86 → di gale 80 (di gale si trova sia in D sia in O); vieli lagnôs 130 → vieli gnagôs 126; al<br />
tucâ su la puarte 40 → al pocâ la puarte 32; Che chel tipo se fos cjapade 51 → Che chel se fos cjapade 44; «Si metarìn<br />
d’acordo» 64 → «Si metarìn dacuardi» 57 (ancora un intervento nel terreno particolare della simulazione del dialogo). 10<br />
Se per il primo romanzo Sgorlon confessa l’influenza dell’esistenzialismo di Čechov e Cassola,<br />
per lo stile degli altri due bisogna menzionare, almeno, l’ideale patrocinio di García Márquez, di Borges<br />
e di Elsa Morante. In particolare, come rivela, la scrittrice diventa il modello per “il gusto di raccontare<br />
storie con sfondi lievemente favolosi, di creare atmosfere particolari e personaggi pieni di miti e illusioni,<br />
i quali tendono a trasformare la realtà in sogno,” 11 tutti aspetti condivisi da Il dolfìn e da Ombris<br />
tal infinît. Per comprendere poi la posizione di Prime di sere rispetto ai due romanzi seguenti, tornano<br />
utili alcune osservazioni critiche di Bruno Maier rivolte alla distanza tra Il vento nel vigneto e le opere<br />
successive. Lo studioso afferma:<br />
nei futuri romanzi [...] il Friuli sarà visto e rappresentato [...] in una dimensione non più esclusivamente realistica,<br />
ma insieme realistica e visionaria, mitica e fiabesca, e proprio perciò ben conveniente a uno scrittore non documentario,<br />
non storico, ma esistenziale. Nel Vento nel vigneto l’ambiente friulano è una realtà; più tardi diventerà una misura di<br />
umanità, un archetipo di esistenza, un paesaggio d’anima. 12<br />
Il dolfìn ha i caratteri di un romanzo di formazione ambientato in un’atmosfera fiabesca, a Tesis,<br />
una località friulana ai confini con le montagne. Il punto di vista della narrazione, che appartiene al protagonista,<br />
Faustìn – già da sé nome parlante, a indicare l’erede prescelto, appunto, il ‘delfino’ – 13 , viene<br />
espresso mediante una prosa densa di informazioni che servono allo stesso tempo a connotare e a<br />
sfumare eventi e situazioni avvolti nei misteri della vita. Il racconto è in prima persona, ma il linguaggio<br />
10 Si trascrivono in nota alcune varianti relative a V 1 rispetto a V; dall’insieme emerge un’operazione che elimina le note a pié<br />
di pagina di V e in qualche caso accorpa a testo le illustrazioni proposte in calce. Tali modifiche sembrano eliminare le forme<br />
avvertite come desuete per avvicinare la lingua del lettore contemporaneo (scegliendo elementi che non necessitano della<br />
mediazione della glossa). Si va da revisioni come daccordo V: 131 ricondotto sempre a d’accordo V 1 : 101 (d’altra parte V: 82<br />
presenta d’accordo); e ecceomini (V: 32) trascritto nella forma invariabile ecceomo (V: 24); a riscritture più interessanti sul<br />
piano della variazione lessicale: me l’asciugo V: 71 → me la cavo V 1 : 55 (e la nota in V glossa «me la sbrigo, me la cavo»); nella<br />
cuccuma V: 117 → nella napoletana V 1 : 92 (e V presenta la nota «Recipiente di rame, ormai antiquato, per preparare il caffè<br />
o altre bevande»); i lavori V: 145 → il cantiere V 1 : 111 (variante che non dipende dalla presenza di note in V); e infine cjavedâl<br />
(V: 164, un friulanismo segnalato dal corsivo e spiegato in nota) diventa “alare di ferro battuto” V 1 : 126 (che elimina il prestito<br />
e assimila la nota di V). Immediato l’interesse storico-documentario per parole abbandonate come cjavedâl e cuccuma.<br />
11 Inchiesta sulla narrativa..., cit., p. 193. Va da sé che Sgorlon è autore di Invito alla lettura di Elsa Morante, Milano, Mursia,<br />
1972.<br />
12 Bruno maier, op. cit., p. 22-23. Su questi aspetti pare importante segnalare elvio guagnini, Simbolismo, immaginazione e realtà<br />
in Carlo Sgorlon narratore, «Ce fastu?» 48-49 (1972-1973), p. 118-141.<br />
13 Si legga “No jerial un âtri segnâl de predilizion dal destìn viars di me, une âtre benevolence tai confronz di Faust, che ancje<br />
il so non al faseve pensâ a une sorte di specjâl?” D: 126.
è più vicino a quello di Sgorlon che a quello di un bambino. La lingua del romanzo si conforma agli usi<br />
dell’autore: di fatto – ma si ribadisce che ciò pare normale per lo scrittore – è la lingua ad assecondare<br />
la narrazione e non viceversa. Questo dato emerge con peculiare evidenza nel momento di svolta del<br />
romanzo, quando la caduta delle illusioni del protagonista è segnata dalla presenza significativa di un<br />
ossimoro: “Une disperazion serene” (D: 227). Anche dal punto di vista stilistico, si fissano la delusione<br />
e, insieme, la raggiunta consapevolezza del personaggio.<br />
Ombris tal infinît pare il romanzo friulano in cui più si distingue lo sforzo di trasfigurare il Friuli<br />
in luogo metaforico, ideale per accogliere un racconto che ancora suggerisce una collettività originaria<br />
invece di fotografare una realtà precisa. 14 Rispetto al Dolfìn il motivo ricorrente è quello della storia: il<br />
Friuli non è più collocato nel passato, ma nel presente. L’autore mescola gli eventi con le percezioni dei<br />
protagonisti, li intreccia di continuo con la finzione della vicenda e conserva toni misteriosi e una certa<br />
indeterminatezza spaziale e temporale, in modo tale da evitare la convergenza con il romanzo storico. 15<br />
Il narratore riporta spesso le sensazioni e gli stati d’animo dei personaggi e partecipa ai loro pensieri<br />
attraverso l’uso, comunque moderato, di numerose frasi esclamative e interrogative che riproducono il<br />
flusso dei discorsi indiretti liberi e di costrutti del parlato: si consideri a esempio l’utilizzo di forme interiettive,<br />
nel riferire i sentimenti della protagonista Eve (“Une rabie scure e disgustade le traviersave.<br />
Salabracs!” O: 81) o della madre (“Tal pantan de sô disperazion si cjalave intor par viodi se al fos il mût<br />
e il mieç par rimedeà la situazion. Ma lafè no!” O: 15). Allo stesso tempo, a livello lessicale, nel giro<br />
di poche righe si oscilla tra il riferimento mitico a “un istint di benandant” e locuzioni colloquiali come<br />
“butâ aghe sul fûc” (si cita entrambi da O: 126), segnali della grande quantità di informazioni che vengono<br />
coinvolte lungo la narrazione. 16<br />
Ancor più che nel romanzo friulano d’esordio, negli ultimi due la lingua tende a un’abbondanza<br />
di vocabolario, funzionale a una minuzia descrittiva che sorprende per l’aggettivazione, le serie sostantivali<br />
e la predilizione per sintagmi calibrati e sorvegliati. Risulta evidente tutto l’impegno volto, come<br />
Sgorlon dichiara a Claudio Marabini, a “interpretare poeticamente il senso arcano dell’esistenza, e i<br />
perenni sentimenti umani: le speranze, le ansie, le illusioni, le delusioni, la fuga del tempo, il timore<br />
della morte” 17 . Rientra in quest’ottica, se non si sbaglia, la presenza ripetuta della parola ‘destino’ (al<br />
limite della personificazione: “in chest ’o rivavi a viodi il colp di záte dal destìn” D: 201) 18 e di una se-<br />
14 Su Friuli letterario di Sgorlon, cfr. Claudio maraBini, Sgorlon e il Friuli in id., Le città dei poeti, Torino, SEI, 1976, p. 47-52;<br />
antonio de lorenzi, Narrativa friulana in lingua italiana nel Novecento, cit. e Caterina fiorentini, Il Friuli di Carlo Sgorlon ovvero<br />
i sentieri dell’immaginazione nel discorso geografico, in Studi in ricordo di Guido Barbina, 2 voll., I. Terre e uomini: geografie<br />
incrociate, a cura di Alma Bianchetti e Mauro Pascolini, <strong>Udine</strong>, Forum, 2001, p.479-495. Se Tesis non esiste, in D vengono<br />
citati nomi di luoghi reali del Friuli (come i santuari di Madone di mont, Lussari e Barbane, D: 95; il Tiliment D: 97), che però<br />
non vanno a definire l’ambientazione; lo stesso in O, in cui, peraltro, il nome della città, che potrebbe essere <strong>Udine</strong>, è sempre<br />
omesso e sostituito dai puntini di sospensione.<br />
15 Alla base di tale pratica sarà da considerare l’esercizio svolto nei romanzi L’ultima valle, La conchiglia di Anataj, L’armata dei<br />
fiumi perduti, La foiba grande, La malga di Sîr, in cui l’invenzione narrativa allude a vicende storiche precise.<br />
16 A riguardo, si dovrebbe tener conto anche dei forestierismi (tutti in corsivo), che non sempre appartengono al linguaggio<br />
medio di comunicazione, ma anzi avvicinano il testo ai dominî della ricerca di letterarietà: in Prime di sere sono pigjama: 17;<br />
oblò: 29; naylon: 96; qualunquismo: 94; ne Il dolfìn sono quasi assenti (gli unici due, ricorrenti, Finesterre e tabù, sono anche<br />
parole chiave del romanzo), in Ombris tal infinît sono usati con più insistenza; si fornisce qui un elenco sommario: chauffeur:<br />
42, boulevards: 45, Vizîr: 59; gangsters: 86; milord: 86; stars: 88; trumeaux: 89; club: 98; Kibbuz: 111; West: 125; dépliants:<br />
152.<br />
17 Claudio maraBini, op. cit., p. 51.<br />
18 Per altri esempi: il gnô destin D: 30; l’ombrene dal destin D: 96; corace dal destin D: 96; destin di esili e di malepasche O: 8,<br />
il so destin O: 27, un lûc segnât dal destin O: 45 il sens dal destin O: 45; une falope dal destin O: 60 il lôr destin O: 61; la ore<br />
dal destin O: 135.<br />
113
114<br />
rie di termini riconducibili al filone tematico del mistero, che il testo assorbe come mezzi che restituiscono<br />
il fascino e la meraviglia per gli incanti della vita, che sono tutti aspetti familiari ai protagonisti.<br />
Per minimi esempi del ruolo della ricercatezza formale all’interno di questo tema, si notino descrizioni<br />
come: “Si veve la impression che tal timp si fos introdot alc di galiot e di diaulic” O: 177; “Pluitost al<br />
semeave ch’al provas un vêl di suturnitât” D: 79 e, in parallelo, l’alta occorrenza di aggettivi come mistereôs,<br />
scûr, striât, suturno che non mancano di accompagnare nomi quali ombre, striez e suturnitât. 19<br />
Pure se in filigrana si percepisce anche in Prime di sere, specie all’interno del Dolfìn e di Ombris<br />
tal infinît, il ‘destino’ costituisce il centro mobile dell’opera. Appare evidente che in questi due romanzi<br />
si fa più forte il lavoro descrittivo dell’autore volto a restituire le dinamiche interiori dei personaggi e<br />
l’impatto con le vicende in cui sono coinvolti. Torna utile quindi leggere come lo scrittore esprime questa<br />
ricerca poetica:<br />
Nella mia narrativa serpeggia la sensazione abissale e ansiosa del nostro legame con la vita, la natura, la Terra,<br />
il Sistema solare, la Galassia che chiamiamo Via Lattea, con l’Universo, col Big Bang. Come i teosofi, sento che noi abbiamo,<br />
per così dire, una proiezione cosmica, perché siamo la risultante di lunghissime azioni ed evoluzioni dell’Essere,<br />
misterioso nella sua origine e nelle sue modificazioni. 20<br />
Un altro aspetto della narrativa friulana di Sgorlon che richiama l’attenzione sulla discreta ma<br />
costante presenza dell’autore nel testo e che ribadisce la letterarietà della pagina – si badi, una letterarietà<br />
non marcata, perché propria dello stile dell’autore, come conferma la narrativa in italiano – è<br />
l’alta percentuale di similitudini. La comparazione analogica si dirige spesso verso il quotidiano, con<br />
accostamenti che avvicinano uomo e animale, collegano un’azione, oppure un concetto astratto, a un<br />
figurante tratto dalla realtà concreta, sfruttando perlopiù espressioni d’uso comune, senza iterare quasi<br />
mai la stessa immagine. 21 Quella che viene iterata, semmai, è la struttura della similitudine (si pen-<br />
19 Per un campione si veda: mûz [...] scûrs e mistereôs D: 11; il so incjant suturno e striât D: 22; un sium scunît e suturno D:<br />
51; dut al jere invezzi inciart e mistereôs D: 129; intuizion sutîl e anzit mistereose O: 31 une fuarce mistereose e striade O:<br />
136; il mont [...] al veve simpri alc di simbolic e di mistereôs O: 103 tal versant suturno de me anime D: 32; tal ream suturno<br />
di mê none D: 36; in maneris mistereosis D: 49; ombre inmagade D: 61; Orient mistereôs D: 72; un striez mistereôs D: 115;<br />
segnos mistereôs D: 131; mont suturno D: 132; providence mistereôse D: 135; un moment striât D: 224; glon mistereôs D:<br />
238; clik mistereôs D: 264; mût mistereôs O: 8; ligrie mistereose O: 27; une rivelazion mistereose O: 33; par intuizion sutîl e<br />
anzit mistereose O: 31; i pareve di jessi sul pont di vê come une rivelazion mistereose O: 33; e fos interessade [...] al aspiet<br />
plui mistereos e suturni dal mont O: 59; une pôre mistereose O: 65; fuarcis mistereosis O: 73; il dolôr mistereôs de vite O: 95;<br />
une resistence mistereose O: 110; come une glace mistereose O: 146; su la cime de maravee e dal straneament O: 93.<br />
20 Carlo Sgorlon, La penna d’oro, [s.l., ma Pezzan di Carbonera], Morganti, p. 215.<br />
21 Per gli animali, il resoconto prevede: al tirave lis orelis come un cjan di ferme P: 46; Il frut al corè-vie lizêr tant’che un gjat<br />
P: 52; petant salz come un zupet P: 70; il frut al tacà a cori come un cjavriûl P: 80; simpri corint come un gneur P: 81; lavorâ<br />
come il mus P: 127 [nel discorso diretto]; cidine come une volp D: 23; Ma lis feminis a’ jerin invelegnadis cuntri di jê, come<br />
gjespis che ur vedin brusât il nît D: 62; tirât-sù come un pavon dentri une gabie d’aur D: 57; Mi sintivi libar come un cjavriûl<br />
D: 104; al jere come par un cai lâ-atôr senze il scus D: 133; al girandolave come une âf piardude toratôr de scuele D: 160; o<br />
restai smaraveât come un cocâl D: 185; di un pas lizêr come chel di un gjat D: 195; ’O tornai te mê cjàmare come une bestie<br />
feride D: 224; e jere sparagnine come lis furmiis O: 7; E saltave intor dai mascjos come une pantere O: 49; come che e fos<br />
une pantiane o une magne O: 65; pronte a saltâ fûr come un crot tal palût O: 84; un caratar scûr e insaziabil come un lôf o un<br />
lion O: 142; Al lave pes stradis di sere e di gnot, come un barbezuan O: 164; al jere di bessôl come un cjan tal so casot O: 167.<br />
Si vedano poi alcuni casi in cui il paragone fa riferimento al mondo naturale: al gambiave dentri come dal dì a la gnot P: 51;<br />
Parcè vignino-sù come foncs o urtìis D: 46; Il gno imborezzament mi butave come grampis di spinis par dutis lis venis D: 61; ’O<br />
restai come brusât dal folc D: 135; Ogni particolâr gnûf ch’o vignivi a savê di jê subìt al servive a dâj flât, come une buere ch’e<br />
sofli sun tun fûc D: 170; ch’e dipendeve di resons invisibilis, come il jevâsi o il sbassâsi dal mâr D: 181; Mi sintivi travanât di<br />
sgrisui di emozion, come la scoreade potent dal taramot, ch’e côr dentri la tiare D: 184; la voe si jere distacade di me come
si, per puro esempio, ai casi: «sarpinz granc’ come trenos» D: 91; «balenis come ìsulis» D: ivi). Accanto<br />
agli ingredienti più elementari, spiccano le similitudini dal tono proverbiale, i cui figuranti sono attinti<br />
dalla religione, dalla mitologia o da àmbiti consimili, come quelli della fiaba e della leggenda, terreni<br />
là dove la coscienza letteraria affonda nell’immaginario popolare (si legga: “e poco dopo al jere alc di<br />
fatâl, come che no puedin no vignî Nadâl o Pasche dentri dal an” O: 33; “La tiarce volte lis robis si scuen<br />
capîlis par fuarce, come Sant Pieri cuant che il gjal al cjantà” O: 171; “lis sôs peraulis a deventavin di<br />
clap, come ch’al vès viodût i vôi di Meduse” D: 194; “di bessôi, come Sant Antoni tal desert egjizian”<br />
O: 74). Di rilievo paiono la concentrazione di due o più di queste immagini e la presenza di moduli lunghi,<br />
spesso collegati ai motivi citati del destino, del mistero e della meraviglia, tutti fattori che nutrono<br />
l’impatto figurale del testo. 22<br />
L’ampia gamma di figuranti, recuperati dall’immaginario comune, la frequente successione sulla<br />
pagina di più associazioni, la pluralità di soluzioni e di particolari costituiscono chiare prove del lavoro<br />
creativo e analitico della mente che le ha concepite. Questo ordito retorico forma la sigla stilistica<br />
che rende i romanzi di Sgorlon prettamente riconoscibili, al di là dei differenti rapporti di forza che<br />
mutano da libro a libro, da un periodo all’altro della sua esistenza. E lo scrittore si pone sempre in una<br />
posizione neutra verso la lingua, con un friulano dalle tonalità medie, ma vissuto dosando le componenti<br />
colloquiali e letterarie, disposte per dare calore alla prosa e ai suoi personaggi e per catturare la<br />
partecipazione di chi legge. L’alto tasso di figuralità può essere ricondotto alla tendenza dell’autore a<br />
interpretare la sua narrativa come «fabulizzazione della realtà» 23 e al tempo stesso – viste le tipologie<br />
elementari dei figuranti che nei casi più articolati sono attinti da esempi biblici o recuperano fiabe e leggende<br />
– alla volontà di Sgorlon di restituire con la sua inventività quell’immaginario figurale di origine<br />
sia colta sia popolare che alimenta il mito e le narrazioni di ogni epoca. 24<br />
une fuee secje e senze vite D: 187; ch’a girassin tal vueit come stelis tal cîl neri e infinît D: 267; come il rivoc che al rimande<br />
l’urli dal boscadôr O: 10; al jentrà come une bugade di tramontan in cjase O: 34; Tu sês strambe come la lune O: 106 [nel<br />
discorso diretto]; lis pretesis dai students a cressevin, si sglonfavin, come un flum cuant che al slavine par dîs e dîs O: 114;<br />
Dut il so sisteme di ideis [...] al jere daûr a sdrumâsi, come il flanc di une coline masse erte e imbombade di aghe O: 119; I<br />
siei desideris a restavin malpajâts e a metevin fûr spinis come i baraçs des moris O: 123; la passion si scjadenave dentri di<br />
jê come une montane O: 141.<br />
22 Pure in questo caso, numerosi esempi si recuperano soprattutto da D e O: al sintive il madressi de stagjon e de campagne,<br />
come tun revoc mistereôs dal so sanc P: 114; al sintive la buere ch’e passave e ’e tornave a passâ tra lis plantis, come une<br />
man senze pâs ch’e sgarfàs tra fueis e vidiz P: 144; La veretât ’e vignì indenant a planc, come une nâf ch’e rivi in tun puart,<br />
vignint fûr de fumate grise e sunant a dadis la sirene D: 49; [...] la veretât. ’E jere platade in tun cjanton dal gno spirt, come<br />
une semence in te tiare D: 50; Par jê al jere come se une piore ’e ves traviarsât un bosc di lôfs plens di fan, cui glutidôrs ros<br />
tan’che flamis in te gnot D: 71; ’O provai par lui une invidie stranie, come se j fòs tocjade une venture che jo no le varès vude<br />
mai plui. Come se no vès mai podût vê l’ardince di tornâ a fâ i siei itineraris, dibessôl e bandonât a ogni sorprese dal destîn<br />
D: 73; L’aiar al semeave plen di une spiete di aveniments spaventôs. Un grum di contadins a vevin cirût di fermâ il cjaval,<br />
ma chel si impenave da fa pôre, come se al fos un nemâl da bataie e al sgagnive di furôr O: 39; “[...] E comande a lis bestiis<br />
come che e fos une strie.” [...] E sintive la aghe sot tiere, e veve la cjalaure losche, e domave lis bestiis par vie che e jere une<br />
strie, o une agane, o alc dal gjenar O: 41; Dute la vite dai oms e jere come compagnade di une fantasime, un alc che nissun<br />
nol viodeve, come un nûl mistereôs e cence sostance. Al jere il destin O: 45; e veve la impression che une paradane di veri si<br />
sfantàs tal so spirt, e al vignìs fûr alc che in definitive al jere une voie ferbinte di piturâ O: 54; Eve e sintive che tra jê e il so<br />
om si jere formade come une paradane di veri, grues come chel des vetrinis O: 149; Il destin al butave la int di ca e di là come<br />
che al fâs il tramontan cu lis fueis secjis de sierade O: 77: L’om al veve la persuasion che al jere propit il destin a disfâ i siei<br />
plans, a fâju sclopâ tant che a fossin bufularie colorade dai frus O: 128; Dut ce che e piturave al meteve fûr come une fumate<br />
di misteri cricant e sgrisulât O: 156.<br />
23 Bruno maier, op. cit., p. 115.<br />
24 Si conferma il quadro della figuralità della narrativa italiana di Sgorlon descritto da Claudio toSCani, op. cit., p. 163-169.<br />
In particolare Toscani ha ben individuato la capacità dell’autore di “inserire nella civiltà della parola la realtà dei fatti; di<br />
115
116<br />
Nota critica<br />
Per offrire minime tracce degli interventi critici sui romanzi friulani di Sgorlon può essere utile<br />
elencare qui i principali contributi. Si concentrano tra parentesi alcuni prelievi apparsi in qualche modo significativi<br />
a chi scrive, pur nella consapevolezza che tutto ciò meriterebbe un più approfondito confronto.<br />
Su P: gianfranCo ellero, «Friuli d’oggi», 11 gennaio 1971 (P “è un’autentica fortuna per una letteratura, come<br />
quella friulana, ricca di buone opere in versi, ma decisamente povera di prosa d’arte”); ottorino Burelli, «La Vita Cattolica»,<br />
27 marzo 1971 (poi, «La Panarie», 4 (dicembre 1971), n. 4, p. 61; “una scrittura che oseremo chiamare perfetta [...] per<br />
la proprietà e l’intuizione felicissima dei vocaboli [...] ma soprattutto per la riuscita [...] fusione del linguaggio con il contenuto”);<br />
dino meniCHini, «Messaggero Veneto», 5 aprile 1971 (“Sgorlon ha dato alla letteratura friulana di lingua ladina il<br />
romanzo atteso da secoli”); giorgio faggin, La letteratura ladina del Friuli negli ultimi trent’anni, «La Panarie», 4 (dicembre<br />
1971), n. 4, p. 29-30 (“Il friulano impiegato [...] è una “koinè” correttissima e asettica, quasi una specie di ‘Basic Friulan’”;<br />
dello stesso, la rec. in «Friuli d’Oggi», 21 febbraio 1972 con un elenco di suggerimenti formali); tito maniaCCo, «Corriere<br />
del Friuli», 31 luglio 1974; su P si vedano, inoltre, le scelte antologiche: Bindo CHiurlo-andreina CiCeri, Antologia della letteratura<br />
friulana, Tolmezzo, Edizioni «Aquileia», 1975, p. 842-853; GianfranCo d’aronCo, Nuova antologia della letteratura<br />
friulana, vol. III, Il secondo Novecento, <strong>Udine</strong>, Ribis, 1982, t. 2, p. 327-335; dino virgili, La Flôr, <strong>Udine</strong>, Società Filologica<br />
Friulana, 1978 2 [1968], p. 358-360. Su D 82 : CelSo maCor, «Voce Isontina», 22 gennaio 1983 (“Qui la lingua friulana è posta<br />
violentemente dinanzi al basilare problema dell’espressione letteraria piena, senza le limitazioni di linguaggio e di lessico<br />
che sono sempre l’immenso fiume da scavalcare per una presenza letteraria senza confini geografici”); lelo CJanton,<br />
«Il Gazzettino», 3 febbraio 1983 (“non saranno pochi i lettori friulani che troveranno qualcosa da eccepire a proposito di<br />
certe espressioni linguistiche e perfino di certe stranezze lessicali”); domeniCo Cerroni CadoreSi, «Il Punto», n. 2, 15 febbraio<br />
1983 (“Sgorlon [...] vuole ancora una volta e coraggiosamente recare il suo prezioso contributo alla crescita culturale della<br />
sua comunità. Ciò magari forzando un po’ i termini del gioco espressivo-linguistico”); aldo moretti, «La Vita Cattolica», 5<br />
marzo 1983 (“Sgorlon al dopre un furlan ristocratic, squasit ch’al fevelas a int studiade. [...] Chel vê alzade e slargjade la<br />
lenghe al è par me un grant servizi fat a la furlanetât”); gianfranCo d’aronCo, Le illusioni perdute di un erede, «Messaggero<br />
Veneto», 26 marzo 1983 (poi, «Ce fastu?», 62 (1986), 2, p. 342-345; “questo lungo racconto – che pare sia stato concepito<br />
in italiano poi scritto in friulano – adopera una lingua molto sorvegliata, propria del friulano colto, intellettuale, tecnicamente<br />
preparato, preciso sino alla pedanteria”); Angelo maria Pittana, Narrativa friulana, «Corriere del Ticino», 26 marzo<br />
1983; gianfranCo SCialino, «La Vita Cattolica», 19 novembre 1983 (“va chiarito che non esiste una discontinuità tra lo Sgorlon<br />
narratore italiano e lo Sgorlon narratore friulano [...] ciò che importa è che entro la letteratura friulana sia comparsa<br />
un’opera che attinge l’universale per temi sviluppati e che ingloba, sotto il velo dell’inesausta fluente sorgività dello stile,<br />
i tormenti degli interrogativi sull’esistere della cultura europea moderna”); luigi mattei, «Secolo d’Italia», 22 gennaio 1984<br />
(poi «Gazzetta di Parma», 26 gennaio, 1984 e «Il Popolo», 29 gennaio 1984); su D si consulti: angelo maria Pittana, Considerazions<br />
sul scrivi prose furlane, «Ce fastu?», 60 (1984), 1, p. 161-163; gianfranCo SCialino, Sgorlon «friulano» e Il dolfìn,<br />
in Bruno maier, Carlo Sgorlon, Firenze, La nuova Italia, 1984 (Il castoro, 201), p. 116-124.<br />
reperire metafore in contesto a situazioni per lo più comuni; di ridare potere vitale, e talvolta resurrettivo, a un linguaggio<br />
dall’antica artigianalità scriptile, dagli ancestrali filoni lessicali (tra magici, visivi, mistico-sacrali, storico-araldici e così via)”<br />
ivi, p. 155.
L’espressione musicale nella narrativa di Sgorlon<br />
di Luisa Sello<br />
Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste<br />
Se tutti considerano Il velo di Maya l’opera di Sgorlon innegabilmente legata alla musica ed al<br />
suo mondo, è forse dovuto al fatto che il protagonista è un compositore, il quale, scoperto un clavicembalo<br />
nella polverosa soffitta della casa materna, già da bambino rimane catturato dal fascino arcano di<br />
quest’arte che sente come “uno dei volti della bellezza.” 1<br />
Per Sgorlon tale volto non si delinea solo nel percorso musicale di Jacopo, il protagonista de Il<br />
velo di Maya; il profilo dell’espressione musicale viene dipinto dallo scrittore friulano in diversi suoi lavori<br />
e con più sfumature, tanto da insinuarsi tra le pieghe dei suoi libri durante tutto il tragitto del suo<br />
narrare, fino a diventarne un filo melodico invisibile che accomuna e armonizza.<br />
In una delle foto che ritraggono Sgorlon accanto alla madre, appare un pianoforte verticale che<br />
più volte avevo notato durante le mie visite alla Signora Livia, allora la mia maestra, madre di Carlo;<br />
quel mobile muto, con presenza imperiosa ma silenziosa, m’aveva sempre dato l’idea di un amore inespresso<br />
o, forse, corteggiato. Sicuramente Carlo già da bambino era rimasto attratto dal suo richiamo<br />
e, nonostante la penna d’oro regalatagli in giovane età avesse predestinato il suo cammino, non aveva<br />
certo ignorato il fascino di quella tastiera, custode di tesori e melodie ricche di arcano mistero e difficili<br />
da spiegare con le parole.<br />
Vissuto in un’epoca in cui gli echi del melodramma risuonavano ancora nei dischi in vinile, gli<br />
LP 33 giri, Sgorlon non rimane infatti escluso dall’entusiasmo per il belcanto, e questo traspare in tutta<br />
la sua opera, a cominciare da Il velo di Maya volutamente dedicato agli “appassionati di musica<br />
classica.” 2<br />
D’altronde ad uno scrittore colto, autodefinitosi “una sorta di cantastorie”, non poteva mancare<br />
l’attrazione ai modelli eterni, grazie alla quale l’artista forma le proprie opere. Se Arthur Schopenhauer<br />
definisce l’arte musicale come ciò che “esprime la saggezza più profonda”, 3 Johann Wolfgang<br />
Goethe “il linguaggio [...] in cima a tutto” 4 e Beethoven “la porta immateriale per un mondo superiore<br />
della conoscenza”, Sgorlon non è da meno, definendo la musica “un’esigenza universale dello spirito.” 5<br />
Non si deve dimenticare, inoltre, che Sgorlon è anche figlio del Friuli, dove è nata la danza che<br />
1 Carlo Sgorlon, Il velo di Maya, Milano, Mondadori, 2006, p. 85.<br />
2 Op. cit., p. 5.<br />
3 JameS anderSon Winn, Unsuspected Eloquence: A History of the Relations between Poetry and Music, London, Yale University<br />
Press, 1981, p. 199.<br />
4 giovanni guanti, Romanticismo e musica. L’estetica musicale da Kant a Nietzsche, Torino, EDT, 1981, p. 79.<br />
5 Carlo Sgorlon, Il velo di Maya, cit., p. 85.<br />
117
118<br />
ha ispirato Bach e Couperin con il suo ritmo ternario, ove la musica popolare ha alimentato le radici di<br />
una identità; egli, infatti, non tralascia di citarne la forza suggestiva, sottolineando, anzi, che i grandi<br />
compositori dell’otto e novecento avevano attinto proprio agli “schemi eterni” 6 della musica popolare<br />
“che non era né antica né moderna, che non conosceva sperimentazioni di nessun tipo, né dodecafoniche,<br />
né seriali, né concrete, ma apparteneva a schemi eterni. Stava nel fondo malinconico dell’anima<br />
della gente, che trasformava in note il sentimento più intimo e melanconico della vita.” 7<br />
Da queste righe traspare con chiarezza che Sgorlon non era affatto digiuno di conoscenza del<br />
repertorio musicale, né dei suoi sviluppi attraverso i secoli. Anzi, in questo romanzo si pone in atteggiamento<br />
critico di fronte alle sperimentazioni contemporanee d’avanguardia e confronta musicisti virtuosi<br />
con quelli più intensi.<br />
Il velo di Maya e Il caldèras, 8 sono libri che contengono molte domande sulla musica, ma tutte<br />
senza risposte. Sembra che essa venga da fonti lontane e ignote, legate alla concezione metafisica del<br />
rapporto con il cosmo. “La musica – scrive Sgorlon – è poi niente altro che una metafora o un aspetto<br />
di Dio.” 9<br />
La sua ammirazione si amplifica ancor di più dinanzi alle qualità di chi crea la musica e la interpreta.<br />
Difficile spiegare da dove venga il genio, afferma, e ancora più arcano rimane il mistero della<br />
provenienza del talento musicale, fatto di codici astratti e impenetrabili. Segno della magnanimità della<br />
Natura, anche in questo grande e divina, il talento artistico lo affascina e lo attrae, tanto da rimarcare,<br />
proprio ne Il velo di Maya, il famoso patto che Adrian Leverkühn, protagonista del Doktor Faustus<br />
di Thomas Mann, aveva stabilito in cambio di un’eterna ispirazione musicale. Non è forse un caso che<br />
il cane lupo del piccolo Jacopo si chiami proprio Faust, a testimonianza di una forte attrazione verso<br />
quegli archetipi comuni che Sgorlon stesso riconosceva, come ne La tredicesima notte, di chiara ispirazione<br />
Shakespeariana.<br />
Il talento bussa alle tempie dell’autore anche nella Regina di Saba materializzato in una creatura,<br />
Isabella, capace di trasformarsi in continue forme artistiche: “suonava, recitava, danzava, ma con la<br />
stessa naturalezza con cui un’ape produce il miele o un’ostrica la perla. Per lei non era un fatto dell’intelletto<br />
ma dell’istinto.” 10 L’acerba, gotica principessa di Ligolais, “la musica ce l’aveva nel sangue e le<br />
veniva fuori naturalmente, con totale fluidità, come un filo che si dipani.” 11 Quella “ragazzetta – confessa<br />
il protagonista io narrante della storia – suscitava in me echi impensati, come fossi uno strumento<br />
musicale che non veniva suonato da tempo immemorabile, o che nessuno aveva mai toccato.” 12<br />
Suoni, strumenti musicali, riferimenti al sonoro, citazione di pagine di repertorio, sono costantemente<br />
presenti nei lavori di Sgorlon. Egli accenna anche a forme sensoriali associate dalla sinestesia<br />
in valori artistici intrecciati. Parla di “accordi musicali” 13 presenti in un’architettura, oppure del suono<br />
di un organo, personificazione di “un’intera orchestra.” 14<br />
Questi intarsi, questi innesti sonori, hanno il compito di rendere la descrizione più espressiva<br />
proprio perché richiamano l’attenzione del lettore anche attraverso percezioni simultanee: il senso<br />
6 Op. cit., p. 132.<br />
7 Op. cit., p. 132-133.<br />
8 Carlo Sgorlon, Il caldèras, Milano, Mondadori, 1988.<br />
9 Op. cit., p. 196.<br />
10 Carlo Sgorlon, Regina di Saba, Milano, Mondadori, 1975.<br />
11 Op. cit., p.29.<br />
12 Op. cit., pp. 13-14.<br />
13 Carlo Sgorlon, La tredicesima notte, Milano, Mondadori, 2002.<br />
14 Op. cit., p. 233.
nell’udito e dell’olfatto, legati tra loro dal ricordo del suono di un organo e di un forte odore di incenso,<br />
o della vista, come nel caso delle fasce di luce che inondano le arcate e colpiscono l’occhio del lettore<br />
come tante modulazioni armoniche.<br />
Le sue sono strutture narrative tese a richiamare più e diverse percezioni e a rendere così la lettura<br />
ricca di sensazioni non solo mentali, ma anche denotative. Si potrebbero definire, segni d’espressione<br />
15 , come in musica, segni che vengono inseriti dal compositore per rendere più espressiva la partitura,<br />
e in questo caso il racconto.<br />
Le colorature sonore si ritrovano anche nella descrizione dei suoi paesaggi, quasi fossero ritmi<br />
musicali alternati in tempi deboli e tempi forti, a sottolineare il procedere della frase. Si pensi alla descrizione<br />
del bosco di Eva, nella Fontana di Lorena, in contrapposizione con le ruspe e i grattacieli che<br />
vi dovrebbero sorgere conseguentemente all’avidità di un business senza scrupoli, oppure alla dimora<br />
Swedenborg 16 o al castello di Martino, ne L’alchimista degli strati, 17 in contrasto con le vie della città<br />
ormai inondate da auto e smog.<br />
Tali descrizioni ricordano le diverse tonalità musicali ed i movimenti lenti e veloci del ritmo, anche<br />
se in Sgorlon il procedere non viene mai accelerato o variato con impennate di tempo. Non esagera<br />
mai le ampiezze dell’anacronia o le analessi, 18 non usa complicati artifizi tra il tempo della storia e<br />
quello della narrazione. I suoi incastri sono morbidi e le anticipazioni temporali, quasi liriche. Ne scaturisce<br />
un tratto rasserenante, fresco ed incantato. Si potrebbe affermare che molte delle pagine <strong>sgorlon</strong>iane<br />
posseggano la struttura di una Sinfonia Classica, forse schubertiana, dove la semplicità dei temi<br />
viene espressa con grande competenza armonica e di forma, accompagnata dalla freschezza melodica<br />
e dalla fluidità della scrittura.<br />
In esse si percepisce attenzione per i valori dell’umanità, della tolleranza e della comprensione,<br />
quasi fossero armonizzazioni ben costruite e allineate ad un respiro cosmico. L’autore stesso definiva le<br />
sue opere sinfonie o brani per coro che abbracciano armonie universali. Se prendiamo la maggioranza<br />
del suo corpus letterario, ne risulta un comune denominatore che predilige la forma polifonica; vicende<br />
di un paese, di un gruppo etnico, di una famiglia, di un popolo. Eppure, all’interno di esse, c’è sempre<br />
un personaggio che dà luce a tutta la narrazione e imbastisce attorno a sé tutta una serie di tematiche,<br />
di variazioni e di rapporti umani che riconducono alla fonte. Viene alla mente la forma del Lied e quel<br />
tratto semplice del canto, variato poi in diverse forme ripetitive e di approfondimento, che arricchiscono<br />
l’incanto del tema stesso e danno struttura alla sua bellezza spontanea. Nel Lied, infatti, l’andamento<br />
è fluido, senza scarti, come nella narrazione <strong>sgorlon</strong>iana, in cui non appaiono improvvise variazioni<br />
del “punto di vista”, 19 siano esse multiple o variabili, e la focalizzazione scorre serena e spontanea, in<br />
un alternarsi di tonalità, maggiori e minori, espresse nei personaggi a volte centrali, a volte secondari.<br />
Secondo Suitner la “tradizionale ricostruzione biografica di un autore può essere arricchita<br />
e potenziata da un’analisi che miri a spiegare quel che rimane nascosto al ritratto tradizionale.” 20 In<br />
quest’ottica, si potrebbe affermare che Sgorlon consegna alla musica un ruolo consolatorio, purificato-<br />
15 Per segni di espressione si intendono tutti quei segni che aiutano a definire l’interpretazione di un brano musicale. Ne<br />
fanno parte i colori (piano, forte, pianissimo, fortissimo) e gli andamenti (lento, allegro, veloce etc.) che vengono scritti nella<br />
partitura musicale dal compositore al fine di indirizzare l’interpretazione del brano.<br />
16 Carlo Sgorlon, Il Circolo Swedenborg, Milano, Mondadori, 2010.<br />
17 Carlo Sgorlon, L’alchimista degli strati, Milano, Mondadori, 2008.<br />
18 gèrard genette, Figure III, Torino, Einaudi, 1976, p. 79-161.<br />
19 Op. cit., p. 237-242.<br />
20 franCo Suitner, La critica della letteratura e le sue tecniche, Roma, Carrocci, 2004, p. 109.<br />
119
120<br />
re, collegato al mistero, all’universalità, ma anche alla comunicazione ed alla tolleranza.<br />
Nel Filo di Seta, 21 Odorico, partito per raggiungere il Medio Oriente a seguito della chiamata<br />
del Vescovo di Khanbaliq, Giovanni di Montecorvino, arriva nella terra del Catai ma, avendo terminato<br />
il denaro a sua disposizione, attinge ai canti aquileiesi per dare una ricompensa a locandieri e ristoratori.<br />
Il canto, non solo si rivela un compenso adeguato, ma permette al frate minore ed ai suoi fratelli di<br />
instaurare un rapporto empatico, al di sopra delle difficoltà linguistiche e le diversità culturali.<br />
1<br />
Odorico, Giacomo e Michele volevano in qualche modo compensare la gentilezza degli Ospiti e fecero un piccolo<br />
parlamento tra di loro, per decidere come.<br />
«Cantando» disse Giacomo.<br />
«Cantando che cosa?»<br />
«I nostri Salmi e inni religiosi, naturalmente».<br />
«Giusto! Forse hai avuto un’idea brillante, fratello...»<br />
«Possiamo provare. Vediamo l’effetto.»<br />
Cantarono antichi canti gregoriani e aquileiesi, come fossero nella chiesa di San Francesco a <strong>Udine</strong>, e nessuna<br />
delle invenzioni che il loro viaggio aveva suggerito si dimostrò altrettanto felice. L’albergatore, sua moglie, le sue aiutanti,<br />
e i clienti si misero ad ascoltare, in un’altra stanza, e poi sempre più si avvicinarono, sedotti dalla bellezza e dalla potenza<br />
del canto. Giacomo soprattutto aveva una voce straordinaria, bassa e profonda, mentre quella di Odorico era più squillante<br />
e più forte, ma si fondevano perfettamente, con effetti mirabili. Tutti ascoltarono in religioso silenzio. La novità di quel<br />
cantare affascinava ognuno in modi completi, senza uno spiraglio di pausa o di disattenzione. 22<br />
Per tutta la durata del canto gli ascoltatori tennero un silenzio perfetto, e soltanto quando i frati tacquero tutti<br />
vennero fuori, per congratularsi, nella loro lingua, che pareva una sorta di perenne cinguettio. Infatti i frati già sapevano<br />
che nel linguaggio del Catai, che cominciavano a orecchiare e a conoscere, la stessa sillaba voleva dire cose diverse<br />
a seconda della scala musicale con cui veniva pronunziata. Ah, com’erano bravi i tre cantanti! Com’era dolce e carico di<br />
suggestioni udire i canti! E quale ristoro e compenso per le orecchie degli ascoltatori! Stringevano loro le mani e li assediavano<br />
di parole da tutte le parti. Congratulazioni vivissime! I tre frati almeno interpretarono in questo modo la cascata<br />
di parole cantate, anche se in realtà capirono ben poco. Dalla cucina veniva un acuto odore di bruciato, e allora la moglie<br />
e le sue piccole aiutanti, salendo di tono nel loro cicaleccio, tornarono ai fornelli, correndo come lepri spaventate. Quando<br />
venne il momento del congedo, padre Giacomo estrasse le sue monete, ma l’albergatore scosse il capo. A gesti accompagnati<br />
da suoni di passero e di stornello fece capire che il canto era un compenso adeguato. 23<br />
La Musica, quindi, viene rappresentata come elemento di aggregazione e di comunicazione,<br />
metafora di comprensione e fratellanza, simbolo di unione nella dimensione umana.<br />
C’è ancora un elemento che emerge chiarissimo e potente dalla personificazione che Sgorlon<br />
consegna a quest’arte, accarezzata e corteggiata quindi, molto di più di quanto possa sembrare a prima<br />
vista.<br />
Anche se non si riteneva molto esperto, grazie all’amore per il bello e il profondo, lo scrittore<br />
ne aveva colto l’essenza cosmica e persuasiva, tanto da metterla in relazione con la figura femminile.<br />
La seduzione che la musica ha esercitato su di lui, si esprime in tutti i suoi lavori e si esemplifica<br />
molto chiaramente nella frase che attraversa la mente di Jacopo ne Il velo di Maya: “la musica è<br />
donna.” E allora, tutto il mondo misterioso ed arcano dell’arte musicale, assume le fattezze femminili<br />
messe in relazione al linguaggio suadente e inafferrabile della musica.<br />
Alice Donadon, personificazione della musica stessa, suadente, bella, libera, è l’insegnante di<br />
21 Carlo Sgorlon, Il Filo di seta, Casale Monferrato, Piemme, 1999.<br />
22 Op. cit., p. 228.<br />
23 Op. cit., p. 231.
musica che si fa incontro a Jacopo quando ancora egli non ha conosciuto l’arte della seduzione. “Il ragazzo<br />
la seguì con gli occhi, e il suo cuore cominciò a battere più veloce. La mente fu attraversata da<br />
un pensiero apparentemente astruso, ma per lui chiaro come la luce: la musica è donna.” Il campo magnetico<br />
provocato dalla giovane maestra di musica si era trasformato in una potente calamita erotica e<br />
la musica ne veniva assorbita, come luce riflessa, in quei giochi potenti, svelati e dis-velati da un velo<br />
che li teneva magicamente nascosti; il velo dell’eros. “Forse, per sentire e vivere profondamente la musica,<br />
– pensava Jacopo – bisognava inserirsi dentro le forze universali della vita, di cui l’eros era quella<br />
dominante.” 24 Da quel momento Jacopo d’Artegna vive intense passioni d’amore legate alla presenza<br />
di musiciste che esercitano su di lui un “magnetismo” 25 irresistibile come vestali di un’arte sacrale.<br />
Marisol compare assieme alla Quarta Sinfonia di Brahms. Il campo della sua energia ricca di<br />
incanti, si dispone come un enigma dalle fattezze umane. Marisol rappresenta l’archetipo musicale che<br />
ogni uomo possiede e Jacopo vi si adagia. Desirèe invece, emerge nei capitoli della vita di Jacopo come<br />
una ragazzina dai vestiti e dalle scarpe impolverate, con un po’ di rossetto sulle labbra e tracce di<br />
ombretto sugli occhi. La giovane, come dice il suo nome, è la rappresentazione della musica nei suoi<br />
aspetti magici ed attraenti. La sua presenza è annunciata dal suono di un carillon con il canto del gallo,<br />
quel motivo così radicato nelle melodie del Friuli, narrato da Sgorlon con un sentimento fresco, naturale,<br />
immediato. Ella conserva gelosamente quel piccolo strumento lasciatole dalla madre in eredità come<br />
segno di un amore giovanile perduto, fatto di aria e di sole. L’essenza di Desirèe è racchiusa in quel<br />
carillon, custode di quel canto, di quel motivo che scava tra le nostre radici.<br />
Molte delle protagoniste dei libri di Sgorlon sono direttamente legate al mondo musicale. Alcune<br />
suonano uno strumento, altre ne vengono attratte, altre ancora ne richiudono il richiamo. Isabella<br />
di Ligolais, nella Regina di Saba, è addirittura una affermata violoncellista che tiene tournée concertistiche<br />
assieme al suo quartetto. Dentro il suo essere si ripercuotono anche i suoni della sciagura e il<br />
suo corpo vibra al ricordo della tragedia dell’infanzia come la cassa armonica del violoncello. Sgorlon<br />
coglie in maniera mirabile le qualità fisiche del suono e del timbro e trasforma le leggi vibratorie e le<br />
onde sonore in personalità e caratteri. Anche Germano, l’amante della sorella Corinna, viene descritto<br />
come un basso tuba o un cembalo risonante, incapace di esprimere una propria idea e abile solo nel ripetere<br />
pensieri altrui. Isabella scomparirà, così come è apparsa, e con lei se ne andranno l’eco dei suoi<br />
suoni e delle sue vibrazioni.<br />
Assieme a lei altre donne, in altri racconti, sanno far vibrare le corde della femminilità rendendo<br />
sonoro il mondo narrativo di Sgorlon; non ultima la coraggiosa e fiera Eva, ne La fontana di Lorena, 26<br />
che gioisce all’idea di recarsi all’Arena di Verona per ascoltare il suo autore preferito, Rossini. A nulla<br />
servono le voci dei parenti nel tentativo di dissuaderla, visto l’avanzata gravidanza.<br />
Ed allora la musica diviene sinonimo di vita, metonimia dell’atto creativo, quando il crescendo<br />
rossiniano spinge tutto il suo corpo ad accelerare le doglie fino al parto gioioso che seguirà alla trionfale<br />
ouverture.<br />
L’Arena, la folla, l’allestimento scenico ben presto la riempirono di ogni possibile meraviglia. Si sedette nei posti<br />
popolari, su un cuscino affittato. Quando la sinfonia cominciò, fu come se Rossini avesse fatto fermare una carrozza<br />
d’oro davanti a lei, e l’avesse invitata a salire. Lei non si fece pregare. Nel momento più trionfale dell’ouverture, quando<br />
24 Carlo Sgorlon, Il velo di Maya, cit., p. 119.<br />
25 Op. cit., p. 250.<br />
26 Carlo Sgorlon, La fontana di Lorena, Milano, Mondadori, 1990.<br />
121
122<br />
i piatti d’ottone si scontrarono nell’orchestra, cavandone una vibrazione fortissima, Eva sentì una forte fitta nella schiena.<br />
Un effetto della musica, evidente. A certi la musica metteva i brividi o produceva il solletico. In lei scatenò qualcosa<br />
di anomalo nel meccanismo del parto, e ad ogni crescendo risentì delle fitte nella schiena, sempre più forti, prolungate e<br />
ravvicinate, sicché strinse i denti e lasciò che il tempo passasse.<br />
«Cos’hai?» le chiese Göran.<br />
«Qualche fitta. È l’emozione della musica. Sta’ tranquillo.» Ma Göran non era affatto tranquillo, era anzi sulle<br />
spine. Verso la fine del secondo atto si verificò un evento che Eva credeva ancora lontano di settimane, e che rivelava invece<br />
l’imminenza del parto. Eva si chinò verso l’orecchio di Göran, sussurrò alcune parole, e l’uomo fu afferrato dal tremito,<br />
alzandosi in piedi e guardandosi attorno come a chiedere soccorso. Una nuova doglia soffocata, come un mugolio. Le<br />
signore più vicine videro, intuirono, si mobilitarono, si sparse la voce, e molte bocche si chinarono sopra orecchie attente.<br />
Che succedeva? Eh, una signora era stata presa dalle doglie, un parto anzitempo... V’era chi reagiva sorridendo e chi era<br />
afferrato da una ventata di emozione e di allegria. Subito un tale si avvicinò a Eva dicendo che era un medico. Bisognava<br />
subito portare la signora fuori dalla folla e dalle gradinate. Ce la faceva ancora a camminare? Eva ci provò, in parte ci riuscì,<br />
ma sentì che il bambino si abbassava e che non v’era più un minuto da perdere. Era una di quelle donne che avevano<br />
il parto facile e senza lungaggini. Arrivata all’uscita le sfuggì un nuovo lamento, che era un urlo represso.<br />
«A che punto è?» chiese il dottore.<br />
«Avanti, Molto avanti, temo» disse Eva.<br />
«Andiamo negli spogliatoi del teatro» ordinò il medico.<br />
Eva era tutta sudata e rossa, non solo per l’evento in sé, ma anche perché ormai era entrata nella psicosi che<br />
suo figlio sarebbe nato in pubblico. Göran la sollevò dal suolo e la portò nei locali chiusi del teatro, mentre il dottore s’affrettava<br />
a spiegare l’emergenza alla gente di servizio. Essa si fece in quattro per trovare subito una brandina e altre cose<br />
che potevano servire. Si creò immediatamente come un cordone sanitario, per cui i curiosi furono cacciati, e rimasero soltanto<br />
quelli che erano in grado di dare una mano. Apparvero teli bianchi, forbici e disinfettanti, e ciò che mancava arrivò<br />
presto da una vicina farmacia.<br />
Il medico esaminò Eva e vide che il parto era avviato. Pensare a trasporti in clinica era ormai cosa fuori del buonsenso.<br />
Le contrazioni del travaglio s’infittivano, il meccanismo del parto procedeva inarrestabile, come la musica dell’opera.<br />
Fuori, sui gradini dell’anfiteatro, la notizia, invece di stagnarsi, continuava a diffondersi, la gente ascoltava, seguiva<br />
attenta l’azione operistica, ma si chinava un attimo anche per raccogliere dai vicini le voci dell’evento. Ogni tanto si ripresentava<br />
il crescendo musicale che, senza volere, tutti coloro che erano informati sovrapponevano a un altro crescendo ,<br />
che aveva luogo nel deposito dei costumi, dietro una tenda sorretta da anelli di ferro e una canna di ottone.<br />
Qualcuno faceva da tramite tra l’avvenimento al chiuso e quello all’aperto. Verso la fine dell’opera si diffuse la<br />
voce che il parto era avvenuto. Un bambino, si sarebbe chiamato Marc. Marc, perché Marc? Marco, volevano dire. No,<br />
proprio Marc, il padre era uno straniero, un russo della Lettonia. La gente sorrideva, era allegra. Nascere all’Arena era<br />
un fatto di buon auspicio? Marc sarebbe diventato un basso, un tenore, o almeno un costumista? Auspicio o no, non era<br />
mai accaduto che una donna partorisse nei locali dell’anfiteatro, che era lì da tanti secoli. Il bambino non aveva aspettato<br />
neppure che l’opera finisse, perché i nascituri non aspettano niente e nessuno, e quando è il loro momento vengono alla<br />
luce senza un minuto di ritardo.<br />
L’opera finì e ci fu un subisso di applausi. Il direttore dell’orchestra salì sul podio e si voltò verso la gente, inchinandosi.<br />
Poi qualcuno si chinò a sussurrargli delle parole. Lui sorrise, ma scosse la testa con energia.<br />
Si chiuse il sipario, cominciarono a spegnersi le luci, la gente prese ad accalcarsi presso le uscite. Tutti erano<br />
ancora eccitati dalla musica che, come fa sempre quella di Rossini, aveva aumentato il sentimento di vitalità degli spettatori.<br />
La notte era serena. Molti, sfollando, udirono e riferirono la voce che durante lo spettacolo era nato un bambino.<br />
Poi la folla dell’Arena si disperse per le cento vie di Verona, e la città pian piano discese nel sonno, perché l’indomani era<br />
giorno di lavoro, e la vita sarebbe ricominciata come sempre. 27<br />
La vita, l’atto della nascita, il sorgere del nuovo giorno, il gonfiarsi dell’energia rossiniana, il ricordo<br />
delle vibrazioni musicali, tutto cospira a far sì che la penna di Sgorlon incontri nel suono e nelle<br />
sue argomentazioni quell’energia creativa e singolare così tipica del suo narrare; una grande melodia<br />
27 Carlo Sgorlon, La fontana di Lorena, cit., p. 330-333.
ed un procedere senza sbalzi, con la flessuosità di un moto perpetuo che rinnova la sua bellezza nell’affiorare<br />
di toni spontanei e familiari racchiusi probabilmente nei ricordi della sua infanzia, spesa al contatto<br />
con le fiabe e le leggende.<br />
Quella stessa magia è possibile riviverla ogni qual volta si ascolti un brano musicale, ed essa<br />
vibra anche nella scrittura <strong>sgorlon</strong>iana, come le corde dell’arpa al contatto con l’aria. Sono le corde<br />
messe in movimento dalla liricità dello scrittore che ha espresso la sua musica con gli occhi pieni di<br />
gratitudine e meraviglia.<br />
Ed allora viene da pensare che quel mobile muto, fissato nel suo abito di legno antico, quel<br />
pianino verticale accanto al sofà di via Chisimaio, era stato guardiano di note corteggiate, trasformate<br />
in carrozze fantastiche dell’immaginario da un ragazzo dalla ‘penna d’oro’ e dall’animo di musicista.<br />
123
124
Sgorlon: un coraggioso giornalista militante conservatore<br />
di Marcello Staglieno<br />
Questo mio è soltanto un rapido ricordo, alla cui brevità à vol d’oiseau mi costringe una faticosa<br />
convalescenza, e che certo senza completezza rievoca qui il lungo quanto prestigioso cursus honorum<br />
di Sgorlon anche quale grande giornalista militante, dall’alba degli anni Sessanta sino alla morte.<br />
Per rievocare la nostra collaborazione, e amicizia, comincio con parole sue: «Conobbi Marcello<br />
Staglieno a Milano quando ambedue collaboravamo al ”Giornale Nuovo” di Montanelli. La prima volta<br />
che ci vedemmo mi chiese se possedevo libri rari, raccolte di giornali, riviste del passato, un archivio<br />
interessante. Restai sbalordito. Ogni intellettuale si lamenta, giustamente, che nel mondo, e da noi in<br />
particolare, le pubblicazioni sono troppe; che non si riesce non solo a seguire le pubblicazioni più importanti,<br />
ma nemmeno a tenersi passabilmente informati. Staglieno invece era a caccia di cose da leggere,<br />
come se la normale produzione editoriale non gli bastasse[...]. Ha conoscenze smisurate sulla storia del<br />
giornalismo, su quella del fascismo e del nazismo, sui loro protagonisti, sulle loro deformi culture. Ha<br />
scritto in pochi mesi [dal maggio all’ottobre 2001 per Mondadori/Le Scie] una biografia di seicento pagine<br />
su Montanelli e un’altra, di simili dimensioni, su Arnaldo Mussolini, direttore del Popolo d’Italia e<br />
per breve tempo ministro dell’agricoltura [Arnaldo e Benito. Due fratelli, Mondadori 2004]. Il suo ultimo<br />
lavoro [nel 2006], è un romanzo sui fratelli Poe (Edgar Allan Poe, dandy o assassino?, Boroli editore)».<br />
Niente m’è più caro, nel ricordarlo per l’appunto come giornalista, d’avere qui sopra riportato<br />
– lungi da me qualsivoglia atteggiamento da miles gloriosus: ma soltanto per sottolineare la sua generosità<br />
davvero amicale nei miei confronti – alcune frasi da lui scritte nell’elzeviro Il giallo dei Poe: era<br />
Edgar Allan o William Henry? (sul «Messaggero Veneto», 31 agosto 2005, p. 13) che volle dedicarmi.<br />
Aveva in precedenza recensito pressoché tutti i miei libri – e di questo continuo a essergli profondamente<br />
grato – a partire dai romanzi (miei e di Renato Besana) Lili Marleen e Il Crociato (Rizzoli 1980<br />
e 1983). In seguito recensì una raccolta di saggi di Montanelli e miei comparsi sul «Giornale», riuniti<br />
nel volume L’Archivista. Tra cronaca e storia (Società europea di Edizioni 1980), recensendo altresì la<br />
riedizione de Il Vero Signore (con prefazione di Montanelli e postfazione mia) del nostro grande amico<br />
Giovanni Ansaldo presso Longanesi nel 1980 e, sempre in tale anno, il Dizionario degli italiani illustri e<br />
meschini dello stesso Ansaldo sempre a cura mia, nonché la biografia Leo Longanesi (Rizzoli 1985) da<br />
me scritta con Montanelli.<br />
L’ultimo articolo che volle dedicarmi (L’Italia vista dal Colle più ambìto, sul «Gazzettino», 30 luglio<br />
2006), lo pubblicò su un mio lungo saggio dedicato agli inquilini del Quirinale (L’Italia del Colle, con<br />
prefazione di Giulio Andreotti, Boroli editore 2006): di tale articolo, dato che continuo a tener molto ai<br />
suoi giudizi, qui di séguito trascrivo l’incipit: «Marcello Staglieno, giornalista genovese, ex vicepresidente<br />
del Senato della Repubblica [dal 2004 al 2006], scrittore poliedrico, mi riempie di meraviglia ogni<br />
125
126<br />
volta che mi fa pervenire la sua ultima fatstorica o letteraria. Infatti si tratta sempre di una riprova della<br />
sua sterminata cultura. I suoi libri sono forniti di una dovizia di rimandi bibliografici e storici per cui il<br />
lettore si domanda se Marcello sia una specie d’incrocio tra Pico della Mirandola e i moderni computers.<br />
Ma non è soltanto un uomo dalla<br />
cultura sterminata. Da storico, interpreta i fatti, li giudica secondo penetranti criteri etici e psicologici.<br />
Gli ambienti e i fatti di cui parla, spesso li ha vissuti dall’interno. Ha conosciuto per lunga consuetudine<br />
protagonisti del mondo parlamentare e giornalistico di ieri e di oggi. I suoi maestri sono stati<br />
Giuseppe Prezzolini, Leo Longanesi, Indro Montanelli e molti altri che in qualche modo si pongono sulla<br />
stessa sua linea ideologica, culturale e psicologica [...]».<br />
Sì, queste sue frasi mi riempiono a tutt’oggi d’orgoglio, ho sempre tenuto moltissimo alla stima<br />
che Carlo volle dimostrarmi, soprattutto quale dimostrazione dell’amicizia profonda che ci legava, anche<br />
per la comune militanza giornalistica. L’incontrai per la prima volta a fine novembre 1974, nella prima<br />
sede del «Giornale» (allora «Giornale Nuovo» fondato il 25 giugno 1974) in piazza Cavour a Milano,<br />
nell’ufficio di Montanelli, dove l’aveva introdotto Geno Pampaloni. Pur non conoscendolo di persona,<br />
avevo letto molti suoi libri, anche perché a segnalarmeli erano stati due comuni amici, Sergio Polillo<br />
e Alcide Paolini, allora rispettivamente presidente e direttore editoriale della narrativa in Mondadori.<br />
In quel 1974, Sgorlon era scrittore famoso. Con il romanzo mondadoriano Il trono di legno aveva<br />
vinto, nel 1973, il premio Super Campiello. Ma era assai noto anche come giornalista. Collaborava,<br />
con elzeviri, saggi e recensioni, e continuò a farlo con il placet montanelliano, al «Piccolo» di Trieste,<br />
al «Gazzettino» di Venezia, al «Messaggero Veneto», alla «Stampa» e «Tuttolibri», senza contare i suoi<br />
interventi, anche con affascinanti poesie, saggi e racconti, su «Il Mondo», «Nuova Antologia», «Vita e<br />
Pensiero», «La Domenica del Corriere», «Selezione», «Epoca»,«Grazia» e su decine di altri periodici. La<br />
sua collaborazione accentuò il prestigio del «Giornale».<br />
In quegli anni di aspra contrapposizione ideologica in cui, specie negli ambienti borghesi di sinistra<br />
e dello chic-radicale, maturò il nascente terrorismo brigatista rosso, collaborare con Indro Montanelli<br />
significava “schierarsi”, con coraggio fisico e morale, in un àmbito decisamente conservatore.<br />
Carlo Sgorlon trovò degnamente posto accanto agli uomini (c’ero anch’io) che avevano partecipato alla<br />
fondazione del «Giornale»: Guido Piovene, Enzo Bettiza, Fernando Mezzetti, Salvatore Scarpino, Egidio<br />
Sterpa, Nicola Abbagnano, Aldo Garosci, Remo Cantoni, Renzo De Felice, Girolamo Arnaldi, Rosario<br />
Romeo, Mario Praz, Geno Pampaloni, Paolo Isotta (poi passato al «Corriere»), Piero Buscaroli (che iniziò<br />
a collaborare come Piero Santerno), Anthony Burgess, Raymond Aron, Jean-François Revel, François<br />
Fejto. Per il proprio acceso anticomunismo Montanelli si era attirato la crescente ostilità delle sinistre<br />
che – specie a partire dal suo allontanamento (1972) da parte di Piero Ottone dal «Corriere» – fin dalla<br />
fondazione del «Giornale» continuavano ad accusarlo d’essere “fascista”, appellativo che ingiustamente<br />
coinvolgeva l’intera redazione e le sue “firme”, tra le quali, Sgorlon incluso, avevano spicco le<br />
migliori intelligenze della cultura liberaldemocratica italiana e europea.<br />
Pur rifiutando, già allora, ogni schieramento o coinvolgimento politico, anche nei propri articoli<br />
Sgorlon si mostrò naturaliter per quel che era, un conservatore. Fu sempre saldamente legato alla<br />
genuinità di un mondo contadino magari anche arcaico, in quanto fermamente ancorato ai ritmi della<br />
natura e dell’alternarsi delle stagioni, fedele alle proprie tradizioni e a una religiosità genuina, a una<br />
fede antica. Pur affermando di «ritrovarsi per intero nell’ambito della cultura e dell’etica cristiane», la<br />
profonda religiosità di Carlo era forse piuttosto quella di un teista, con suggestioni continue verso il<br />
politeismo naturistico del mondo pagano al pari degli amatissimi Georges Dumézil, Mircea Eliade e di<br />
Baruch Spinoza, quello del «Deus sive Natura» all’insegna del postulato «Ordo et connectio idearum<br />
idem est ordo et connectio rerum»(Ethica, II, p.VII).
Anche nei propri articoli non era tuttavia correlabile, Sgorlon, a tale dualismo gnoseologico spinoziano<br />
già implicito in Galileo e poi esplicitamente teorizzato da Cartesio. Era invece uno spiritualista,<br />
pur con un saldo realismo ma ostile a ogni eccesso dei sensisti. Aveva sostanzialmente fatto proprio,<br />
ne discutemmo più volte assieme, quanto Quirino Principe - capovolgendo l’assioma peripatetico «Nihil<br />
est in intellectu quod prius non fuerit in sensu» poi citato da Tomaso d’Aquino e quindi da John Locke<br />
– aveva scritto, correlandolo in modi quasi neoplatonici (e goethiani: «Tu sei nel tuo corpo quel che la<br />
tua Anima vuole» aveva infatti detto a Eckermann il sommo sire di Weimar) per il nostro comune amico<br />
Ernst Jünger: «Nihil est in sensu quod prius in intellectiu non sit».<br />
Pur all’insegna di tale primato della spiritualità sulla materia, era altresì proiettato verso la modernità,<br />
Sgorlon, appassionato della meccanica quantistica di Heisenberg, Plank e Pauling. Nondimeno<br />
rifuggiva i ritmi affannosi e nevrotici di un totalizzante industrialismo («È una delle eredità neopositiviste<br />
più perniciose del diamat, del materialismo dialettico questo antinaturalistico assoluto dominio della<br />
tecnica sulla natura e contro chi la difende con l’ecologia» nell’àmbito di quella che oggi definiamo<br />
globalizzazione, mi disse la sera di sabato 12 marzo 1983, lo rilevo da un vecchio taccuino, nella casa<br />
milanese di Marco Formenton e di sua moglie Cristina Mondadori, che gli consegnarono una grande<br />
«M» d’oro zecchino fusa da Giò Pomodoro quale premio per aver superato, con i suoi romanzi presso<br />
Mondadori, un milione di copie vendute che oggi, incluse le traduzioni in mezzo mondo compresa la Cina,<br />
hanno superato i quattro milioni).<br />
Fu sempre, senza posa alcuna, un anticonformista coraggioso. Nei suoi libri, al pari dei suoi articoli<br />
che furono quelli d’un giornalismo davvero militante, capaci d’affrontare in modi fermi e schietti i<br />
temi,e le polemiche,affioranti dalla contemporaneità e dalla stesa cronaca quotidianità, non mancarono<br />
alcuni temi tra i più scottanti della storia: le due Guerre Mondiali,il dramma delle foibe con il genocidio<br />
della popolazione istriana che fu tra i primi a svelare superando l’ostilità e l’egemonia culturale<br />
del Pci,il disastro del Vajont.<br />
La nostra conoscenza si trasformò in amicale consuetudine quando, nel 1976, subentrai a Giorgio<br />
Zampa quale responsabile della Pagina dei Libri. Gli suggerivo recensione oppure, per tale pagina,<br />
alcuni fondi che talvolta Montanelli, per la loro acutezza e per smalti stilistici, trasformava in elzeviri<br />
per la Terza. Diventammo davvero amici subito dopo il terribile terremoto che, il 6 maggio 1976, aveva<br />
colpito il suo Friuli. Poiché mia madre si trovava presso amici a Percoto, espressi a Carlo, cui telefonicamente<br />
avevo chiesto notizie su di lui e sulla moglie, il desiderio di raggiungere Percoto. L’8 maggio,<br />
si offerse d’accompagnarmi.<br />
Sulla mia auto, per lunghe ore notturne dato che molte strade erano interrotte, parlammo a lungo<br />
della sua terra martoriata dal sisma. Una volta raggiunta mia madre, Carlo andò a pernottare dagli<br />
amici Gianola e Benito Nonino, fondatori dell’omonimo prestigioso premio, poi da lui vinto nel 1989 con<br />
il romanzo Il Caldéras (Mondadori 1988) dopo aver riconquistato nel 1983 il Super Campiello e poi vinto<br />
nel 1985 il Premio Strega con i mondadoriani La conchiglia di Anataj (1983) e L’armata dei fiumi perduti<br />
(1985). Carlo trasferiva anche nella conversazione le proprie convinzioni, con una pacatezza sempre sollecitata<br />
dalla fertilissima sua fantasia creativa, capace per esempio di farti rivivere un paesaggio – al<br />
pari di quanto gli era solito scrivere in non pochi articoli – attraverso accostamenti inattesi.<br />
Ricordo per esempio, sempre sulla base d’un mio vecchio taccuino, il pomeriggio del mercoledì<br />
12 aprile 1978. Ero in auto assieme a Montanelli e a Sgorlon, seguìti da una seconda auto con su<br />
Gianni e Paolo Granzotto. Eravamo diretti a Tarcento, già praticamente quasi del tutto ricostruita («Come<br />
era dove era») e Carlo si commosse quando Montanelli e Corradi lo ringraziarono per l’attivismo<br />
suo nella sottoscrizione tra i lettori del «Giornale» indetta subito dopo il terremoto, ricordandogli che il<br />
contributo più sostanzioso, quasi tre miliardi (almeno 40 milioni degli attuali euro), vennero concentrati<br />
127
128<br />
dal «Giornale» sulla ricostruzione di tre paesini andati quasi completamente distrutti: Montemars, Vito<br />
D’Asio e Sedilis, frazione proprio di Tarcento in quel di <strong>Udine</strong>. Sì, ai ringraziamenti di Montanelli e Corradi,<br />
Carlo si commosse. Poi, d’un tratto, commosse noi.<br />
Guardando il paesaggio rigato da vigne, con passione epica, soprattutto con pathos e vera forza<br />
evocativa, ci rievocò il longobardo Paolo Warnefrido detto Diacono («Di certo passò per questi luoghi<br />
anche lui»), la sua nascita friulana (nel 720 a Forum Julii ovvero Cividale), la sua vita monacale dedita<br />
al lavoro manuale, alla poesia e alla storia. Ricordò, Carlo, la paziente sua opera nell’insegnare il latino<br />
(precisando: «Insegno anch’io al liceo e la pazienza è d’obbligo») a molti giovani longobardi, svegliando<br />
le loro dure cervici facendo loro compitare per prima cosa il proprio nome, «Wulfius, Wulfii, ovvero Lupo<br />
figlio di Lupo», indirizzando così verso la civilizzazione romana quanti erano appena usciti da una fara,<br />
una selvaggia tribù guerriera, con padri che ancora avevano la bocca schiumante del furore della strage<br />
nel ricordo di quanti, nel 568, avevano conquistato la stessa Cividale. Carlo, a memoria, ci recitò molti<br />
passi dell’Historia Langobardorum di Paolo Diacono, colmi di mestizia e di poesia, specie dal sesto libro,<br />
legato al regno di re Liutprando ovvero al periodo vissuto dallo stesso Paolo nella prima giovinezza.<br />
Quindi recitò alcuni versi in friulano di Pasolini: pur apprezzandone le assonanze non ne capimmo nulla,<br />
se non ch’erano tratti dal volumetto pasoliniano (1953) Tal còur di un frut: Sgorlon ne scrisse qualche<br />
giorno dopo, anche in relazione a quel breve nostro soggiorno a Tarcento, rientrammo infatti l’indomani<br />
a Milano, in un elzeviro pubblicato sul «Messaggero Veneto».<br />
Il giovedì 13 aprile di quel 1978, facendo assieme la prima colazione, Carlo consegnò a Montanelli<br />
un lungo elzeviro sul Friuli dicendogli: «È un racconto sulla mia terra, spero piaccia ai nostri<br />
lettori. Vedi, la mia misura ideale, connaturata al mio sentire e ai miei mezzi, è il romanzo, concepito<br />
come un’unitaria ampia sinfonia. Gli elzeviri invece, specie in forma di racconto, li considero una sorta<br />
di Lieder: la necessità di restringere lo spazio ti obbliga, al pari d’un articolo di fondo e tu, Indro,<br />
lo sai bene, sì ti costringe a essere fulmineo, senza mai distorcere il ritmo narrativo». Montanelli assentì<br />
sgranando gli occhi chiari e, appena lasciato Carlo a <strong>Udine</strong>, gli applicò quel che molti anni prima<br />
Longanesi aveva detto di Henry Furst: «Anche Sgorlon, come il nostro caro Furst, è una stufa sempre<br />
accesa...».<br />
Ho molti altri ricordi personali di Carlo. Pur non avendo sottomano l’elenco (del resto troppo<br />
lungo) dei suoi articoli soprattutto sul «Giornale», voglio qui ricordare quanto in essi emergesse la sua<br />
policentrica cultura, dove di continuo affioravano, con naturalezza e senza mai appesantire il ritmo e la<br />
qualità della fluente sua scrittura, le letture più disparate. In essi poteva spaziare, Sgorlon, da Goethe a<br />
Thomas Mann, da Ernst Jünger a Günter Grass, da Franz Kafka a Jaroslav Seifert, da Dostoevskij a Pasternak<br />
e Solzenicyn, da Lee Masters a Scott Fitzgerald e a On the road di Kerouak, da Borges a Garcia<br />
Marquez, da Freud (che amava poco) all’amatissimo Carl Gustav Jung. Tra gli italiani, a parte i nostri<br />
classici, prediligeva l’ariosa forza inventiva di Buzzati, la capacità di distendersi («Come un grande fiume<br />
in piena che t’avvolge e ti trascina» m’aveva detto nel 1974, dopo averne letto La storia) senza mai<br />
guastare il ritmo narrativo, di Elsa Morante. Sul piano filosofico apprezzava Nietzche («È un grande ma<br />
spesso oscuro maestro»), privilegiandogli però lo Schopenhauer dei Parerga e del Die Welt als Wille<br />
und Vorstellung («Li lessi da giovane in traduzione francese, non conosco abbastanza il tedesco») e, tra<br />
gli eterodossi pensatori italiani, l’Elémire Zolla dell’Eclisse dell’intellettuale (Bompiani 1959) e di molti<br />
saggi successivi, da Archetypes (Allen & Unwin, Londra 1981) a Verità segrete esposte in evidenza<br />
(Marsilio 1990) sino a Conoscenza religiosa (Edizioni Storia e Letteratura 2006).<br />
Sempre per restare qui sul piano filosofico, uno degli aspetti meno noti della poetica di Sgorlon,<br />
mi piace ricordare un acuto articolo di Luca Negri (reperibile on-line sul sito del «Giornale della Fondazione<br />
Magna Charta») dedicato, in data 19 dicembre 2010, proprio al conservatorismo di lui. Là dove si
legge: «[...]era alieno al “culto del divenire” e del progresso e amava quello che resta oltre il cammino<br />
della Storia, ciò che dura: archetipi, etica ed epica, miti, fiabe, saghe.<br />
«E proprio non poteva ritrovarsi nell’esistenzialismo con la nausea indotta degli anni ‘50, nel<br />
marxismo schematico del neorealismo [...] era contrario al divorzio e fino all’ultimo sostenne che “l’aborto<br />
volontario è un assassinio”. Ci teneva a ricordare quanto la mentalità atea portasse ancora l’impronta<br />
del materialismo ottocentesco invece di aggiornarsi alle scoperte del Novecento sulla fisica<br />
quantistica. Si era finalmente giunti alla conclusione che la materia è energia, come già insegnavano<br />
tutti i testi sacri [...]».<br />
Mi resi personalmente conto di quanto originalmente profonda fosse l’elaborazione del suo<br />
pensiero anche in relazione alla filosofia durante una lunga conversazione ch’ebbi con lui nel 1989 a<br />
Percoto, subito dopo la consegna a Carlo del Premio Nonino, come qui sopra ho ricordato, per il romanzo<br />
Il Caldéras.<br />
Rilevo da un altro mio vecchio taccuino elementi che meglio chiarificano quanto sopra rilevato<br />
da Luca Negri: «Mentre quasi tutti gli ospiti dei Nonino se ne stanno andando, a un tavolo Carlo e io ci<br />
attardiamo a parlare. ”Vedi”, mi dice riprendendo temi di altre nostre conversazioni, ”la mia attenzione<br />
è tutta per l’Essere, non per il Divenire. Non è vero, come sostennero Hegel e poi Marx, che la storia<br />
proceda secondo una linea retta irreversibilmente tesa verso il progresso, attraverso una successione<br />
di eventi contrastanti, cioè di ’tesi’ e ’antitesi’ che, finendo per trovare l’equilibrio in una ’sintesi’,<br />
muovono razionalmente verso un futuro che è tutt’uno con il Progresso. A questa concezione, già te lo<br />
dissi, ritengo si debba opporre quello che Nietzsche definì Eterno Ritorno. Sono convinto che la storia<br />
proceda in un movimento a spirale che ne ripropone, con varianti, la concatenazione tra causa e effetti<br />
negli eventi. Del resto già lo sostenne Tucidide, per il quale la Storia è ’ktéma es aeì’, un bene perenne.<br />
Tale principio, lo sai bene, ispirò anche Machiavelli e poi Vico nella Scienza nuova. Anche loro privilegiarono<br />
l’Essere sul Divenire, la stabilità sul transeunte, ovvero gli elementi che Pareto definì ’residui’<br />
contrapponendoli alle ’derivazioni’...<br />
«Ecco perché, ma senza paura alcuna verso il ’nuovo’, noi dobbiamo privilegiare quelli che, attraverso<br />
le generazioni, si sono dimostrati i fondamenti della vita sociale: la famiglia, la proprietà privata,<br />
il senso d’appartenenza a un territorio e a una nazione, la religione”. Lo ascolto ammirato ma<br />
senza sorpresa, già in altre occasioni Carlo m’aveva manifestato questo profondo suo modo di sentire,<br />
espresso del resto nei suoi romanzi, in più saggi e articoli. Al nostro tavolo sotto un alto tendone, davanti<br />
alla fabbrica e alla residenza dei Nonino, avvolgendosi meglio la spessa sciarpa rossa attorno al<br />
collo, dopo un altro sorso di grappa Risìt d’aur riprende a parlare: ”Non è poi vero che in questo nostro<br />
mondo, e nelle nostre azioni, prevalga marxisticamente la Ragione, proprio no. A prevalere è invece la<br />
Volontà. A ben spiegarlo è stato, per primo, Kant. Il quale, nella Critica della ragione pratica, sostenne<br />
per l’appunto ’il primato della ragione pratica, la Volontà, sulla ragion pura’, l’assoluta razionalità. È la<br />
Volontà infatti, sempre secondo Kant, con un impulso non di rado fideistico ad avvicinarci alla Metafisica,<br />
che include in sé l’idea di noi stessi e del nostro destino, l’idea del mondo e della Divinità: tutto<br />
quanto cioè che ci è precluso in termini di Ragione. Da tale ’primato’ kantiano prese le mosse Schopenhauer<br />
sino ad affermare che, per superare le apparenze, determinate dal Velo di Maya che ci occulta<br />
la realtà (ti anticipo che sarà il titolo di un mio nuovo romanzo) e giungere all’essenza delle cose c’è<br />
per l’appunto solo la Volontà, tutt’una con la ’volontà di vivere’. Poi venne Nietzsche, per il quale la Volontà<br />
fa superare ogni tipo di costrizione, o quanto meno ad accettarla virilmente, e qui sta forse il suo<br />
’superomismo’, con un amor Fati che, assieme all’Eterno Ritorno, gli fa superare ’nell’eternità del presente’<br />
sia il nichilismo sia le due grandi antinomie della filosofia d’Occidente, quella essere-sembrare<br />
e essere-divenire...”».<br />
129
130<br />
La preparazione filosofica di Carlo emerge tuttavia evidente da un lungo suo saggio, II declino<br />
del materialismo e la rinascita dello spirito, pubblicato nel luglio-agosto 2009 sul periodico<br />
«Vita e Pensiero». Eccone il sottotitolo: Da Talete a Einstein, lo scrittore friulano rilegge la storia<br />
della conoscenza e del pensiero umano analizzando il ruolo giocato dalla prospettiva materialistica,<br />
di cui constata la grave crisi di fronte a un irresistibile ritorno dello spirituale.<br />
Dato che passeranno forse anni anni prima di vederlo ripubblicato, ne ripropongo qui di seguito<br />
ampi brani specie perché rivela aspetti, lo risottolineo, poco noti di lui, nell’àmbito delle sue collaborazioni<br />
giornalistiche:<br />
Questa mia lettura avrà un carattere piuttosto didascalico, fortemente etico. Sono aspetti che la gente di oggi<br />
non ama. Per molti parlare di etica significa fare moralismo, e ai nostri tempi la morale è considerata spesso un argomento<br />
noioso e discutibile. Viviamo in una temperie culturale che autorizza gli uomini a fare ciò che vogliono, ad assecondare<br />
il proprio egoismo ed edonismo istintivi, che sono sempre esistiti, ma ora certamente alimentati dal relativismo, l’individualismo,<br />
la perdita del sentimento di sacralità, la marginalità dei sentimenti religiosi e così via.<br />
L’ultimo scacco alla morale è venuto da alcune posizioni della cosiddetta rivoluzione sessantottesca. Ne sono<br />
derivati molti aspetti della società permissiva, che sta creando tanti guai nell’ambito della giustizia, della scuola, in ogni<br />
settore della vita civile.Il permissivismo diffuso, l’individualismo e il relativismo etico senza dubbio originano dalla filosofia<br />
di fondo del nostro tempo, da quella metafisica generalizzata che è il materialismo. Dò subito, per cancellare ogni<br />
possibilità di essere frainteso, una definizione precisa del materialismo teorico, substrato filosofico di quello pratico, che<br />
sembra essere diventato il criterio di comportamento di gran parte dell’umanità.<br />
Il materialismo teorico è edificato su questo postulato: tutto ciò che fa parte della sterminata realtà dell’universo<br />
è fatto di materia. È come dire che possiede una massa e un’estensione nello spazio.<br />
[...]<br />
Il postulato su cui si basa il materialismo ha grandi conseguenze psicologiche, filosofiche e pratiche. Esso esclude<br />
che esistano entità prive di massa e di spazialità, ossia quelle che apparterrebbero, secondo le concezioni non materialistiche,<br />
alla dimensione dello spirito. Prima di proseguire è opportuno che fornisca un altro chiarimento: ho affermato<br />
che il materialismo è una metafisica. Uso questo termine, infatti, non nel senso aristotelico, ma in quello moderno. Per<br />
Aristotele le cose metafisiche infatti stanno al di là della realtà fisica, mentre oggi si intende qualunque opinione che riguardi<br />
la totalità del reale. Quindi il materialismo, che è una filosofia totalizzante, universale, può essere definito metafisica.<br />
Esso ha una sua storia, che accennerò per sommi capi.<br />
Lo troviamo già – a volte in forme ambigue, a volte esplicite e indubitabili – nella filosofia greca, che è quasi<br />
sempre una forma del pensiero sulla totalità dell’Essere, quindi è metafisica. Anche i filosofi presocratici, come Talete,<br />
Anassimandro, Anassimene, Empedocle, Anassagora, Eraclito, Democrito, Parmenide, sono dei metafisici, perché si occupano<br />
del problema fondamentale dell’Essere.<br />
Cos’è per loro la realtà: materia? Materia e spirito insieme? Qual è la sua origine e il destino? È sostanzialmente<br />
immutabile, come voleva Parmenide, o in perenne divenire, come pensava Democrito? Si può dire con certezza che<br />
Eraclito, Democrito, gli Stoici e gli Epicurei furono sostanzialmente materialisti. Intuirono come la materia sia fatta di<br />
atomi. E l’etica epicurea giungeva all’edonismo, ossia a cercare il piacere, magari nelle sue forme più raffinate, e a sfuggire<br />
il dolore.<br />
Sono punti di contatto con il materialismo moderno. Per gli epicurei, i più coerenti materialisti dell’antichità, anche<br />
le cose che paiono spirituali, come l’anima, il pensiero, sono fatte di atomi più raffinati e sottili. Ma i maggiori filosofi<br />
dell’antichità, come Socrate, Platone, Aristotele, sono dualisti, ossia credono che esistano nella realtà due dimensioni<br />
fondamentali: quella dello spirito e quella della materia. A esse assegnano un’importanza diversa. Infatti per Platone la<br />
realtà vera è quella dello spirito, ossia delle idee. Prima vengono i concetti delle cose, o degli esseri viventi, e poi questi<br />
ultimi. Platone, cui era ovviamente sconosciuto il concetto di evoluzione, non ragionava male: per creare il cavallo, o l’albero,<br />
o qualsiasi essere vivente, il Demiurgo doveva averne un’idea, un piano.<br />
«Il materialismo illuminista - II dualismo di materia e di spirito era insanabile. Durò per tutto il Medioevo. Fu<br />
accettato dai maggiori filosofi, come Agostino, Scoto Eriugena, Anselmo, i<br />
Vittorini, Bonaventura, Abelardo, Alberto Magno, Tommaso. Ma la materia cominciava a prendersi le sue rivincite.<br />
Per san Tommaso essa avrebbe potuto essere anche eterna, increata. San Francesco è ammiratore entusiasta della<br />
natura e di tutte le cose esistenti. Ma è soprattutto con i nominalisti che la dimensione spirituale entrò in crisi evidente.
I nominalisti più notevoli furono il francese Roscellino, lo scozzese Duns Scoto e l’inglese Occam. La loro tesi centrale fu<br />
che i concetti, le idee, ossia gli elementi che formavano la dimensione dello spirito, non avevano un carattere ontologico,<br />
ossia sostanziale. Non esistevano realmente. L’iperuranio di Platone non era che una fantasia suggestiva. I concetti, che<br />
i filosofi di allora chiamavano “universali”, non erano che puri nomi, dedotti dalla realtà.<br />
Persistevano ancora i platonici, che sintetizzavano il problema con la formula: ”universalia ante rem” (i concetti<br />
vengono prima della realtà materiale). V’erano poi gli aristotelici, che affermavano: ”universalia in re”, ossia i concetti<br />
sono incorporati con le cose, sono la loro anima, che Aristotele chiama «entelechia». Ma San Tommaso, aristotelico,<br />
aveva affermato: ”Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu”. Ossia nella mente nulla esiste che prima non sia<br />
stato nei sensi, che rivelano la realtà.<br />
[...]<br />
Ma il vero materialismo, quello classico, globale, metafisico, nasce con l’Illuminismo, che elimina con la forza e<br />
l’autorità della ragione anche i residui della cultura medievale. Accanto al deismo, che ammetteva l’esistenza di un Dio<br />
architetto dell’universo, come in quello dei massoni, nasce il materialismo assoluto di Helvetius, di La Mettrie, del tedesco<br />
von Holbach. Per costoro non esisteva se non la materia. Ogni cosa, anche le infinite forme della vita, non erano che<br />
un prodotto delle trasformazioni della materia, delle affinità e delle capacità combinatorie dei suoi elementi. Tutto ciò che<br />
esiste, anche l’uomo, non è che un meccanismo dellamateria.<br />
[...]<br />
Le nuove complessità della materia - II dualismo naturalmente non sparisce del tutto. Nell’epoca sentimentale<br />
e appassionata del Romanticismo ci sono non soltanto filosofie e scrittori spiritualisti, ma anche intellettuali cristiani<br />
e cattolici come Chateaubriand, De Maistre, Manzoni, Rosmini, Gioberti, alcuni apertamente reazionari, altri cultori di<br />
sentimenti patriottici e di atteggiamenti romantici. Gli idealisti, come Fichte e Hegel, credevano in uno spirito del tutto<br />
immanente, frutto della mente umana e del suo evolversi nella storia. Per Fichte il pensiero umano, che egli chiamava l’Io,<br />
creava il mondo, definito ”non Io”. Per lui dunque lo spirito umano era il prìmum della realtà, che esso creava.<br />
Ma ormai da secoli hanno cominciato a mettersi in rilievo le spie rivelatrici della crisi del materialismo. Esse si<br />
possono indicare a partire da Isacco Newton, che qualcuno considera il più grande fisico di tutti i tempi. Newton, scienziato<br />
cristiano, e dunque anche spiritualista [...] concentrò le sue ricerche. Scoprì alcune cose, ma rendendosi conto che<br />
non riusciva a capirle fino in fondo. Capì ad esempio che la luce bianca era una mescolanza di vibrazioni diverse, ognuna<br />
delle quali produceva l’impressione di un colore differente. Intuì che essa poteva venire scomposta nella gamma dell’iride,<br />
e che poteva essere ricomposta con il famoso disco di sua invenzione, facendolo girare a forte velocità.<br />
Oggi un po’ tutti sappiamo che la realtà non è quella compatta, liquida o gassosa, percepita dai nostri sensi. La<br />
realtà consistente, colorata, che si vede e si tocca non è che l’apparenza, il Velo di Maya, dea indiana dell’illusione. Già<br />
queste conoscenze provocano incrinature nel materialismo settecentesco e ottocentesco di Moleschott, di Marx, di Engels<br />
e di tutti i loro seguaci socialisti, che hanno costruito le loro dottrine economiche ed egalitarie sulla base del materialismo<br />
storico e dialettico. Mi sto avvicinando ai fenomeni che ci consentono di ipotizzare un nuovo spiritualismo. Per<br />
cominciare a scorgerne le tracce all’orizzonte dobbiamo arrivare alla fisica atomica e particellare, a pensare alla struttura<br />
dell’atomo, alle concezioni di Einstein e in particolare a quella che riguarda il rapporto tra energia, massa-materia e la<br />
velocità della luce. Ma anche, in modi trasversali, la relativizzazione delle dimensioni universali della realtà, il tempo, lo<br />
spazio, la sua curvatura.<br />
[...]<br />
È un altro importantissimo legame che ci unisce all’universo, al Tutto, e che rivela aspetti misteriosi della parte<br />
sconosciuta della realtà, quella oltre il velo di Maya, dentro il quale per fortuna viviamo. Una volta si parlava di immanenza<br />
e trascendenza, io preferisco pensare alla trascendenza come alla parte sconosciuta e misteriosa della realtà, cui<br />
dovremmo pensare molto di più, per ricostruire in noi sentimenti che abbiamo perduto. Per esempio quello del mistero e<br />
della sacralità, che sarebbero per noi di grande aiuto per sentire con maggiore intensità, concretamente<br />
Per me e per molti, anche se non sanno bene perché, è già cominciata quella e e senza riserve, i valori etici. Se<br />
un giorno il materialismo entrerà davvero in una crisi diffusa, lo Spirito, l’Energia dell’universo, i valori etici, oggi quasi<br />
scomparsi, acquisteranno per noi un’importanza e un prestigio che sembrano perduti. Il materialismo produce sentimenti<br />
e concetti negativi, come il nichilismo, la crudeltà, il sadismo, l’indifferenza, l’egoismo, la superficialità, il vuoto spirituale<br />
che cerchiamo di riempire con interessi di natura pratica, come la produzione, i soldi, il possesso delle cose, le<br />
modificazioni della coscienza prodotte dalle sostanze allucinatene. Lo spirito può agire anche sulla materia. che un frate<br />
medievale, che Dante definì «di spirito profetico dotato», Gioacchino da Fiore, chiamava l’età dello Spirito, dopo quella<br />
del Padre e del Figlio.<br />
131
132<br />
Nel rimandare i lettori alla lettura completa di quest’importante suo intervento, sarei in grado<br />
d’aggiungere altri elementi a questo mio ricordo di Sgorlon quale giornalista. Ma qui mi fermo, precisando<br />
soltanto che senza la sua presenza in mezzo a noi, senza la calda umanità della sua persona,<br />
senza i suoi articoli e soprattutto senza i suoi romanzi il mondo in cui ci tocca vivere sarebbe indubitabilmente<br />
peggiore. Carlo carissimo, ti ripenso con affetto, grazie: hai reso davvero migliori gli uomini,<br />
le culture, le Patrie.
I treni di Carlo Sgorlon<br />
di Romano Vecchiet<br />
Direttore della Biblioteca Civica “V. Joppi” di <strong>Udine</strong><br />
C’è indubbiamente un elemento di discontinuità tra la rappresentazione del treno nelle letterature<br />
di metà Ottocento, quelle che lo raffiguravano nelle sue prime, inedite e spettacolari uscite, e i<br />
riscontri dei decenni successivi fino a tutto il Novecento e oltre. La sua irruzione, così portentosa, violenta<br />
e moderna che caratterizzò le prime testimonianze letterarie di Victor Hugo, 1 di Caterina Percoto, 2<br />
di Ippolito Nievo 3 o, in minore e diversa misura, di Carlo Collodi 4 – tanto per fare alcuni nomi tra i più<br />
significativi nel panorama europeo e italiano, e che andrebbero in perfetta sintonia con la splendida<br />
invenzione pittorica di William Turner 5 – divenne a poco a poco quotidiana e “normale”, tanto che la<br />
sua presenza si andrà a inserirsi quale parte integrante e organica del paesaggio, diventerà strumento<br />
abituale di viaggio, modalità consueta e privilegiata di spostamento, dove la noia per la ripetitività<br />
del tracciato e dei paesaggi sempre eguali, o la serialità dei suoi ritmici rumori, avrebbe spesso prevalso<br />
sull’ingenuo entusiasmo degli avventurosi esordi. Il passaggio, se il confronto non tiene conto dei<br />
1 Un brano di una lettera alla moglie è stato pubblicato in remo CeSerani, Treni di carta. L’immaginario in ferrovia: l’irruzione del<br />
treno nella letteratura moderna, Genova, Marietti, 1993, p. 75. La fonte primaria è in viCtor Hugo, Voyages. France et Belgique<br />
(1834-1837), a cura di Claude Gely, Paris, Presses Universitaires de Grenoble, 1974 : « La locomotiva fiammeggiava davanti a<br />
me con un rumore terribile, e grandi raggi rossi che coloravano gli alberi e le colline, giravano con le ruote. »<br />
2 Su Caterina Percoto e la tematica del treno e del viaggio, rimando a romano veCCHiet, I treni di Caterina Percoto, in Caterina<br />
Percoto e l’Ottocento, a cura di Romano Vecchiet, <strong>Udine</strong>, Biblioteca Civica “V. Joppi”, 2008, p.99-117. Nel saggio viene<br />
attestato, tra l’altro, uno dei primissimi racconti di viaggio in treno della letteratura italiana, contenuto nel racconto La coltrice<br />
nuziale, uscito per la prima volta nel 1850 a Torino su “La Concordia” di Lorenzo Valerio. Ma è nel racconto I gamberi, composto<br />
nel 1855, che la Percoto celebra la locomotiva al suo grado più alto: “Così il vapore, quest’altro monumento della potenza<br />
dell’uomo, l’aveva ella bensì sognato come ala d’uccello, come fulmine, in tutte le bizzarre combinazioni che può suggerire<br />
la fantasia inesperta, ma dinanzi al fatto positivo in azione, e agli uomini indifferenti, non curanti, che lo usufruttuavano,<br />
sbalordiva; e le pareva immensurata e quasi audace la forza di questa scintilla divina, che sta nascosta nella povera creta<br />
caduca e che si chiama umano ingegno.”<br />
3 Va almeno ricordato il racconto La Santa di Arra pubblicato nel settembre 1855 sul “Caffè” di Milano e poi confluito nel<br />
Novelliere campagnuolo. Qui il treno “disorienta e stordisce, scardina le percezioni spazio-temporali del personaggio”. Cfr.<br />
marinella Colummi Camerino, Il tema del viaggio nella narrativa di Ippolito Nievo, in “Quaderni Veneti”, (1990), n. 11, p. 155-167,<br />
in particolare p. 160.<br />
4 Carlo lorenzini, Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico-umoristica. Firenze, Tipografia di Giuseppe Mariani,<br />
1856. Si veda ora il primo volume dell’edizione nazionale delle opere di Carlo Lorenzini, pubblicata da Giunti nel 2010, con<br />
prefazione di Michèle Merger e introduzione di Elvio Guagnini. In Collodi, però, prevale un aspetto meno ingenuamente<br />
legato all’ideologia del progresso, che è quello che Merger chiama “il comico ferroviario”: l’effetto portentoso e violento<br />
dell’irruzione della macchina a vapore, lascia spazio a una dimensione comica, stravagante e ironica.<br />
5 Il celebre dipinto Pioggia, vapore e velocità, che anticipa i canoni dell’impressionismo nella rappresentazione di una locomotiva<br />
in corsa, è del 1844.<br />
133
134<br />
confini temporali in cui tali testimonianze vengono rese, è brusco e quasi inspiegabile. Se dal sempre<br />
memorabile passo di Victor Hugo che racconta in presa diretta le emozioni fortissime suscitate dal suo<br />
primo viaggio in treno tra Anversa e Bruxelles (1837), passiamo alle atmosfere decadenti e ferme della<br />
stazione di Ancona nel Venturiero senza ventura di Gabriele D’Annunzio (1897), 6 constatiamo quanto<br />
diversa possa essere la percezione del treno, e quanto opposte le sensazioni (dall’esaltazione all’avversione)<br />
che esso suscita alle soglie del secolo nuovo.<br />
Certo, la presenza del treno, anche ai suoi inizi, non fu condivisa da tutti con entusiasmanti unanimi<br />
clamori. La “fazione” dei contrari fu numerosa e ben rappresentata, se pensiamo soltanto a Gustave<br />
Flaubert, a Charles Dickens o a Thomas Hardy. 7 Ma ciò che qui vorremmo sottolineare è che, col<br />
passare degli anni, il treno si sottopose naturalmente a un ridimensionamento, a un riposizionamento<br />
di minore impatto (visivo, emozionale) nell’economia della scrittura narrativa, pur riservando al lettore,<br />
da parte di tanti scrittori delle più disparate letterature, dimensioni di non minore rilievo e originalità.<br />
La patina della novità, insomma, l’irruzione quasi improvvisa e inaspettata nelle periferie urbane di ciò<br />
che oggi chiamiamo archeologia industriale, come nei più bucolici paesaggi in aperta campagna, si offusca<br />
e scolora, ma non per questo le sensazioni che il treno riesce ancora a trasmettere si fanno meno<br />
efficaci. Altri mezzi di locomozione entrano ormai alla ribalta e saranno capaci di attrarre nuovi cantori,<br />
affascinati da una leggerezza più aerea e rapida (l’aeroplano), o da una libertà di movimento ben più<br />
vasta e capillare, alla portata di tutti (l’automobile). Ma il treno conserva – proprio per i suoi evidenti<br />
limiti, le sue costrizioni determinate da tracciati ben determinati in un sistema chiuso – caratteristiche<br />
più spiccate e specifiche, entra nel linguaggio comune, si impadronisce di metafore e similitudini familiari,<br />
diventa l’incipit, lo sfondo o la conclusione di tanti romanzi novecenteschi, ricrea avventurose ambientazioni<br />
di viaggio, perdendo, almeno un po’, quel carattere perturbante e satanico delle sue origini.<br />
Carlo Sgorlon, che per tanti versi interpreta la migliore narrativa italiana degli ultimi trent’anni<br />
del Novecento, nonché i primi di questo, nell’andamento fantasioso dei suoi romanzi, ma sempre legati<br />
a dati realistici di base diligentemente documentati e applicati, riprende il tema del treno nei suoi tanti<br />
romanzi con un’originalità e una versatilità indubbie e lo coniuga con situazioni ed epoche spesso molto<br />
diverse. Espressione anche per lo scrittore friulano di un progresso condannabile per le sue limitanti<br />
connotazioni materialistiche e storicistiche, il treno però si riscatta quasi sempre dalla sua espressività<br />
ideologica, e – quasi contradditoriamente – assume caratteristiche positive, o comunque neutre, funzionali<br />
allo sviluppo della storia raccontata.<br />
Potremmo iniziare la nostra breve indagine sul tema del treno nella narrativa di Carlo Sgorlon,<br />
proprio verificando in quali romanzi lo scrittore friulano lo pone all’inizio della storia. Da mezzo per introdurre<br />
il protagonista nel proscenio del racconto, sottolineando fin da subito la distanza delle sue origini<br />
e dunque la sua diversità, a strumento di fuga da situazioni troppo oppressive, a evento onirico e<br />
catastrofico iniziale, fino a diventare il soggetto vero di un intero romanzo, Sgorlon utilizza il treno e il<br />
sistema che gli si è costruito attorno per aprire la trama di un’opera di ampio respiro, che apre orizzonti<br />
6 Pierluigi Pellini, La stazione e il caminetto (sul Trionfo della morte di d’Annunzio), in Pierluigi Pellini, marina PolaCCo, Paolo zanotti,<br />
Strade ferrate. La tematica del treno e della ferrovia nei testi di Jules Verne, Gabriele d’Annunzio, Gabriel García Marques e<br />
parecchi altri scrittori. Con una introduzione di Remo Ceserani, Pisa, Nistri-Lischi, 1995, p. 35-94. “La stazione è morta. Sotto<br />
la vasta tettoia nera i lumi sono semispenti. Le fiammelle vacillano fioche in cima ai becchi, nei fanali. I carri fermi su le rotaie<br />
sembrano feretri fasciati di gramaglie. I bovi, proginieri invisibili, mugghiano di continuo rispondendosi, come nel chiuso d’un<br />
macello quando attendono il maglio o il taglio. Sotto un carro un cane biancastro rosicchia qualcosa nel sudiciume.” (p. 42-43)<br />
7 Cfr. remo CeSerani, Introduzione, in Pierluigi Pellini, marina PolaCCo, Paolo zanotti, Strade ferrate, cit., p. 7-34, in particolare p. 10.<br />
Su Flaubert e l’aneddotica che lo poneva tra i “nemici” del treno, si veda sempre remo CeSerani, Treni di carta..., cit., p. 31-32.
nascosti e nuovi, che il treno a sua volta aiuta a scoprire.<br />
La prima opera importante scritta da Sgorlon nel 1960, anche se pubblicata più tardi di altre,<br />
nel 1973, Il vento nel vigneto, 8 si apre con il protagonista, Eliseo Bastianutti, ex carradore, che arriva in<br />
treno nel paese che lo dovrà accogliere dopo ventisette anni di carcere per aver ucciso il marito della<br />
sua amante. Così inizia il romanzo:<br />
Subito dopo la stazione di Reana l’uomo tirò giù dalla rete la valigia di fibra e andò a mettersi vicino allo sportello.<br />
«Smontate qui?» gli chiese il controllore.<br />
L’uomo fece segno di sì.<br />
«Sono appena le cinque, ed è già scuro come in bocca» aggiunse il ferroviere.<br />
«Inverno» disse l’altro.<br />
Il treno correva forte. Si sentiva il cigolio acuto delle ruote mescolato col vento della corsa. Dopo due minuti<br />
rallentò e presto si fermò.<br />
«Stazione di Tricesimo» disse due volte il controllore. Poi aprì lo sportello e saltò sul marciapiede. L’uomo gli andò<br />
dietro, facendo a uno a uno gli scalini del predellino, poi diede attorno un’occhiata lenta, come se sperasse cha qualcuno<br />
fosse lì ad aspettarlo. Ma non c’era anima viva. Faceva molto freddo. Il vento girava attorno alla stazione e fischiava tra<br />
i rami dei gelsi. Presto il treno ripartì, con impeto stridente, e l’uomo stette a guardarlo, finché le luci sparirono dietro una<br />
curva lontana. Scosse la testa e si avviò verso lo stradone, cercando di camminare più svelto che poteva per scaldarsi. 9<br />
L’ambientazione di questo vero e proprio incipit è funzionale all’animo del protagonista, che da<br />
violento e vendicativo qual era, dopo l’esperienza carceraria “diventa un uomo profondamente contemplativo<br />
e sereno, anche se è sempre accompagnato dalla malinconia per la sua vita mancata.” 10 È proprio<br />
ciò che vediamo nel protagonista in questi primi accenni, un uomo malinconico che contempla la<br />
partenza del treno da cui era disceso, perché nessuno è venuto ad aspettarlo in stazione al suo arrivo,<br />
mentre il vento freddo gira attorno alla stazione e il suo fischio richiama “il cigolio acuto delle ruote”<br />
del treno, quando ancora poco prima correva velocemente verso Tricesimo. Una coerenza profonda fra<br />
le sensazioni vissute dal protagonista e la realtà esterna rappresentata da quella stazione malinconicamente<br />
deserta e da un treno visto ripartire “con impeto stridente”.<br />
Altra apertura ferroviaria, indubbiamente più corale della precedente, la riscontriamo nelle primissime<br />
pagine de La contrada, il romanzo che Sgorlon pubblicò sempre da Mondadori nel 1981, quando<br />
Matteo, emigrato vari anni or sono in Alasca, dopo varie peripezie ritorna a <strong>Udine</strong>, la sua città. E vi<br />
ritorna, almeno nell’ultima parte del viaggio, utilizzando il treno, accolto da uno stuolo di amici che viene<br />
festosamente a salutarne l’arrivo in una serata d’inverno. Così inizia il romanzo:<br />
La notizia si diffuse in un baleno in tutta la contrada. “Matteo ritorna. Forse arriva col treno delle cinque...” Matteo?<br />
Arriva Matteo? Tornava così all’improvviso, dopo tanti anni?” 11<br />
La stazione della città si prepara ad accogliere il protagonista della storia, assieme a tutti i suoi<br />
amici della contrada. Tra questi anche Lazzaro, un giovane esuberante, dinamico e ottimista della vita,<br />
che analizzeremo meglio più avanti, e che assieme al padre vende carbone in città:<br />
8 Laddove è possibile, mi rifaccio sempre alle testimonianze autobiografiche rese dall’autore in Carlo Sgorlon, La penna d’oro,<br />
[s.l., ma Pezzan di Carbonera], Morganti editori, 2008.<br />
9 Cito da Carlo Sgorlon, Il vento nel vigneto. Roma, Gremese Editore, 2006, nuova edizione, p. 5.<br />
10 Carlo Sgorlon, La penna d’oro, cit., p. 55.<br />
11 Carlo Sgorlon, La contrada, Milano, Mondadori, 1981, p. 11.<br />
135
136<br />
Arrivato alla stazione Lazzaro si riscosse e fermò i cavalli impetuosamente. Fuori dall’edificio, sotto l’occhio luminoso<br />
dell’orologio, c’erano un paio di carrozzelle, con i cocchieri infreddoliti che ogni tanto sbattevano i piedi per terra,<br />
o si fregavano le mani. Una vecchia seduta dentro una nicchia del muro vendeva le caldarroste. 12<br />
E se dall’esterno della stazione, in un’atmosfera rassicurante e tipicamente invernale, quasi<br />
tratta da una cartolina d’epoca, si passa poi al suo interno, il clima silente d’attesa, appena scosso dalle<br />
consuete operazioni di manovra dei carri, diventa predominante:<br />
La stazione era semideserta. Un manovale picchiava qualcosa contro le ruote del treno in sosta su un binario<br />
appartato, con un martello dal manico lunghissimo. Più lontano si muoveva una lanterna ad acetilene, alzandosi e abbassandosi<br />
senza una ragione apparente. Alcuni binari erano bianchi di brina e di ghiaccio. Una piccola locomotiva di servizio<br />
sbuffava su e giù, lasciandosi dietro grandi nuvole di fumo bianco, che s’illuminava alla luce della luna che stava sorgendo.<br />
Qualche vagone scuro qua e là, sui binari morti, vicino allo scalo merci. Tutti tacevano, tutti aspettavano. 13<br />
La stazione si fa proscenio ideale per l’arrivo del protagonista Matteo. Il mito del lasimpón<br />
“(corruzione friulana del tedesco Eisenbahn, ferrovia), che seduce i friulani e li attira nei quattro angoli<br />
della terra col richiamo del lavoro, ma anche col fascino romantico dei posti sconosciuti”, 14 qui si rovescia<br />
in un’altra sirena, la Heimveh, dopo una vita intera passata all’estero: è il forte desiderio di ritornare<br />
nella propria terra, il Friuli, che distingue e segna le vicende di tanti altri personaggi della galleria<br />
<strong>sgorlon</strong>iana, ma al tempo stesso carica la vicenda narrata di elementi nuovi, inediti o addirittura magici,<br />
che solo l’arrivo di un personaggio da un posto esotico e lontano sembra poter pienamente assicurare.<br />
L’eccezionalità della prestanza fisica di Matteo si riflette istantaneamente nelle cose che gli<br />
stanno attorno (“tutto ciò che lo circondava, la pensilina verde, le colonne di ferro, la stazione, gli pareva<br />
rimpicciolito”), 15 e il protagonista, che la stazione ha prima accolto e poi restituisce nelle sue vere<br />
dimensioni, è ora pronto a entrare in azione.<br />
Ventidue anni dopo, nel 2003, quando il fantasioso e anarcoide protagonista de L’uomo di Praga,<br />
Alvar, entra in scena, Sgorlon preferisce presentarcelo come forestiero intabarrato in un mantello<br />
scuro, che cammina a passi decisi per le vie del piccolo paese di montagna, Naularo. Ma se non si<br />
presenta subito alla stazione di Naularo, disceso da un accelerato d’inizio secolo, poco ci manca. Ben<br />
presto, infatti, Alvar si farà sorprendere nella piccola stazione del paese e Sgorlon ci spiega il perché:<br />
“vi saliva per recarsi in città o per andare fino al confine, dove passavano anche convogli internazionali<br />
che volavano verso le grandi città dell’Impero, Vienna, Salisburgo, Praga, Budapest”, o per sdoganare<br />
una serie di casse di legno arrivate “con un merci dalla Boemia” 16 che contenevano un oggetto particolarissimo<br />
e misterioso: uno dei primi proiettori cinematografici che, rimontato, regalerà a Naularo l’emozionante<br />
esperienza del cinema muto.<br />
In Sgorlon la confidenza con i soggetti ferroviari è comunque sentita anche in circostanze dove<br />
il treno non vi può essere, perché quella valle angusta e sperduta, che darà il titolo al romanzo, il treno<br />
non poteva attraversarla. Basta allora la conformazione delle sedute di un’osteria di paese, che si rivelerà<br />
essere il vero centro di quella comunità, per evocare all’inizio del racconto un’atmosfera che non<br />
può che essere familiare e cordiale:<br />
12 Op. cit, p. 15.<br />
13 Op. cit, p. 15-16.<br />
14 Carlo Sgorlon, La penna d’oro, cit., p. 100<br />
15 Carlo Sgorlon, La contrada, cit., p. 17.<br />
16 Carlo Sgorlon, L’uomo di Praga, Milano, Mondadori, 2003, p. 14.
L’osteria era un grande locale, vecchio di secoli, diviso lungo i muri da panche e tavolini di legno scuro, che parevano<br />
scompartimenti di un treno. L’ambiente metteva un piacevole senso d’intimità e di calore, ed ognuno vi si sentiva<br />
a suo agio, come fosse a casa sua. 17<br />
Se escludiamo un altro incipit ferroviario, la fuga in treno di un ragazzo in una grande città del<br />
Nord italiano, nel racconto per le scuole La fuga a Verona, 18 un’immagine che sarà replicata l’anno dopo<br />
anche ne Il velo di Maya, e che – come vedremo meglio in seguito – ci apre ad altre riflessioni sul tema<br />
della fuga e dell’avventura, compiuta usando il treno, un altro “quadro” iniziale di ambientazione ferroviaria,<br />
funzionale all’ingresso del protagonista, anche se in questo caso sono prevalenti le connotazioni<br />
di decadenza e di staticità, lo ritroviamo in un altro tra i primi romanzi di Sgorlon, La luna color ametista.<br />
Rabal, “uno strano ragazzo che sembra piovuto dalla luna”, 19 viene ritrovato all’interno di un vagone di<br />
una stazione abbandonata, in un contesto fortemente compromesso dall’incuria e dalla fatiscenza, che lo<br />
avvicina per molti versi alla situazione delle stazioni e dei treni “fantasma”. Ma tale effetto è raggiunto<br />
con una cura estrema per il dettaglio realistico, qui riferito ai vagoni (“la loro vernice si staccava a scaglie”,<br />
“quasi tutti i finestrini erano stati ricoperti da carta blu”, “avvertii soltanto un tanfo di paglia bagnata<br />
e un acuto odore di animale”), solo a tratti compensato e arricchito da qualche sapiente metafora<br />
(“erbe giganti o edere aggrovigliate li ancoravano al terreno, come le corde trattengono al molo una nave”),<br />
per ricreare un’ambientazione tipicamente <strong>sgorlon</strong>iana. Vale la pena riprendere il passo per intero:<br />
Giungemmo sul piazzale della stazione, dove da tempo nessun treno partiva o arrivava. La linea era fortemente<br />
passiva, e così qualcuno aveva deciso di far cessare i servizi. I binari erano tutti mangiati dalla ruggine; in certi luoghi<br />
avevano sbullonato e portato via le traversine per farne legna, in altri esse erano sparite sotto il fango e il groviglio delle<br />
erbacce. Sulle rotaie erano rimasti quattro o cinque vagoni, che avevo sempre visti nello stesso posto. La loro vernice si<br />
staccava a scaglie, le lastre dei finestrini erano spaccate e erbe giganti o edere aggrovigliate li ancoravano al terreno,<br />
come le corde trattengono al molo una nave. Ogni tanto qualche girovago vi prendeva alloggio, e dai tubi sporgenti incominciava<br />
a uscire del fumo. Nessuno però ci stava a lungo, dopo qualche tempo il vagabondo se ne andava, spesso senza<br />
aver scambiato neppure una parola con qualcuno di noi, e le carrozze restavano di nuovo vuote.<br />
L’uomo a un tratto si agitò sotto la mantellina e sporse una mano a indicare qualcosa.<br />
«Nell’ultima» disse. «Quella celeste».<br />
Non replicai, aspettando gli eventi. Nella carrozza sul principio non vidi niente perché quasi tutti i finestrini erano<br />
stati ricoperti di carta blu da qualche sconosciuto odiatore del sole. Avvertii soltanto un tanfo di paglia bagnata e un<br />
acuto odore di animale. Per un attimo provai una vaga paura, come se in fondo alla vettura avessi potuto scoprire una fiera<br />
accovacciata. Sotto il sedile, su una bracciata di fieno, era disteso uno strano giovanotto. 20<br />
Ma dove la dimensione fantastica e apertamente kafkiana 21 di un’ambientazione ferroviaria<br />
raggiunge il suo acme nella produzione narrativa dell’autore, è nelle prime pagine di La notte del ragno<br />
17 Carlo Sgorlon, L’ultima valle, Milano, Mondadori, 1987, p. 8.<br />
18 Carlo Sgorlon, La fuga a Verona. Un racconto con dodici finali. Roma, Gremese Editore, 2005. Un treno che, nell’isolamento<br />
di uno scompartimento, favorisce la riflessione di Jacopo, il protagonista in fuga, è l’ambiente ideale per fare scorrere il<br />
pensiero: “Jacopo si sedette in uno scompartimento semivuoto. Era come un gatto che si stesse leccando le ferite. Pensava<br />
a tante cose, secondo l’eterno arbitrio del pensiero, che va sempre dove vuole.” (p. 11). Lo stesso passaggio lo ritroveremo in<br />
Il velo di Maya, Milano, Mondadori, 2006, p. 56.<br />
19 Carlo Sgorlon, La penna d’oro, cit., p. 69.<br />
20 Carlo Sgorlon, La luna color ametista, Padova, Rebellato editore, 1972, p. 9.<br />
21 Lo riconosce lo stesso Carlo Sgorlon, nella presentazione che di questo romanzo fornisce ne La penna d’oro: “Neppure<br />
del tempo v’è alcuna certezza, e non si capisce nemmeno se il romanzo duri una notte oppure due. La realtà non fornisce<br />
coordinate sicure, come se tra l’uomo ed essa non ci fossero più affiatamento né simpatia. Sembra un po’ il mondo di Kafka,<br />
o quello di Bruno Schulz. È un sentimento, si potrebbe dire, di alienazione, di estraneità, di Entfremdung.” (p. 64)<br />
137
138<br />
mannaro. In questo romanzo, dello Sgorlon più tipicamente “tedesco”, 22 Walter, l’io narrante della storia,<br />
subisce fin da subito e sia pure “a distanza” le conseguenze paradossali di un grave incidente occorso<br />
a un treno merci, deragliato su un raccordo alla stazione di <strong>Udine</strong>, preannunciato da un “gran fischio<br />
di treno” e poi da uno “sfasciume di urti e di cigolii che si incrociano e si aggrovigliano”:<br />
Forse hanno scaricato un vagone di rottami, nella ferriera.<br />
Spalanco di colpo gli scuri sul viso della notte. La prima cosa che riesco a vedere è un gran fuoco sotto un capannone.<br />
Le fiamme a volte aumentano all’improvviso, con venature gialle e globi di fumo scuro. Forse sono esse a colorare<br />
il cielo di soffi rossastri. Accanto all’altoforno riesco a vedere alcuni vagoni cilindrici, color argento, rovesciati lungo la<br />
scarpata della ferrovia. Vicino e sotto di essi c’è una cascata di cose vive e brillanti. Cosa diavolo sarà?<br />
Vedo già piccole forme nere correre lungo i vagoni, saltando come grilli o cavallette. Devo correre anch’io? Cerco<br />
di convincermi che è una cosa che non mi riguarda, una cosa lontana, basta che chiuda gli occhi un momento perché<br />
non esista più. Ma ogni volta che li riapro, i grilli e le cavallette sono sempre più numerosi. Sembra che saltino fuori dalla<br />
terra, da buchi invisibili scavati nei prati o nel pietrisco ferroviario. Le loro minuscole figure nere sono illuminate dal rosso<br />
delle fiamme. Mi infilo in fretta la vestaglia, temendo di essere già in ritardo, e via di galoppo, chiedendomi se sia stato<br />
il rantolo misterioso o il fischio del treno a stanarmi dalla soffitta.<br />
Ben presto mi trovo sulla scarpata. Vado avanti saltando, cercando di individuare velocemente la pietra meno<br />
spigolosa sulla quale tra un istante metterò il piede, ma i sassi sembrano tagliati tutti con la scure, e ogni passo è un<br />
guizzo di dolore dal tallone al cervelletto. 23<br />
I pesci continuano “a venir giù a fontana dai vagoni squarciati” e un nugolo di persone sfacciate<br />
e insistenti come cavallette cercano di procacciarseli a più non posso e senza troppi riguardi. L’odore<br />
salmastro aggredisce le narici di Walter, che viene sconvolto da una nausea insopportabile. Ben presto,<br />
a questa scena caotica e concitata, se ne aggiunge una più agghiacciante: dalle lamiere slabbrate<br />
e contorte della cabina della locomotiva “viene fuori un ostinato gocciare di sangue”, “un gocciolare<br />
regolare, come se si trattasse di un rubinetto malchiuso”: 24<br />
Finalmente la portiera cede. Tutti si spingono o si tirano per vedere. Tra quelli che stanno dietro<br />
scopppiano delle liti, due vecchi cominciano a mollarsi calci negli stinchi. Dentro la cabina non c’è<br />
nessuno, solo una piccola chiazza di sangue che si sta raggrumando. Guardo in alto, e mi accorgo che<br />
il tetto è sfondato e che chiunque potrebbe essere passato di lì. 25<br />
La scena dell’incidente ferroviario notturno, che percorre e domina un po’ tutta la prima parte<br />
del romanzo, si accresce più oltre di un nuovo, sinistro particolare. Da una cabina di un vagone squarciato,<br />
da cui sta gocciolando altro sangue, spunta l’angolo di una foto: è quella di un ferroviere. L’io narrante<br />
inizia da qui la ricerca spasmodica di questa figura, che ha strane somiglianze con un vecchietto<br />
che, trovato sul luogo dell’incidente, lo insegue nottetempo. Ma poi, nel caos onirico di quella memorabile<br />
notte, Walter inizia a dimenticarsi del ferroviere da ricercare, e a escluderlo dalla cerchia dei possibili<br />
“padri”, salvo poi definire questa ricerca non conclusa “una battaglia perduta.” 26<br />
22 Si veda a questo proposito il saggio di Luigi Reitani in questo stesso volume.<br />
23 Carlo Sgorlon, La notte del ragno mannaro, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1995, p. 15-16.<br />
24 Op. cit., p. 23.<br />
25 Op. cit., p. 25.<br />
26 Op. cit., p. 109. Il critico Toscani identifica in questa figura quella del padre del protagonista del racconto, anche se in Walter<br />
il riconoscimento è ben più lento e contraddittorio: “Penso malinconicamente che forse mia madre non ha mai conosciuto un<br />
ferroviere, e tutto non è altro che un’invenzione della mia mente febbrile, del mio desiderio di avere un padre.” (p. 151). Cfr.<br />
Claudio toSCani, Invito alla lettura di Carlo Sgorlon, Milano, Mursia, 1994, p. 53.
Appendice<br />
Alla fine degli anni ’70 Carlo Sgorlon compose un romanzo dal titolo Nel segno del fuoco , liberamente<br />
ispirato alla vita di Pier Paolo Pasolini. Per varie ragioni l’opera rimase inedita. Per gentile concessione<br />
della vedova Edda Agarionis Sgorlon ne pubblichiamo ora il primo capitolo, La città.<br />
Carlo Sgorlon, La città<br />
(primo capitolo del romanzo inedito Nel segno del fuoco)<br />
Dopo aver faticato tutto il giorno a tavolino, undici, dodici ore, con strettissimi intervalli per ingoiare<br />
due bocconi quando lo stomaco li protestava, Oreste si infognava precipitoso nei vicoli notturni<br />
della città. Via, via! Aria! Una corsa mozzafiato, per snebbiarsi la mente! La testa gli fumava per la<br />
stanchezza. Non ne poteva più di stare al chiuso, nel tanfo di pollaio e di malga delle sue stanzacce,<br />
di respirare aria stracca e avvelenata. Scendeva le scale a salti e si gettava per le strade come un cane<br />
tenuto tutto il giorno alla catena, sotto l’incendio di un sole africano. Niente di meglio per levarsi di<br />
dosso lo stancheggio micidioso, il giramento affumicato di pensieri.<br />
Per le strade si sentiva rimesso a nuovo, un pesce ributtato nel mare. Sguazzava nel suo elemento.<br />
La gente che oziava diventava la sua gente, l’odore di fritto e di rosticceria che zaffava dalle<br />
porte aperte delle osterie, gli era domestico come quello che alonava il cesto delle focacce pasquali<br />
nella casa di sua madre a Montane. Come l’odore di lenzuola sbiancate con la lisciva e allargate nel<br />
sole, sopra l’erba della braida.<br />
Ma quando trottava frettoloso per le vie più larghe in lui ronzava l’impressione di essere avvolto<br />
dall’ansimare misterioso di animali addormentati. Veniva da ogni dove, portato dalla schiena ondulata<br />
del vento della sera. Dagli angoli più folti e più scuri dei parchi opulenti, dalle cripte semibuie delle<br />
chiese barocche, dagli antri cavernosi di palazzi decrepiti, dai cunicoli terragni delle catacombe. Sì, anche<br />
di quelle Oreste aveva la sensazione che risuonassero ed echeggiassero sotto di lui. Non le vedeva,<br />
ma c’erano, là sotto, ramificate come vene secche di un cadavere mummificato. Correvano sotto i<br />
colli, sotto il fiume e i quartieri, scavate nel tufo e nel travertino, un labirinto disorientante, una selva<br />
intricata, scavata dalle talpe cristiane ai tempi dei tempi, tra fumi di incenso e litaniamenti senza fine.<br />
Oreste là sotto non c’era mai stato. Gli mettevano paura. Dio, che freddo! Che senso di umido<br />
e di vuoto nelle ossa, al solo pensarci...! No, non avrebbe mai dato spago alla curiosità, non sarebbe<br />
mai andato a fiutare le muffe e gli spurghi di salnitro, laggiù. Però era spesso attraversato dal pensie-<br />
139
140<br />
ro di un’anticittà sotterranea, ormai svuotata da secoli, gremita soltanto dei propri silenzi muschiosi e<br />
delle proprie leggende. Si diceva che in passato, chissà quando, dei turisti incauti si fossero infilati nei<br />
budelli ciechi e senza ritorno, e avessero rivisto la luce soltanto in forma di scheletri terrosi, dopo anni<br />
e anni. Oreste aveva la sensazione di aver assistito, là sotto, a messe bisbigliate e salmodiate nella<br />
fumea delle torce, diciannove secoli prima. «Kyrie eleison! Christe eleison!» aveva gridato anche lui,<br />
stipato dentro un gregge di disperati, ammassati come sacchi di sale sopra le banchine di un porto.<br />
Nel suo andare frettoloso, senza destinazione, Oreste sentiva il respiro composito dell’intera<br />
città. Provava un’ansia di correre, e le gambe lo portavano ancora con la foga dei vent’anni. Gli pareva<br />
che ombre e ombre si addensassero dappertutto, dietro gli archi di antichi mercati, nei faraglioni di<br />
mura diroccate, sopravvissuti come radici di denti nella mandibola di un vecchio. Di sera il rosso del<br />
mattone diventava cupo come sangue raggrumato, e i golfi d’ombra si facevano anche più neri, per contrasto,<br />
nel polverio luminoso dei pleniluni.<br />
A Oreste pareva che i più vasti fossero ancora caldi delle fiere che li avevano appena abbandonati,<br />
al rumore dei suoi passi, per rifugiarsi più lontano, dove nessuno poteva scovare le ombre. Le<br />
pietre e i mattoni sgretolati, percorsi da millenni dalle lente tartarughe dello sfacelo, recavano ancora<br />
tracce del loro pelame grigio e giallastro. Oreste si avvicinava come volesse constatare con i suoi occhi<br />
la fuga appena avvenuta, e toccare con mano la paglia fetida di covili ancora caldi. Vedeva gli occhi fosforici<br />
di un gatto, o il dimenio uggioloso di un cucciolo sperduto e affamato. Si avvicinava con cautela,<br />
spremendosi dalle labbra suoni adescanti e affettuosi.<br />
«Túi, túi..; micio, micio» poi sostituiva al primo suono istintivo, che gli aveva fatto affiorare sulla<br />
bocca suoni seppelliti nella memoria di ragazzo. «Fido, Fido» sussurrava a bastardelli furtivi, allevati<br />
e nutriti dal ventre rancido della città.<br />
Se era uscito in macchina, subito le sue mani generavano fagottelli di cibo, spesso vecchi di<br />
giorni. «To’ piglia! Mangia, mangiate!» sussurrava, già turbato dalla fame spaventosa degli animali,<br />
che si slanciavano diffidenti verso le sue mani donative. Miagolavano, ansimavano, uggiolavano, latravano,<br />
si divincolavano, si intersecavano, affamati e ansimanti. I cigli erbosi svariavano di groppe grigie<br />
o nerastre. I musi si spalancavano e si divaricavano, emettendo le invocazioni rauche del soccorso vitale.<br />
Pareva che gli animali fossero allo stremo, e quei cartocci di avanzi, già artigliati dalla putrefazione,<br />
fossero l’ultima Thule della loro salvezza.<br />
A Oreste pareva di rivedere i colli incordati e tendinosi, i visi teschiosi che erano emersi dalle<br />
pancheletto dei campi di sterminio, all’arrivo dei liberatori. Provava lo stesso scuotimento di cuore di<br />
quando aveva visto quelle foto, o seguito quelle scene nei documentari. «Piglia! Pigliate! Adesso non<br />
ho altro! Finito tutto!» sussurrava. Sentiva mordere, lappare, in un divincolìo di denti lacerativi, decisi<br />
a sopravvivere a qualunque costo. La fame era, la fame... la fame che non cessava di far suonare il<br />
suo mucchietto d’ossa inaridite per i selciati di pietra delle strade della città, e del mondo intiero. Era<br />
la megera che aveva urtato nei fianchi anche lui, col gomito scheletrito, e gli aveva stretto lo stomaco<br />
nei primi tempi che era calato laggiù. Di notte lo svegliava di soprassalto, e lui sentiva i gorgoglii vuoti<br />
delle angurie e delle castagne secche ingoiate per ingannarla, nelle sere squattrinate e senza fine.<br />
Si rivoltava nel letto come fosse tarantolato. L’inseguimento della strega era durato a lungo, a lungo,<br />
mesi e mesi, per non dire anni. Se l’era portata dietro come una rogna che non vuol guarire, come una<br />
maledizione. Le gambe gli ballavano nel pantalone, gli occhi scialbavano le cose viste per la povertà<br />
da sciacquatura del sangue. Conservava ancora i fantasmi di quella fame nelle naftaline ostinate del<br />
suo spirito.<br />
Ma erano altre cose che lo attiravano in quegli animali. Vedeva le casse toraciche che si dilatavano<br />
e si stringevano. Indovinava il palpitare ansioso del cuore, lo stiramento eterno delle visce-
e, sconvolte dalla paura atavica di un animale più grosso che potessero incontrare sulla loro via, e da<br />
cui avrebbero potuto essere divorati. Sentiva quella paura scolpita nelle vene, nelle corde tese delle<br />
budella. Si sentiva trascinato dalla rete a strascico di una pietà rasposa come le scaglie di un pesce,<br />
che aveva cento gole e cento bocche, e da ognuna di esse sfiatava un lamento vetroso sotto le stelle.<br />
Doveva strapparsi ad essa ed ai plotoni imploranti degli animali a viva forza. «Via, via! Non ho<br />
più niente! Basta, piantatela!» Ma dentro si scioglieva come colla scaldata. Si sentiva raggiunto e sommerso<br />
dalla marea montante della compassione, che in lui cresceva col capriccio lunatico e gigantesco<br />
dei fiordi rocciosi della Bretagna e della Cornovaglia. Provava l’impulso di afferrare un animale qualsiasi<br />
per la collottola e portarselo a casa, per fare con esso ruzzamenti e capriole sui pavimenti di casa<br />
sua, come faceva da moccioso, nella casa del nonno, a Montane, lontano dagli occhi di bove di suo padre.<br />
Le sue membra magre erano ancora sguizzate da raffiche di energia, da impeti giovanili, e invece<br />
nel suo sacco cozzavano e suonavano già più di quaranta noci. «Quaranta, quaranta!» sbalordiva. Era<br />
alto e magro come un asceta, tutto ossa, tendini e muscoli. Una faccia da contadino scavata dalle fatiche<br />
sotto la pioggia e sotto il sole, un viso di pelle di talpa asciugata nei soli roventi delle canicole.<br />
Era butterato malamente da un tentativo di vaiolo generato da una dose di vaccino troppo forte, collocata<br />
dalla sfortuna davanti al suo braccio nudo, poco prima di partire per una colonia marina. Gli occhi<br />
negreschi gli ardevano di febbri sconosciute e impetuose. I capelli, lucidi come pelo di iena, gli crescevano<br />
lunghi e disordinati, tendendo a torcersi in riccioloni sulle guance e sulla nuca. Addosso teneva<br />
giubbotti di cuoio tagliuzzati dalla vecchiaia, e calzonacci di tela, ruvidi come vele di antichi galeoni.<br />
Si sentiva dentro, anche dopo il lavoro, anche nel cuore di notti crivellate dal canto dei grilli,<br />
folate di una energia senza fine. Aveva bisogno di correre, di saltare, di agitarsi, di arrampicare, di dare<br />
libero sfogo a gridi rauchi che gli grattavano la gola come un odore di fritto. Perciò quando arrivava in<br />
periferia, nei pratelli polverosi, tra i casoni popolari, cominciava subito a sgambare coi ragazzini dietro<br />
pallonesse sgangherate e bozzerose, che ghignavano da squarci malamente ricuciti con spaghi biancastri,<br />
da ciabattini frettolosi o da madri bercianti. Le prime volte i ragazzini stupefacevano, allocchivano,<br />
e stavano a guardarlo come statue di sale.<br />
«Ma quello che vuole? Chi lo ha chiamato?»<br />
«E io che ne so? Si è messo lì da sé...»<br />
Lui però correva più di loro. Pareva più in fiato. Scartava, dribblava, segnava dei goal da lontano,<br />
sicché loro finivano per vederlo come uno della ganga, e gli sorridevano paciosi e amichevoli. «Sai<br />
pure segnare! Sei meglio di Nordhal!» gli dicevano ammirati. Li conquistava tutti, quanti erano. «Come<br />
ti chiami?» gli chiedevano. Mai avrebbero sospettato che il suo nome si conoscesse come quello di un<br />
corridore ciclista, e stesse sui cartelloni dei teatri e sulle copertine delle riviste. Già la terza o quarta<br />
volta che giocava con loro se lo disputavano bramosi, e quasi si baruffavano per averlo con sé. Gli davano<br />
del tu, fregandosi le manacce su canottiere pantanose, su camicie rattoppate. Pareva loro luminoso<br />
come l’arcangelo Gabriele, disceso dall’altare, e fattosi di carne e sangue per giocare. Da lui si<br />
aspettavano le sette meraviglie del mondo.<br />
Certe volte, di sera, quando le macchie dei pini s’erano ingoiate il melone rosso del sole, scoprivano<br />
la sua macchina sportiva. O era lui a mostrargliela. Loro alla prima guardatura capivano che<br />
era un’auto di quelle che per partire rombavano e stracciavano l’aria, come avessero un giaguaro nel<br />
motore. Non credevano ai loro occhi. Dalle bocche aperte colava giù inconsapevole la saliva del desiderio.<br />
Superato lo stupore lunare della rivelazione, cominciavano ad esaminarla in ogni parte, come<br />
fossero un branco di selvaggi del Gabon o del Borneo. Studiavano la targa, il cruscotto, il volante, le<br />
marce, toccando ogni cosa con le loro mani raspose. Si sedevano e si dimenavano sui sedili di cuoio<br />
rosso, lasciando i segni di terra delle loro brachette infangate. Coglieva nei loro occhi i riflessi dorati<br />
141
142<br />
del loro entusiasmo. Sentiva che per essi l’automobile emanava richiami da piffero orientale, da tappeto<br />
volante, quasi lui fosse Sinbad il marinaio, e tenesse un genio realizzatore di ogni desiderio dentro<br />
l’orcio di terracotta.<br />
Allora in Oreste scoccava la diana di una rivelazione. Vedeva la sua auto, che a volte gli veniva<br />
a noia, come una vecchia mignotta sempre pronta a ogni capriccio, con i loro stessi occhi. Spesso ne<br />
caricava quattro o cinque, strappava un permesso frettoloso a una zia o a una nonna, e li scarrozzava a<br />
tutta velocità fino a un paese dei colli, o del litorale.<br />
«Avete fame?» gli chiedeva.<br />
«Eccome no».<br />
Stavano a combattere con l’oste per decidere cosa mangiare, e facevano i difficili nello scegliere,<br />
mutando continuamente parere. Litigavano e si trovavano in difficoltà con forchette, coltelli e tovaglioli,<br />
come fossero marziani alle prese con cose mai viste. Infine buttavano via tutto ciò che li teneva<br />
in soggezione, e attaccavano a mangiare con totale naturalezza, leccandosi le dita e raspando le braciole<br />
sotto l’osso, con l’ingordigia di giovani mastini. S’abbuffavano ridendo, minacciando di strangolarsi.<br />
Spruzzavano il vino dal naso, negli eccessi più feroci del riso, dandosi grandi pacche sulla schiena. Conoscevano<br />
soltanto i rimedi più primitivi e tribali.<br />
Oreste gli dava spago, li stuzzicava come fossero grilli nella tana, li assecondava nei loro stralunamenti<br />
e nelle loro mariolerie, finché in lui si mettevano a suonare le campane di un entusiasmo senza<br />
freni. Sentiva che tra loro correva la fiumara torrentizia della simpatia, e che quei ragazzini venivano a<br />
riempire con tumulti selvaggi lo spazio vuoto della famiglia che non aveva. A volte si vedeva come un<br />
bracco malinconico che corresse con la lingua spenzolata appresso a due selvaggine ugualmente chimeriche,<br />
la vecchia famiglia che non esisteva più, e quella nuova che non esisteva ancora, che in tutti<br />
quegli anni non era riuscito a mettere in piedi, per ragioni più insondabili della Fossa delle Filippine.<br />
Della famiglia antica non restava più che sua madre, Caterina. Un destino impetuoso l’aveva<br />
disfatta e dispersa, senza che nessuno potesse alzare un braccio per fermare le cose. Neanche sua madre,<br />
imponente come era, avrebbe potuto farci niente. Ora che aveva passato i sessanta, pareva che<br />
i suoi occhi verdi fossero calcinati dalla meraviglia di non vedersi circondata dalla nuvola di altri figli<br />
sognati e non venuti al mondo. Caterina era sempre affacciata al balcone dei pensieri tumultuosi del<br />
figlio.<br />
Forse per questo Oreste, nelle osterie domenicali di Genzano o di Valmontone, si figurava di<br />
essere piombato all’interno di una famiglia improvvisata, piovuta dal cielo. Una famiglia precaria e avventizia,<br />
uscita da un sobbalzo della fortuna, indossata provvisoriamente, come un abito che non ci appartiene.<br />
Eppure, nel suo slancio arruffato, s’immaginava che quell’abito fosse stato tagliato proprio<br />
per lui, e nelle sue vene ronzava una sensazione dispersa di paternità...<br />
La foga dei ragazzini era come il borbottio rivelativo di pitonesse, che disegnassero a giovani<br />
patrizi il loro destino, dentro grotte oracolari. Tutto ciò che facevano i ragazzi aveva il sigillo di sulfuree<br />
rivelazioni. Tutto ciò che dicevano mandava scintillii luminosi, grondava dei mieli dorati della simpatia.<br />
Le loro zie sinodali e le loro nonne sdentate diventavano per lui delle fate popolane che avevano vegliato<br />
i loro sonni infantili col favore delle stelle, in paesucoli laziali o sanniti. Assecondava le cascate<br />
spumose delle loro risate come formassero specchi d’acqua, che riflettevano le immagini e i geroglifici<br />
del suo destino. Ah, come erano incredibilmente giovani!<br />
Sentiva la freschezza di ostrica del loro vivere spensierato, i loro slanci, le loro fami, le loro seti<br />
di giovani animali. «Avete ancora fame? Lo volete un altro piatterello di spaghetti? Una forchettata<br />
di peperoni sottaceto?» li tentava. Quelli facevano di sì con le teste, come si fossero scordati il no e i<br />
modi per significarlo prima ancora di nascere. Lui si sbracciava per chiamare i camerieri, e sul tavolo
en presto rifioriva la primavera di nuovi piatti colorati. Anche Oreste mangiava con fame gagliarda. Da<br />
costellazioni remote gli pioveva fortissima la sensazione di essere ancora molto giovane, soltanto un<br />
ragazzo, e di avere ancora cisterne intatte di anni e di lavoro davanti a sé.<br />
In lui i progetti s’infittivano come i passeri negli alberi del cortile, di sera, cinguettando con foga<br />
sgolata e ubriacante. Soprattutto vedeva ammiccare la fatamorgana della giovinezza, che da decenni<br />
continuava a percorrere tutte le strade e tutti i vicoli davanti a lui, eternamente circondata dal suo riso<br />
ed eternamente inafferrabile, come un’ombra fantasiosa, proiettata dal suo stesso corpo.<br />
Ma quel nodo di sentimenti non aveva durata. Il fantasma di un’ipotetica famiglia sfumava<br />
in brume autunnali. Invisibili bracci di mare venivano a dividerlo dai giovani amici. I festoni colorati<br />
dell’entusiasmo erano sfilacciati e maciullati in poltiglie fangose, e crollavano giù da tutte le parti, in<br />
un rovinio da terremoto.<br />
Una vaga coscienza di colpe e di rimorsi remoti e sferzanti saltava a cassetta dentro di lui, e<br />
cominciava ad agitare la sua frusta di postiglione imperioso. Si sentiva ricacciato da nuvole di fantasmi<br />
senza corpo dentro un ghetto risonante di gridi e di ululati. Sentiva di appartenere a una razza di dannati,<br />
di reprobi, che portavano sulla fronte il segno inconfondibile di Caino. Si sentiva colui che aveva<br />
abbandonato il branco e si era avventurato solitario in regioni fredde e paurose. Aveva divorato i frutti<br />
della vita, raccattandoli dovunque li trovasse, bagnandosi il mento di sughi che colavano come le acquoline<br />
dell’ingordigia. Una fame da lupo lo lanciava sempre in ogni possibile direzione, ed egli si gettava<br />
su ogni cosa con slancio primordiale, come un uomo delle caverne o dei terramare. Trangugiava<br />
ogni cosa come il luccio, il pesce tutto fauci, ingoiativo e insaziabile, e non importava che si trattasse<br />
di un boccone avvelenato. Anche quella sua fame l’aveva strappato dalle radici che lo tenevano legato<br />
e l’aveva sbalestrato nella metropoli. Ma quelle radici e quelle barbe penzolanti a volte riacquistavano<br />
una sensibilità dolorosa, sicché si sentiva di colpo dolorante come un reumatizzato, quasi avesse lasciato<br />
Montane solo due giorni prima. Le ferite rimarginate e cicatrizzate tornavano a dolorare, come<br />
stigmate misteriose.<br />
Tuttavia si portava ancora dietro spezzoni della sua infanzia e adolescenza vissute fra i campi.<br />
Era l’amuleto magico del suo gusto per l’arcaico. Egli lo conservava come i negri rubati dai negrieri tenevano<br />
ancora con sé, in terra americana, il sacchetto di pelle con dentro il pelo di cavallo, la piuma di<br />
gufo e il dente di leone. In esso bruciavano tuttora i fuochi rituali dei Celti, risuonavano ancora gli amplessi<br />
magici che univano i contadini nei campi arati, sotto i pleniluni d’estate, per favorire la fecondazione<br />
dei campi, e i venti di età perdute. Oreste si sentiva risucchiato nel passato da voci remotissime,<br />
velate, come se per arrivare fino a lui avessero dovuto attraversare mari e savane, paludi e brughiere.<br />
Erano voci già risuonate sulle strade lastricate di Tebe e di Corinto, di Argo e di Micene, che si erano<br />
perse dentro bianchi templi, costruiti nel verde dei prati, o sulle rive del mare da cui era partita la nave<br />
degli Argonauti. Erano voci cariche di un sacro orrore, che gli rintronavano nelle orecchie, come non<br />
avessero mai cessato di farsi udire da tremila anni in qua. Oreste era convinto che proprio per questo i<br />
suoi drammi svegliavano il fiore della compassione nell’anima della gente. La parola compiva ogni miracolo.<br />
Ammansava le fiere, muoveva le pietre, richiamava i morti dal loro freddo soggiorno, scioglieva<br />
le bende funerarie attorno al corpo di Lazzaro, che stava nel sepolcro da quattro giorni e già puzzava.<br />
Lui ne aveva una certezza rocciosa. Ne aveva conferma ogni volta che un suo dramma veniva<br />
recitato, quando le parole acquistavano una vita irruente nelle voci degli attori, nei gesti, nei gridi, nel<br />
pulsare congestionato delle vene del collo. Tutto il bulicame delle sue passioni si versava con sfrigolii<br />
di lava incandescente nelle sue parole, che scolpiva con gli inchiostri capricciosi delle biro su grandi<br />
brogliacci ingialliti. Sapeva che la gente del popolo che veniva a vedere e sentire, le avrebbe subito afferrate,<br />
le sue parole, perché erano scritte per lei...<br />
143
144<br />
Esse scendevano da lontananze misteriose. Anche se parevano venire dalle sue viscere, ammuffite<br />
da una lunga incubazione, e avevano il sapore scorticato e lacerato del parto, esse venivano in<br />
realtà da più lontano. Sentiva in loro l’asma roca e profonda di chi viene da chissà dove. Le vedeva circondate<br />
dal ronzio cosmico di ciò che ha attraversato spazi vertiginosi, e sembra provenire da Andromeda<br />
o da Aldebaran. Quando le scriveva o le sentiva recitare dagli attori, provava i brividi di chi viene<br />
sfiorato da ali di pipistrello o di vampiro. Sapeva che le aveva generate lui, che uscivano da lui, e nel<br />
contempo che venivano da molto più lontano. Era il segnale rivelativo di una forza misteriosa del reale,<br />
che lui aveva soltanto captato in un etere senza fine. La parola poetica era una delle manifestazioni<br />
oscure e inesplicabili della forza della vita, e lui rabbrividiva soltanto a pensarci.<br />
Ma essa nasceva veramente soltanto se si era a contatto immediato con il popolo. Altrimenti<br />
inaridiva, assumeva l’aspetto deformato delle scorie di fusione. Per ciò Oreste continuamente si tuffava<br />
in mezzo al popolo minuto, parlava e viveva con esso, ne avvertiva d’istinto la forza creativa e la fontana<br />
inesauribile del suo amore per la vita. Entrava nelle sue case aperte sul vicolo, sentiva gli odori di sudore<br />
e di cucina degli interni. Stava a parlare con lui, restando sulla strada oppure saliva sulle terrazze<br />
e terrazzini, e accettava bicchieroni d’acqua intorbidati da un dito d’orzata o di tamarindo.<br />
I vecchi erano quelli che avevano più tempo da dedicargli. Piantati a gambe larghe sulle sedie di<br />
paglia, snocciolavano i rosari rievocativi di infinite miserie e infinite fatiche. Oreste sentiva scricchiolare<br />
nei loro racconti gli stridori della pena quotidiana, l’affanno dell’eterno combattere, che attraversava<br />
tutta la collana dei loro anni tartassati e tribolati.<br />
Nel mazzo dei suoi amici v’erano vecchi pescatori di Fregene, di Ladispoli o di Terracina, che<br />
complicate risacche della vita avevano sospinto fino alle periferie della metropoli, e ve li avevano depositati<br />
come spezzoni di legno o di corda di antichi naufragi. Le mandibole scure della morte, che sempre<br />
li sovrastava, che li aveva inghiottiti e risputati cento volte, diventavano nelle loro parole masticate, intrise<br />
di tabacco, più quotidiane del fuoco che cuoceva il loro pesce sopra i fornelli. Pareva che la morte<br />
fosse una donna ammansata e canterina che li cullasse, nelle albe e nelle notti, li consolasse d’esser<br />
nati, e promettesse loro riposi più dolci di quelli già conosciuti nel ventre delle madri.<br />
Accendevano nella mente di Oreste visioni sconvolte di notti passate sul mare. Di onde che venivano<br />
avanti come muraglie d’acqua, che parevano doverli cancellare dalla faccia della terra. Di mari<br />
sconvolti da ringhiose baruffe di libeccio e di grecale. Di cieli fradici di pioggia che pesavano sulle barche,<br />
sul punto di abbattersi sopra di esse per l’eccesso di gravezza.<br />
A forza di provarci e riprovarci, la morte aveva davvero strappato loro un cognato o un fratello,<br />
in una notte di burrasca che non pareva più impestata delle altre. Di essi andavano cercando dopo anni<br />
la jella nascosta in strani segnali che si erano verificati la sera prima, sulla porta di casa o tra le mura<br />
del paese. Erano convinti che i grandi fatti della vita sempre si preannunziavano in qualche modo, con<br />
un tuono a cielo sereno, o con il nove di picche che cadeva loro di mano, durante una partita di ramino,<br />
o una invasione di scarafaggi sulle pietre umide della cucina. Ma parlavano di morti e di naufragi con<br />
quieta mansuetudine, in fondo, perché per loro erano anch’essi cose di tutta normalità.<br />
Uno di loro, un anziano di Ladispoli che si era spinto al largo con i suoi compagni, perché vicino<br />
alla costa pareva che il pesce fosse svanito, aveva visto spuntare e crescere nella notte le mille luci di<br />
un mostro nero che filava sul mare, silenzioso. Aveva un’andatura uniforme come quella di uno squalo.<br />
Era passato a poche centinaia di metri dal peschereccio, diritto per la sua rotta. Non s’era minimamente<br />
accorto di loro, che s’erano azzittiti ed erano rimasti fermi come statue, a guardare, finché era<br />
scomparso. Oreste si era entusiasmato del racconto, e infatti vedevano il transatlantico anche i pescatori<br />
dell’unico dramma di mare che avesse scritto. Poi, tornati a casa, lo raccontavano nella piazza del<br />
mercato, con una filastrocca cantante, alla gente intorno, ai venditori e alle lavandaie. Si sbracciavano,
andavano eccitandosi via via, si ubriacavano del loro racconto e del sole che inondava la piazza. Erano<br />
scossi da visioni di terremoto, finché si abbattevano esausti sui banchi, dove saltellava l’argento vivo<br />
del pesce appena pescato.<br />
I racconti dei vecchi e delle donne gonfiavano l’anima di Oreste come una mongolfiera, e lui<br />
sentiva che quelli erano i momenti più veri della sua vita. Si figurava di percorrere a grande velocità<br />
tutte le strade e i vicoli dell’esistenza, spinto alle spalle da forze immani e senza volto. Aveva la sensazione<br />
che sipari ignoti gli si spalancassero davanti, e lui ruzzolasse con impeto dietro quinte sempre<br />
più vaste, giù giù, sempre più dentro. Passando attraverso di lui ogni cosa si moltiplicava e si dilatava,<br />
spalancava le valve del suo guscio, per mostrare le sue segretezze e le sue risonanze remote...<br />
Aveva scritto parecchio. Aveva messo in scena pescatori, contadini, boscaioli, malgari delle sue<br />
montagne, che passavano quattro mesi a duemila metri, in una solitudine da eremiti. Ma era convinto<br />
che il meglio dovesse ancora venire. Bolliva e si rimescolava dentro di lui come pietra fusa di vulcano,<br />
in attesa di trovare il varco per esplodere all’aperto. Il meglio era ancora là, sepolto come un tesoro di<br />
pirati in un’isola. Aspettava chimeriche braccia, pale e picconi per vedere finalmente la luce. Ogni storia<br />
di popolo lo esaltava come una bevuta di vino. Sentiva il pullulare delle forze misteriose che spingevano<br />
gli uomini allo sbaraglio, dentro il formicolìo affannoso della vita, e lui le guardava con occhi<br />
che moltiplicavano le misure, proiettando ogni cosa nel paese dei giganti. Non gli importava granché<br />
il fatto che i benpensanti si strappassero le vesti e si sgolassero contro di lui, chiamandolo macellaio,<br />
amorale, svergognato. Lui parlava del popolo, e i popolani erano sempre avvolti dallo stupore di una<br />
misteriosa salvezza.<br />
Tra loro c’erano anche puttane di tutte le risme, che chiamavano i clienti con voci rauche di fumo,<br />
e quasi se li tiravano per la giacca, per portarseli nell’aria tanfosa dei loro domicilii. C’erano scipparoli,<br />
rubagalline, borsaioli. C’erano deformi mammane, che maneggiavano ferraglia insanguinata nel<br />
ventre di ragazzine incaute. C’erano quelli che uscivano in mare, la notte, per caricare sul motoscafo la<br />
cassa del contrabbando, generata dalla nave greca o maltese che passava al largo, da polverizzare poi<br />
nei cento rivoli dei minutanti e dei loro cassetti segreti. C’erano ruffiani e magnaccia che passavano<br />
l’esistenza nei caffè, nelle sale da biliardo senza sole, con l’aria avvelenata dalle sigarette, a giocare<br />
a poker o a scalaquaranta.<br />
Eppure agli occhi di Oreste stavano tutti su quella zattera di salvezza, ilari come galletti, travolti<br />
da una letizia vitale, da un gusto di vivere aspro e acetoso come fondi di torchio. Lui non sapeva perché.<br />
Forse perché erano tutti lottatori, e risalivano la corrente che li portava a valle sbattendo le braccia<br />
come disperati, in una oscura consapevolezza che alle loro spalle c’era sempre una cascata lì pronta<br />
a ingoiarli. Ogni giorno dovevano ricominciare la loro battaglia per la sopravvivenza, contro il mare, la<br />
fame, la polizia, i padroni. Non importava contro cosa. Era tuttuno. Era sempre la stessa lotta, la stessa<br />
corsa affannosa. Era lo stesso precipitarsi a testa bassa contro qualcosa, il medesimo corpo a corpo<br />
contro un nemico irriducibile, che ogni giorno cambiava volto, ma che in sostanza era sempre lo stesso...<br />
Era in fondo la medesima lotta che conduceva anche lui, non sapeva contro cosa, che gli faceva<br />
bruciare di continuo immense riserve di energia negli altiforni dello spirito. Perdonava ai popolani ogni<br />
cosa, come fossero bambinelli di pochi anni. Le loro malefatte erano poco più della tendenza a lasciare<br />
sul lenzuolo le geografie urinarie dell’infanzia.<br />
Sentiva la loro ansia di sopravvivenza, il loro dimenìo da anguille nelle vasche cieche delle pescherie.<br />
La loro ingordigia era nient’altro che il residuo di fami secolari, la somma di montagne di crediti<br />
nei confronti dei potenti. Il giorno che si fossero decisi finalmente a riscuotere le loro cambiali, l’aria<br />
avrebbe tremato di paura e l’orizzonte avrebbe muggito di collere. Nei loro occhi sarebbero passati gli<br />
sciabordii verdastri di aurore boreali, le sabbie insanguinate di arene, e avrebbero cominciato a pestare<br />
145
146<br />
il suolo con gli zoccoli neri di tori da corrida.<br />
Solo che non sapevano bene di averle, quelle cambiali. Annebbiati dalla dimenticanza di intieri<br />
evi storici, le avevano buttate nel mar morto della loro infinita pazienza, nelle taighe sterminate della<br />
loro sopportazione. Forse si sarebbero ricordati di averle soltanto l’ultimo giorno della creazione, quando<br />
non ci sarebbe stato più tempo per riscuotere...<br />
Per la pallida razza degli scribi e farisei, invece, Oreste provava una diffidenza istintiva e invincibile.<br />
Per essa l’amore era corruzione, il denaro era un vizio freddo e solitario. Per tutte le cose erano<br />
disappetenti e nauseati come un animale troppo sazio. Mai erano dovuti uscire a faticare nei campi.<br />
Mai erano vissuti per quindici giorni, o un mese intiero, sopra un piccolo natante, per andare a pescare<br />
merluzzi nei mari boreali, come il padre del Portoghese, il fabbro di Montane. Mai avevano sentito sulla<br />
faccia le ragnatele vellutate della morte, sopra le onde selvagge del Tirreno...<br />
Certe volte Oreste si domandava se la sua attrazione per le puttanelle e gli scipparoli non contenesse<br />
qualcosa di diverso da quello che credeva, di più torbido, più fangoso, più sotterraneo. Era<br />
come un’ombra che gli passasse sul corpo, un brivido freddo causato da un’improvvisa eclissi di sole.<br />
Quando ci pensava il suo cuore aveva guizzi da delfino.<br />
Nel suo scasarsi notturno Oreste aveva delle mete privilegiate, le strade dove battevano le mignotte.<br />
Ci arrivava a suo capriccio, perché lui non aveva orari né etichette, e nella sua vita soffiava in<br />
eterno il ghibli incostante del disordine e dell’improvvisazione. Quelle erano le sue donne, il suo harem<br />
di vizi scalcagnato e maledetto, cacciato in esilio da editti antichissimi e dimenticati. Un piacere sempre<br />
rinnovato avvinghiava il suo cuore quando arrivava a quei marciapiedi, con la sua macchinaccia incrostata<br />
dal fango di tutte le strade. Si metteva a marciare pianopiano, per guardarsele con respiro e<br />
agio di vista, maledicendo che gli fosse interdetto di portarsele tutte a casa sua e di abbagliarle con<br />
regali e grandezze.
147
148
149
150
Finito di stampare<br />
nel mese di dicembre 2012<br />
151
152