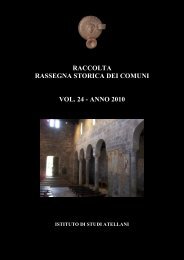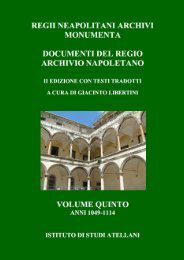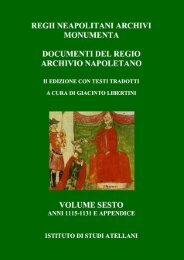LA CHIESA DI SAN MARCO “IN SYLVIS” - Istituto studi atellani
LA CHIESA DI SAN MARCO “IN SYLVIS” - Istituto studi atellani
LA CHIESA DI SAN MARCO “IN SYLVIS” - Istituto studi atellani
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
di cui accenneremo quando tratteremo degli affreschi.<br />
Le cappelle sul lato sud, probabilmente più antiche, risultano essere di<br />
maggiore ampiezza rispetto a quelle opposte.<br />
Il presbiterio, ritenuta dagli <strong>studi</strong>osi una delle parti più antiche della chiesa,<br />
presenta una pianta rettangolare coperta da un’imponente volta a crociera. In<br />
origine questo ambiente era illuminato dalle monofore laterali e da un finestrone<br />
absidale diverso da quello attuale, ma a causa dei rifacimenti la monofora nord<br />
fu chiusa dall’esterno e quella sud restò oscurata per essere stata addossata alla<br />
parete la torre campanaria, edificata intorno al XIV secolo. L’altare maggiore, di<br />
fattura settecentesca, prima con elegante paliotto ed angeli come capoaltare,<br />
proviene dalla chiesa S. Marco all’Olmo e fu fatto trasportare qui nel 1897 dal<br />
sacerdote Luigi M. Jazzetta per sostituire la vecchia ara in muratura.<br />
I muri d’ambito esterni presentano diverse peculiarità. Sul lato nord,<br />
all’interno di una piccola edicola, vi è un affresco raffigurante la Madonna col<br />
Bambino. Questa piccola edicola è il residuo di un antico ingresso della chiesa,<br />
coperto da un arco pensile su mensole, anche se oggi appare interrato.<br />
La singolare composizione del portale, con arco e lunetta superiore è<br />
abbastanza rara e rimanderebbe ad edifici in stile romanico o tardoromanico,<br />
quindi ascrivibile al tardo XIII-inizi XIV secolo.<br />
Sul muro absidale nei pressi del campanile è murata la “pietra di S. Marco”,<br />
sormontata da un’edicoletta che conserva deteriorate tracce, come si è detto, di<br />
un affresco con i Santi Gennaro e Marco, fatto eseguire nel 1897 dal parroco<br />
Jazzetta. La pietra era prima all’interno dell’edificio, ma all’epoca del parroco<br />
don Adorisio de Gentile (1541-1570), fu murata fuori affinché la si potesse<br />
venerare sempre, in quanto il tempio restava spesso chiuso.<br />
Sulle pareti esterne, di cui non è visibile la struttura muraria poiché coperta<br />
da intonaco cementizio di colore grigio, sono visibili delle piccole croci che la<br />
tradizione vuole risalenti al XII secolo, ma che tuttavia sono successive ed<br />
ascrivibili al XIX secolo. Insieme ad esse l’esterno è configurato come un<br />
complesso compatto cui si affianca il campanile, posto in linea con la parete<br />
esterna dell’abside e incastrato sul fianco sud.<br />
La struttura è a quattro livelli cui si aggiunge il pinnacolo ottagonale,<br />
visibile anche dall’autostrada che da Pomigliano d’Arco conduce alla<br />
Tangenziale di Napoli. Caratteristica peculiare è la conformazione della torre,<br />
che si restringe ad ogni livello, assottigliando anche la murature.<br />
Il campanile, insolitamente posto sul fondo della costruzione, sovrasta<br />
l’edificio e si configura come elemento caratterizzante dell’intero complesso.<br />
Simile nelle forme ai molti coevi campanili, soprattutto quelli relativi<br />
all’areale del Napoletano (in particolare con il S. Pietro a Maiella) e dell’Irpinia<br />
occidentale (Avella, Napoli, Nola, Montella etc.), la torre si riallaccia ad una<br />
tradizione architettonica che partendo dalla mediazione di forme e canoni di<br />
matrice orientale e bizantina, fra il XIV e il XV secolo si stabilizzò nello schema<br />
della costruzione affiancata e retrostante all’edificio, quasi in collegamento<br />
diretto tra essa e la zona absidale.<br />
La tradizione riportata da Jazzetta riferisce che dai libri parrocchiali erano<br />
documentate due campane, che poi, deteriorandosi, furono restaurate dal parroco<br />
Giuseppe Cerbone nel 1693 «con la spesa di ducati cinquanta». La fattura di<br />
queste campane non doveva essere ottima, se nel 1694 ne venne ricostruita<br />
26