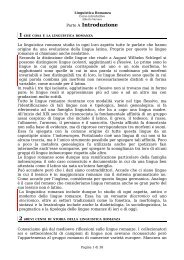Presentazione - Sabatini Coletti - Appunti Unict
Presentazione - Sabatini Coletti - Appunti Unict
Presentazione - Sabatini Coletti - Appunti Unict
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PRESENTAZIONE E GUIDA ALL’USO DEL SABATINI-COLETTI (2003)<br />
OBIETTIVO (comune a tutte le edizioni)<br />
L’obiettivo del Disc è stato sempre quello di realizzare un dizionario che si consulta non<br />
solo per controllare l’esatta grafia e la corretta pronuncia delle parole poco note o per<br />
conoscere il significato delle parole ignote, ma spesso anche per essere guidati nella<br />
costruzione delle frasi e per scegliere le parole con criteri di efficacia comunicativa.<br />
CARATTERISTICHE E NOVITA’<br />
Caratteristiche :<br />
- esauriente e rigorosa descrizione del funzionamento sintattico dei verbi<br />
- identificazione delle CONGIUNZIONI TESTUALI, degli AVVERBI FRASALI e dei<br />
SEGNALI DISCORSIVI<br />
- presa in considerazione delle FRASI SCISSE e FRASI SEGMENTATE<br />
- distinzione tra sorda e sonora per la z iniziale e per la s intervocalica. Viene indicata<br />
sempre la norma, ma in casi specifici le varianti sono segnalate come accettabili.<br />
Novità di questa edizione -> i rinvii dai sostantivi ai loro aggettivi di relazione anche nel<br />
caso in cui essi abbiano una diversa base etimologica.<br />
-> ampliamento del lemmario con molti neologismi<br />
-> precisazione delle info morfologiche ed etimologiche e<br />
perfezionamento della data di attestazione grazie alle nuove<br />
banche dati disponibili.<br />
Tutte le voci del dizionario sono articolate in 3 aree:<br />
l’area del lemma;<br />
l’area semantica ;<br />
l’area dell’etimologia e della datazione.<br />
Alcune voci sono corredate, in coda, di una nota di approfondimento.<br />
AREA DEL LEMMA<br />
Nell’area relativa al lemma troviamo<br />
- il LEMMA in neretto e con l’iniziale minuscola (con l’indicazione dell’accento solo se<br />
questa è obbligatorio nella norma grafica)<br />
Si ha la maiuscola : - nei forestierismi che lo richiedono<br />
- nelle voci relative alla botanica e alla zoologia lemmatizzati al plur.<br />
- TRASCRIZIONE tra parentesi quadre o barre oblique, in cui si dà anche la<br />
- SILLABAZIONE (presente in tutti i lemmi propriamente italiani), l’indicazione<br />
- dell’ACCENTO tonico mediante accento grafico e l’indicazione di<br />
- PRONUNCIA sonora o sorda di alcuni suoni
- le VARIANTI del lemma, se presenti, in neretto e nello stesso colore del lemma se hanno lo stesso<br />
uso<br />
- la QUALIFICA GRAMMATICALE<br />
PRONUNCIA SORDA o SONORA di S e di Z<br />
La pronuncia standard è indicata da quanto appare sotto la consonante :<br />
- se sotto la consonante non vi è nessun contrassegno, ciò indica che la pronuncia è sorda<br />
(costa, alzare)<br />
- se sotto la consonante vi è un puntino, ciò indica che la pronuncia è sonora<br />
(cosmo, climatizzare)<br />
Viene anche indicata la doppia pronuncia (sempre all’interno dello standard) della<br />
“z”iniziale e della “z”intervocalica mediante un’ondina posta sotto la zeta.<br />
LA TRASCRIZIONE FONEMATICA (con i simboli dell’AFI) è indicato solo in alcuni casi :<br />
ü monosillabi grammaticali per specificare la pronuncia di e ed o;<br />
ü le lettere dell’alfabeto;<br />
ü le sigle;<br />
ü le interazioni che presentano la h;<br />
ü i forestierismi e i loro eventuali adattamenti italiani ;<br />
ü i latinismi;<br />
ü i grecismi.<br />
àPer i derivati italiani di parole straniere, spesso da nomi propri, si dà la sillabazione e la<br />
trascrizione fonematica (Freudiano).<br />
àIl raddoppiamento fonosintattico viene segnalato solo per i monosillabi che lo<br />
producono nella pronuncia nazionale, ed è indicato con l’ abbreviazione “radd. sint.”.<br />
In tutto il dizionario il carattere neretto è riservato ai lemmi (in colore) e le loro varianti,<br />
agli alterati e derivati avverbiali e alle unità polirematiche evidenziate in corsivo nell’area<br />
semantica. In tutte le altre sedi, la lingua oggetto di analisi è in corsivo chiaro. La lingua del<br />
lessicografo (indicatori, definizioni, spiegazioni ecc..) è in carattere tondo chiaro.<br />
I lemmi sono disposti in ordine alfabetico. Nel caso di omografi,questi vengono registrati<br />
di seguito con il numero in esponente.<br />
RINVII<br />
Il rinvio viene rappresentato mediante una freccia (à) anteposta o posposta al lemma a<br />
cui si rinvia. Hanno il rinvio:<br />
ü le varianti (che rinviano al lemma pieno)<br />
ü le forme tronche;<br />
ü le preposizioni articolare;<br />
ü gli adattamenti di forestierismi<br />
ü le polirematiche di natura grammaticale (loc. preposizionali, loc. congiuntive, loc.<br />
cong. testuali) che non hanno sviluppo autonomo e hanno il rinvio alla voce in cui<br />
sono trattate.<br />
a causa di à causa1. (إﺇ loc. prep.).
INDICAZIONI GRAMMATICALI<br />
La qualifica grammaticale ad intestazione può essere unica se la parola si colloca in una<br />
sola categoria, ma può essere multipla se si colloca in diverse categorie. In quest’ultimo<br />
caso le indicazioni sono poste sempre nell’intestazione e solo nell’area attinente alla<br />
semantica verranno spiegati le eventuali specificazioni.<br />
Tra parentesi tonde si danno:<br />
ü i femminili dei nomi di professione, in –tore e in – sore, e di quelli che esprimono<br />
una condizione, un modo di essere o di fare (chiacchierone).<br />
Si danno indicazioni per la formazione :<br />
ü del plurale maschile ( e se occorre anche del corrispondente femminile)<br />
- dei nomi che terminano in -co, -go, -sco,<br />
- dei maschili in –ìo. –io, -a;<br />
ü del plurale dei nomi femminili che terminano in –cia, -gia, -scia, -ie e in -o<br />
ü del plurale degli ambigeneri (atleta);<br />
ü del plurale dei composti (capostazione).<br />
L’invariabilità delle forme al plurale (nomi in –i, parole tronche ecc..) è segnalata con<br />
“inv.” fuori parentesi.<br />
INDICATORI<br />
A chiusura dell’area del lemma si colloca , quando richiesto, un indicatore che segnala se<br />
la parola, o una sua variante, è qualificabile come:<br />
ü ANTICA, le parole che recano tale indicazione sono quelle il cui uso comune sembra<br />
essere uscito entro la metà dell’800 (età convenzionale che segna un periodo di<br />
mezzo tra la svolta manzoniana e i mutamenti portati dall’unificazione d’Italia);<br />
ü ANTIQUATA,<br />
ü REGIONALE;<br />
ü DIALETTALE;<br />
ü LETTERARIA, si indicano come letterarie tutte quelle parole usate da poeti e<br />
prosatori, di stile alto, sia antichi che moderni.<br />
ü NON COMUNE.<br />
Gli stessi indicatori possono essere utilizzati anche per le singole accezioni nell’area<br />
semantica.<br />
“ALTA DISPONIBILITA’ DEI LEMMI”<br />
10.000 lemmi circa hanno un fondino (di colore grigio nell’edizione del 1997, rosso in<br />
quella del 2003), che indica che queste parole sono di ALTA DISPONIBILITÀ nell’uso<br />
odierno della lingua. Ovvero,sono parole altamente frequenti nell’uso e sono conosciute e<br />
comprese da un parlante italiano di media cultura.<br />
Nel <strong>Sabatini</strong> – <strong>Coletti</strong> queste parole sono state selezionate sulla base di liste di frequenza<br />
esistenti come il LIF e il LIP, intervenendo con valutazioni personali.<br />
Tra queste 10.00 parole non state inclusi :<br />
- termini tecnici, in quanto legati a determinati discorsi e proprio per questo difficilmente<br />
sostituibili
- i numerali, in quanto sono tutti potenzialmente di alta disponibilità<br />
L’AREA SEMANTICA<br />
ARTICOLAZIONE PER CATEGORIE GRAMMATICALI<br />
Questa è racchiusa tra 2 tratti lunghi (-…-) ed è l’area dedicata :<br />
- alla DEFINIZIONE<br />
- all’ESEMPLIFICAZIONE DEI SIGNIFICATI e usi della voce<br />
- all’eventuale SEZIONE degli ALTERATI e dei DERIVATI AVVERBIALI<br />
Se la voce presenta nell’area del lemma più categorie grammaticali, queste vengono<br />
riprese e specificate nell’area semantica in altrettante articolazioni, segnalate dal simbolo<br />
di un rombo nero .<br />
Se la voce o locuzione è usata in funzione diversa da quella primaria, per cui si ha ad<br />
esempio :<br />
- un uso avverbiale di aggettivi -> dolce<br />
- un uso aggettivale di nomi -> fiume<br />
- un uso sostantivato di infiniti di verbi -> piangere<br />
- un uso di avverbi o congiunzioni come congiunzioni testuali ->allora, benché<br />
tale uso, che costituisce una categoria acquisita, è segnalato alla fine della categoria di<br />
partenza con il simbolo e introdotto dalla formula “in funzione di”.<br />
Se il significato non cambia, tale uso è introdotto dalla formula “Anche in funzione di”.<br />
ACCEZIONI, LOCUZIONI E UNITA’ POLIREMATICHE<br />
Se la definizione si articola in diverse accezioni queste sono numerate con numeri arabi in<br />
colore, puntati (1., 2., ecc..) e ordinate in base alla loro frequenza e importanza.<br />
Nell’ambito dell’accezione ritroviamo le locuzioni che ad essa si riferiscono. In particolare :<br />
ü le locuzioni di valore avverbiale o aggettivale,le frasi fisse, i modi dire, i detti e i<br />
proverbi sono preceduti da barretta doppia (||) in apertura della serie, e<br />
successivamente da barretta semplice (|).<br />
Una barretta doppia divide anche le locuzioni proprie da quelle figurate, seguita<br />
dall’indicatore “ figg.” quando queste sono più di una.<br />
ü le polirematiche non messe a lemma. Queste locuzioni sono segnalate in entrambi i<br />
lemmi a cui si riferiscono.<br />
ü le locuzioni preposizionali o congiunzionali (anche testuali) sono precedute dal<br />
simbolo إﺇ, e collocate in fondo all’accezione.<br />
INDICATORI DI SETTORE<br />
Nell’area semantica sono collocati gli indicatori di settore (bot., dir., fis., gramm., ling., mat.,<br />
ecc) o di uso figurato o estensivo (fig., estens.).<br />
Sono eventualmente presenti anche gli indicatori di registro (pop., volg., ecc.) se riguardano<br />
una di queste parti della voce.
L’uso figurato quando è marginale viene introdotto da questo simbolo ~ seguito da “fig.” o<br />
dalle formule “anche fig” , “anche in senso fig”.<br />
Il simbolo di una s piccola dentro un tondino introduce la sessione dei sinonimi.<br />
Gli esempi in forma di battute dialogiche sono tra doppie virgolette alte (“ ”).<br />
Gli esempi tratti da citazioni sono tra doppie virgolette sul rigo (>) .<br />
VERBI<br />
L’uso dei verbi è descritto tenendo conto della loro “valenza”, cioè del numero degli<br />
elementi necessari (argomenti) che il verbo richiede per formare il nucleo della frase.<br />
Innanzitutto vengono segnalati gli usi impersonale, intransitivo, transitivo, riflessivo, col<br />
simbolo di categoria .<br />
La valenza viene indicata con il numero di argomenti tra parentesi ( nel calcolo non è<br />
inserito il soggetto quindi i verbi che richiedono solo questo come argomento non recano<br />
l’indicazione di argomenti). Il passaggio da una valenza all’altra viene indicata con il<br />
simbolo . Nel caso di verbo riflessivo (v.rifl.) non viene calcolato l’argomento.<br />
Se il verbo appartiene ad una sola categoria che ha una sola valenza, entrambe queste<br />
indicazioni sono fornite già e solo nell’area del lemma.<br />
Se il verbo, oltre a quello predicativo, possiede altri valori (ausiliare, modale, ecc..) la voce<br />
viene articolata in sezioni distinte da un numero romano a inizio di rigo (venire, dovere,<br />
fare).<br />
AGGETTIVI DI RELAZIONE<br />
Circa 700 sostantivi sono seguiti dal simbolo di una A dentro un tondino seguita<br />
dall’indicazione: “ agg. rel. non derivati dal lemma” per indicare gli aggettivi di relazione<br />
(idrico) che derivano da una base etimologica diversa rispetto al sostantivo di riferimento<br />
(idrico-acqua).<br />
ALTERATI E DERIVATI AVVERBIALI<br />
A conclusione dell’area semantica, nella sezione aperta dal simbolo di una D dentro un<br />
tondino sono raccolti gli alterati e i derivati avverbiali, ovvero gli avverbi in –mente<br />
derivati dagli aggettivi.<br />
Gli alterati che sono anche registrati come lemma autonomo presentano la freccia di<br />
rinvio.<br />
àESEMPI E CITAZIONI<br />
Negli esempi la virgola separa più casi in cui il lemma ha lo stesso valore; il punto e<br />
virgola distingue esempi diversi.<br />
Nell’area semantica il lemma è scritto con la lettera iniziale puntata, tranne per:<br />
i monosillabi;<br />
nei casi in cui la forma estesa è necessaria per evitare degli equivoci;<br />
parola composta;
L’AREA DELL’ETIMOLOGIA<br />
ETIMOLOGIA E FORMAZIONE DELLE PAROLE<br />
L’informazione etimologica è introdotta dal simbolo E dentro un tondino<br />
Nella derivazione del latino si distingue :<br />
ü la tradizione diretta, attraverso l’uso parlato popolare, segnalata dalla formula:<br />
“lat.”;<br />
ü il recupero dotto, attraverso fonti scritte, segnalato dalla formula: “dal lat.”;<br />
Se la parola è attesta nel LATINO CLASSICO non si aggiungono specificazioni, che vengono<br />
invece aggiunte se le parole sono attestate :<br />
- nel latino volgare, un latino ricostruito, usando la formula “lat. volg.” e un asterisco<br />
anteposto alla forma.<br />
- nel latino popolare, cioè se la parola è presente in testi di epoca classica ma di registro<br />
basso<br />
- nel latino tardo<br />
- nel latino Ecclesiastico<br />
- nel latino Umanistico<br />
- nel latino Medievale<br />
- nel latino Scientifico<br />
La base latina è sempre citata nella forma dell’accusativo, tranne quando la parola italiana<br />
discende direttamente da un altro caso.<br />
Le basi greche sono riportate al nominativo.<br />
A volte vengono date informazioni etimologiche anche delle varianti principali.<br />
Per derivati e composti ottenuti con elementi della lingua italiana, si rinvia ai lemmi<br />
corrispondenti.<br />
DATAZIONE<br />
Dopo l’informazione etimologica segue un punto . , simbolo che introduce la sessione<br />
riguardante la data, dove ritroviamo la data di prima attestazione della parola nella lingua<br />
scritta in un testo volgare o almeno in un contesto linguistico volgare.<br />
Per le parole attestate prima del 1800 si indica globalmente il secolo, in numeri romani.<br />
Per le voci databili a partire dal 1800 si indica, quando possibile, l’anno.<br />
Le parole provenienti da altre lingue o dai dialetti parlati moderni sono datate dal<br />
momento del loro ingresso nella lingua italiana, mentre non sono datate affatto molte<br />
locuzioni ereditate dal latino.<br />
In pochi casi non è stata trovata nessuna documentazione utile per la datazione.<br />
FORESTIERISMI<br />
Nel dizionario sono presenti anche i forestierismi (che De Mauro chiama esostismi). Essi<br />
sono lemmatizzati :<br />
- in neretto corsivo in colore<br />
- nella grafia della lingua originaria, se l’alfabeto usato è quello latino.
Non sono considerati forestierismi le parole straniere ormai acclimate in italiano (bar, film,<br />
sport) e le parole composte da un elemento forestiero e uno italiano (antidoping).<br />
Nel caso in cui il forestierismo abbia un adattamento italiano, questo viene lemmatizzato<br />
con rinvio alla forma italianizzata, dove nella sede riguardante l’etimologia verrà indicata<br />
la base originaria (brokerage/brokeraggio).<br />
Nel caso di adattamenti italiani non acclimatati sono lemmatizzati con il rinvio al<br />
forestierismo. Ex. Gilèàgilet.<br />
I latinismi e i grecismi integrali (humus, thesaurus) sono trattati come forestierismi.<br />
APPROFONDIMENTO<br />
Circa 300 voci sono corredate, in coda come ultima sezione, di una nota di<br />
approfondimento, segnalata da un quadratino tutto nero posto a capo del rigo, in cui<br />
abbiamo :<br />
ü lo sviluppo analitico delle reggenze di tutte le preposizioni monosillabiche (e anche<br />
di sopra e sotto) e di alcune congiunzioni (che, perché, quando) più produttive;<br />
ü la descrizione dettagliata dei complementi e di ogni tipo di frase “dipendente”;<br />
ü spiegazione e documentazione anche storica degli usi, specialmente testuali, di<br />
avverbi, congiunzioni e locuzioni (allora, ancora, comunque, e, ma ecc..);<br />
ü le liste, in ordine alfabetico, delle locuzioni aggettivali, avverbiali e sostantivali, e<br />
delle frasi fisse che fanno a capo ad alcuni lemmi più produttivi sotto questo<br />
aspetto (andare, dare, fare, mano ecc..);<br />
ü chiarimenti sulle nozioni espresse da alcuni termini della grammatica e della<br />
linguistica (anacoluto, argomento, dialetto, ecc);<br />
ü segnalazioni di stereotipi e intercalari (come praticamente nella voce pratico, attimino<br />
in attimo).<br />
In generale diciamo che nelle note di approfondimento sono trattati problemi<br />
grammaticali, dubbi e usi controversi. All’interno dell’approfondimento i diversi<br />
argomenti sono separati dal simbolo di un rettangolo verticale bianco [] .<br />
Edizioni del <strong>Sabatini</strong> – <strong>Coletti</strong> : I edizione nel 1997<br />
II edizione nel 2001<br />
III edizione nel 2003<br />
IV edizione nel 2007<br />
ALCUNE DIFFERENZE TRA GRADIT - DISC<br />
Il <strong>Sabatini</strong> <strong>Coletti</strong> dà molta importanza alle valenze dei verbi, alla struttura della frase e ai<br />
suoi elementi di composizione. Si sostituisce ai manuali di grammatica.<br />
Il S.C. cita le forme pronominali dei verbi all'interno della stessa forma lemmatizzata, il De<br />
Mauro invece lemmatizza le varie forme separatamente. E poi mentre nel De Mauro ci
sono le marche d'uso, nel <strong>Sabatini</strong> <strong>Coletti</strong> ci sono circa 10.000 lemmi contrassegnati da un<br />
pallino che corrisponde alle parole di alta disponibilità.