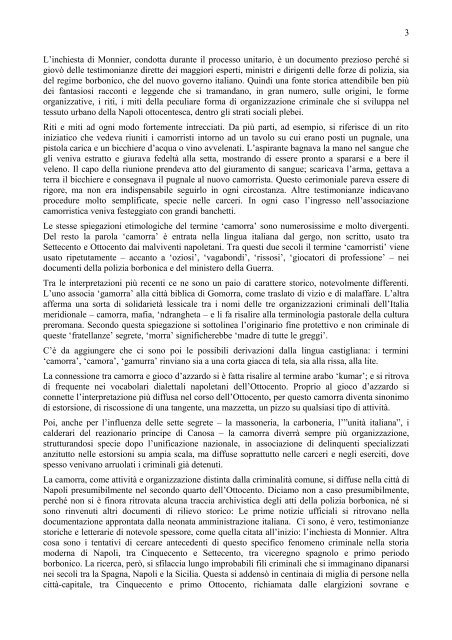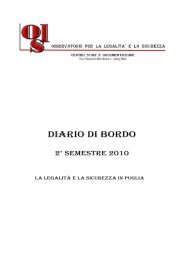Le origini della camorra - (anno 2010) - Osservatorio per la legalità ...
Le origini della camorra - (anno 2010) - Osservatorio per la legalità ...
Le origini della camorra - (anno 2010) - Osservatorio per la legalità ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’inchiesta di Monnier, condotta durante il processo unitario, è un documento prezioso <strong>per</strong>ché si<br />
giovò delle testimonianze dirette dei maggiori es<strong>per</strong>ti, ministri e dirigenti delle forze di polizia, sia<br />
del regime borbonico, che del nuovo governo italiano. Quindi una fonte storica attendibile ben più<br />
dei fantasiosi racconti e leggende che si tramandano, in gran numero, sulle <strong>origini</strong>, le forme<br />
organizzative, i riti, i miti <strong>del<strong>la</strong></strong> peculiare forma di organizzazione criminale che si sviluppa nel<br />
tessuto urbano <strong>del<strong>la</strong></strong> Napoli ottocentesca, dentro gli strati sociali plebei.<br />
Riti e miti ad ogni modo fortemente intrecciati. Da più parti, ad esempio, si riferisce di un rito<br />
iniziatico che vedeva riuniti i camorristi intorno ad un tavolo su cui erano posti un pugnale, una<br />
pisto<strong>la</strong> carica e un bicchiere d’acqua o vino avvelenati. L’aspirante bagnava <strong>la</strong> mano nel sangue che<br />
gli veniva estratto e giurava fedeltà al<strong>la</strong> setta, mostrando di essere pronto a spararsi e a bere il<br />
veleno. Il capo <strong>del<strong>la</strong></strong> riunione prendeva atto del giuramento di sangue; scaricava l’arma, gettava a<br />
terra il bicchiere e consegnava il pugnale al nuovo camorrista. Questo cerimoniale pareva essere di<br />
rigore, ma non era indispensabile seguirlo in ogni circostanza. Altre testimonianze indicavano<br />
procedure molto semplificate, specie nelle carceri. In ogni caso l’ingresso nell’associazione<br />
camorristica veniva festeggiato con grandi banchetti.<br />
<strong>Le</strong> stesse spiegazioni etimologiche del termine ‘<strong>camorra</strong>’ sono numerosissime e molto divergenti.<br />
Del resto <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> ‘<strong>camorra</strong>’ è entrata nel<strong>la</strong> lingua italiana dal gergo, non scritto, usato tra<br />
Settecento e Ottocento dai malviventi napoletani. Tra questi due secoli il termine ‘camorristi’ viene<br />
usato ripetutamente – accanto a ‘oziosi’, ‘vagabondi’, ‘rissosi’, ‘giocatori di professione’ – nei<br />
documenti <strong>del<strong>la</strong></strong> polizia borbonica e del ministero <strong>del<strong>la</strong></strong> Guerra.<br />
Tra le interpretazioni più recenti ce ne sono un paio di carattere storico, notevolmente differenti.<br />
L’uno associa ‘gamorra’ al<strong>la</strong> città biblica di Gomorra, come tras<strong>la</strong>to di vizio e di ma<strong>la</strong>ffare. L’altra<br />
afferma una sorta di solidarietà lessicale tra i nomi delle tre organizzazioni criminali dell’Italia<br />
meridionale – <strong>camorra</strong>, mafia, ‘ndrangheta – e li fa risalire al<strong>la</strong> terminologia pastorale <strong>del<strong>la</strong></strong> cultura<br />
preromana. Secondo questa spiegazione si sottolinea l’originario fine protettivo e non criminale di<br />
queste ‘fratel<strong>la</strong>nze’ segrete, ‘morra’ significherebbe ‘madre di tutte le greggi’.<br />
C’è da aggiungere che ci sono poi le possibili derivazioni dal<strong>la</strong> lingua castigliana: i termini<br />
‘<strong>camorra</strong>’, ‘camora’, ‘gamurra’ rinviano sia a una corta giacca di te<strong>la</strong>, sia al<strong>la</strong> rissa, al<strong>la</strong> lite.<br />
La connessione tra <strong>camorra</strong> e gioco d’azzardo si è fatta risalire al termine arabo ‘kumar’; e si ritrova<br />
di frequente nei vocabo<strong>la</strong>ri dialettali napoletani dell’Ottocento. Proprio al gioco d’azzardo si<br />
connette l’interpretazione più diffusa nel corso dell’Ottocento, <strong>per</strong> questo <strong>camorra</strong> diventa sinonimo<br />
di estorsione, di riscossione di una tangente, una mazzetta, un pizzo su qualsiasi tipo di attività.<br />
Poi, anche <strong>per</strong> l’influenza delle sette segrete – <strong>la</strong> massoneria, <strong>la</strong> carboneria, l’”unità italiana”, i<br />
calderari del reazionario principe di Canosa – <strong>la</strong> <strong>camorra</strong> diverrà sempre più organizzazione,<br />
strutturandosi specie dopo l’unificazione nazionale, in associazione di delinquenti specializzati<br />
anzitutto nelle estorsioni su ampia sca<strong>la</strong>, ma diffuse soprattutto nelle carceri e negli eserciti, dove<br />
spesso venivano arruo<strong>la</strong>ti i criminali già detenuti.<br />
La <strong>camorra</strong>, come attività e organizzazione distinta dal<strong>la</strong> criminalità comune, si diffuse nel<strong>la</strong> città di<br />
Napoli presumibilmente nel secondo quarto dell’Ottocento. Diciamo non a caso presumibilmente,<br />
<strong>per</strong>ché non si è finora ritrovata alcuna traccia archivistica degli atti <strong>del<strong>la</strong></strong> polizia borbonica, né si<br />
sono rinvenuti altri documenti di rilievo storico: <strong>Le</strong> prime notizie ufficiali si ritrovano nel<strong>la</strong><br />
documentazione approntata dal<strong>la</strong> neonata amministrazione italiana. Ci sono, è vero, testimonianze<br />
storiche e letterarie di notevole spessore, come quel<strong>la</strong> citata all’inizio: l’inchiesta di Monnier. Altra<br />
cosa sono i tentativi di cercare antecedenti di questo specifico fenomeno criminale nel<strong>la</strong> storia<br />
moderna di Napoli, tra Cinquecento e Settecento, tra viceregno spagnolo e primo <strong>per</strong>iodo<br />
borbonico. La ricerca, <strong>per</strong>ò, si sfi<strong>la</strong>ccia lungo improbabili fili criminali che si immaginano dipanarsi<br />
nei secoli tra <strong>la</strong> Spagna, Napoli e <strong>la</strong> Sicilia. Questa si addensò in centinaia di miglia di <strong>per</strong>sone nel<strong>la</strong><br />
città-capitale, tra Cinquecento e primo Ottocento, richiamata dalle e<strong>la</strong>rgizioni sovrane e<br />
3