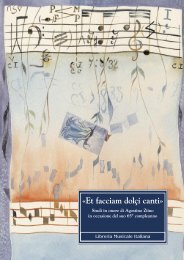Articolo Tagliavini appoggiature
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI<br />
mai rigettare Garcia quale «infido testimone per il recitativo di Mozart» semplicemente<br />
per i suoi suggerimenti 46 sull’esecuzione della frase di Donna Anna<br />
«Padre mio, caro padre» (Don Giovanni, Atto I, Scena III, Recitativo accompagnato,<br />
batt. 31-32)? Forse per la breve, inoffensiva appoggiatura sulla seconda<br />
sillaba di «caro»? Le altre <strong>appoggiature</strong> sono quelle ‘obbligatorie’, del resto pertinentemente<br />
suggerite nell’edizione critica a cura di Wolfgang Rehn e Wolfgang<br />
Plath. 47 E su che si basa l’affermazione che nel dialogo tra Don Giovanni e<br />
Zerlina (Atto I, Scena IX) Garcia, «evidentemente irritato» dalla triplice ricorrenza<br />
delle note dello stesso accordo sulle parole «quegli occhi bricconcelli, quei<br />
labbretti sì belli, quelle ditucce candide e odorose», si sarebbe concesso la libertà<br />
di modificare (umkomponieren) il testo mozartiano per «correggere» una pretesa<br />
monotonia? 48 In realtà Garcia 49 riproduce con assoluta fedeltà il testo di Mozart<br />
e si limita a commentare che «i buoni cantanti […] evitano i valori eguali, il<br />
ritorno delle pause a distanze eguali, la ripetizione degli stessi suoni e la simmetria<br />
degli accenti»; nulla ci dice che qui Garcia suggerisca di ritoccare il testo<br />
mozartiano che sembra citato solo quale eccezione alla regola; l’«abile cantante»<br />
può tutt’al più scorgervi il suggerimento di mascherarne la simmetria sul piano<br />
dell’interpretazione. È vero che fa storcere il naso l’osservazione di Garcia<br />
secondo cui nei recitativi secchi, da lui definiti «parlanti» ed esclusivi alla sua<br />
epoca dell’opera buffa, trattandosi generamente di «una specie di luoghi<br />
comuni, l’artista è libero, senza offendere il compositore, di cangiarne la melodia».<br />
50 Ma non mi sembra che tale asserzione basti da sola a controbilanciare<br />
negativamente le messe preziosa di insegnamenti ch’egli ci offre nella sua scuola<br />
di canto e, come afferma Neumann, a «squalificarlo», quanto piuttosto a farne<br />
portavoce di un’usanza che – piaccia o non piaccia – era probabilmente radicata<br />
da tempo immemorabile e s’inseriva perfettamente nella convinzione della sempre<br />
più frequente «anonimità» compositiva del recitativo secco. 51<br />
46 Scuola di Garcia, Parte II, Cap. IV, sezione Dell’Espressione, p. 55. Cfr. NEUMANN, Vorschlag und<br />
Appoggiatur, p. 370.<br />
47 W. A. MOZART, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie II, Werkgruppe 5, Band 17, Bärenreiter, Kassel<br />
1968, p. 49.<br />
48 NEUMANN, Vorschlag und Appoggiatur, p. 370.<br />
49 Scuola di Garcia, Parte II, Cap. V, sezione Recitativo parlante, p. 66. Ritengo opportuno in questo<br />
caso riprodurre il testo originale francese (dall’edizione del 1847 su cui afferma basarsi Neumann,<br />
edizione qui sopra citata alla nota 13, p. 64): «Les chanteurs habiles ont grand soin d’introduire<br />
une certaine variété dans la forme et dans le mouvement des cantilènes, c’est-à-dire qu’ils évitent<br />
les valeurs égales, le retour des repos placés à distances égales, les répétitions des mêmes intonations<br />
et la symétrie des accents».<br />
50 Ivi, p. 65.<br />
51 Mi fa notare Marco Beghelli che, tra i tanti, Rossini s’avvalse di anonimi collaboratori per la<br />
composizione dei recitativi secchi almeno a partire da La pietra del paragone, già quindi al suo<br />
secondo anno di carriera operistica.<br />
978